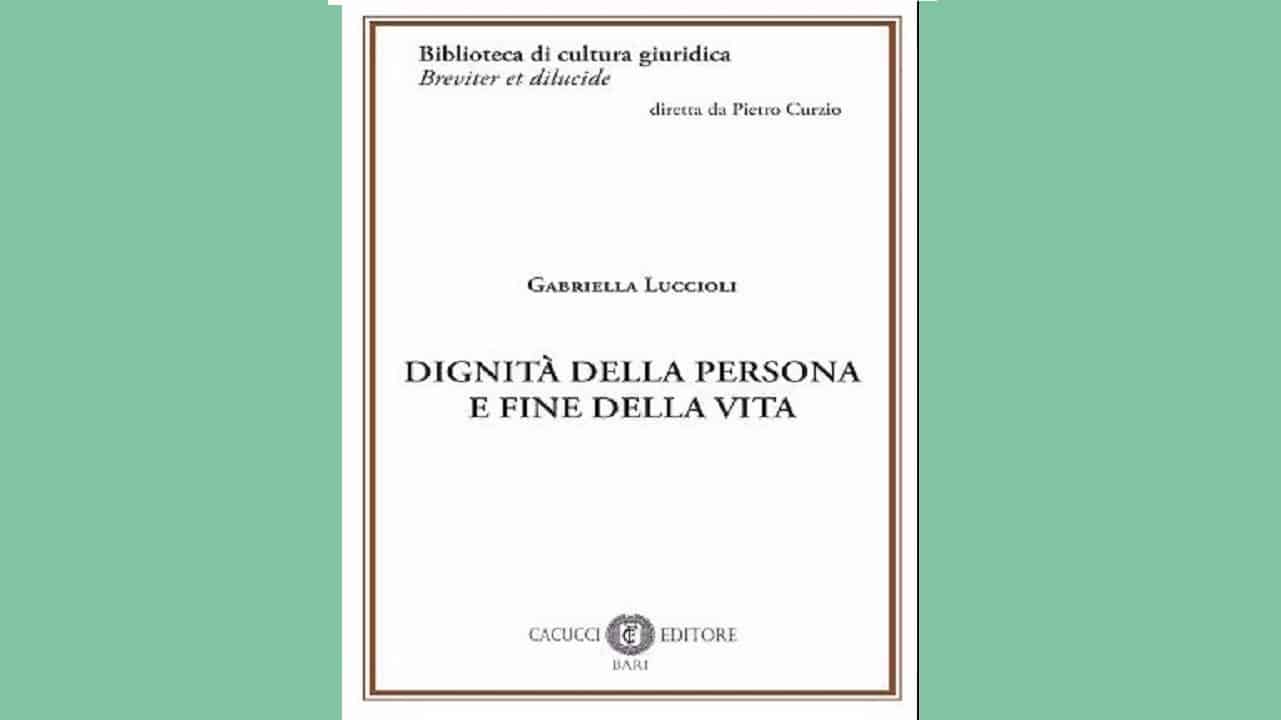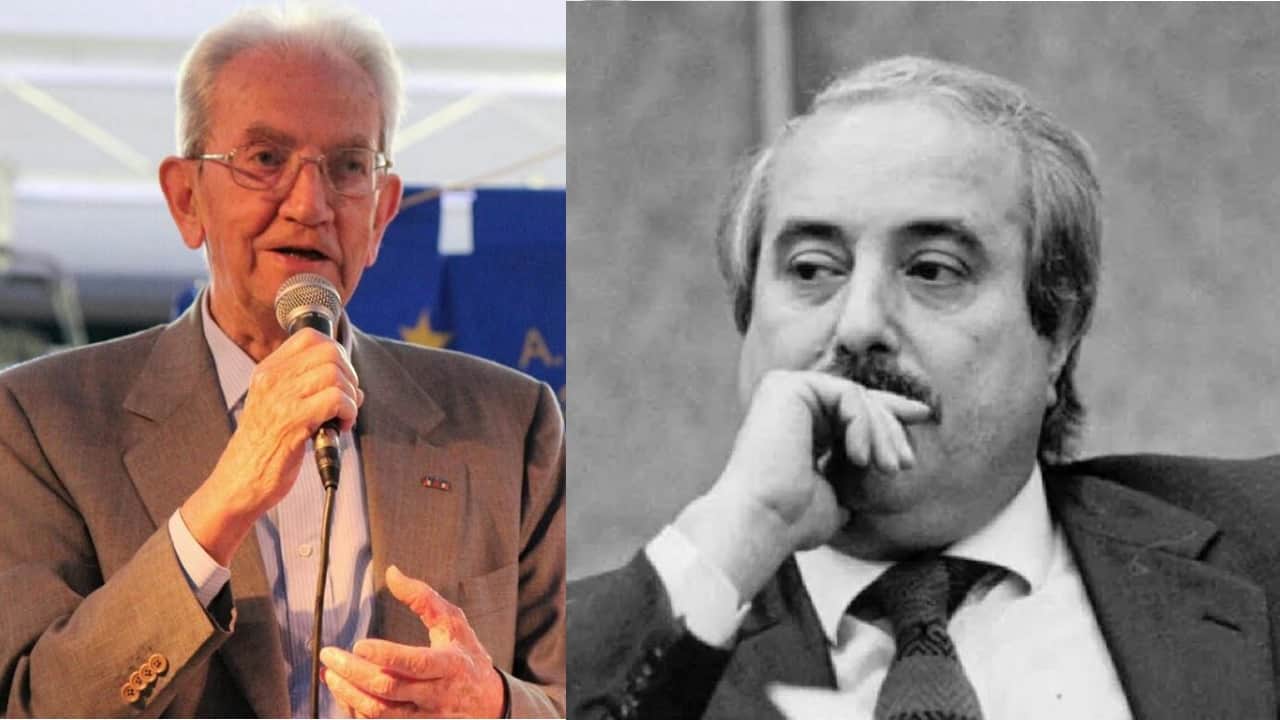CEDU e cultura giuridica italiana
9) La CEDU e il diritto amministrativo
Roberto Giovanni Conti
Intervista
Roberto Caranta, ordinario diritto amministrativo Università di Torino
Francesco Goisis, ordinario di diritto amministrativo nell’Università statale di Milano
Giuseppe Tropea, ordinario di diritto amministrativo dell’Università di Reggio Calabria
1. Le domande. 2. La scelta del tema. 3. Le risposte. 4. Le repliche. 5. Le conclusioni. 6. Intervista in pdf.
1.Le domande
1) Quali sono, a Suo giudizio, i nodi più problematici che la Corte edu dovrà nel prossimo futuro sciogliere in tema di giusto processo amministrativo e Cedu?
2) Sono a suo avviso ipotizzabili dei dubbi di conformità a CEDU del sistema recentemente ridisegnato in tema di riparto di giurisdizione dalla sentenza della Corte costituzionale n.6/2018?
3) L’attuale assetto normativo previsto in materia di provvedimenti ablatori, dopo gli interventi della Corte costituzionale (sentt.n.348 e 349 del 2007, 71/2015) e del legislatore ordinario – art.42 bis T.U. espr. – presenta, a suo avviso, dei profili di inconvenzionalità rispetto ai parametri degli artt.6 CEDU e 1 Prot.n.1 annesso alla Cedu?
2.La scelta del tema.
Roberto Giovanni Conti
Il viaggio in corso alla scoperta del pianeta Convenzione europea dei diritti dell’uomo arriva nella cittadella dei rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione. Un ambito complesso che tendeva a vivere all’interno di coordinate proprie rispetto alla famiglia dei rapporti che non vedono coinvolti l’interesse pubblico e la pubblica amministrazione e che, come a tutti noto, da anni si è avvicinato a quella famiglia per vari ordini di ragioni. Questo processo non ha, conseguentemente, lasciato immune l’ambito del diritto amministrativo dalle influenze provenienti dalla CEDU. I temi scelti ai quali i tre professori – Roberto Caranta, Francesco Goisis e Giuseppe Tropea – hanno accettato di rispondere con grande partecipazione offrono, peraltro, l’occasione per mettere a fuoco questioni di rilievo centrale per il giurista, sia esso o meno di estrazione amministrativista, arrivando a lambire tematiche quali quelle dell’unità della giurisdizione, delle relazioni fra le giurisdizioni di ultima istanza nazionali ed i loro rapporti con la Corte edu.
3.Le risposte.
1) Quali sono, a Suo giudizio, i nodi più problematici che la Corte edu dovrà nel prossimo futuro sciogliere in tema di giusto processo amministrativo e Cedu?
Roberto Caranta
Un primo fondamentale e trasversale aspetto da chiarire attiene al valore che i giudici nazionali devono riconoscere all’interpretazione fornita dalla Corte EDU delle norme convenzionali, a fronte del delicato ‘match’ cui si è recentemente assistito tra la Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo. L’arresto n. 49/2015, in cui la Consulta ha ritenuto vincolante solo l’interpretazione che costituisca un diritto consolidato all’interno della giurisprudenza europea, ovvero nel caso delle c.d. decisioni pilota, ha invero rappresentato un arretramento rispetto all’integrazione tra i due sistemi. Come noto, la Corte EDU nella sentenza G.I.E.M. del 2018, in tema di confisca urbanistica, ha ribadito che tutte le sue pronunce hanno lo stesso valore giuridico e sono ugualmente vincolanti, in chiara risposta al giudice costituzionale.
La questione è indubbiamente rilevante anche in tema di giusto processo amministrativo e lo strappo dato dall’arresto n. 49/2015 non può ancora ritenersi superato. Al riguardo, laddove giunga a conclusione il procedimento di ratifica nell’ordinamento italiano del meccanismo di parere consultivo del Protocollo n. 16[1], questo potrà, ove correttamente applicato, giocare un ruolo nel raggiungimento di un’interpretazione dei principi convenzionali sempre più condivisa e “istituzionalmente dialogata”. L’obiettivo dichiarato del Protocollo n. 16 è infatti quello di rafforzare il “carattere costituzionale” della Corte di Strasburgo quale giudice dei principi, investendola dunque di un ruolo di nomofilachia preventiva – seppur limitata alle questioni di principio – proprio al fine di indirizzare gli Stati aderenti e prevenire interpretazioni potenzialmente difformi e, conseguentemente, future violazioni del diritto convenzionale.
Un altro profilo profondamente problematico attiene all’esecuzione delle pronunce definitive della Corte EDU che accertano una violazione di un diritto fondamentale e all’individuazione delle conseguenze, sostanziali e processuali, che tali pronunce comportano nell’ordinamento nazionale.
All’interno di questa tematica i nodi più problematici in ambito amministrativo risultano costituiti da: (i) il rapporto tra la decisione definitiva della Corte EDU e la possibile riapertura del processo amministrativo; in altri termini, l’attitudine della pronuncia sovranazionale a costituire il fondamento per il successivo superamento del giudicato interno; (ii) la possibilità o meno di ricorrere allo strumento generale del ricorso per ottemperanza quale sede per garantire l’attuazione diretta del giudicato sovranazionale, sia come esecuzione degli obblighi pecuniari, che di quelli eventualmente conformativi; (iii) il rapporto tra la sentenza definitiva e il meccanismo interno di autotutela, i.e. la possibile idoneità del giudicato sovranazionale a costituire un obbligo per l’amministrazione interna a riesaminare la questione, anche se coperta da giudicato interno, e intervenire con un’autotutela doverosa[2].
Al riguardo, peraltro, va evidenziato come la stessa Corte EDU abbia ribadito la discrezionalità in capo agli Stati aderenti nella scelta dei mezzi processuali per conformarsi ad una sentenza che accerti una violazione, senza imporre necessariamente meccanismi di restitutio ad integrum, ma con il solo vincolo di risultato di assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti (Scordino v. Italia [2006]; Scozzari e Giunta v. Italia [2000]). Pertanto, attualmente la questione sembra porsi più a livello nazionale per i giudici ed il legislatore italiano, spettando alla Corte EDU piuttosto una valutazione ex post sulla adeguatezza delle tecniche e degli strumenti processuali prescelti nel raggiungimento del risultato richiesto nel caso concreto.
Da questo punto di vista è rilevante la recente pronuncia della Corte EDU nella causa Mazzeo v. Italia [2017], la quale ha evidenziato la non adeguatezza della tutela offerta dall’ordinamento nazionale. Il valore del giudicato era stato infatti clamorosamente eluso tramite l’esercizio del potere di autotutela in seguito ad una pronuncia interna di condanna a carico della p.a., ponendosi così in contrasto con il rispetto del diritto fondamentale ad un giusto processo, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale[3]. In particolare, la Corte ha affermato che l’intervento in autotutela, successivo ad una sentenza passata in giudicato di condanna, che sostanzialmente priva la parte vittoriosa della corretta esecuzione della sentenza interna, si pone in contrasto con il principio di sicurezza giuridica e costituisce una violazione del diritto di accesso degli interessati sancito dall’art. 6, co. 1 CEDU.
Il primo aspetto da evidenziare – anche in raffronto alla “speculare” problematica suesposta di superamento del giudicato interno contrario ai principi convenzionali – è che la Corte, riprendendo propri precedenti, fondi la sua decisione sulla duplice considerazione che: “la certezza del diritto presuppone il rispetto del principio dell’autorità della cosa giudicata, ossia del carattere definitivo delle decisioni giudiziarie... In effetti, un sistema giudiziario caratterizzato dalla possibilità di rimettere continuamente in causa e di annullare ripetutamente delle sentenze definitive viola l’articolo 6 § 1 della Convenzione”. Nello specifico, richiamando la causa Hornsby [1997], afferma che: “La protezione effettiva della persona sottoposta alla giustizia implica l’obbligo per lo Stato o uno dei suoi organi di eseguire la sentenza. Se lo Stato rifiuta o omette di dare esecuzione, o tarda a farlo, le garanzie dell’articolo 6 di cui ha beneficiato tale persona nella fase giudiziaria della procedura perderebbero ogni ragione di essere”.
Conseguentemente, la Corte EDU imposta il proprio ambito di indagine: valutare se il successivo provvedimento di annullamento della p.a. costituisca una violazione del principio di certezza giuridica e di accesso ad un tribunale. Tale impostazione prescinde pertanto da qualsiasi valutazione circa la legittimità o meno del provvedimento in sé considerato, che pure potrebbe essere formalmente legittimo, ma si concentra invece esclusivamente sugli effetti di tale provvedimento rispetto alla possibilità di ottenere esecuzione della sentenza.
Questa prospettiva sembrerebbe quindi aprire una nuova tipologia di limite all’esercizio dell’autotutela amministrativa, ulteriore rispetto a quanto attualmente previsto dall’art. 21–nonies della l. 241/1991 o, quantomeno, una diversa definizione del contemperamento con gli interessi del privato coinvolto. La questione appare di evidente rilevanza sul piano sistematico generale e meriterà verosimilmente un approfondimento sia sul piano interno che sovranazionale.
Un ulteriore ambito, più settoriale, di possibile criticità del sistema concerne l’attuale regolamentazione del procedimento di emanazione delle sanzioni amministrative erogate dall’Antitrust, sancita dal d.lgs. n. 3/2017[4] ed i limiti del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo su tali decisioni, così come elaborato dalla giurisprudenza. L’attuale assetto sembra, invero, porsi in contrasto con i principi elaborati dalla Corte EDU in tema di giusto processo a fronte di sanzioni riconosciute come sostanzialmente penali[5].
Come noto la Corte di Strasburgo ha sancito per sanzioni ritenute sostanzialmente penali, secondo i c.d. criteri Engel, l’estensione, in forza dell’art. 6 CEDU, di tutte le fondamentali garanzie difensive del giusto processo (quali il diritto ad esser giudicati da un’autorità terza e imparziale, il rispetto del principio della parità delle armi e del contraddittorio nella formazione della prova e l’audizione delle parti in pubblica udienza) anche alla fase della procedura amministrativa. Qualora emerga un deficit di tali garanzie nella fase amministrativa (come peraltro accertato, proprio in riferimento ai procedimenti sanzionatori delle Autorità nel noto caso Grande Stevens) è necessario, in subordine, che il sindacato del giudice amministrativo su tali sanzioni sia di c.d. full jurisdiction. In altre parole, per assicurare il rispetto delle garanzie poste dall’art. 6 CEDU il giudice dovrebbe essere in grado di riformare qualsiasi punto, in fatto ed in diritto, della sentenza.
L’attuale giurisprudenza nazionale ha invece ribadito, in ossequio peraltro al dettato normativo vigente, che il giudice amministrativo in tali materie non ha un potere sostitutivo rispetto alle valutazioni opinabili e di discrezionalità tecnica (soprattutto con riferimento ai complessi ed indeterminati concetti quali quello di ‘mercato rilevante’); egli può soltanto operare un sindacato di legittimità[6], che si traduce in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza circa le valutazioni tecniche esercitate dall’Antitrust (Così da ultimo Cass. S. U. n. 1013/2014). Posto che le garanzie individuate derivanti dall’art. 6 CEDU non paiono pienamente rispettate né nella fase procedimentale, né nella successiva fase di controllo giurisdizionale, ci si chiede se l’attuale assetto necessiti di un intervento sia in sede Costituzionale (stante il rinvio ex art. 117, co. 1 Cost) sia da parte della stessa Corte EDU.
Francesco Goisis
I profili di possibile influenza della CEDU sul processo amministrativo (o comunque sulla tutela giurisdizionale avverso gli atti della PA, ove anche esercitata dall'AGO) sono ovviamente molteplici.
Ma il primo e a mio giudizio principale punto di necessaria incidenza dell'art. 6 CEDU mi pare relativo ai limiti del sindacato, in rapporto al canone della full jurisdiction.
Procediamo per ordine.
In effetti, forse uno de principali ostacoli al riconoscimento della rilevanza dell’art. 6 CEDU nel diritto amministrativo è stato costituito, in Italia[7], dal fatto che tale articolo tutela il giusto processo solo nella materia penale e civile. Paiono così apparentemente escluse le controversie relative all'esercizio del potere amministrativo.
Come da ultimo ben colto dalla Consulta, tuttavia, l'obiettivo fondamentale in vista del quale si è costruito l'intero insegnamento dei giudici di Strasburgo in punto di sanzioni amministrative è quello di evitare che, per via dell'opzione per la forma della sanzione amministrativa, vada «disperso il fascio delle tutele che aveva storicamente accompagnato lo sviluppo del diritto penale, e alla cui difesa la CEDU è preposta»[8].
Il concetto di illecito penale è dunque autonomo rispetto a quello proprio dei vari ordinamenti nazionali. In particolare, a differenza della visione tradizionalmente prevalente in Italia, la prospettiva CEDU è accentuatamente sostanzialistica e così indirizzata ad operare attraverso categorie ampie e flessibili: il riconoscimento come di carattere penale di un illecito consente difatti l’estensione di alcune importanti garanzie; è cioè strumento di rafforzamento delle tutele per il cittadino.
Fin dal 1976 i giudici europei occupandosi, nel caso Engel [9], di sanzioni disciplinari militari (come tali del tutto prive, nell’ordinamento di appartenenza, di un carattere penale), hanno elaborato due principali criteri sostanziali per la qualificazione di un provvedimento dei pubblici poteri come sanzione penale: in primo luogo, la natura del provvedimento, e, in particolare, lo scopo afflittivo–deterrente e la generalità (ossia riferibilità astratta a tutti i cittadini); in secondo luogo – anche in mancanza del primo elemento (ovvero per rafforzare le conclusioni raggiunte sulla base di quest’ultimo) – la severità, e, cioè, la gravità del malum infliggibile (più precisamente, del massimo edittale).
La qualificazione formale che una data sanzione è invece vincolante esclusivamente in senso estensivo, ossia, nell’ambito di quella che è stata definita (fin dalla sentenza Engel) una autonomia [10] a senso unico (one–way autonomy), (solo) per affermare ed estendere l’applicabilità dell’art. 6 CEDU. In altri termini, se una sanzione è penale nell’ordinamento nazionale, non sarà necessario accertare che siano integrati i requisiti sostanziali affermati dai giudici di Strasburgo. Invece, la classificazione formale ai sensi dell’ordinamento nazionale non è in alcun modo dirimente per negare l’applicabilità delle garanzie convenzionali. Basta che la misura sia penale per natura ovvero dotata di una significativa severità.
Pertanto, non è oggi dato dubitare che tutte le sanzioni amministrative pecuniarie italiane (da quelle, più rilevanti, delle Autorità amministrative indipendenti, a quelle minori per illeciti stradali) siano penali ai sensi CEDU, così reclamando pienezza di garanzie a favore del cittadino.
Ed infatti, già nel 1999, la Corte di Strasburgo non ha mostrato alcuna incertezza nel definire di natura penale una comune sanzione amministrativa pecuniaria italiana per eccesso di velocità, dall’ammontare di 62.000 lire [11]; nel 2006 ha qualificato penalisticamente una sanzione pecuniaria nazionale per attività edilizie in violazione della disciplina posta a tutela del paesaggio [12]; con la sentenza Menarini del 2011 [13], poi, una sanzione amministrativa antitrust della nostra AGCM è stata ricondotta al penale ed, infine, nel 2014, è stata vista come penale una sanzione Consob per manipolazione del mercato[14].
Ebbene, in estrema sintesi, la realizzazione del diritto al giusto processo penale di cui all'art. 6 CEDU è affidata, in materia sanzionatoria amministrativa, nonché in relazione a quei provvedimenti amministrativi, che, in quanto incidono su diritti civili, rientrano nella materia civile, al concetto di full jurisdiction.
Essa significa assenza di ogni limitazione – "autoimposta o altrimenti prevista"[15] – all'esame da parte del giudice dei punti centrali della controversia tra cittadino e Amministrazione.
Tale canone (nonostante diffusi tentativi di sminuirne il significato) è tutt'altro che privo di portata innovativa rispetto agli assetti più consueti del nostro sindacato di legittimità: il cittadino deve poter avere accesso ad "un tribunale con giurisdizione sul merito della questione" [16], ossia sul fatto come sul diritto, punto su punto, senza mai dover declinare la capacità di conoscere i fatti e di provvedere[17]. Il giudice amministrativo (o civile, ove dotato di giurisdizione, come nel caso dell'impugnazione di svariate sanzioni amministrative) non deve essere (o considerarsi) "vincolato dai precedenti accertamenti degli organi amministrativi su punti decisivi per l'esito del caso, così prescindendo da un esame indipendente di tali questioni"[18].
In particolare, a certe condizioni ed entro certi limiti, grazie a tale sindacato pieno è dato rimediare – ex post – ai deficit del procedimento amministrativo[19]. In pratica, pur laddove un procedimento amministrativo sia determinativo di diritti civili o, come nel caso delle sanzioni amministrative, di sanzioni penali e quindi in linea di principio chiamato ex se e fin da subito a conformarsi al canone del giusto processo ex art. 6 CEDU, in vista della flessibilità del sistema (e per adeguarsi ad un modello di azione amministrativa sicuramente ben rappresentato in Europa), è consentito offrire successivamente, nella fase formalmente giurisdizionale, le garanzie del giusto processo paritario, così da "rimediare ad ogni difetto del procedimento di primo grado"[20].
Ma naturalmente, presupposto logico necessario di questa capacità "terapeutica" del procedimento giurisdizionale è l'identità di oggetto (pur temperata dal principio della domanda di parte) tra fase amministrativa e fase giurisdizionale. Detto altrimenti: la rinuncia alla tradizionale distinzione tra merito e legittimità.
Esattamente osserva il Consiglio di Stato con riguardo al contenzioso sulle sanzioni Consob[21] come il sindacato di full jurisdiction realizzi (e logicamente presupponga) "un continuum tra procedimento amministrativo e procedimento giurisdizionale", in cui il giudice è chiamato a "sostituire la sua valutazione a quella, contestata, dell’amministrazione". In altri termini, "quando le garanzie del giusto processo non siano assicurate in sede procedimentale, esse devono essere necessariamente soddisfatte in sede processuale ove il giudice, per supplire alla carenza di garanzie del contraddittorio, di indipendenza del decisore, di parità delle parti, deve agire come se riesercitasse il potere, senza alcun limite alla piena cognizione dei fatti e degli interessi in gioco".
Si realizza così un superamento di una tradizionale distinzione organica tra giurisdizione ed amministrazione. Quel che conta è il fatto in sé dell’inflizione di sanzioni penali o della determinazione di diritti civili, sostanzialmente irrilevante essendo ogni caratterizzazione formale, sia essa relativa all’assetto istituzionale ed organizzatorio che al modus operandi [22] (che semmai deve discendere dalla qualificazione sostanziale, non pretendere di determinarla).. In particolare, dice la Corte EDU, "ai fini dell’art. 6, § 1, della Convenzione un tribunale non deve essere una corte inserita nell’ordinaria organizzazione giudiziale". Difatti, "un tribunale, nel contesto dell’art. 6, § 1 CEDU, è qualificato nel senso sostanziale del termine dall’esercizio di una funzione giurisdizionale, cioè dal fatto di decidere questioni nell’ambito della sua competenza sulla base della legge e all’esito di procedimenti condotti in un certo modo …" [23].
La questione acquista – se possibile – ulteriore attualità ed urgenza anche in relazione alla scelta degli artt. 7 e 9 del d.lgs. 3/2017 (in tema di private enforcement in materia antitrust) di parificare, ai fini dell'efficacia nel giudizio civile risarcitorio, provvedimento amministrativo inoppugnabile ed invece giudicato che lo "confermi"[24].
Una volta quindi che il provvedimento AGCM sia capace non solo di infliggere sanzioni penali, ma altresì di determinare imperativamente un profilo indubbiamente civilistico, quale uno dei presupposti necessari del diritto al risarcimento del danno (la condotta antitrust), si apre, allora, la strada, in mancanza di un'effettiva full jurisidiction, per il riconoscimento di una violazione non solo del giusto processo penale, ma anche, quale ulteriore titolo di possibile violazione dell'art. 6 CEDU, del giusto processo civile.
Difatti, il giudice civile risulterebbe vincolato da un accertamento amministrativo, il quale, tuttavia, è stato realizzato nel contesto di un procedimento non conforme al principio della parità delle armi, senza che i relativi limiti siano stati compensati in sede giurisdizionale amministrativa.
In sostanza, come ben osservato in un'ultima importante presa di posizione del Consiglio di Stato del luglio 2019, la necessità di un sindacato pieno e sostitutivo su ogni profilo dell'accertamento dell'illecito antitrust è oggi dimostrata anche dal fatto " che, nelle azioni risarcitorie c.d. stand alone (ossia non precedute da una decisione dell'Autorità), il giudice civile – sia pure ai fini risarcitori – è chiamato a verificare direttamente ed in prima persona i presupposti dell'illecito, senza che occorra alcuna intermediazione di potere pubblico"[25].
Curiosamente, però, la lettera dell'art. 7 cit., ben lungi dal ricercare una conciliazione (almeno apparente) con il canone della full jurisdiction, sembra invece andare nel senso di una significativa riduzione delle tutele rispetto anche agli approdi più "evolutivi" rinvenibili in giurisprudenza. Il riferimento è ovviamente alla previsione per cui "Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima.". Come dire che la verifica giudiziale non si estende all'intrinseco dei profili tecnici caratterizzati da un oggettivo margine di opinabilità[26].
La norma – oltre che (almeno sul piano letterale) certamente in contrasto con il canone della full jurisdiction in quanto diretta proprio ad escludere ogni riesame effettivo delle questioni tecniche – è altresì affetta da un evidente difetto di delega. Essa non trova difatti alcun fondamento anche solo indiretto nella legge delega 9 luglio 2015, n. 114 o nella Direttiva 2014/104/UE.
Per tutte queste ragioni, sembra da privilegiare (in attesa di un'auspicabile abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale) un'interpretazione il più possibile correttiva.
Ad esempio, quanto ai provvedimenti sanzionatori, sulla base dello stesso dato letterale, si potrebbe immaginare il seguente percorso: la norma fa riferimento ai poteri del giudice in sede di giurisdizione di legittimità ("il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima"). Tuttavia, come ricordato, l'art. 134 c.p.a. opportunamente inserisce il sindacato sulle sanzioni AGCM nel contesto della giurisdizione di merito.
In questo senso, parrebbe da seguire e generalizzare la già menzionata pronuncia del Consiglio di Stato del luglio 2019. Essa prescinde da una specifica valorizzazione dell'art. 134 c.p.a., preferendo ragionare in termini di più ampio adattamento del sindacato giurisdizionale amministrativo al canone della full jurisdiction[27].
Anzitutto il giudice di appello sintetizza efficacemente il nucleo concettuale della full jurisdiction: "Secondo la giurisprudenza della Corte Europea, il «fair trial» non ha ad oggetto unicamente il processo, ma anche il procedimento, amministrativo, e segnatamente: per «tribunale» deve intendersi qualunque autorità che, pur attraverso un procedimento non formalmente qualificato processo nell’ordinamento interno, adotti atti modificativi della realtà giuridica, incidenti significativamente nella sfera soggettiva di un soggetto privato, anche se tale funzione viene esercitata al di fuori di una organizzazione giurisdizionale". Da qui la "rilevanza centrale, nelle controversie sull’esercizio del potere sanzionatorio, del concetto di «full jurisdiction». Secondo i giudici di Strasburgo la decisione amministrativa incidente su civil rights and obligations, per quanto adottata senza il rispetto di tutti i requisiti prescritti dal principio del «fail trail», può nondimeno essere considerata adottata conformemente alla Convenzione, laddove le garanzie procedurali ivi previste siano comunque riscontrabili nella sede di controllo della decisione stessa".
Quindi, proprio in relazione all'art. 7 cit. e ai problemi posti dalla disciplina sul private enforcement, alla luce dei principi CEDU, e quindi nel rispondere al quesito se " anche alla luce del nuovo assetto del public and private enforcement, in cui….la violazione del diritto antitrust constatata da una decisione definitiva di un’autorità nazionale garante della concorrenza, rimasta inoppugnata o confermata dal giudice amministrativo, è divenuta incontestabile nel giudizio per il risarcimento del danno proposta dinanzi al giudice civile – il…sindacato “non sostitutivo” di ragionevolezza e proporzionalità sull’illecito antitrust sia ancora coerente con la fisionomia che il processo amministrativo ha nel frattempo assunto informandosi all’anzidetto principio di effettività", osservato che dato che " l’ordinamento generale pone esso stesso una regola sostantiva che determina a priori ed in astratto ciò che spetta ad ognuno dei soggetti coinvolti, ai cui interessi viene dunque assicurata, entro questi limiti, soddisfazione", "nulla si oppone a che sia il giudice a “definire” la fattispecie sostanziale", i giudici di Palazzo Spada propongono il superamento del tradizionale limite del divieto di sostituzione delle valutazioni tecniche: rispetto alle sanzioni AGCM, non debbono operare " i limiti cognitivi insiti nella tecnica del sindacato sull'esercizio del potere", essendo viceversa il giudice amministrativo "pienamente abilitato a pervenire all'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale invocata (nella specie, l'accertamento della realizzazione o meno dell'intesa illecita punita con una pesante sanzione pecuniaria)".
Come si vede, quindi, è finalmente emersa in giurisprudenza la rilevanza dell'efficacia di accertamento autonomo del provvedimento AGCM nel (quantomeno) suggerire nuove linee di evoluzione del sindacato in coerenza con i dettami CEDU. In effetti un sindacato di mera legittimità, per quanto talvolta satisfattivo nel caso concreto, manca però di quel carattere sostitutivo (nei limiti delle richieste di parte ricorrente) che costituisce – piaccia o no – la base logica stessa del concetto di full jurisdiction.
Lo si ripete: la caratterizzazione della full jurisdiction (se chiamata ad una funzione compensatoria dei limiti del procedimento amministrativo) come sindacato effettivamente (e non solo a parole) pieno (e quindi sostitutivo) costituisce il frutto di una necessità anzitutto logica, come tale emersa anche in altri ordinamenti: ad es., nel 1980, proprio in un caso relativo a sanzioni amministrative, la Corte suprema degli Stati Uniti ha statuito che perché una violazione della due process clause nella determinazione iniziale dei diritti del cittadino da parte di un’autorità con funzioni prosecutorial (ossia, potremmo dire, di accusa, come contrapposte a quelle semigiudiziali) possa essere “curata”, occorre che vi sia una ulteriore fase giudiziale non solo rispettosa dei principi del giusto processo, ma anche, e soprattutto, di "sindacato ex novo su tutte le questioni fattuali e giuridiche" [28].
Credo sia venuto il momento di prendere realmente atto di tutto ciò, avviandosi verso un significativo rafforzamento degli spazi di (effettivo e non meramente nominale) sindacato giurisdizionale sulla c.d. discrezionalità amministrativa.
Giuseppe Tropea
Non ho certo la pretesa di toccare in questa sede i molteplici snodi problematici sottesi dalla domanda.
Del resto, se ho ben compreso le lodevoli intenzioni di chi ci ha coinvolto in questa interessante iniziativa, si tratta di un dialogo tra giurisprudenza pratica e teorica, e ho accanto colleghi ben più autorevoli ed esperti di me sul tema, sicché confido sul fatto che ciò che verrà da me trascurato o non adeguatamente sviluppato sarà certamente ripreso da loro.
Solo un’altra chiosa, a mò di premessa: l’idea del dialogo tra dottrina e giurisprudenza, a mio sommesso avviso, è cruciale in questa delicata fase in cui – per responsabilità equamente divise tra dottrina e foro – si tende alla separazione e a una deprecabile invasione di ruoli.
Ritengo che il tema del giusto processo amministrativo sia tuttora cruciale per misurare lo stato del dialogo fra le corti, in particolare fra giudice nazionale e Corte di Strasburgo.
La questione può essere osservata almeno sotto tre punti di vista generali: quello degli istituti del diritto amministrativo interno; quello del giusto processo in senso “strutturale”; quello del giusto processo in senso “funzionale”.
Il primo riguarda la tutela riservata dall’ordinamento interno a materie e/o istituti di diritto sostanziale, alla luce del loro trattamento processuale.
Il caso più emblematico è probabilmente quello dell’espropriazione per pubblica utilità (non è un caso che le notissime sentenze gemelle del 2007 riguardano tale tema), ma su di esso c’è una esplicita domanda alla cui risposta rinvio.
Per fare solo un altro esempio, che presenta particolare attualità, accenno ai casi legati al diritto dell’immigrazione o della sicurezza pubblica. Se è vero che nella giurisprudenza della Corte Edu le garanzie del giusto processo (art. 6) non sono applicabili alla materia dell’immigrazione e dell’asilo, è anche vero che l’art. 13 (effettività) viene ritenuto funzionale al fine di ottenere standard di tutela comuni, specie per il caso di diritti assoluti, ad esempio vita (art. 2), divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3), etc. Sotto questo aspetto il tema delle misure di esecuzione dell’allontanamento e del trattenimento mantiene rilevantissimi profili di criticità, anche alla luce dei pacchetti sicurezza degli ultimi mesi. A ciò si aggiunga il complicato criterio di riparto di giurisdizione in questa delicata materia, che si rifletta, in senso deleterio, sul principio di concentrazione delle tutele, corollario del principio di effettività (art. 7 c.p.a.) e sul principio della ragionevole durata del processo. Si pensi anche al caso del cd. “Daspo urbano”, introdotto nel nostro ordinamento con d.l. n. 14/2017, che ha introdotto nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e comportamenti di inciviltà, incidenti sulla vivibilità dei luoghi nevralgici della vita cittadina e suscettibili di determinare un “effetto abbandono”, che è una delle concause della formazione di diffuse forme di illegalità. Nel caso di specie si pone sia il problema relativo al fatto che per questo istituto si possono riproporre le questioni tradizionali in tema di misure di prevenzione, che prescindono dall’accertamento giudiziale di delitti e si basano su meri sospetti, e tutto ciò può porsi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza De Tommaso. Senza contare che, a voler considerare – come alcuni già fanno – tali provvedimenti come sanzioni sostanzialmente penali (alla luce dei noti criteri Engel) si pongono notevoli problemi con riguardo alla tutela sostanziale procedimentale e ai limiti della full jurisdiction compensativa del giudice amministrativo.
Vengo quindi al tema più specifico del giusto processo, nel combinato disposto degli artt. 6 e 13 Cedu e mi limito anche qui ad alcuni esempi, distinguendo il profilo strutturale dell’organizzazione giurisdizionale da quello funzionale della qualità ed effettività della tutela erogata.
Sul primo fronte si pone l’annoso problema della indipendenza e imparzialità del giudice amministrativo. È vero che la Corte Edu, dopo una prima apertura nel caso Procola, ha ritenuto insussistente, dopo una verifica concreta, la parzialità strutturale dell’organo esercitante funzioni consultive e giurisdizionali (casi McGonnel; Kleyn; Sacilor Lormines), ma è anche vero che persistono dei dubbi, con riguardo ad alcune forme di raccordo e/o contiguità. Ad esempio, con l’art. 54, co. 3, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, si è stabilito che il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all’inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di presidenza, individui le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e quelle che, invece, esercitano funzioni consultive. In base a quest’ultima disposizione dal 2011 pure alla III ed alla II sezione sono state attribuite funzioni giurisdizionali. Sicché, non sono più predeterminate per legge le sezioni che svolgono attività giurisdizionale e quelle che svolgono attività consultiva. È quindi necessario evitare sistematicamente e in modo preventivo che il magistrato che ha reso pareri su un determinato oggetto possa essere chiamato a giudicare un ricorso concernente il medesimo oggetto su cui si sia espresso in sede consultiva, anche attraverso la previsione di criteri predeterminati per la distribuzione delle funzioni tra le sezioni del Consiglio di Stato da parte del suo Presidente.
C’è poi il problema delicato della nomina governativa del quarto dei membri del Consiglio di Stato e del Presidente. Su quest’ultimo punto, al netto della giurisprudenza costituzionale che ha da sempre ammesso tale evenienza (sin dalla sent. n. 1/1967), anche alla luce di recenti vicende che hanno alterato la prassi secondo cui il Consiglio di Presidenza indicava un solo nominativo che di fatto veniva ratificato dal Governo, sembra necessario ritenere che il suddetto parere del Consiglio di Presidenza sia pubblico, contenga criteri sufficientemente precisi per la nomina del Presidente e – soprattutto – debba essere considerato vincolante per il Presidente del Consiglio.
Quanto al profilo funzionale, penso ad alcune persistenti ipotesi di sottrazione dal sindacato giurisdizionale di alcuni atti o vizi, con potenziale violazione, all’interno, dell’art. 113 Cost., nonché dell’art. 13 Cedu.
Prima di tutto viene alla mente l’art. 21 octies, co. 2, l. n. 241/90, secondo il quale non sono annullabili gli atti adottati in violazione di norme sulla forma e sulla procedura allorché, per il contenuto vincolato dell’atto, sia palese che il contenuto di quest’ultimo non sarebbe comunque stato diverso da quello in concreto adottato. Nel caso poi di omessa comunicazione di inizio del procedimento, tale possibilità sussiste addirittura anche in caso di atti discrezionali, purché sia dimostrata in giudizio la suddetta irrilevanza sul piano sostanziale. Rispetto a tale disposizione sono state avanzate diverse tesi per risolvere il potenziale conflitto con i parametri interni e Cedu su indicati. Ora, se in effetti ha prevalso la tesi processualista (mancanza di interessa a ricorrere nel caso concreto e ininfluenza della norma sul declassamento del vizio a mera irregolarità), da un lato ciò non esclude che certe interpretazioni giurisprudenziali (es. in tema di onere della prova in capo al ricorrente in caso di omessa comunicazione o estensione della non annullabilità ai casi non espressamente previsti, es. art. 10–bis l. n. 241/90, cd. preavviso di rigetto) non forzino eccessivamente il sistema, dall’altro resta l’art. 6 Cedu e la potenziale compressione del principio del giusto procedimento apportata dall’art. 21octies, comma 2. Connessa criticità riguarda la motivazione. Qui il parametro interposto costituzionale è molto rafforzato (v. Corte cost. ord. n. 92/2015, secondo cui la motivazione è il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo potere amministrativo), per cui non può escludersi che una q.l.c. derivante da una pronuncia Corte Edu sul punto verrà accolto ove venga a consolidarsi l’idea di “dequotare” la motivazione, peraltro in contrasto con la giurisprudenza europea che la considera “forma sostanziale”.
In secondo luogo penso all’annoso problema dell’atto politico. Il vigente art. 7 codice del processo amministrativo tuttora sottrae tale tipologia di atti dal sindacato del giudice amministrativo. Come noto, Già il previgente art. 31 t.u. Cons. Stato era stato ricondotto a Costituzione attraverso un’esegesi volta a configurare l’atto politico come distinto da quello amministrativo o ad escludere la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della tutela giurisdizionale (legittimazione e/o interesse a ricorrere). Oggi tendenzialmente, anche dopo che la Consulta ha assunto su tale categoria un’impostazione molto rigorista (Corte cost., n. 81/2012), vengono qualificato come politici solo gli atti “costituzionali” e “internazionali” (es. caso Dal Molin, caso F35).
Da ultimo si è manifestato nella questione dell’Unione degli Atei Agnostici Razionalisti, che può avere riflessi sul piano dei rapporti con la Corte di Strasburgo. In prima battuta il Tar Lazio ha detto che il diniego di avviare il procedimento volto all’intesa, ex art. 8, comma 3, Cost., è atto politico, ma tale decisione è stata ribaltata dal Consiglio di Stato e dalla Cassazione, che hanno riconosciuto la possibilità di controllo giurisdizionale sull’atto, considerato estrinsecazione di discrezionalità tecnica. Tuttavia la Corte costituzionale, con sentenza n. 52/2016 ha dato ragione al Governo ritenendo che non spettava alla Corte di Cassazione affermare la sindacabilità in sede giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei ministri ha negato all’UU.AA.RR. l’apertura delle trattative per la stipulazione dell’intesa. Non mi soffermo qui sulla condivisibilità di tale impostazione, che comunque non deve troppo sorprendere, quanto meno per chi conosce le origini dell’istituto e la cd. teoria scettica o storicista che ne predica la relatività a seconda dei rapporti volta a volta dati tra poteri dello Stato. Il punto è che la questione si prospetta dinanzi alla Corte di Strasburgo, in quanto la nostra giurisprudenza interna sembra porsi in contrasto col concetto convenzionale di libertà religiosa. Potrebbe infatti porsi un problema di rapporti fra giudicato costituzionale “interno”, tutelato ex art. 137 Cost. ed eventuale sentenza della Corte Edu che accogliesse un ricorso dell’UU.AA.RR. per contrasto tra giudicato nazionale e artt. 6, 9 e 14 Cedu, oltre che della giurisprudenza convenzionale in materia (Cfr. Corte EDU 31 luglio 1998, Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et alii c. Austria, par. 92, là dove il giudice di Strasburgo sottolinea che a tutti i gruppi religiosi deve esser data l’opportunità di far domanda per avere il medesimo riconoscimento nello Stato in cui operano). Ci si chiede, in un caso del genere, se la Corte costituzionale possa eventualmente reagire dichiarando l’incostituzionalità della giurisprudenza della Corte EDU, attivando i controlimiti.
Infine, non si può qui riprendere, per ragioni di spazio, il problematico tema del sindacato sulla cd. discrezionalità tecnica. La materia in cui la giurisprudenza di Strasburgo ha maggiormente inciso – come probabilmente ricorderà uno dei massimi esperti della materia qui interpellato (Francesco Goisis) – è quella delle sanzioni, in particolare delle Autorità Indipendenti, qualificate come sostanzialmente penali e ammesse a un sindacato di full jurisdiction.
Punto massimo di emersione interna dell’influenza di tale giurisprudenza è, in Italia, la recente sentenza “Simeoli” sul caso Avastin e Lucentis (Sez. VI, n. 4990/2019), che dà una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 7 d.lgs. n. 3/2017 sul cd. private enforcement che sembra limitare il sindacato in caso di opinabilità della valutazione complessa. Secondo i giudici di Palazzo Spada nel caso in discussione gli elementi descrittivi del divieto di intesa anti–competitiva, anche quelli valutativi e complessi, sono presi in considerazione dalla norma attributiva del potere, nella dimensione oggettiva di «fatto storico» accertabile in via diretta dal giudice, e non di fatto “mediato” dall'apprezzamento dell'Autorità. Per questi motivi, il giudice non deve limitarsi a verificare se l’opzione prescelta da quest'ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date a quel problema alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto, bensì deve procedere ad una compiuta e diretta disamina della fattispecie. Al sindacato (non sostitutivo) di “attendibilità” va dunque sostituito un sindacato pieno di “maggiore attendibilità”.
Restano forse alcuni limiti sui casi di diritti civili. Mi riferisco, più che alle vicende relative ai riconoscimenti di malattia per cause di servizio, sui quali si registrano evoluzioni grazie pure al caso Placì del 2014, alla delicata materia di vincoli storico–artistici, dove il self restaint del giudice amministrativo nazionale perlopiù permane, forse più che per lo stretto intreccio fra valutazione opinabile e valutazione discrezionale per il particolare rilievo dell’interesse pubblico alla tutela e valorizzazione del bene culturale discendente dall’art. 9 Cost.
2) Sono a suo avviso ipotizzabili dei dubbi di conformità a CEDU del sistema recentemente ridisegnato in tema di riparto di giurisdizione dalla sentenza della Corte costituzionale n.6/2018?
Roberto Caranta
Per rispondere compiutamente al quesito, occorre sempre partire dal dato fondamentale che il nostro ordinamento non prevede un rimedio o un meccanismo processuale specifico per intervenire direttamente sulle pronunce giurisdizionali che si pongono in contrasto con il diritto CEDU. Se la sentenza del giudice nazionale in contrasto con il diritto convenzionale viene successivamente portata al vaglio della Corte di Strasburgo e questa riconosce tale incompatibilità, il giudicato interno formatosi resta comunque tendenzialmente fermo (salvi gli interventi in materia penale, su cui infra; si rinvia sul punto anche a quanto evidenziato nel primo quesito).
Il sopravvenuto accertamento della contrarietà al diritto CEDU non rientra tra le ipotesi tassativamente previste di revocazione della sentenza passata in giudicato e non giustifica una riapertura del processo civile e amministrativo[29]. Tale principio è stato da ultimo ribadito, su rimessione operata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 123/2017, con riferimento al termine di decadenza del 15 settembre 2000 sancito dall’art. 69, co.7 d. lgs. 165/2001. In particolare, si dubitava della compatibilità costituzionale, per interposizione dell’art. 117 Cost, di tale normativa, a fronte delle pronunce della Corte EDU nei casi Mottola e Staibano. La Consulta ha escluso l’ampliamento dei casi di revocazione civile e amministrativa, evidenziando le differenze con il proprio precedente che aveva giustificato una riapertura del processo in materia penalistica (Corte Cost. n. 113 del 7 aprile 2011[30]). Tale impostazione è stata quindi fatta propria dal Consiglio di Stato nell’Adunanza plenaria n. 12/2017.
Chiarito il contesto, occorre ora ripercorrere brevemente le tappe che hanno portato alla pronuncia della Corte cost. n. 6/2018. La questione verteva ancora una volta – e non a caso forse – sull’asserita incompatibilità costituzionale (per effetto del parametro interposto dell’art. 6 CEDU) della decadenza prevista dall’art. 69, co.7 d. lgs. 165/2001 per il contenzioso dei c.d. medici gettonati. La pronuncia del Consiglio di Stato che dichiara l’intervenuta decadenza viene impugnata, prima che si formi il giudicato, avanti la Cassazione per “motivi di giurisdizione” facendo leva sull’interpretazione sempre più “estensiva” e “dinamica” della nozione di “motivi inerenti la giurisdizione” di cui all’art. 111, co. 8 Cost. elaborata dalla Cassazione[31]. Tale approccio espansivo trae formalmente spunto proprio dai principi di effettività della tutela, unità funzionale della giurisdizione, e primazia del Diritto UE e dalla ritenuta possibilità di estendere tali principi anche al diritto convenzionale della CEDU[32]. La Corte di cassazione ha voluto investire della questione la Corte costituzionale, affinché si esprimesse una tantum sui limiti della nozione di “motivi inerenti alla giurisdizione”, specificamente in rapporto con la compatibilità al diritto CEDU, facendosì così indirettamente arbitro nel risolvere la querelle esistente tra Consiglio di Stato e Cassazione circa i limiti generali di tale sindacato[33].
Come noto, la Corte ha decisamente negato l’interpretazione evolutiva ritenendo che la natura “dinamica ed estensiva” del sindacato sulle sentenze del Consiglio di Stato sia contraria alla Costituzione ed ha ritenuto privo di fondamento o comunque estraneo ad una questione qualificabile come propriamente di giurisdizione, il richiamo a princìpi fondamentali quali la primazia del diritto comunitario, l’effettività della tutela, il giusto processo e l’unità funzionale della giurisdizione.
In particolare, e per quanto qui rileva, ha ritenuto che: “Quanto all’effettività della tutela e al giusto processo, non c’è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione.” Inoltre, “L’intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU, non essendo peraltro chiaro, nell’ordinanza di rimessione e nella stessa giurisprudenza ivi richiamata, se ciò valga sempre ovvero solo in presenza di una sentenza sopravvenuta della Corte di giustizia o della Corte di Strasburgo. In ogni caso, ancora una volta, viene ricondotto al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), motivo sulla cui estraneità all’istituto in esame non è il caso di tornare”.
In altre parole, la Corte non ha certo voluto limitare con il proprio intervento la possibilità di applicazione e tutela del diritto CEDU previste dall’ordinamento; tuttavia, ha ribadito l’impossibilità di stravolgimento del meccanismo di controllo giurisdizionale previsto ex art. 111, co. 8 Cost. al fine di introdurre surrettiziamente un’ipotesi di riapertura del processo per potenziali incompatibilità con il diritto CEDU. Riapertura (o rectius, in questo caso, riesame posto che non si è ancora formato il giudicato) che non è prevista dal legislatore nazionale e che, invero, non pare neppure imposta dal sistema CEDU. Invero, come chiarito dalla stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non esiste un’unitarietà di impostazione in seno agli Stati aderenti e non si può ritenere che il rimedio in forma specifica costituisca un’ipotesi prevalente o obbligatoria, tenuto conto anche della necessità di contemperamento con gli altri diversi interessi in gioco, quali la stabilità dei rapporti giuridici ed il rispetto del diritto di contraddittorio per le parti non intervenute nel giudizio di Strasburgo.
Peraltro, è bene precisare che la Corte costituzionale non si è mostrata contraria, in linea di principio, alla previsione di un meccanismo di riapertura e/o di revocazione; al contrario ha richiamato quanto già affermato proprio nel suo precedente n. 123/2017, ribadendo, tuttavia, la necessità di un intervento legislativo. La Consulta ha infatti dato pienamente conto che: “Rimane il fatto che, specialmente nell’ipotesi di sopravvenienza di una decisione contraria delle Corti sovranazionali, il problema indubbiamente esiste, ma deve trovare la sua soluzione all’interno di ciascuna giurisdizione, eventualmente anche con un nuovo caso di revocazione di cui all’art. 395 cod. proc. civ., come auspicato da questa Corte con riferimento alle sentenze della Corte EDU (sentenza n. 123 del 2017)”.
In conclusione, non è palmare che la sentenza della Corte cost. n. 6/2018 abbia determinato un nuovo assetto potenzialmente incompatibile con il diritto CEDU, avendo ribadito i limiti e la portata del controllo giurisdizionale per motivi di giurisdizione, così come sanciti in Costituzione all’art. 111, co. 8. La problematica circa le modalità di attuazione ed esecuzione delle pronunce della Corte EDU è, come visto, un tema più generale e preesistente a questa pronuncia e che richiederebbe verosimilmente o un intervento diretto del legislatore o un ripensamento generale dell’assetto istituzionale tra i vari livelli così come attualmente delineato dalla Corte costituzionale, soprattutto in seguito alla sentenza n. 123/2017.
Francesco Goisis
Imposterei anzitutto il problema partendo proprio dalla qualificazione CEDU in termini penali della sanzione amministrativa, quale riconosciuta dalla stessa Consulta a partire dal 2010.
In questo senso, la posizione espressa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 123/2017, con riferimento al termine di decadenza del 15 settembre 2000 sancito dall’art. 69, co.7 d. lgs. 165/2001 per cui un ampliamento dei casi di revocazione civile e amministrativa non sarebbe necessaria, in virtù delle differenze con il proprio precedente che aveva giustificato una riapertura del processo in materia penalistica (Corte Cost. n. 113 del 7 aprile 2011), non appare solida. Se le sanzioni amministrative sono materia penale ai sensi CEDU, anche per il relativo contenzioso dovrebbe valere un meccanismo che ne imponga una piena capacità di adattamento alle pronunce CEDU.
Questo dovrebbe comportare, a differenza di quanto ritenuto da Corte cost. n. 6/2018, una potestà della Corte regolatrice di intervenire sub specie di sindacato sui “motivi inerenti la giurisdizione” di cui all’art. 111, co. 8 Cost., per "violazione di norme dell’Unione o della CEDU"?
O piuttosto dovrebbe portare ad estendere, in via legislativa o di intervento additivo della Consulta, i casi di revocazione contro il giudicato?
Mi sembra che la soluzione più lineare sia la seconda.
La prima soluzione, invece, presupporrebbe, sul piano teorico, la (impegnativa) conclusione per cui ogni violazione di principi fondamentali del diritto europeo si risolva sempre in una questione di giurisdizione. Il che solleva almeno due questioni:
1. il fatto che una decisione sia sbagliata sul piano dell'applicazione del diritto europeo non ha particolari connessioni con l'esistenza o meno della competenza a giudicare. Cioè si rischia un'eccessiva assimilazione tra limiti interni e limiti esterni della giurisdizione, peraltro non imposta a livello di diritto UE (invece tendenzialmente attento a rispettare l'autonomia processuale degli stati membri);
2. i principi fondamentali del diritto europeo sono per di più moltissimi, quindi le questioni di giurisdizione sarebbero potenzialmente numerosissime e, quindi, si rischierebbe una significativa incertezza del diritto, in quanto presumibilmente la giurisprudenza finirebbe per operare delle distinzioni ulteriori, affidate a logiche casistiche, non sempre prevedibili.
Giuseppe Tropea
Bisogna a mio avviso partire dal caso che ha dato luogo alla sentenza n. 6/2018. È la vicenda dei medici a gettone.
Con sentenza n. 4/2007 l’Adunanza plenaria dichiarava l’inammissibilità del ricorso dei “medici a gettone” dell’Università Federico II di Napoli, sul rilievo che l’art. 45, comma 17, D.Lgs. n. 80/1998 ricollegava alla scadenza del termine del 15 settembre 2000, senza che si fosse adita la giurisdizione amministrativa, la perdita del diritto. La Corte Edu, adita da alcuni originari ricorrenti di fronte al Tar, ha per contro ritenuto la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione e dell’art. 1 del primo protocollo addizionale.
Sicché per condivisibili ragioni di giustizia sostanziale si è cercato di dare attuazione a un giudicato della Corte Cedu contrastante con un giudicato interno. Le strade proposte sono state diverse: quelle dell’ottemperanza, un po’ come l’esecuzione penale nel caso Contrada. Quella della revocazione della sentenza. Quella della sua ricorribilità in Cassazione.
Con ordinanza n. 2/2015 l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale degli artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c., «nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo». La dottrina si è quindi divisa fra chi ha preconizzato un intervento della Consulta in linea col precedente del 2011 per il processo penale (caso Dorigo) e chi, invece, ha ritenuto che nel difficile rapporto tra giustizia sostanziale e preservazione dell’efficacia e del valore della cosa giudicata, che trova nella revocazione un punto di equilibrio, spostare l’asse verso il primo dei valori renderebbe più difficile la ricerca di un nuovo equilibrio. Si pone anche il problema rappresentato dalla diversità dei valori in gioco, poiché un conto è il giudicato penale di condanna, che tocca direttamente la libertà personale dell’individuo, altro è il giudicato civile e amministrativo, dove i beni in gioco sono differenti e tendenzialmente “meno” inviolabili. Infine la questione della tutela del contraddittorio: non di rado nel giudizio civile e in quello amministrativo la lite è tra due o più soggetti privati che si contendono il medesimo bene della vita, e nei cui confronti il giudicato costituisce l’accertamento in ordine alla spettanza del diritto in funzione di certezza, a fronte di un giudizio dinanzi alla Corte di Strasburgo che non garantisce la partecipazione di tutti i soggetti che siano stati parti nel processo definito dalla sentenza del giudice nazionale. Questi ultimi due aspetti sono valorizzati da Corte cost. n. 123/2017, la quale ritiene che l’obbligo di conformazione alle sentenze della Corte Edu ha un contenuto variabile e afferma che è rimessa agli Stati medesimi la scelta di come meglio conformarsi alle pronunce della Corte, «senza indebitamente stravolgere i principi della res iudicata o la certezza del diritto nel contenzioso civile, in particolare quando tale contenzioso riguarda terzi con i propri legittimi interessi da tutelare».
Secondo la Corte costituzionale è in via prioritaria il legislatore nazionale che può effettuare questa delicata opera di bilanciamento fra il diritto di azione degli interessati e il diritto di difesa dei terzi, come di recente è stato fatto in Paesi quali la Germania, la Spagna e la Francia. In tal senso la sentenza Corte cost. n. 123/2017 sembra segnare un punto d’arresto rispetto a un indirizzo diretto a collocare il coordinamento fra ordinamento nazionale e ordinamenti europei su un piano tipicamente processuale, a costo di introdurre una profonda revisione dei principi sulla giurisdizione, quando ciò sia ritenuto utile per attuare le pronunce della Corte di Giustizia e della Corte Edu.
Anche per esigenze metodologiche legate a un più equilibrato rapporto fra corti nazionali e sovranazionali ritengo che questa sia la via più ortodossa per risolvere questo problema, anche se la sentenza del 2017 in effetti si espone a qualche critica. Ad esempio, si può discutere sulla tenuta di una distinzione così tranchant tra il grado di afflittività del giudicato penale rispetto al giudicato civile o amministrativo, basti pensare all’arcinota nozione sostanziale di sanzione penale che ci viene proprio dalla giurisprudenza della C. edu. Peraltro il diritto all’equo processo di cui all’art. 6 Cedu non dovrebbe avere una forza diversa a seconda della situazione soggettiva che va a proteggere: questa funzionalizzazione dell’equo processo sarebbe molto opinabile, in quanto l’equo processo costituisce prima di tutto un diritto fondamentale in sé e solo dopo un diritto strumentale. Anche l’ostacolo del contraddittorio potrebbe essere ripensato, non tanto perché lo Stato (presente a Strasburgo) comprende, nei suoi rapporti internazionali, tutte le amministrazioni, quanto perché in questo caso si trascura che anche nel giudizio penale potrebbero esserci altre parti oltre lo Stato e l’imputato che potenzialmente danneggiate da una decisione della C. Edu alla quale non hanno partecipato, senza considerare che non è così scontata l’affermazione secondo cui l’“invito” del Presidente della Corte europea dei Diritti è rimesso alla sua valutazione discrezionale.
Peraltro, al di là dell’incerto intervento del nostro legislatore, contribuirebbe (se non a risolvere quanto meno) a mitigare il problema del rapporto fra giudicati la ratifica del Protocollo 16, adottato dal Comitato dei Ministri il 10 luglio 2013 e aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa il 2 agosto 2013 – che come è noto ha introdotto per la Corte di Strasburgo un meccanismo analogo al cd. rinvio pregiudiziale previsto nel sistema della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, consentendo alle Corti Supreme di uno Stato che sia parte della Convenzione Europea di sospendere il procedimento interno e chiedere alla Grande Camera dei pareri consultivi (advisory opinions) in merito a questioni di principio sull’interpretazione o sull’applicazione di una norma convenzionale e sui protocolli addizionali.
Ritengo invece ineccepibile la sentenza n. 6/2018. La Consulta, nella medesima vicenda che ha portato alla sentenza n. 123/2017, ha avuto modo di porre un freno al recente orientamento delle Sezioni unite che, nel prospettare una evoluzione della nozione di “motivi inerenti alla giurisdizione” ai fini dell’impugnazione in Cassazione delle pronunce dei giudici amministrativi, hanno sostenuto che a tali motivi sono riconducibili quei «casi estremi in cui il giudice adotta una decisione anomala o abnorme, omettendo l’esercizio del potere giurisdizionale per errores in iudicando o in procedendo che danno luogo al superamento del limite esterno», comprese le gravi divergenze dalla interpretazione del diritto comunitario accolta dalla Corte di giustizia.
Al netto della condivisibilità o meno del vigente sistema dualistico sancito dall’art. 103 Cost., e pur riconoscendo che vi sono talune questioni che meriterebbero un trattamento uniforme affidato alla giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni unite, su tutte la responsabilità della pubblica amministrazione, la strada intrapresa dalla Cassazione, non a caso a far data dal 2008 con la questione della c.d. pregiudiziale amministrativa, e poi proseguita ed estesa ai casi di abuso del processo o di rapporti tra ricorso principale e incidentale, qui chiamando in causa la nozione parimenti aleatoria di “violazione manifesta del diritto comunitario”, appare frontalmente in contrasto col dato costituzionale. In questo senso non si possono che condividere i recenti moniti espressi da Corte cost., n. 6/2018, ferma restando l’opportunità della previsione di un Tribunale dei conflitti allargato, sul modello francese, alla presenza di componenti di altre giurisdizioni, amministrativa e contabile su tutte.
Come si vede, si torna alla problematica del giusto processo in senso “strutturale” di cui si è parlato sopra. In tal senso ritengo inopportuna un totale riassorbimento del giudice amministrativo nel giudice ordinario. Gli argomenti di Calamandrei in Assemblea Costituente devono oggi fare i conti con l’effettività e rapidità della tutela erogata da questo giudice, ineguagliata dalla magistratura ordinario. Certo ciò non impedisce di prospettare interpretazioni o riforme che possano però assicurare una sua più rigorosa separazione rispetto all’Esecutivo di turno e un diverso assetto dell’organo competente alla decisione delle questioni di giurisdizione, arginando così tendenze della Cassazione che, pur comprensibili nel loro obiettivo, non convincono per le modalità con cui sono state perseguite.
Per queste ragioni non vedo particolari profili di contrasto tra la sentenza n. 6/2018 e la Cedu.
Anzi, la Corte costituzionale potrebbe intervenire proprio per rimuovere alcuni sacche di immunità dal potere tuttora derivanti dalla giurisprudenza della Cassazione, queste sì in contrasto con i principi convenzionali del giusto processo e dell’accesso alla tutela piena ed effettiva.
Non si può escludere in questo senso un intervento della Consulta, in sede di conflitto di attribuzioni, a tutela della pienezza del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità o nell’ammissione dell’ampiezza degli interessi tutelabili. Si è sempre ritenuto esistente un potere cassatorio sull’eccesso di potere giurisdizionale dei giudici speciali per invasione del merito amministrativo. Sennonché Santi Romano, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Stato, riuscì ad imporre un sostanziale self–restaint del giudice della giurisdizione, per ragioni di effettività della tutela, volendo con ciò prevenire interventi della Cassazione che sanzionassero come pretesi sconfinamenti nel merito quelli che in realtà erano controlli sulla discrezionalità amministrativa. In tali casi si potrebbe sostenere che l’errata qualificazione della Cassazione, scambiando una discrezionalità sindacabile col merito amministrativo, finisca per determinare un’ingerenza nella giurisdizione del giudice speciale, andando quindi oltre i motivi di giurisdizione. Si pensi a una vicenda di qualche anno fa, in tema di sindacato sulla discrezionalità tecnica, con la quale si è cassata, si badi “con rinvio”, una sentenza del Consiglio di Stato che avrebbe sostituito, anche alla luce di una c.t.u., il proprio apprezzamento a quello riservato dalla legge all’amministrazione sul requisito della “fiducia” ai fini di un rifiuto di aggiudicazione di un appalto pubblico. Stessa considerazione potrebbe farsi per un altro principio che caratterizza il sistema giuspubblicistico, e cioè l’ampiezza degli interessi tutelabili, rispetto al catalogo ristretto del sistema civilistico: anche per questa ipotesi il rischio è, come si verificò negli anni ’70 del secolo scorso (si pensi al caso Italia Nostra), che l’invasività della Cassazione porti a una restrizione dell’accesso alla giustizia, e anche in questo caso sarebbe probabilmente prefigurabile, come rimedio a chiusura del sistema, il conflitto di attribuzione dinanzi al giudice delle leggi.
3) L’attuale assetto normativo previsto in materia di provvedimenti ablatori, dopo gli interventi della Corte costituzionale (sentt.n.348 e 349 del 2007, 71/2015) e del legislatore ordinario – art.42 bis T.U. espr. – presenta, a suo avviso, dei profili di inconvenzionalità rispetto ai parametri degli artt.6 CEDU e 1 Prot.n.1 annesso alla Cedu?
Roberto Caranta
L’attuale disciplina in materia di provvedimenti ablatori, regolata dall’art. 42 bis T.U. Espropriazioni è stata modellata da una serie di fondamentali pronunce delle giurisdizioni superiori nazionali[34], avendo come obiettivo di riferimento il sistema di tutele convenzionali delineato dalla Corte EDU[35].
Tali interventi giurisprudenziali se, da un lato, hanno indubbiamente cercato di ricondurre tale controversa materia nell’alveo delle garanzie costituzionali e convenzionali, dall’altro, hanno mantenuto talune criticità che si proverà qui brevemente a esporre.
Un primo e fondamentale profilo critico è rappresentato dal fatto che l’art. 42 bis lascia un margine di discrezionalità alla p.a. autrice dell’illecito permanente non solo circa la scelta se adottare o meno il provvedimento di acquisizione, ma anche sul momento per farlo; in particolare, non sussiste un termine perentorio entro il quale la p.a. deve decidere se emettere tale provvedimento. Questa circostanza incide indirettamente sulla possibilità per il privato sia di ottenere il risarcimento del danno che sulla possibilità di restituzione del bene, previa riduzione in pristino.
La giurisprudenza è intervenuta al riguardo su più fronti, determinando, a parere di chi scrive, solo in parte dei miglioramenti rispetto alla posizione del privato e, indirettamente, rispetto alla compatibilità con il diritto convenzionale.
Al di là dell’obbligo di motivazione rinforzata circa l’acquisizione sanante e la possibilità di ricorrervi solo in extrema ratio, qualora non vi siano valide alternative (così Corte cost. n. 71/2015), è stato affermato il principio secondo cui è esclusa l’adottabilità del provvedimento acquisitivo a fronte di un giudicato restitutorio che condanni espressamente la p.a. alla restituzione del bene. Questo costituisce il limite temporale ultimo entro cui la p.a. può esprimersi e si pone, indubbiamente, nell’ottica di valorizzare il principio di effettività della tutela.
Più discutibile appare invece la posizione assunta dalla Adunanza plenaria n. 2/2016 che, a fronte di un giudicato puramente cassatorio, i.e. che dispone solamente l’annullamento degli atti espropriativi o comunque sancisce l’illegittimità del provvedimento espropriativo, ammette la possibilità per la p.a. di adottare successivamente il provvedimento acquisitivo ex art. 42–bis. In altre parole, è stato negato che l’effetto naturale e diretto della pronuncia cassatoria sia la restituzione del bene, previa riduzione in pristino, con conseguente allungamento del periodo in cui la p.a. può esercitare la propria scelta discrezionale e soprattutto – sic – la propria inerzia.
Proprio per combattere l’inerzia della p.a. la giurisprudenza è intervenuta (Cass. 71/2015 e A.P. 2/2016) riconoscendo la possibilità sia di proporre azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., sia di promuovere un giudizio di ottemperanza ex art.114 c.p.a. e nominare un commissario ad acta che adotti il provvedimento di acquisizione sanante. In disparte la complessa questione circa la possibilità in generale per il giudice di ordinare alla p.a. di acquisire il bene e per il commissario di adottare tale provvedimento[36], ci si vuole qui soffermare sul fatto che tale impostazione comporta un ulteriore onere per il privato di attivare nuovi strumenti processuali (a fronte, sostanzialmente, della perdurante inerzia della p.a.) ed un inevitabile allungamento del processo complessivamente necessario per ottenere una tutela effettiva rispetto a quello che è e rimane un illecito permanente della p.a. Tutto ciò appare, invero, difficilmente compatibile con i principi convenzionali in materia di giusto processo e ragionevole durata dello stesso; appare altresì poco soddisfacente rispetto al bilanciamento tra il sacrificio imposto alla proprietà privata e la tutela degli interessi pubblici; bilanciamento che la Corte EDU ha individuato quale metodo fondamentale per valutare la sussistenza o meno di una violazione del diritto di proprietà ai sensi del Protocollo 1 alla CEDU.
Un ulteriore aspetto critico, sempre in relazione al principio di ragionevole durata del processo, è rappresentato dalla improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per equivalente o di restituzione se, nel corso del giudizio, sopravviene il provvedimento ex art. 42 bis. In altre parole, la giurisprudenza ha nel tempo consolidato il principio secondo cui tutte le aspettative di tutela del privato, risarcitorie e restitutorie, si debbono canalizzare nell’eventuale contenzioso avente ad oggetto il provvedimento di acquisizione intervenuto nel corso del processo, il quale si chiude conseguentemente con una pronuncia di declaratoria di improcedibilità (da ultimo ex multis Cons. St. Sez. IV, n. 3148/2018; id. n. 2765/2018). Ciò, in pratica, può significare che, a distanza di anni, dopo che il privato ha ottenuto la declaratoria di illegittimità dell’espropriazione e nelle more del giudizio per ottenere il conseguente risarcimento o restituzione del bene, la p.a., potrà con un atto pienamente discrezionale e, verrebbe da dire, potestativo, costringere il privato, laddove non sia soddisfatto dell’indennizzo/risarcimento proposto, ad intraprendere una nuova azione giudiziaria. Se tale impostazione si pone in ossequio a quel principio generale – ma così problematico – di inesauribilità del potere amministrativo (vedi anche nella seconda questione rispetto al potere di autotutela), essa pare, invero, poco rispettosa del principio fondamentale di matrice convenzionale di ragionevole durata del procedimento.
Infine, si vuole qui esprimere una breve considerazione “a caldo” sulla scelta adottata dalla recentissima Ad. plen. n. 2/2020 di negare l’applicabilità alla materia espropriativa dell’istituto pretorio della rinuncia abdicativa da parte del privato illegittimamente espropriato.
Le argomentazioni esposte dal supremo consesso amministrativo appaiono invero condivisibili dal punto di vista dell’impostazione teorica e della ricostruzione dogmatica dell’istituto.
Tale inammissibilità pare inoltre giustificata dai limiti, posti proprio Corte costituzionale nella sentenza n. 71/2015, alla possibilità per la p.a. di procedere all’acquisizione della proprietà ex art. 42 bis; limiti che verrebbero invero compromessi laddove il privato potesse imporre liberamente alla p.a. di acquisire il bene anche in assenza di tali presupposti.
Peraltro, come osservato nella stessa pronuncia della plenaria, l’applicabilità di tale istituto alla materia espropriativa era stata ammessa in via pretoria non tanto per la sua perfetta compatibilità teorica, quanto piuttosto per le sue conseguenze pratiche, indubbiamente favorevoli per il privato, soprattutto in un’ottica di concentrazione della tutela ai sensi dell’art. 111 Cost e di ragionevole durata del processo.
Conseguentemente, la scelta per l’inammissibilità adottata dalla Plenaria, se pare condivisibile sul piano teorico e della funzione pubblica, finisce, ancora una volta, per riaffermare l’assoluta disparità di trattamento riservata in tale materia alla p.a. (che può discrezionalmente e per un tempo sostanzialmente molto lungo decidere se acquisire o meno la proprietà del bene già illegittimamente occupato), rispetto a quella del privato (che, pur illegittimamente privato del bene, non può discrezionalmente decidere se rinunciare a tale proprietà, laddove la ritenga irrimediabilmente compromessa dall’attività illegittima della p.a.). Nella pratica, poi, tale disparità sembra spesso tradursi in un ingiustificato privilegio per un’amministrazione ab origine in una posizione di illegittimità ed illiceità e, in questo senso, finisce forse con l’imporre un sacrificio sproporzionato tra il diritto di proprietà e le esigenze pubblicistiche che a questo punto deve trovare rimedio in un intervento del legislatore.
Francesco Goisis
L’attuale disciplina in materia di c.d. "accessione invertita" di cui all’art. 42 bis T.U. Espropriazioni rappresenta certamente un tentativo di ritrovare una conciliazione con le tutele convenzionali delineate dalla Corte EDU[37], quale recepite dal giudice delle leggi[38].
In breve, rimane però il problema – non privo di una sua delicatezza – di un sistema che consente pur sempre alla PA di avvantaggiarsi di un proprio atto illegittimo, optando (seppur al giusto prezzo e sulla base di una previsione di legge) per l'acquisizione sanante, quale atto unilaterale pubblicistico, come tale capace di privare il privato del suo diritto di rifiutare la cessione del diritto reale.
Il che non è detto sia del tutto conforme all'insegnamento CEDU per cui" La Corte osserva poi che la situazione in causa ha consentito all’amministrazione di trarre vantaggio da una occupazione di terreno illegittima. In altre parole, l’amministrazione ha potuto appropriarsi del terreno in violazione delle norme che disciplinano l’espropriazione in debita forma"[39].
Inoltre, l'acquisizione sanante costituisce un atto non solo unilaterale, ma altresì discrezionale, come tale per definizione di incerta emanazione. Rispetto ad esso il proprietario si trova solo limitatamente garantito anche sotto il profilo delle tempistiche, specie in ragione della limitata tutela che l'ordinamento offre al cittadino in caso di inerzia amministrativa.
In sintesi, v'è ancora da capire se nella prospettiva CEDU sia accettabile che da un comportamento illegittimo ed illecito (l'occupazione senza titolo) possa legittimamente conseguire il sorgere di un potere unilaterale e discrezionale, che si impone (elidendola) sull'autonomia privata del proprietario.
Giuseppe Tropea
Dopo le sentenze “gemelle” del 2007 poco cambia, seppure esse restino fondamentali nel tracciare il rapporto fra ordinamenti (non solo) in materia, secondo lo schema della norma interposta, e abbiano avuto grande importanza nel ridefinire il quantum dell’indennizzo e i suoi rapporti col risarcimento in caso di apprensione del bene illecita.
Sicché, come è ben noto, il sistema dell’accessione invertita è stato stigmatizzato da varie sentenze della Corte edu (es. Belvedere Alberghiera, Carbonara Ventura) e l’art. 43 t.u. espropriazioni, introdotto nel 2001, è andato incontro a persistenti criticità.
Come noto, invece, l’art. 42–bis, introdotto nel 2011, è stato giudicato costituzionale dalla 71/2015, che ne ha anche riscontrato la conformità coi principi convenzionali di prevedibilità della norma, a causa di alcuni punti “fermi” (motivazione dell’interesse pubblico all’acquisizione, denuncia alla Corte dei Conti, spartiacque rappresentato dal giudicato restitutorio).
In verità, purtroppo, la giurisprudenza si è spesso trovata dinanzi a questioni che legittimano persistenti dubbi sulla conformità al sistema dell’acquisizione sanante.
Si pensi al tema delicato del giudicato restitutorio e ai poteri del commissario ad acta, rispetto al quale Ad. plen. n. 2/2016 non ha fornito risposte del tutto soddisfacenti.
Negli ultimi anni è spesso accaduto, come attesta la casistica giurisprudenziale, che l’amministrazione rimanesse inerte con riguardo all’adozione del provvedimento di acquisizione
sanante, anche in pendenza dell’azione del privato. Probabilmente tale situazione deriva anche dal fatto che, ai sensi dell’art. 42–bis d.P.R. n. 327/2001, comma 7, è oggi prevista la comunicazione alla Corte dei conti del provvedimento.
Tutto ciò ha determinato notevoli problemi con riguardo al rispetto della “barriera” del giudicato restitutorio, che Corte cost. n. 71/2015 considera invalicabile per rispettare effettivamente i parametri convenzionali degli artt. 6 Cedu e 1 Prot. 1 annesso alla Cedu. Da un lato si è “utilizzato” il processo azionato dal privato per imporre all’amministrazione di attivarsi per risolvere la vicenda, sull’implicito presupposto pratico che la restituzione resti puramente teorica. In tale contesto una certa giurisprudenza è arrivata addirittura a condannare l’amministrazione ad emanare il provvedimento di cui all’art. 42–bis. Secondo una variante più soft, maggiormente condivisibile, il giudice amministrativo, si è limitato ad adottare una condanna generica a provvedere ex art. 42–bis entro un certo termine, o in alternativa a restituire il bene.
Senonché sono rimasti aperti vari problemi interpretativi e, quindi, applicativi.
Emblematica una sentenza del Consiglio di Stato del 2015, la nr. 4403, la quale ha statuito che la temporanea carenza di fondi per procedere alla bonifica di un sito illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione può costituire per essa una valida motivazione a supporto di una acquisizione sanante, che evita la restituzione di un’area, previa sua bonifica, ordinata dal giudice, atteso che diversamente essa dovrebbe far ricorso ad un gravoso indebitamento mentre invece le consente di sostenere di avere agito dopo aver ponderato gli interessi in conflitto e di motivare specificatamente sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione.
Come detto la plenaria n. 2/2016 è intervenuta per chiarire la delicata questione del rispetto dei vincoli Cedu e costituzionali nel rapporto tra acquisizione sanante e giudicato restitutorio.
A mio avviso, però, alcuni questioni restano aperte. Due in particolare.
La prima riguarda gli effettivi confini del giudicato restitutorio. Secondo la plenaria la preclusione del giudicato restitutorio non sussiste in talune ipotesi. In particolare: i) quando il privato non ha interesse reale ed attuale alla tutela reipersecutoria, e non propone quindi una rituale domanda di condanna dell’amministrazione alla restituzione previa riduzione in pristino; ii) quando il proprietario ha interesse alla restituzione ma il giudice non si pronuncia sulla relativa domanda o si pronuncia “in modo insoddisfacente”; iii) quando il giudice amministrativo, ferma restando l’impossibilità di condannare direttamente in sede di cognizione l’amministrazione a emanare tout court il provvedimento in questione, imponga all’amministrazione, eventualmente anche nel rito sul silenzio, di decidere — ad esito libero, ma una volta e per sempre, e nel rispetto delle garanzie sostanziali e procedurali — se intraprendere la via dell’acquisizione ex art. 42–bis ovvero abbandonarla in favore di altre soluzioni (restituzione del fondo, accordo transattivo, etc.).
Mi pare che soprattutto il punto ii) dia luogo a situazioni di incertezza, che si riflettono in possibili frizioni col parametro convenzionale, specie nella parte in cui si fa riferimento a una pronuncia “insoddisfacente” del giudice sulla fattispecie.
Peraltro, ulteriore riprova del fatto che i confini del giudicato restitutorio restino mobili è data dal fatto che di recente la questione è ritornata alla plenaria, in relazione, ad esempio, al se il giudicato restitutorio escluda anche il potere della pubblica amministrazione di imporre una servitù di passaggio, ovvero se la preclusione del giudicato restitutorio sussista solo in relazione ai giudicati formatisi dopo la pubblicazione della sentenza Ad. plen. n. 2/2016, ovvero anche in relazione a quelli formatisi in precedenza (sez. IV, ord. n. 4950/2019). Altro problema processuale che attende una nuova risposta della Plenaria è se, ove sia invocata la sola tutela restitutoria e/o risarcitoria prevista dal codice civile e non sia richiamato l'art. 42 bis, il giudice amministrativo può qualificare l'azione come proposta avverso il silenzio dell'Autorità inerte in relazione all'esercizio dei poteri ex art. 42 bis; se, in tale ipotesi, il giudice amministrativo può conseguentemente fornire tutela all'interesse legittimo del ricorrente applicando la disciplina di cui all'art. 42 bis e, eventualmente, nominando un Commissario ad acta già in sede di cognizione (sez. IV, ord. n. 5391/2019). In tali casi il Collegio mostra di propendere per una soluzione conforme al principio di effettività della tutela e ai principi sulla conversione della domanda processuale, ammettendo che il g.a. possa desumere — senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato — dalla domanda restitutoria o risarcitoria la domanda volta alla tutela del coesistente interesse legittimo, in presenza della perdurante inerzia dell'Autorità a fronte del dovere di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto, qualificando l'azione come proposta avverso il silenzio e pronunciandosi ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
L’altro problema è rappresentato dalla fattispecie della cd. “usucapione acquisitiva”. Che quella dell’usucapione potesse rappresentare la “valvola di sicurezza” o “di chiusura” del sistema è affermazione ricorrente in giurisprudenza, ed è intesa ad “assicurare il principio di certezza giuridica in situazioni di possesso a favore della pubblica amministrazione di un bene privato, ormai trasformato ed utilizzato da lunghissimo tempo per scopi di pubblica utilità”. I rilievi della dottrina si sono appuntati su vari profili: intanto il dubbio di fondo su tale forma di espropriazione indiretta, in rapporto al principio di legalità dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, così come delle garanzie richieste in materia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; poi, la possibilità di applicare la disciplina di cui all’art. 1158 c.c. in una vicenda in cui più che di possesso si dovrebbe parlare di detenzione del bene da parte dell’amministrazione; inoltre, il problema fondamentale — a voler ammettere la cittadinanza della figura nel sistema — del dies a quo, che a rigore (ai sensi dell’art. 2935 c.c.) dovrebbe decorrere dalla “possibilità di far valere il diritto”, ergo dall’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dell’acquisizione sanante (col d.P.R. n. 327/ 2001); last but not least, le conseguenze gravemente lesive dell’applicazione di tale istituto per il proprietario, il quale non solo non avrà a disposizione la tutela restitutoria, ma neanche quella per equivalente (tornandosi, per questa via, alla situazione anteriore al 1983).
La Plenaria del 2016 opportunamente interviene anche su tale aspetto. Non è un caso che ammetta l’usucapione solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull'Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu; dunque a condizione che: i) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta; ii) si possa individuare il momento esatto della interversio possesionis; iii) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Sono sufficienti tali presupposti, a fronte di un istituto di creazione (ancora) pretoria che pare non garantire integralmente la qualità del quadro normativo e in mancanza di garanzie procedimentali e di motivazione sull’esistenza di interesse pubblico?
In questo senso, la tematica dell’acquisizione sanante si pone sempre più come questione di diritto processuale, ma al contempo continua a non rimanere avulsa da scenari più generali, posto che oggi il rispetto dei principi sanciti prima dalla Corte Edu, poi dalla Consulta, a garanzia del proprietario rispetto ad una espropriazione indiretta, passano soprattutto, a seconda dei casi, per la rigorosa applicazione e/o per l’affinamento di svariati istituti di matrice processuale, oltre che per il contenimento dell’uso in chiave “speciale” (ergo: funzionalizzata alla cura dell’interesse pubblico) di istituti civilistici (se prima era l’accessione oggi è l’usucapione). Inoltre, sotto il profilo del diritto sostanziale, e sempre a conferma delle persistenti incertezze sull’ampiezza applicativa dell’istituto, che si riflettono pure sulla integrale conformità convenzionale dello stesso, si pensi a un’ulteriore serie di ordinanze di rimessione alla Plenaria, che rilevano quanto segue: «In linea di principio, qualora si dovesse ritenere rilevante nell'attuale ordinamento, la ‘rinuncia abdicativa' si dovrebbe estrinsecare in una esplicita dichiarazione, basata sulla consapevolezza di essere titolare del bene e sulla mera volontà di dismettere il diritto e di perdere la qualità di proprietario (e non sulla richiesta di una somma di denaro, a titolo risarcitorio, posta in rapporto di sostanziale sinallagmaticità con il trasferimento del diritto dominicale). Diversamente, infatti, si introdurrebbe nel sistema la possibilità che, con un atto unilaterale, sia pure sotto forma di azione giudiziale, la parte perverrebbe alla produzione di effetti patrimonialmente rilevanti non solo nella propria sfera giuridica, ma anche nella sfera giuridica dell'Amministrazione, soggetto che, invece, non ha manifestato alcuna volontà volta all'acquisizione del diritto. Di talché, non sembra che una tale dichiarazione, produttiva dei conseguenti effetti, si possa desumere dalla proposizione di una domanda risarcitoria» (sez. IV, ordd. nn. 5391, 5399, 5400 del 2019).
È di estremo interesse sottolineare come la questione sia stata recentemente risolta da Ad. plen. n. 2/2020. Essa ha ritenuto di escludere la configurabilità nel nostro ordinamento della rinuncia abdicativa quale atto implicito ed implicato nella proposizione, da parte di un privato illegittimamente espropriato, della domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dall’illecito permanente costituito dall’occupazione di un suolo da parte della p.a., a fronte dell’irreversibile trasformazione del fondo.
Le ragioni a sostegno di tale autorevole opinione sono molto significative. Si è infatti ritenuto che la figura della rinuncia abdicativa: a) non spiega esaurientemente la vicenda traslativa in capo all’Autorità espropriante; b) la rinuncia viene ricostruita quale atto implicito, secondo la nota dogmatica degli atti impliciti, senza averne le caratteristiche essenziali.
Ma soprattutto, anche ai nostri fini, si è osservato, in senso decisivo e assorbente, che essa non è provvista di base legale in un ambito, quello dell’espropriazione, dove il rispetto del principio di legalità è richiamato con forza sia a livello costituzionale (art. 42 Cost.), sia a livello di diritto europeo. Si è ricordato, infatti, sotto questo profilo, che occorre evitare, in materia di espropriazione cd. indiretta, di ricorrere a istituti che in qualche modo si pongano sulla falsariga della cd. occupazione acquisitiva, cui la giurisprudenza fece ricorso negli anni Ottanta del secolo scorso per risolvere le situazioni connesse a una espropriazione illegittima di un terreno che avesse tuttavia subìto una irreversibile trasformazione in forza della costruzione di un’opera pubblica.
L’auspicio, in conclusione, è che una certa giurisprudenza del giudice amministrativo, non porti a nuovi interventi della Corte Edu, dopo la lunga e tormentata stagione dell’illegalità avviata dalla Cassazione nel 1983, la cui conclusione una “realista” Corte costituzionale nel 2015 prova a certificare, salvando l’art. 42–bis, ma certo non può definitivamente sancire.
Si consideri, infatti, che la Corte di Strasburgo nelle sue decisioni opera con approccio casistico, poco legato alle costruzioni giuridiche dei singoli ordinamenti nazionali e orientato soprattutto ad accertare la lesione del ricorrente, valutata in concreto caso per caso. Sicché l’effettiva tenuta dell’art. 42–bis va misurata soprattutto nella quotidiana pratica delle amministrazioni, oltre che nel sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, affinché vengano comunque, ed effettivamente, rispettati gli stringenti oneri cui la suddetta disposizione grava le amministrazioni.
Come si è visto, peraltro, vi sono importanti prese di posizione della giurisprudenza amministrativa, anche nella sua massima istanza nomofilattica, per circoscrivere l’operatività delle “valvole di sicurezza” di cui si è detto, dalla c.d. usucapione sanante alla possibilità di adottare il provvedimento ex art. 42–bis anche nel giudizio d’ottemperanza.
Il fatto che se ne attendano altre, tuttavia, al netto dei persistenti dubbi sulla conformità alla convenzione di istituti “sdoganati” dalla Plenaria del 2016 come l’usucapione sanante, è indice che il sistema non si sia ancora definitivamente assestato, dopo tutti questi decenni, ma è anche conferma della pertinenza e profonda sensibilità giuridica che traspare dalle domande che mi sono state rivolte.
La recente sentenza dell’Adunanza plenaria n. 2/2020, in questo senso, appare più netta e perentoria rispetto al precedente del 2016, e fa ben sperare in una maggiore conformità della giurisprudenza nazionale ai moniti di Strasburgo.
4.Le repliche
del Prof.Francesco Goisis
a)alla risposta alla 1^ domanda
Concordo quanto alla dubbia condivisibilità del tentativo della Consulta di distinguere tra pronunce consolidate o, rispettivamente, "pilota" della Corte di Strasburgo, quando esse, pur nel loro procedere inevitabilmente casistico, sono tutte egualmente vincolanti ex art. 117, co. 1, Cost. Del resto, ancor più pericoloso può essere l'approccio di disconoscere l'effettivo tenore di un insegnamento CEDU, anche laddove certamente consolidato e, almeno nelle linee fondamentali, chiaro. Si pensi alla sentenza 196/2016, dove la Consulta ha negato che tutte le sanzioni disciplinate dalla legge 689 del 1981 ricadano nella materia penale CEDU (quando è francamente evidente e più volte confermato dalla Corte EDU che tutte le sanzioni amministrative pecuniarie siano pene ai sensi CEDU, se non altro in ragione della loro funzione afflittiva – da sola sufficiente anche laddove una sanzione sia poi di modesto ammontare –).
Quanto alla pronuncia Mazzeo c. Italia sull'autotutela, essa mi pare interessante soprattutto laddove chiarisce come l'autotutela amministrativa non possa essere vista come uno strumento di privilegio per la PA, ma debba recuperare una funzione di "giustizia" nel caso concreto, che, naturalmente, implica anche il totale rispetto dell'art. 6 CEDU (sul punto, M. Allena, L'annullamento d'ufficio. Dall'autotutela alla tutela, Napoli, 2018).
Infine, in relazione al tema della profondità di sindacato, vedo piena consonanza di idee circa la necessità di prendere sul serio gli obblighi CEDU, senza arroccarsi su formule tradizionali, o, peggio, senza fingere di non capire il significato del canone della full jurisdiction
b) alla prima domanda del Prof. Tropea
Il Collega ha messo bene in luce come le note questioni delle nomine governative dei magistrati e del Presidente del Consiglio di Stato, nonché della coesistenza tra funzioni consultive e giurisdizionali nello stesso Consiglio, non siano risolte ma, anzi, risultino ancor più attuali. Il che fa dubitare dell'effettiva consapevolezza del rilievo dell'art. 6 CEDU per la giustizia amministrativa.
Non posso che concordare poi sulla centralità del profilo della discrezionalità tecnica per l'effettiva realizzazione della full jurisdiction e sull'esistenza, sul punto, di affermazioni e concrete applicazioni giurisprudenziali in realtà molto diverse e contraddittorie (dalla tradizionale opzione per l'intrinseco della scelta tecnica complessa come merito amministrativo, alla più recente rivendicazione della necessità di un sindacato sostitutivo). Esse probabilmente riflettono una logica casistica ed equitativa. Essa è comprensibile, ma certo non pienamente soddisfacente, sia sotto il profilo della piena conformazione agli obblighi CEDU, sia sotto quello della certezza del diritto quanto ai poteri effettivamente esercitabili in sede giurisdizionale.
c) alle risposte alla 2^ domanda
Vedo piena sintonia con i Colleghi quanto all'opportunità di un intervento legislativo rispetto al problema del contrasto di una sentenza giurisdizionale amministrativa con pronunce CEDU, essendo invece difficile immaginare la via di un'estensione delle questioni di giurisdizione.
Apprezzo anche l'osservazione del prof. Tropea circa l'opportunità che la Corte regolatrice riveda certi suoi (anche recenti) orientamenti in tema di merito amministrativo, i quali ne dilatano troppo l'ampiezza. Ciò in pieno contrasto con l'insegnamento CEDU e con lo stesso ruolo tradizionale del GA come giudice del potere amministrativo, che non può rinunciare a confrontarsi efficacemente anche con il concreto uso della discrezionalità amministrativa.
d) alle risposte alla 3^ domanda
Non posso che condividere i dettagliati rilievi dei Colleghi quanto all'esistenza, ad oggi, di un quadro certamente più in linea con i principi CEDU rispetto al passato, ma con tutta probabilità non ancora del tutto conforme.
In fondo, mi pare che i colleghi colgano la stessa contraddizione da me ipotizzata: come giustificare che da un illecito della PA possano derivare delle situazioni di privilegio, per quanto legalmente configurate in termini di poteri amministrativi. Ciò fermo restando che, come ben ricorda il prof. Tropea, in sede CEDU interessa soprattutto la " quotidiana pratica delle amministrazioni"; più che le astratte costruzioni dogmatiche.
Repliche del Prof. Giuseppe Tropea.
Roberto Caranta effettua un giusto discorso sull’autotutela amministrativa cd. “doverosa”, concetto rispetto al quale però persistono in dottrina ancora perplessità, non superate con la riforma del 2015 dell’art. 21–nonies l. n. 241/1990, neanche con riferimento ai rapporti con il diritto dell’Unione europea, che presenta come ben noto un più intenso collegamento col diritto nazionale rispetto al diritto convenzionale. Quanto al tema della full jurisdiction, come ho notato la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato va invero verso un controllo intrinseco pieno, tentando di dare una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata del d.lgs. n. 3/2017 (v. Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990).
Condivido l’idea che dopo Corte cost. n. 123/2017 il problema dei rapporti fra sentenza Cedu e giudicato interno resti aperto, e che sarebbe opportuno un intervento sul punto del legislatore, sollecitato in tal senso proprio dalla Consulta. Peraltro mi pare che Corte cost. n. 6/2018 sia totalmente condivisibile, e non si prospetti un contrasto contrasto con gli artt. 6 e 13 Cedu, ma semplicemente una corretta lettura dell’art. 111 Cost., negli ultimi anni forzato dalla Cassazione.
Condivido l’idea che vi siano persistenti profili di criticità nell’art. 42–bis T.U. espropriazioni, che Ad. plen. n. 2/2020 contribuisce a ridurre, ma che non elide del tutto.
Francesco Goisis, nel rispondere in modo molto approfondito e convincente alla prima domanda, conferma il suo punto di vista già argomentato in tanti scritti precedenti: ormai il sindacato del giudice (non solo amministrativo) nei confronti delle sanzioni sostanzialmente penali deve essere di full jurisdiction e in tal senso l’art. 7 d.gs. n. 3/2017, che presenta molteplici profili di sospetta incostituzionalità, deve essere interpretato in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato.
Condivido anche quanto osservato sulla seconda domanda. Mi pare interessante la critica alla sent. n. 123/2017 sulla base dell’idea secondo la quale se le sanzioni amministrative sono materia penale ai sensi CEDU, anche per il relativo contenzioso dovrebbe valere un meccanismo che ne imponga una piena capacità di adattamento alle pronunce CEDU. Confesso che non avevo pensato a questa argomentazione, apparendomi la sent. n. 123/2017 tendenzialmente esente da critiche, più per ragioni di metodo che di merito. In ogni caso, le nostre posizioni si avvicinano perché anche a mio avviso la strada è quella indicata proprio dalla suddetta sentenza: l’intervento del legislatore. Sono d’accordo, infatti, che la via dell’allargamento dei “motivi inerenti la giurisdizione” non sia praticabile, come ha ben ritenuto Corte cost. n. 6/2018.
I problemi tuttora aperti in tema di acquisizione sanante senz’altro esistono, come ho tentato di dimostrare richiamando casistica tuttora aperta o definita in senso restrittivo all’impiego dello strumento (es. tema della rinuncia abdicativa, su cui si v. Ad. plen. n. 2/2020; il problema del giudicato restitutorio; il problema della cd. usucapione sanante).
D’altra parte, a conferma ulteriore di come restino aperti svariati problemi, può richiamarsi la recentissima Plenaria n. 5/2020, che adotta un approccio di flessibile rilevanza dell’art. 42-bis: da un lato ritenendo applicabile la disposizione nel caso di nullità o annullamento di un contratto di compravendita, posto che anche nei modelli privatistici la finalità di interesse pubblico resterebbe immanente al rapporto, dall’altro che il giudicato restitutorio non precluda l’emanazione di un atto di imposizione di servitù, poiché questo presuppone il mantenimento del diritto di proprietà in capo al suo titolare. Credo che questa tendenza esegetica, declinata in senso ampliativo e generalizzante, nel futuro potrà comportare ulteriori frizioni con la giurisprudenza della Corte edu.
5.Le conclusioni.
Roberto Giovanni Conti
L’approfondimento dedicato ai quesiti dei tre docenti è di tale spessore da indurre soltanto qualche breve riflessione su alcune delle questioni sottoposte ai tre docenti.
Quanto al tema del giusto processo amministrativo e, dunque, dell’applicabilità dell’art.6 CEDU in materia la giurisprudenza della Corte edu si è andata ormai stabilizzando da anni nel senso di ampliare lo spettro operativo dell’art.6 CEDU offrendo della dizione “obbligazioni civili” ivi contemplata un’interpretazione “autonoma” che dunque consente di sganciarla da quella in vigore all’interno dei singoli ordinamenti.
In questa prospettiva, come è noto, non ha alcun rilievo dirimente ai fini dell’esclusione dell’applicazione dell’art.6 CEDU la figura dell’interesse legittimo –cfr. Corte edu, 5 ottobre 2000, Mennitto c. Italia– mentre è ormai assodato che il giusto processo si applichi per i giudizi in cui è in discussione il pubblico impiego– cfr. Corte edu, 8 dicembre 1999, Pellegrin c. Finlandia,– applicandosi il criterio c.d. funzionale che riduce l’esclusione dell’art.6 CEDU per quei dipendenti che svolgono funzioni connesse alla precipua posizione ricoperta dalla P.A., risultando comunque applicabile, il parametro convenzionale anzidetto quando in gioco vi siamo questioni di natura patrimoniale.
Si applica, poi, pacificamente, l’art.6 CEDU alle ipotesi di contenziosi su licenze edilizie e commerciali e tariffe di servizi pubblici, tutte avvinte dal concorrente parametro convenzionale di cui all’art.1, Prot.n.1, annesso alla CEDU, che reca peraltro in sé una dimensione procedurale assai spiccata.
Le superiori considerazioni, unite alla portata contenutistica dell’art.2, commi 1 e 2 del codice del processo amministrativo, ove si fa espresso riferimento al principio del giusto processo di cui all’art.111, primo comma, Cost., come è noto figlio dell’art.6 CEDU nell’attuale formulazione, consentono di superare i residui dubbi e di riconoscere la applicabilità pressoché indifferenziata del canone del giusto processo al processo amministrativo.
In questo contesto si inserisce il tema della c.d. full jurisdiction affrontata dai tre docenti con specifica attenzione al tema delle sanzioni.
Può essere forse utile ricordare la posizione espressa di recente dalle Sezioni Unite civili sul tema, proprio nell’ambito di un procedimento definito in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato (sent. n.4266/2016) nel quale il giudice amministrativo aveva annullato il provvedimento dell’AGCM, con il quale era stato disposto il divieto di ulteriore diffusione di un messaggio pubblicitario contenuto in un depliant in quanto integrante un’ipotesi di pubblicità ingannevole compiuta in violazione degli artt.19, 20 e 21 del Codice del consumo e la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
In tale occasione, Cass., S.U., 7 maggio 2019, n.11929, occupandosi del ricorso proposto dall’AGCM con il quale era stato ipotizzato il vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ebbe a ricordare la propria giurisprudenza sui limiti esterni del sindacato del g.a. in tema di provvedimenti sanzionatori adottati dalle Autorità di concorrenza–Cass., S.U., n. 1013/2014–, pure menzionando Cass., S.U., n. 30974/2017, ove era stato ribadito che la non estensione al merito del sindacato giurisdizionale sugli atti dell'Autorità Garante implica che il giudice non possa sostituire con un proprio provvedimento quello adottato da detta Autorità, ma non che il sindacato sia limitato ai profili giuridico–formali dell'atto amministrativo, restandone esclusa ogni eventuale verifica dei presupposti di fatto, “ […] in quanto la pienezza della tutela giurisdizionale necessariamente comporta che anche le eventuali contestazioni in punto di fatto debbano esser risolte dal giudice, quando da tali contestazioni dipenda la legittimità del provvedimento amministrativo che ha inciso su posizioni di diritto soggettivo”. Ciò in linea con quanto affermato in precedenza da Cass. n. 770/2017 e Cass., n.25141/2015 sulla necessità di un processo giurisdizionale che garantisca un sindacato pieno in ambito di sanzioni adottate da Autorità indipendenti senza trasmodare in un controllo sostitutivo delle prerogative riservate a tali organismi, e successivamente con quanto affermato dal legislatore che, in sede di recepimento della direttiva 2014/104/EU, ha fra l’altro affermato che “Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione” (art.7 d.lgs.n.3/2017), in tal modo normativizzando parte dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella ricordata sentenza n. 1013/2014, a proposito della riserva comunque garantita all’Autorità in tema di valutazioni tecnico discrezionali.
Questo risultando lo stato dell’arte del diritto vivente delle S.U. anche per effetto della giurisprudenza della Corte edu pure ricordata nelle risposte, occorrerà verificare se il sindacato sui provvedimenti sanzionatori come ricostruito dal giudice amministrativo debba aprirsi a forme di ancora più incisivo controllo sul tema delle valutazioni tecniche.
Rimane il tema estremamente caldo dell’esecuzione delle sentenze della Corte edu che hanno accertato le violazioni a carico dello Stato prodotte da un giudicato amministrativo ovvero condannato al pagamento dell’equo soddisfacimento.
I tre accademici sono dell’idea che la risposta sul “che fare” non possa che arrivare dal legislatore, salvo a ponderare la possibilità dell’uso del potere di autotutela. Sul tema è qui sufficiente solo ricordare, al fine di arricchire la riflessione, un’opinione espressa in passato sul come riempire il vuoto legislativo – R. Conti, La giurisprudenza civile sull’esecuzione delle decisioni della Corte Edu, in Questione giustizia, speciale n.1/2019, La Corte di Strasburgo, nonché id., L’esecuzione delle sentenze della Corte edu nei processi non penali dopo Corte cost. n. 123 del 2017, in Consulta online, II, 2017, pp. 333–344–.
Un solo breve accenno alla tematica dell'atto politico, pure sfiorata in alcune delle risposte, per ricordare che anche la giurisprudenza della Cassazione aveva avuto occasione di riconoscere l’insindacabilità di atti politici in modo da negare ogni tutela a situazioni con essi contrastanti– Cass., S.U., 8 Gennaio 1993 n°124, in Giust. civ., 1993, I, 1525; Cass. 11 ottobre 1995 n.10617, anche se In tempi più recenti si è tuttavia assistito ad un ridimensionamento della categoria dell’atto politico. Cass., S.U., nn.11502/2019, 11588/2019 e n.18829/2019, ricordando le prese di posizione della Corte costituzionale– fra le altre, Corte Cost. n. 339 del 2007 e Corte Cost.n.52/2016 – non hanno mancato di osservare che “l’esistenza di aree sottratte al sindacato giurisdizionale va necessariamente confinata entro limiti rigorosi”, così offrendo una linea ermeneutica che mette al riparo da valutazioni in termini di inconvenzionalità del sistema.
Ciò, peraltro, non significa affatto escludere talune aree dal sindacato giurisdizionale. La ricordata Cass., S.U. n.11588/2019 ha infatti ritenuto di confermare la decisione del Consiglio di Stato (sent.n.3871/2017) che aveva escluso la giustiziabilità dell'interesse di un soggetto diverso dal titolare delle attribuzioni ad ottenere una decisione sulla richiesta di promovimento del conflitto di attribuzione da parte della Regione rispetto all’attività compiuta dall’autorità giudiziaria penale, attenendo tale conflitto – e l'opportunità o meno di promuoverlo – alla determinazione dei confini dei poteri sul quale è soltanto l'ente ad avere interesse o a godere di un potere di scelta che non può essere condizionato dall'istanza di un soggetto diverso, né può essere sottoposto a verifica giudiziale, a pena di mettere in discussione una valutazione che, come già detto, attiene alle prerogative costituzionali dell'ente. Ed è interessante che proprio le Sezioni Unite abbiano escluso che tale conclusione determini una violazione del parametro convenzionale(art.6 CEDU) e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, “non potendo ravvisarsi una lesione del diritto all'accesso ad un tribunale rispetto ad una posizione giuridica sfornita di tutela secondo l'ordinamento interno, al quale spetta il potere di determinare le aree di esercizio di potestà discrezionale sovrana – cfr. Corte edu, 10 maggio 2001, Grande Camera, Z. e a. c. Regno Unito, § 103”–cfr. par. 5.8 sent. ult.cit. –.
Passando al tema della seconda domanda, esso involge, indiscutibilmente, il concetto di giurisdizione che il sistema anche costituzionale è andato nel tempo disegnando.
Un concetto più ampio di giurisdizione, che alle Sezioni Unite della Cassazione era parso consentire di sindacare non solo le norme sulla giurisdizione che individuano "i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale", ma anche quelle che stabiliscono "le forme di tutela" attraverso cui la giurisdizione si estrinseca, nei casi nei quali la violazione delle stesse comporta un diniego di giustizia. Ciò era stato ricorrendo alla nozione di giurisdizione c.d. "dinamica" (o "funzionale" o "evolutiva"), secondo cui risulterebbe sindacabile anche la violazione di legge (sostanziale e/o processuale) in relazione alla giurisdizione, qualora sia conseguenza di un'interpretazione "abnorme o anomala" (Cass., S.U. 20/05/2016, n. 10501) tale da ingenerare un vero e proprio diniego di giustizia, ovvero di uno "stravolgimento" (Cass., S.U., 17 gennaio 2017, n. 956) delle "norme di riferimento" (di rito o di merito, Cass. S.U., 17 gennaio 2017, n. 964; Cass., S.U., 11 maggio 2017, n. 11520), in particolare nel caso di violazione di norme sovranazionali (Cass., S.U., 17 gennaio 2017, nn. 956 e 953).
A giustificazione di tale indirizzo quanto al concetto di giurisdizione si erano evocati: a) la primazia del diritto comunitario; b) il giusto processo; c) il principio di effettività della tutela; d) il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell'ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva (Cass., S.U., 23 dicembre 2008, n. 30254, Cass., S.U., 6 febbraio 2015, n. 2242; Cass., S.U., 13 maggio 2013, n. 11345; Cass. S.U., 29 dicembre 2017, n. 31226, tutte ricordate da Cass., S.U., 11 novembre 2019 n.29082).
L’interpretazione offerta del comma 8 dell’art.111 Cost., inaugurata dalle Sezioni Unite in tema di pregiudizialità amministrativa – Cass.S.U. 23 dicembre 2008, n. 30254 – in precedenza, v. Cass., S.U. sentt. nn. 13559 e 13660/2006 – rispetto al sindacato sulle questioni attinenti ai ricorsi proposti contro le decisioni del Consiglio di Stato in tema di giurisdizione era andata, in effetti, riconoscendo velatamente alla Corte di Cassazione, quanto meno in via indiretta, una posizione nomofilattica anche nei confronti del giudice amministrativo.
Invero, quando Cass., S.U.n.30254/2008 ebbe a censurare per violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che negava l’ingresso di una tutela risarcitoria degli interessi legittimi in carenza di una tempestiva impugnativa dell’atto autoritativo, essa si era fatta portatrice di alcune rilevanti affermazioni di principio sul concetto di giurisdizione, prospettando un ruolo particolarmente rilevante delle Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a farsi sempre più garante del rispetto di un nuovo ordine nel quale assumono prioritaria valenza, fra gli altri, i canoni di effettività e di tutela dei diritti insieme al primato del diritto UE sul diritto interno.
Nella stessa prospettiva Cass., S.U. n.2242/2015 era giunta a riconoscere il proprio sindacato in punto di giurisdizione nei confronti di una pronunzia del Consiglio di Stato distonica rispetto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di aggiudicazione di appalti resa però in epoca successiva alla decisione del G.A. L’ampliamento del controllo sull’operato del g.a. era stato in tale ultima occasione ritenuto doveroso, in relazione alla peculiarità del caso concreto, nel quale l’intervento interpretativo della Corte di giustizia era giunto in epoca successiva alla decisione del Consiglio di Stato ad esso non conforme, “...oltre che al fine di delineare gli ambiti giurisdizionali del GA nel senso voluto dalla normativa europea (come, in questo caso, interpretata dalla Corte di giustizia), anche al fine di sottrarre lo Stato dalla responsabilità risarcitoria per i danni cagionati dagli organi giurisdizionali di ultima istanza.”
Vi era, sottesa, un’idea di base correlata alla necessità di approntare, nella prospettiva costituzionale una tutela forte ed effettiva ai diritti fondamentali, protetti anche a livello del diritto UE e della CEDU.
Sulla stessa lunghezza d’onta si era posta Cass. (ord.) S.U. n.6891/2016 che, prendendo le mosse dai principi espressi da Cass., S.U. n.2242/2015, non ritenendo di potere ‘disapplicare’ il giudicato interno in ragione della diversità di approccio al diritto di matrice convenzionale, si erano rivolte alla Corte costituzionale, ipotizzando un contrasto fra la norma interna – art.69 c.7 d. lgs. n.165/2001– sulla quale si era fondato il giudicato amministrativo nazionale e i parametri convenzionali che la Corte edu aveva riconosciuto violati con le sentenze rese nei casi Stabbiano c. Italia e Mottola c. Italia del 4.2.2014.
Alla battuta di arresto inferta dalla sentenza n.6/2018 – su cui v., volendo, P. Tomaiuoli, L’“altolà”della Corte costituzionale alla giurisdizione dinamica (a margine della sentenza n. 6 del 2018), in Consultaonline, 2018 fasc.1.–che ha ritenuto tale ampliamento interpretativo, le S.U. della Cassazione hanno ritenuto di dare continuità.
Cass.S.U.9 novembre 2018 n.28652, in Il processo, 2,2019,443– ha ritenuto che «il sindacato che queste Sezioni Unite hanno ricondotto sotto il cono d'ombra dell'art. 111, comma 8, Cost. riguarda, per l'appunto, esclusivamente i casi di vero e proprio rifiuto dell'esercizio della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo rispetto ad una questione concernente materia riservata alla cognizione di altri organi costituzionali — cfr. Cass., Sez. Un., 15 febbraio 2013 n. 3731, Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2008 n. 2439, Cass., Sez. Un., 1 dicembre 2016, n. 24624 — o di difetto assoluto di giurisdizione, ipotizzabile soltanto ove il Consiglio di Stato o la Corte dei conti abbia affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (c.d. invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, l'abbia negata sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento) – cfr. Cass., Sez. Un., 19 luglio 2018 n.19283 – ».
Altre volte si è dato esplicito rilievo al carattere vincolate della sentenza n.6/2018– Cass.S.U. n. 7926/2019 – in relazione al fatto che il giudice costituzionale aveva premesso che la questione allo stesso demandata "rientra...nella competenza naturale di questa Corte, quale interprete ultimo delle norme costituzionali e – nella specie – di quelle che regolano i confini e l'assetto complessivo dei plessi giurisdizionali".
Il semaforo rosso in atto acceso rispetto a quella stagione, come si diceva, ha trovato conferma nella giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite – cfr. Cass.S.U.n.29082/2019–, secondo cui la soluzione espressa dalla sentenza n.6/2018 non vulnera il canone del giusto processo – Cass.S.U.29082/2019 – né quello dell’effettività della tutela giurisdizionale come protetta a livello UE.
Su tale ultimo punto, Cass.S.U.17 dicembre 2018 n.32622 ha affermato che la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111 Cost., comma 8, delle violazioni del diritto dell'Unione Europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali, è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, essendo il sistema correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione. Principio al quale ha dato continuità, più di recente, Cass.S.U., 1 aprile 2019 n.9042 – ma v., contra, anche se prima di Corte cost.n.6/2018, A.Lamorgese, L'eccesso di potere giurisdizionale e il diritto eurounitario, in Questione giustizia, 18 aprile 2017 –.
Nemmeno tanto sullo sfondo rimangono, forse non del tutto risolti, i rapporti fra i commi 7 e 8 dell’art.111 Cost. sui quali l’analisi potrebbe non ritenersi conclusa se si guarda, ancora una volta al ruolo delle Sezioni Unite previsto dalla Costituzione e si pone l’accento sulla centralità dei diritti fondamentali– F. Del Canto, Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione dinanzi alla Corte costituzionale, in Giur.cost., 2018,3, 1537–.
Del resto, il lasso di tempo trascorso dalla sentenza n.6/2018 consente ora un’analisi meno emotiva, lontana in ogni caso dall’idea di creare o fomentare una contrapposizione muscolare fra “plessi giurisdizionali” ed invece rivolta ad approfondire serenamente gli aspetti che ancora rimangono da affrontare. Non ultimo quello che riguarda la vincolatività della sentenza che dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite, fornendo un apparato motivazionale destinato dichiaratamente ad operare, almeno nelle intenzioni della Corte costituzionale, in funzione nomofilattica, proprio in ragione dell’interpretazione secundum Constitutionem fornita dal “giudice della Costituzione”. Le S.U. della Cassazione sono del resto ferme nel ritenere che il vincolo derivante, sia per il giudice "a quo" sia per tutti gli altri giudici comuni, da una sentenza interpretativa di rigetto, resa dalla Corte costituzionale, è soltanto negativo, consistente cioè nell'imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale, così da non ledere la libertà dei giudici di interpretare ed applicare la legge (ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost.) e, conseguentemente, neppure la funzione di nomofilachia attribuita alla Corte di cassazione dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, non essendo preclusa la possibilità di seguire, nel processo "a quo" o in altri processi, "terze interpretazioni" ritenute compatibili con la Costituzione, oppure di sollevare nuovamente, in gradi diversi dello stesso processo "a quo" o in un diverso processo, la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sulla base della interpretazione rifiutata dalla Corte costituzionale, eventualmente evocando anche parametri costituzionali diversi da quello precedentemente indicato e scrutinato – cfr.Cass., S.U., 16 dicembre 2013 n.27986, Cass.n.24762/2019 –.
Come che sia, l’attuale assetto del diritto vivente formatosi dopo la sentenza n.6/2018 non sembra comunque destare alcuna preoccupazione nei tre accademici, rassicurando chi, invece, aveva visto il precedente indirizzo come vagamente rivoluzionario – R. Villata, “Lunga marcia” della Cassazione verso la giurisdizione unica (“Dimenticando” l'art. 103 della Costituzione)?, in Dir. proc. amm., 2013, 344; M. Mazzamuto, L'eccesso di potere giurisdizionale del giudice della giurisdizione, in Dir. proc. amm., 2012, 1677 ss. –
La questione si lega all’ultimo quesito proposto che, in definitiva, si raccorda a tutte le precedenti domande se è vero, come si è visto, che entra comunque in gioco il ruolo del giudice controllore delle modalità di esercizio dei poteri amministrativi.
Il caso dell’occupazione illegittima e dell’atto di acquisizione sanante introdotto a più riprese dal legislatore, dopo l’incostituzionalità dell’art.43 TUE e l’introduzione dell’art.42 bis, dimostra la necessità di approntare livelli di protezione del diritto di proprietà in precedenza non offerti in maniera adeguata a livello interno né dal giudice di legittimità (al quale spettava il “monopolio” della giurisdizione in tema di occupazioni illegittime prima del d.lgs.n.90/98 e dell’art.7 l.n.205/2000) né dalla Corte costituzionale.
Peraltro, il monopolio in punto di giurisdizione del g.o., ormai perduto quanto alla giurisdizione sulle occupazioni illegittime – v., ex plurimis, Cass.S.U., 17 settembre 2019 n. 23102 –, non ha tuttavia eliminato l’esistenza di giurisprudenze non sempre omogenee rese da plessi giurisdizionali diversi su medesime questioni.
Basta ricordare che le Sezioni Unite sono organo di ultima istanza rispetto alle decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche – in forza degli artt.200 e 201 T.U. n.1775/1933 – e che proprio in questo contenzioso le stesse, di recente, hanno affermato principi rilevanti a proposito del rispetto del canone del contraddittorio, riconoscendo che l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante presuppone una valutazione discrezionale degli interessi in conflitto qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo, non limitata genericamente alla eccessiva difficoltà od onerosità delle possibili soluzioni ma volta ad accertare l'assenza di ragionevoli alternative all'acquisizione – prima fra tutte la restituzione del bene – in relazione alle quali il proprietario deve essere posto in grado di svolgere il proprio ruolo partecipativo secondo le regole generali sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo (Cass., S.U. 6 febbraio 2019 n.3517, in Foro it., 2019, I, 1648, pure richiamata da Cass., S.U., n.29466/2019). Principio che non risultava marcato in seno alla giurisprudenza amministrativa di ultima istanza.
Ora questa diversità di plessi giurisdizionali, al di là del tema dell’unità delle giurisdizioni che non può certo in questa sede essere richiamato o svolto, invoca in ogni caso la necessità di una “unità delle interpretazioni”– v. sul punto, volendo, R. Conti, Il mutamento del ruolo della Corte dic Cassazione fra unità della giurisdizione e unità delle interpretazioni, in Consulta on line, 7 dicembre 2015 – e di un dialogo aperto fra tali plessi. Un dialogo che dovrebbe essere fatto di conoscenza e di confronto.
Basti pensare alla questione relativa agli effetti del provvedimento di acquisizione sanante sul giudizio in cui si discute dell’azione risarcitoria spiegata dal privato.
La giurisprudenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione – Cass.n. 11258/2016, Cass. n. 11920/2017; Cass. n. 13532/2017; Cass. n. 14311/ 2018 – ha nel tempo ritenuto che il provvedimento di acquisizione non poteva essere adottato quando, formatosi un giudicato sulla illiceità del comportamento della P.A. sia stato accertato il conseguente diritto del privato al risarcimento del danno. Tale tesi è stata poi suggellata dalle Sezioni Unite della Cassazione – Cass. SU n. 539 del 2019, Cass.S.U. n.29466/20199 – ed alla stessa hanno aderito i giudici amministrativi (cfr. Cons. Stato n. 3871 del 2019 –. Con la sola non marginale precisazione che l’effetto dell’improcedibilità dell’azione “…deve invece essere escluso in presenza della "formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno. Invero, il provvedimento ex art. 42 bis è volto a ripristinare (con effetto "ex nunc") la legalità amministrativa violata – costituendo, pertanto, una "extrema ratio" per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito –, sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione" (Cass., Sez. 1, 31/05/2016, n. 11258, Cass.n.3649/2018).
Anche l’Adunanza Plenaria si è occupata, in altro contesto, della “tenuta” del giudicato civile o amministrativo rispetto al successivo atto di acquisizione sanante non incidente sulla proprietà ma su una limitazione alla stessa correlata alla costituzione di un diritto di servitù, ritenendo che il giudicato restitutorio (amministrativo o civile), inerente all'obbligo di restituire un'area al proprietario da parte dell'Amministrazione occupante sine titulo, non preclude l'emanazione di un atto di imposizione di una servitù, in esercizio del potere ex art. 42–bis, comma 6, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, poiché questo presuppone il mantenimento del diritto di proprietà in capo al suo titolare.
Soluzione, quest’ultima, in astratto ineccepibile, che non potrà non fare i conti con l’impianto di protezione del diritto di proprietà di matrice convenzionale, laddove occorrerà verificare se la successiva acquisizione di un diritto reale di godimento abbia inteso di fatto realizzare l’effetto proprio del provvedimento ablatorio non definito legittimamente dal quale era derivato il giudicato civile o amministrativo in favore del proprietario, entrando in gioco la necessità di offrire misure dotate di base legale e proporzionate.
Non armonico, allo stato, risulta per converso il tema legato alla configurabilità della rinunzia abdicativa in caso di occupazione illegittima.
Le ricordate Ad.Plen., Cons. Stato, nn. 2 e 4/2020 sembrano averla esclusa dal sistema superando la giurisprudenza di legittimità della Cassazione – Cass.n.3827/1987, Cass. Cass.1814/2000, Cass.S.U. 1907/1997, Cass. 3 maggio 2005 n. 9173, Cass. n. 24819/2005– in Riv. amm. Rep.it., 2006, 2,202, con commento di chi scrive –, Cass.S.U. n.735/2015, in Corr. Giur., 2015, 3, 319, con nota di chi scrive –.
L’opzione sconfessata dal Consiglio di Stato era stata escogitata dalla Corte di Cassazione per ovviare al dilagare di fenomeni di vero e proprio scempio amministrativo nei quali la p.a., pur in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, provvedeva ciononostante a realizzare l’opera pubblica. Ma tale meccanismo, pur contestando gli approdi delle Sezioni Unite del 1983, finiva per cadere nel medesimo equivoco, creando anch’esso un nuovo modo di acquisto della proprietà attraverso l’estensione analogica di norme eccezionali.
Questa insoddisfazione, –sia consentito il rinvio a R. Conti, Occupazione acquisitiva. Tutela della proprietà e dei diritti umani, Milano, 2006,116 ss.; id., in AA., La responsabilità civile della p.a., a cura di Protto e Caringella, Torino, 2005, 878, in cui era ricordata la inedita Trib. Palermo 20 febbraio 2001– ha dunque trovato eco nell’Adunanza Plenaria n.2/2020.
Resta il fatto che la giurisprudenza della Corte di cassazione è orientata diversamente– Cass.n.25549/2018, Cass.27197/2019, Cass.n.3035/2020–.
Aporie del sistema che andranno vagliate quanto alla conformità a CEDU, laddove dovessero produrre risultati capaci di vulnerare i parametri convenzionali volta per volta rilevanti.
Armonia fra le giurisdizioni che, per converso, sembra regnare fra g.o. e g.a. quanto alla limitata possibilità di fare ricorso all’istituto dell’usucapione c.d. sanante delle quale si è pure fatto cenno nelle risposte.
Rispetto a queste pare utile evidenziare la sintonia fra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione. Cass.n.27197/2019 ha fatto il punto sulle condizioni e sugli spazi di operatività dell'istituto di diritto privato dell'usucapione nell'ipotesi di occupazione illegittima. Dopo avere ricordato i precedenti di legittimità favorevoli alla configurazione di condotte materiali di occupazione e di manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione anche ai fini della loro usucapibilità, senza distinzione tra le fattispecie dell'occupazione acquisitiva e di quella usurpativa (Cass. n. 1804/2013 e SU n. 735/2015), si è sottolineato che tale indirizzo consentirebbe in astratto, a partire dalla configurazione dell'illecito, la possibilità per l'Amministrazione occupante di maturare un possesso integrativo dell'usucapione in applicazione delle norme di diritto privato in presenza di un animus possidendi necessario ad usucapire che si manifesta attraverso un atto di interversione del possesso. Ed infatti, venuto meno l'agire secondo modelli pubblicistici l’amministrazione potrebbe acquisire come un qualsiasi privato, in ragione di condotte di occupazione e manipolazione, la proprietà del bene per usucapione. Ma la Cassazione si premura a chiarire le condizioni che possono giustificare siffatto modo di acquisto della proprietà, conseguente ad un illecito di diritto comune lesivo dell'altrui diritto di proprietà ed alternativo rispetto alle ipotesi della restituzione dell’area, della transazione, della rinunzia abdicativa e non traslativa del proprietario al suo diritto che resta implicitamente contenuta nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente, o del provvedimento amministrativo D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42 bis. La implicita premessa di base dalla quale muove la pronunzia in esame è costituita da un lungo ed accidentato percorso giurisprudenziale, fortemente condizionato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – a partire dai noti casi Carbonara e Ventura e Belvedere Alberghiera c. Italia del maggio 2000 – e dai “seguiti” interni (Corte cost.nn.348 e 349 del 2007, Cass., S.U. n.735/2015) ed ormai stabilizzato nel senso della natura permanente dell’illecito perpetrato in danno del privato attraverso condotte riconducibili alle figure (di matrice pretoria) dell’occupazione acquisitiva e/o usurpativa o in via di mero fatto. Ora, secondo Cass. n.27197/2019 perché le condotte di occupazione acquisitiva ed usurpativa o in via di mero fatto possano dare luogo all’acquisto della proprietà del bene in favore dell’espropriante per usucapione, nei casi in cui il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente dalla P.A. come detenzione – in presenza di validi provvedimenti amministrativi (dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, ecc.) –, occorre l'allegazione e la prova da parte della P.A. della trasformazione della detenzione in possesso utile "ad usucapionem", ex art. 1141 c.c., comma 2, cioè il compimento di idonee attività materiali di opposizione specificamente rivolte contro il proprietario–possessore, non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all'esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. Cass. n.27197/2019 pone dunque un limite alla concreta operatività dell’usucapione nelle vicende di cui si è detto, ritenendo che l’occupazione illegittima non può “integrare il requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione, sortendosi altrimenti l'effetto di reintrodurre nell'ordinamento interno forme di espropriazione indiretta o larvata, in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale annesso alla Cedu”. Ed infatti, il possesso che pure si accompagna alla permanenza dell'illecito non può valere, senza soluzione di continuità, agli effetti dell'usucapione destinati ad operare fin dal momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, con estinzione retroattiva della tutela reale ripristinatoria e di quella indennitaria del proprietario del fondo.
Tale ultima vicenda conferma la necessità che il sistema interno trovi dei meccanismi capaci di rendere il concetto nazionale di legalità sempre più omogeneo e quello omologo patrocinato dalle giurisdizioni sovranazionali al quale il giudice interno avrebbe il dovere di conformarsi.
Ed infatti, il rispetto del principio di legalità come espresso dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ed individuato nei suoi precisi confini dal giudice di Strasburgo fa sì che le ingerenze nell’esercizio dei diritti e delle libertà tutelate dalla CEDU siano autorizzate purché queste siano chiare, accessibili e prevedibili – Corte edu, 2 agosto 1984, Malone c. Regno Unito, § 66; Corte edu, 22 settembre 1994, Hentrich c. Francia, Corte edu,8 luglio 1986, Lithgow; Corte edu, 30 maggio 2000, Belvedere Alberghiera c. Italia e Carbonara e Ventura c. Italia, pp.57–.
In conclusione, l’ampio respiro delle risposte fa il paio con la necessità di mantenere alto il livello di attenzione sulle tematiche trattate che, a ben considerare, entrano ed escono dalla porta della CEDU, ma attengono a questioni di ordine interno di assoluta centralità, alle quali il diritto vivente del giudice ordinario e del giudice amministrativo offrirà il proprio contributo, tenendosi per mano con la scienza giuridica.
[1] In estrema sintesi, il Protocollo n. 16 istituisce una giurisdizione consultiva e preventiva della Corte EDU di carattere incidentale, con cui le Corti di vertice individuate dagli Stati contraenti, possono, laddove ne ravvisino la necessità all’interno di un procedimento pendente dinanzi a loro, formulare una richiesta di parere consultivo non vincolante alla Corte EDU su questioni di principio relative all’interpretazione e/o all’applicazione dei diritti e libertà definiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
[2] Come ben evidenziato da Lipari in, L’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo nella giurisdizione amministrativa, in Il processo, 2, 2019, 265 ss.
[3] Si veda De Napoli, “La Corte di Strasburgo e l’esauribilità sostanziale del potere amministrativo”, in Dir. proc. Amm., 2, 2019, 557 ss.
[4] La norma ha trasposto a livello nazionale la Direttiva 2014/104/EU sul public e private enforcement in materia di tutela della concorrenza.
[5] Si veda Previti, “Il tramonto della full jurisdiction per gli antitrust agreements”, in Dir. Proc. Amm., 4, 2018, 1325 ss.
[6] Tranne che con riferimento alla quantificazione della sanzione, per cui l’art. 134(1)(c) c.p.a. prevede un’ipotesi di sindacato esteso al merito.
[7] Il nostro Paese è invero rimasto in larga parte estraneo ad un dibattito che, in altri ordinamenti europei, è iniziato da anni.
Vanno comunque ricordati, con ampiezza di argomenti, Allena, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2012 e, sotto alcuni profili di rilievo per il diritto amministrativo nazionale, Pacini, Diritti umani e amministrazioni pubbliche, Milano, 2012 e Mirate, Giustizia amministrativa e Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’altro diritto europeo in Italia, Francia e Inghilterra, Napoli, 2007. Da ultimo, Follieri, Sulla possibile influenza della giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo sulla giustizia amministrativa, in Dir. proc. amm., 2014, 685 ss.
Una prima trattazione da parte di chi scrive dei temi poi sintetizzati in questo lavoro in Villata–Goisis, Procedimenti per l’emanazione di provvedimenti individuali, in La tutela del risparmio nella riforma dell’ordinamento finanziario, commento alla l. 28 dicembre 2005, n. 262, e ai provvedi attuativi, a cura di De Angelis e Rondinone, Torino, 2008, 554 ss. e Goisis, Garanzie procedimentali e Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo, in Dir. proc. amm., 2009, 1338 ss. e in alcuni successivi scritti che saranno di seguito ricordati, tra cui, più organicamente, Goisis, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2015.
[8] Corte cost., 26 marzo 2015, n. 49.
[9] Corte eur. dir. uomo, Plenaria, 8 giugno 1976, caso n. 5100/71, Engel and Others v. the Netherlands, in tema di sanzioni detentive disciplinari–militari.
[10] Sul tema generale degli approcci interpretativi “autonomistici” da parte della Corte di Strasburgo, Letsas, A theory of interpretation of the European Convention on Human Rights, Oxford, 2009.
[11] Trattasi della pronuncia Corte edu, sez. II, 9 novembre 1999, caso n. 35260/97, Varuzza v. Italy, in cui la Corte si limita a ricordare che «the offence at issue is a “criminal” one within the meaning of Article 6, § 1 of the Convention (see the Öztürk v. Germany judgment of 21 February 1984, Series A no. 73, p. 21, § 53). The applicant was thus in principle entitled to have a court determine the charge against him».
[12] Corte edu, sez. IV, 21 marzo 2006, caso n. 70074/01, Valico v. Italia.
[13] Corte edu, sez. II, 7 settembre 2011, caso n. 43509/08, Menarini c. Italia.
[14] Corte edu, sez. II, 4 marzo 2014, casi nn. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10, Grande Stevens and Othersv. Italy.
[15] Così, da ultimo, Corte edu, sez. V, 11 gennaio 2018 , casi nn. 38334/08 and 68242/16, Haralambi Borisov ANCHEV v. Bulgaria , § 132: «"It therefore cannot be said that the courts declined to examine facts or issues which had a bearing on the determination of the case before them. Their not going into those points was not a limitation, self–imposed or otherwise, of their jurisdiction.".
[16] Corte edu, Plenaria, 8 luglio 1987, caso n. 9749/82, W. v. United Kingdom, § 82: "In a case of the present kind, however, there will in the Court’s opinion be no possibility of a “determination” in accordance with the requirements of Article 6, § 1 (art. 6–1) of the parent’s right in regard to access, as analysed in paragraph 77 above, unless he or she can have the local authority’s decision reviewed by a tribunal having jurisdiction to examine the merits of the matter. And it does not appear from the material supplied by the Government or otherwise available to the Court that the powers of the English courts were of sufficient scope to satisfy fully this requirement during the currency of the parental rights resolution".
[17]Corte edu, sez. I, 17 aprile 2012, caso n. 21539/07, Steininger v. Austria, § 52, § 50: "it considered these submissions on their merits, point by point, without ever having to decline jurisdiction when replying to them or ascertaining various facts".
[18] Corte edu, sez. V, 21 luglio 2011, casi nn. 32181/04 35122/05, Sigma Radio Televisioni Ltd v. Cyprus, §157: "Where, however, the reviewing court is precluded from determining the central issue in dispute, the scope of review will not be considered sufficient for the purposes of Article 6 (see Tsfayo, cited above, § 48). The Court has therefore found violations of Article 6 § 1 in cases where the domestic courts considered themselves bound by the prior findings of administrative bodies which were decisive for the outcome of the cases before them, without examining the issues independently (see, amongst many authorities, Obermeier v. Austria, 28 June 1990, §§ 69–70, Series A no. 179; Terra Woningen B.V. v. the Netherlands, 17 December 1996, § 46 and §§ 50–55, Reports 1996–VI; I.D. v. Bulgaria, no. 43578/98, §§ 50–55, 28 April 2005; Capital Bank AD v. Bulgaria, no. 49429/99, §§ 99–108 ECHR 2005–XII (extracts); Tsfayo, cited above; and Družstevní záložna Pria and Others v. the Czech Republic, no. 72034/01, § 112–115, 31 July 2008). In addition the Court has found a violation of Article 6 where a ground of challenge has been upheld by the reviewing court but it was not possible to remit the case for a fresh decision by the same or a different body (see Kingsley, cited above, § 32).".
[19] Corte edu, Grande Camera, 23 giugno 1981, casi 6878/75 e 7238/75, Le Compte, Van Leuven and De Meyer v. Belgium, § 51: "Whilst Article 6 par. 1 (art. 6–1) embodies the "right to a court" (see paragraph 44 above), it nevertheless does not oblige the Contracting States to submit "contestations" (disputes) over "civil rights and obligations" to a procedure conducted at each of its stages before "tribunals" meeting the Article’s various requirements. Demands of flexibility and efficiency, which are fully compatible with the protection of human rights, may justify the prior intervention of administrative or professional bodies and, a fortiori, of judicial bodies which do not satisfy the said requirements in every respect ".
[20] Così, Corte edu, sez. V, 16 dicembre 2008, caso n. 23510/02, Vitrenko and Others v. Ukraine, § 2: "Even assuming that the first applicant's absence could raise the issue of infringement of the equality of arms principle, the applicant had the opportunity to make any necessary submissions before the appellate court that had full jurisdiction to review the case both on facts and on law and to remedy any defect in the first–instance court proceedings":
[21] Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2015, nn. 1595 e 1596.
[22] Sul punto, già esatte osservazioni in D. Galligan, Due Process and Fair Procedures, A Study of Administrative Procedures, Oxford, 1997, 217, che, guardando al problema dal punto di vista delle categorie di procedimenti amministrativi soggetti all’art. 6 CEDU, osserva che: "Since the threshold test looks to the consequences of a process rather than to its nature or function, administrative processes may be subject to Article 6".
[23] Corte edu, sez. I, 5 febbraio 2009, caso n. 22330/05, Olujc v. Croatia, § 37 "The Court reiterates that for the purposes of Article 6 § 1 of the Convention a tribunal need not be a court of law integrated with the standard judicial machinery […] since a tribunal, within the meaning of Article 6, § 1, is characterised in the substantive sense of the term by its judicial function, that is to say, the determining of matters within its competence on the basis of rules of law and after proceedings conducted in a prescribed manner (see Philis, cited above, § 50)".
Sul tema della nozione autonoma e funzionale di tribunale nella CEDU, M. Allena, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2012, 36 ss.
[24] Sul rapporto tra funzione amministrativa e giurisdizionale nel private enforcement del diritto antitrust, cfr. K. Wright, The Ambit of Judicial Competence after the EU Antitrust Damages Directive, in Legal Issues of Economic Integration, 43, no.1(2016),15 ss.
[25] Cons. Stato Sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4990.
[26] Riprendo qui alcuni argomenti già sviluppati in F. Goisis, Il canone della Full jurisdiction, tra proteiformità e disconoscimento della discrezionalità tecnica come merito. Riflessioni critiche sull'art. 7, co. 1, d.lgs 19 gennaio 2017, n. 3, in Persona e amministrazione, 2018, 199 ss.
[27] Cons. Stato Sez. VI, n. 4990/2019, cit..
[28] Cfr. in particolare Corte suprema degli Stati Uniti, 28 aprile 1980, Marshall v. Jerrico, Inc., 446 U.S. 238, 245, in cui si osserva che, per ovviare al difetto di terzietà dell’Amministrazione sanzionatrice, "the administrative law judge is required to conduct a de novo review of all factual and legal issues", insegnamento poi ripreso, in termini più generali, da Corte suprema degli Stati Uniti, 14 giugno 1993, Concrete Pipe and Products of California, Inc v. Construction Laborers Pension Trust for Southern California, 508 US 602, 618: "Where an initial determination is made by a party acting in an enforcement capacity, due process may be satisfied by providing for a neutral adjudicator to “conduct a de novo review of all factual and legal issues”".
[29] È stato peraltro osservato che il problema di riapertura del processo – tema al centro della pronuncia n. 6/2018 – si pone essenzialmente nei casi in cui la Corte EDU abbia successivamente accertato una violazione del diritto alla difesa ex art. 6 CEDU. In tali ipotesi, la pronuncia della Corte non entra nel merito della questione sostanziale ma si limita a verificare l’irritualità del processo svolto e la sua inattitudine a garantire la corretta formazione della pronuncia avanti il giudice nazionale; da qui la necessità di riapertura del processo per poter accertare, nel rispetto dei principi del giusto processo, la sussistenza o meno della pretesa sostanziale. Si veda in generale Lipari, op. cit. § 14.
[30] La citata pronuncia in materia penale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. "nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza penale o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell'uomo".
[31] Alla base di tale impostazione, vi è l’assunto che sussistano casi estremi in cui il giudice amministrativo adotta una decisione «anomala o abnorme», omettendo l’esercizio del potere giurisdizionale per errores in iudicando o in procedendo che danno luogo al superamento dei limiti esterni e, per questo, diventano sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione. Tale impostazione ha trovato riscontro in seno alla stessa giurisprudenza della Cassazione in un numero limitato di ipotesi, tra cui, tuttavia, spicca quella di radicale stravolgimento delle norme europee come interpretate dalla Corte di giustizia in materia di appalti (Cass. S.U. 2242/2015 e S.U. 31226/2017).
[32] Emblematica di tale orientamento è stata Cass. Sez. Un. N. 30254/2008 secondo cui “è norma sulla giurisdizione non solo quella che individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, ma anche quella che dà contenuto al potere stabilendo attraverso quali forme di tutela esso si estrinseca”. Rientra quindi nelle ipotesi di ricorso per motivi di giurisdizione, «l’operazione che consiste nell'interpretare la norma attributiva di tutela, per verificare se il giudice amministrativo non rifiuti lo stesso esercizio della giurisdizione, quando assume della norma un'interpretazione che gli impedisce di erogare la tutela per come essa è strutturata».
[33] Così, in senso critico Police, “I soli motivi inerenti la giurisdizione nella giurisprudenza della Corte costituzionale”, in Il Processo, 1, 2019, 113 ss.
[34] in particolare Corte cost. n. 71/2015, Cass. S.U. n. 735/2015 e n. 22096/2015, Cons. St. Ad. plen. n. 2/2016 e la recentissima Ad. plen. 2/2020.
[35] (Rossi e Variale [2014], Pascucci, [2014], Immobiliare Cerro [2012], Guiso, [2009], Scordino [2007 e 2005], Sciarrotta, [2006], Soc. Belvedere alberghiera [2000]; Carbonara e Ventura [2000] (Rossi e Variale [2014], Pascucci, [2014], Immobiliare Cerro [2012], Guiso, [2009], Scordino [2007 e 2005], Sciarrotta, [2006], Soc. Belvedere alberghiera [2000]; Carbonara e Ventura [2000].
[36] La questione attiene al rapporto generale tra discrezionalità amministrativa e potere giurisdizionale ed alla difficile compatibilità di tale ordine con i principi generali in tema di pronunce di condanna del g.a., tenuto conto anche del fatto che Corte cost. 71/2015 ha ribadito la natura discrezionale di tale scelta dell’amministrazione.
[37] (Rossi e Variale [2014], Pascucci, [2014], Immobiliare Cerro [2012], Guiso, [2009], Scordino [2007 e 2005], Sciarrotta, [2006], Soc. Belvedere alberghiera [2000]; Carbonara e Ventura [2000] (Rossi e Variale [2014], Pascucci, [2014], Immobiliare Cerro [2012], Guiso, [2009], Scordino [2007 e 2005], Sciarrotta, [2006], Soc. Belvedere alberghiera [2000]; Carbonara e Ventura [2000].
[38] in particolare Corte cost. n. 71/2015, Cass. S.U. n. 735/2015 e n. 22096/2015, Cons. St. Ad. plen. n. 2/2016 e la recentissima Ad. plen. 2/2020.
[39] Così da ultimo, Corte EDU, 9 febbraio 2017, causa n. 26128/04, Messana c.Italia, par. 46.