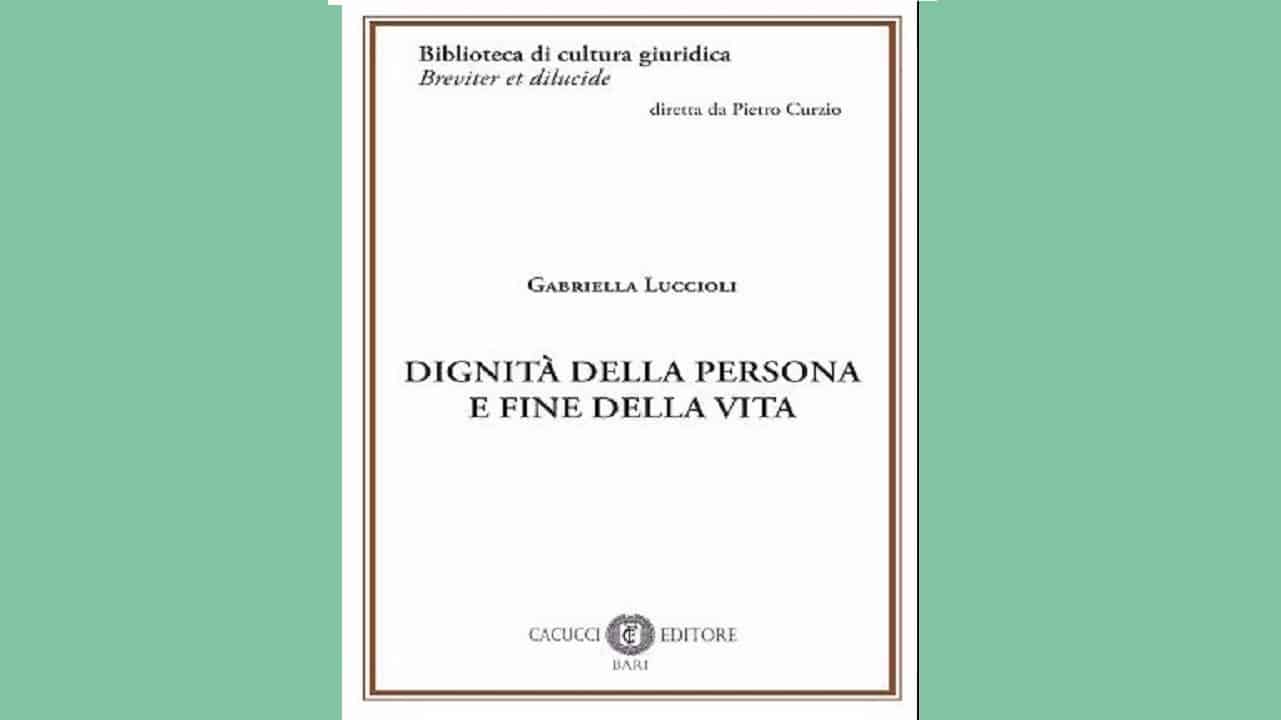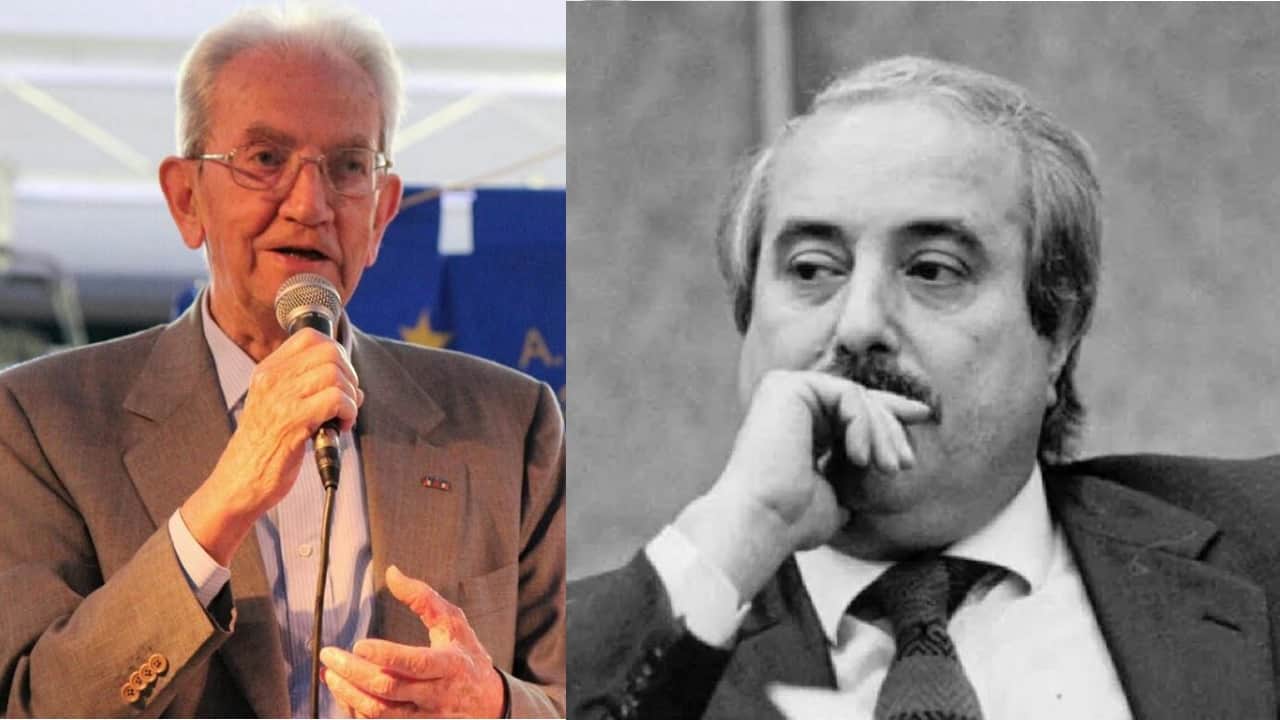CEDU e cultura giuridica italiana
5) La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e i civilisti
Roberto Giovanni Conti intervista
Nicolò Lipari, professore Emerito diritto civile Università Roma
Emanuela Navarretta, ordinaria diritto privato Università di Pisa
1. Le domande. 2. La scelta del tema. 3. Le risposte. 4. Le conclusioni. 5. L’intervista in pdf.
1.Le domande
1) Qual è, a Suo avviso, l’impatto prodotto nei rapporti interprivati dall’accresciuto ruolo della CEDU nell’ordinamento interno riscontrato nell’ultimo ventennio?
2) Costituzione e CEDU per il civilista: sovrapposizione, contrapposizione, ordinazione gerarchica?
3) Quali sono, a suo avviso, in materia civile i settori sui quali i livelli di protezione garantiti dalla CEDU potranno svolgere un peso rilevante nel prossimo futuro?
4) Nel ragionamento giuridico che svolge l’interprete chiamato ad applicare la legge in una controversia civile quale incidenza ha prodotto o dovrebbe produrre, a suo avviso, la CEDU?
5) Quali oneri aggiuntivi, a suo avviso, incombono sul giudice e sull’avvocato che si occupa di civile rispetto alla conoscenza ed applicazione della CEDU e del suo diritto vivente?
2. La scelta del tema.
Roberto Giovanni Conti
L’approfondimento odierno sul tema “Cedu e diritto civile” apre le porte ad una riflessione su questioni che non sembrano appassionare in modo diffuso e filiforme la dottrina e la giurisprudenza domestiche. Impera ancora l’idea che l’incidenza della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in ambito civile sia questione per lo più teorica, di scarso impatto pratico nella vita delle persone e, al più, riservata ad approfondimenti dei c.d.esperti e/o di ambiti più o meno elitari.
Le riflessioni offerte ai lettori di Giustizia Insieme dalla Professoressa Navarretta e dal Professore Lipari, sollecitati a fare il punto sull’incidenza dei diritti fondamentali di matrice convenzionale nei rapporti interprivati e sul loro fare sistema con la Costituzione, hanno consentito di sfatare false credenze attorno alla marginalità ed eccentricità della Cedu in ambito privatistico, al contempo dimostrando la necessità di una centralizzazione del tema nelle aule accademiche e di giustizia. Necessità oggi ancor più avvertita in un momento nel quale la centralizzazione della persona e dei diritti che attorno ad essa vivono non sembra lasciare spazio a posizioni di seconda linea, invece sollecitando gli operatori giudiziari tutti ad azioni corali ed avanguardiste, concretamente rivolte a garantire in termini effettivi ed efficaci la protezione di quel bagaglio di valori destinato a incidere sempre di più nelle vicende che toccano gli interessi più delicati delle persone. Esigenza che appare del resto ancora più pressante quando la partita coinvolge la galassia dei soggetti vulnerabili, nell’accezione ampia che tale espressione va assumendo se si orienta lo sguardo per l’un verso ai rapporti fra cittadino e Stato e, per altro verso, a quelli che coinvolgono i portatori di diritti controversi, contestati, se si vuole contro maggioritari.
È proprio in questi ambiti che le influenze della giurisprudenza della Corte edu si dimostrano palpabili e tutt’altro che marginali, producendo un fascio di questioni problematiche che i soggetti intervistati hanno focalizzato – pur con accenti non sempre sovrapponibili – in modo talmente adamantino da precludere per il futuro un ritorno ad un passato sereno e calmo nel quale si è spesso preferito continuare a navigare.
3. Le risposte
Qual è, a Suo avviso, l’impatto prodotto nei rapporti interprivati dall’accresciuto ruolo della CEDU nell’ordinamento interno riscontrato nell’ultimo ventennio?
Nicolò Lipari
Vorrei innanzitutto proporre una osservazione di fondo, che può valere in qualche modo da premessa a tutte le mie risposte. Vado da tempo insistendo nel dire – e l’ho ribadito in maniera particolarmente argomentata nel mio ultimo libro (Diritto civile e ragione, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019) – che come giuristi, pratici o teorici, noi dobbiamo registrare l’esito di una rivoluzione: il diritto non scende più dall’alto di atti di posizione, ma sale dal basso di atti di riconoscimento. Da questa constatazione – ormai irreversibile, quali che siano gli ultimi conati di un positivismo decadente, ancorché proposto sotto le raffinate vesti del nichilismo – discende la necessità di adeguare i nostri strumenti ricostruttivi. In particolare, risulta improprio qualificare i modi di porsi dell’esperienza sociale come effetti di presupposti normativi o di assetti istituzionali perché accade sempre più di sovente che siano piuttosto questi ultimi le conseguenze dei primi. Probabilmente ciò è sempre accaduto nell’esperienza giuridica, ma il processo appariva meno evidente in una stagione di consolidati modelli sociali e di convergenza sui punti di orientamento in chiave di valore. La prospettiva del postmoderno, con la frantumazione degli indici assiologici che ha determinato, ha rotto questo equilibrio. Si tratta dunque volta per volta di ricostruire il modo d’essere di una prassi nella consapevolezza che da questa dipende – all’opposto di quanto si riteneva in passato – lo stesso modo d’intendere il principio di legalità e, di riflesso, le chiavi ricostruttive attraverso le quali esso viene proposto.
Se si cala questo paradigma all’interno della storia della CEDU dalla Convenzione di Roma del 1950, al Protocollo n. 11 del 1994, che ha introdotto l’istituto fondamentale del ricorso individuale alla Corte, all’esperienza contemporanea, risulta difficile, a mio avviso, ricondurne il processo ricostruttivo entro lo schematismo del rapporto causa-effetto. Probabilmente – se dobbiamo davvero interpretare la realtà non nella chiave univoca e quindi riduzionistica dell’epistemologia contemporanea, ma piuttosto nell’ottica di una ragione per così dire analogica, che si esprime in forma complessa e che è dotata di una continua duttilità – sarà necessario riconoscere che la cultura dei diritti ha ormai pesantemente innervato l’intera esperienza giuridica (almeno nell’area dei paesi civilizzati), facendo sì che ciò che appariva all’inizio come un traguardo da raggiungere, appunto attraverso l’ausilio di strumenti normativi ed istituzionali, non possa che essere ormai ritenuto un indispensabile presupposto cui è inevitabile che quegli strumenti si adeguino. Quel panorama che, nell’ottica dei costituenti, Barile aveva paragonato alla musica di Mahler, destinata non ai contemporanei, che erano sgradevolmente colpiti dalla sua novità, ma ai posteri, è ormai divenuto uno spazio di vita condiviso, una musica che sempre più appartiene (nonostante talune persistenti sacche di resistenza) alla sensibilità di tutti.
In questa chiave era inevitabile che si venisse affermando, al di là della prepotente Europa economica e della (tuttora) evanescente Europa politica, l’Europa dei diritti. E’ questo il modello che è ormai destinato inesorabilmente a prevalere, al di là degli strumentali argomenti di chi, per contingenti convenienze di parte, vede nell’Europa esclusivamente una fonte di sacrifici. Se vogliamo dunque ridurre ad una formula di sintesi un lungo processo, direi che l’esperienza della CEDU ha concorso a radicare – almeno nella sensibilità dei più avveduti – il cambiamento di cui dicevo.
Semmai vanno segnalati (ad una cultura giuridica spesso disattenta e superficiale) due punti nodali nel quadro di quella che è stata e rimane una vera e propria rivoluzione culturale. Il primo riguarda il superamento di un ottuso richiamo al principio di maggioranza, che pure all’inizio ci era apparso come un’áncora di salvezza rispetto agli schemi costrittivi delle grandi dittature del Novecento. I diritti si affermano di per sé, nell’insopprimibile forza della loro individualità, e non chiedono un riconoscimento maggioritario. Come è stato giustamente detto, la legge di ragione fa premio sulla stessa forza del numero. Il secondo supera un altro dei paradigmi consolidati sui quali si è fondato il positivismo giuridico: l’intervento necessario e garantista del legislatore. I diritti non chiedono un riconoscimento legislativo perchè preesistono a qualsiasi enunciato. Essi si affidano dunque alla mediazione giudiziale e probabilmente impongono che venga ridisegnato quello che una volta si qualificava come rapporto tra poteri. Se dunque vogliamo davvero parlare di un “impatto” sulla cultura giuridica, questo – come ho cercato di chiarire in altro luogo – va colto nella necessità di ridisegnare alcuni dei modelli sui quali vengono ancora (purtroppo) strutturate le nostre Facoltà giuridiche e che tuttora risultano passivamente riflessi negli interventi di alcuni noti personaggi che vengono periodicamente interpellati nei talk show televisivi.
Non si tratta allora, a mio avviso, di gingillarsi con la teoria dei controlimiti, ma di intendere che l’irreversibile forza dei “diritti” è destinata ormai ad imporsi al di là di qualsiasi condizionamento formale. Un ordinamento giuridico, quali che siano i suoi punti di riferimento istituzionale o il suo ambito territoriale, non può giustificare se stesso se non sulla base di un riconoscimento delle libertà fondamentali, che opera dunque quale presupposto – non quale esito – del valere del diritto come valore. Forse è riduttivo dire che questo è dipeso da un accresciuto ruolo della CEDU nell’ordinamento interno. Certo è comunque che la Convenzione europea dei diritti umani si è venuta progressivamente affermando come un organismo vivo, capace di offrire sia alla Corte che ai giudici nazionali la possibilità di estendere la tutela anche a diritti non esplicitamente enunciati nella Convenzione. Non direi tuttavia che l’effettività della tutela è, per così dire, discesa da quel testo. Esso è stato semmai il sintomo anticipatore di un’esperienza destinata inevitabilmente ad affermarsi, nonostante le persistenti resistenze e gli inevitabili attriti.
Emanuela Navarretta
Premessa
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è riuscita a permeare la disciplina civilistica, avvalendosi di una molteplicità di tecniche giuridiche e di soluzioni interpretative.
Attraverso la responsabilità civile degli stati, la Corte di Strasburgo ha sottoposto la legislazione civilistica, nonché l’agire dei pubblici poteri nei confronti dei privati, ad un controllo sul rispetto degli obblighi negativi e positivi derivanti dalla Convenzione. In tal modo la Corte di Strasburgo ha offerto ai privati un’opportunità di tutela che, almeno in parte, bilancia la mancanza, nel nostro ordinamento, di un ricorso diretto alla Corte costituzionale.
Al contempo, la Convenzione è stata applicata direttamente ai rapporti orizzontali che legano i soggetti pubblici ai privati, in quanto, oltre a conferire diritti a questi ultimi, impone immediatamente doveri in capo ai primi.
Infine, in virtù del coordinamento sostanziale e, grazie all’art. 117 C., anche formale, fra la Costituzione e la Convenzione, quest’ultima esplica un’efficacia sulla disciplina privatistica e sui rapporti fra privati, che viene mediata dai principi costituzionali e, dunque, dal modo con cui essi agiscono in campo civilistico. In tal modo, si riverbera sull’intero sistema di diritto privato una peculiare ‘sensibilità europea’ nella ricostruzione dei principi fondamentali.
L’impatto in campo civilistico della responsabilità civile dello Stato per violazione degli obblighi negativi
Nell’ultimo ventennio le condanne degli stati nazionali e, specificamente, dello Stato italiano per la violazione delle norme Cedu offrono un’interessante panoramica sul tipo di impatto sostanziale che la Convenzione ha esercitato sul diritto civile sia nell’area degli interessi patrimoniali sia in quella degli interessi personali.
L’influenza della Cedu sul modo di intendere gli interessi patrimoniali
Nella prima prospettiva la vicenda più significativa è rappresentata, senza dubbio, dalla c.d. occupazione acquisitiva, che ha condotto alle storiche sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007. Il messaggio che si inferisce non è quello di un ritorno a concezioni lockiane della proprietà, in virtù del rilievo assegnato dall’art. 1 Prot. 1 della Cedu ai beni e al diritto di proprietà. Viceversa, la Corte di Strasburgo, con le due famosissime sentenze Scordino (del 2004 e del 2007), ha inteso evitare che, dietro lo schermo formale della funzione sociale della proprietà, si celassero veri e propri abusi della P.A. sul piano sia sostanziale sia delle garanzie procedimentali. Gli orientamenti legislativi e giurisprudenziali nazionali, compresi quelli della Corte costituzionale, avevano, infatti, consentito alla P.A. di acquisire beni senza il previo accertamento di motivi di pubblica utilità e pagando indennizzi di valore ampiamente inferiore a quello venale; il tutto avveniva senza alcun rispetto del principio di legalità, così omettendo una congrua valutazione degli interessi in conflitto.
Se, dunque, questa è, in estrema sintesi, la ricostruzione della vicenda, se ne inferisce che il modello della Cedu non orbita intorno al binomio libertà-proprietà, bensì impone una necessaria proporzionalità del sacrificio dell’interesse privato rispetto al, pur preminente, interesse pubblico. In sostanza, i principi della Cedu orientano verso una ricostruzione del limite intrinseco alla proprietà, costituito dalla funzione sociale, il più possibile rispettoso di procedure che, compatibilmente con la tutela del prioritario interesse pubblico, siano idonee a contenere l’impatto negativo sulla proprietà, in quanto diritto comunque dotato, anche nel nostro sistema costituzionale, di una garanzia d’istituto.
Che questo sia l’approccio indotto dal raccordo fra l’art. 42 C. e l’art. 1 Prot. 1 Cedu trova conferma nella recente vicenda relativa all’art. 42 bis del D.P.R. n. 3217/2001, come modificato dall’art. 34, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011, sull’utilizzazione senza titolo di un bene da parte della P.A. Infatti, pur non potendosi tacere qualche criticità nella decisione della Corte cost. n. 71 del 2015, che ha preservato la legittimità dell’art. 42 bis, deve, tuttavia, riconoscersi la ben maggiore attenzione, rispetto al passato, che il legislatore ha rivolto al contemperamento fra interessi pubblici e interesse privato. Ne sono testimonianza il riferimento nella disposizione richiamata ad “attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, che giustificano la peculiare procedura, e la previsione di un congruo indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimoniali, cui si aggiunge il risarcimento del danno per il periodo dell’occupazione sine titulo, quantificato forfettariamente, fatta salva la prova del maggior danno.
Una medesima ispirazione di fondo, volta ad impedire che presunte ragioni sovraordinate servano solo a dissimulare abusi dei pubblici poteri, trapela anche dalle vicende nelle quali lo stato tende a riverberare in maniera del tutto causale sui privati i suoi doveri di attuazione della giustizia sociale. Il riferimento è alle numerose sentenze di condanna dello Stato italiano per le proroghe degli sfratti e per l’eccessiva durata dei relativi processi (cfr. i casi Immobiliare Saffi v. Italia del 1999, ric. n. 22774/93; Ghidotti v. Italia del 2002, ric. n. 28272/95; Sorrentino Prota v. Italia del 2004, ric. n. 40465/98). Tali condanne non intendono disconoscere la gerarchia assiologica fra diritto all’abitazione e diritti patrimoniali, ma vogliono rendere palese che lo Stato, nel redistribuire – anche tramite strumenti privatistici – i costi della giustizia sociale, deve rispettare criteri di proporzionalità nonché il principio di eguaglianza formale e sostanziale; e questo non accade se detti costi vengono puramente riversati sui privati, che casualmente si imbattono in situazioni di criticità sociale. Lo Stato non dovrebbe alimentare la contrapposizione fra proprietari e locatori; al contrario, dovrebbe: fornire sostegni economici agli indigenti affinché possano non risultare morosi; garantire benefici fiscali a chi loca l’immobile a canoni più favorevoli; mettere a disposizione gli strumenti del social housing per rendere più agevoli gli sfratti di chi non ha altra abitazione e versa in condizioni di difficoltà.
In definitiva, l’influenza della Cedu non serve a reintrodurre una logica veteroliberista della proprietà, bensì a svelare l’inganno che, dietro lo schermo della funzione sociale o della prevalenza degli interessi personali su quelli patrimoniali, palesa in realtà l’abuso dei pubblici poteri o la tendenza di questi ultimi a sottrarsi alle loro responsabilità e a scaricarle puramente e casualmente sui soggetti privati.
L’influenza sul modo di intendere gli interessi personali
Venendo all’ambito personalistico, il quadro della giurisprudenza della Corte di Strasburgo mostra, nell’ultimo ventennio, una tendenza ad addentrarsi in vicende civilistiche dense di complessi risvolti etici e bioetici: dal tema delle unioni civili (v. caso Oliari a altri v. Italia del 2015 ric. nn. 18766/11 e 36030/11) e dell’adozione del figlio del partner di un’unione civile (caso X e altri contro Austria del 2013 ric. n. 19010/07), ai profili del transessualismo (v. caso Y.Y. v. Turchia del 2015 ric. n. 14793/08), sino alle complesse tematiche connesse con la fecondazione assistita (caso Costa-Pavan v. Italia del 2912 ric. n. 54279/10; caso Parrillo v. Italia del 2015 ric. n. 46470/11) e al problema del riconoscimento del figlio nato a seguito di surrogazione di maternità effettuata all’estero (caso Mennesson v. Francia del 2014 ric. n. 65192/11 e caso Labassee v. Francia sempre del 2014 ric. n. 65941).
Traino di tali orientamenti sono stati l’art. 8 Cedu e spesso il principio di autodeterminazione, che suscitano una valutazione fortemente chiaroscurale quanto alla loro influenza sul diritto civile.
Da un lato, la Corte di Strasburgo sembra incarnare per gli stati nazionali una funzione di stimolo a ripensare soluzioni nazionali alla luce dell’evoluzione tecnologica e dell’esperienza degli altri ordinamenti europei, ma senza con questo intaccare la discrezionalità degli stati nel loro sforzo di ricostruire una qualche visione etica condivisa. Scrive, a riguardo, la Grande Camera della Corte EDU nella sentenza del 2011 ric. n. 57813/00 caso SH v. Austria che: là dove “non esist[a] alcun consenso tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa, [...] per ciò che riguarda [sia] l’importanza relativa degli interessi in gioco [sia] il mezzo migliore per salvaguardarli, in particolare laddove la causa sollevi questioni di sensibilità morale o etica, il margine [di discrezionalità] è ampio. Grazie al diretto e continuo contatto con le forze vitali dei loro Paesi, le autorità dello Stato sono, in linea di massima, in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per pronunciarsi non solo ‘sull’esatto contenuto dei requisiti della morale’ nel loro paese, ma anche sulla necessità di una limitazione destinata a dar loro una risposta [...]. Di norma vi è un ampio margine di discrezionalità se allo Stato è richiesto di stabilire un armonioso equilibrio tra opposti interessi privati e pubblici o tra diritti tutelati dalla Convenzione”.
Da un altro lato, tuttavia, non può tacersi la forte influenza che esercitano le istanze palesate dalle coscienze individuali, dinanzi al frantumarsi del monismo etico, e il conseguente potenziamento dell’autodeterminazione mano a mano che le sue ragioni si affermano nei vari stati europei. Non è in sostanza irreale ravvisare una tendenza ad assecondare l’autodeterminazione nelle singole vicende, in funzione della progressiva diffusione del trend da uno stato europeo all’altro.
Se questa è la prima immagine chiaroscurale del personalismo della Cedu, la sua seconda impronta è quella del multiculturalismo, che spiega il prevalere della fraternité sulla libertà religiosa e del best interest of the child sull’identità religiosa del nucleo familiare.
Infine, terzo tratto identificativo del personalismo della Cedu è la netta opposizione rispetto a qualsivoglia condotta risulti in qualunque modo evocativa di pericoli per la democrazia, il cui nucleo di valori aveva inteso con forza preservare la Convenzione, all’indomani del secondo conflitto mondiale. Si ascrivono a questo contesto tanto le pronunce che qualificano in termini di abuso della libertà di espressione orientamenti negazionisti dell’Olocausto quanto le sentenze che condannano ogni forma di sopruso da parte dei pubblici poteri, che si tratti del trattamento disumano dei carcerati o dell’ingiusto protrarsi dei tempi processuali.
Un particolare riverbero in campo civilistico si è avuto proprio nella vicenda dell’eccessiva durata del processo, rispetto alla quale il nostro ordinamento non è riuscito né a rispettare la logica di un intervento attuativo dell’obbligo positivo né a garantire una tutela effettiva, come l’art. 13 della Convenzione imporrebbe, al diritto di cui all’art. 6. E, infatti, il testo originario della legge Pinto si limitava a garantire il risarcimento per l’eccessiva durata del processo, spostando a livello nazionale la soluzione sussidiaria offerta dalla Cedu e, oltretutto, limitando la tutela nell’an e nel quantum. Quanto al testo riformato dalla legge di Stabilità 2016, esso finge di introdurre rimedi preventivi, mentre il suo vero obiettivo è di far gravare sui cittadini nuovi oneri, spesso inutili ai fini della riduzione dei tempi processuali, che comportano la perdita del diritto all’indennizzo. E, non a caso, non ha tardato a venire la condanna dello Stato italiano, tramite la sentenza Olivieri e altri v. Italia (del 2016 ric. nn. 17708/12, 17717/12, 17729/12 e 22994/12), per aver impedito una tutela effettiva dell’art. 6 della Convenzione, escludendo, tramite la nuova legge, finanche il diritto all’indennizzo, in caso di mancata presentazione dell’istanza di prelievo.
La responsabilità dello Stato per violazione degli obblighi positivi
La vicenda appena richiamata, con il suo riferimento all’inadeguata tutela effettiva dell’art. 6 della Cedu, introduce a considerare quella che deve ritenersi una sicura svolta nel processo di condizionamento del diritto civile da parte della Cedu: l’accoglimento, ad opera della Corte di Strasburgo, della teoria degli obblighi positivi. Recepita sin dai casi degli anni ’90 (Lopez Ostra v. Spagna del 1994, Osman v. Regno Unito del 1998 e Guerra v. Italia sempre del 1998), la teoria implica che gli stati aderenti alla Convenzione non debbano soltanto impedire la violazione dei diritti in essa contemplati, ma anche garantire la loro tutela effettiva e, dunque, l’attuazione dei relativi principi, nei limiti, pur sempre, del margine di apprezzamento riservato agli stati.
In particolare, sono gli obblighi positivi e la c.d. Drittwirkung impropria a giustificare una serie di condanne pronunciate dalla Corte di Strasburgo nei confronti di stati che non hanno adempiuto al dovere positivo (che resta un dovere verticale) di garantire la tutela dei diritti della Convenzione nei rapporti orizzontali. Si pensi alla responsabilità dello Stato per la mancata previsione di una disciplina sulla successione del convivente dello stesso sesso in un contratto di locazione, che viola il divieto di discriminazione e, al contempo, omette di dare attuazione al principio di non discriminazione (cfr. caso Karner v. Austria del 2003 ric. n. 40016/98 e caso Kozac v. Polonia del 2010 ric. n. 13102/02). O ancora si consideri il caso Ceni v. Italia del 2014 ric. n. 25374/06 nel quale la Corte ricorda che l'art. 1 Prot. n. 1 può imporre «alcune misure necessarie per tutelare il diritto di proprietà (…) anche nel caso in cui abbia ad oggetto una controversia tra persone fisiche o giuridiche [principio già affermato nel] (caso Sovtransavto Holding v. Ucraina [del 2012 ric.] n. 48553/99 ...) [e] largamente applicato nel contesto di procedure esecutive a carico di debitori privati (... caso Fuklev c. Ucraina [del 2015 ric.] n. 71186/01 ... ; caso Kesyan v. Russia del 2006 ric. n. 36496/02; caso Stib e Majkić v. Serbi [del 2010 ric.] n. 12312/05 e caso Marčić e altri v. Serbia [del 2007 ric.] n. 17556/05)». In particolare, nella sentenza Blumberga v. Lettonia (ric. n. 70930/01 del 2008), la Corte ha dichiarato che: «ogni violazione del diritto al rispetto dei beni commessa da un privato cittadino fa nascere per lo Stato l'obbligo positivo di garantire nel suo ordinamento giuridico interno che il diritto di proprietà venga sufficientemente tutelato dalla legge e che dei ricorsi adeguati permetteranno alla vittima di tale violazione di far valere i suoi diritti, soprattutto, eventualmente, chiedendo il risarcimento del danno subito».
Da quanto evidenziato risulta palese che nella tipologia di casi sopra richiamati venga implicata la responsabilità dello Stato per violazione di doveri positivi rispetto a discipline che coinvolgono i privati e non – come spesso erroneamente si sostiene – l’efficacia diretta della Cedu nei rapporti orizzontali. La ragione è evidente: ai fini di una Drittwirkung diretta non basta che i privati possano rivendicare diritti sulla base della Convenzione; sarebbe, infatti, a tal fine necessario che anche i doveri di protezione gravassero direttamente sui privati. Ma questo non accade, in quanto la Cedu ha visto un’assunzione di doveri da parte dei soli stati nazionali, i quali non possono limitarsi a riversare i loro doveri in capo ai privati per ottemperare ai propri impegni.
Simile constatazione, al contempo, non esclude che, proprio in virtù della teoria degli obblighi positivi, un’efficacia orizzontale diretta possa ravvisarsi fra un privato ed un soggetto pubblico, sul quale il dovere di protezione grava in via immediata, e che, finanche nei rapporti fra solo privati, la Convenzione possa ritenersi efficace, purché il suo riverbero risulti mediato dai principi costituzionali. In altri termini: la Cedu condiziona l’interpretazione dei principi costituzionali e questi hanno la capacità di riflettersi in via indiretta e, a particolari condizioni, anche in via diretta sui rapporti fra privati.
La proiezione diretta della CEDU nei rapporti fra soggetti pubblici e privati e la proiezione mediata dai principi costituzionali nei rapporti fra privati. Gli obblighi positivi della CEDU come spinta alla c.d. lacuna incostituzionale
Il passaggio dalla responsabilità civile degli Stati (c.d. Drittwirkung impropria) a meccanismi di proiezione orizzontale diretta o indiretta della Cedu si deve all’estensione degli obblighi negativi e positivi, assunti con la Convenzione, al potere giudiziario, come è stato esplicitamente chiarito sin dal caso Öneryıldız v. Turchia del 2003 ric. n. 24351/94.
In particolare – come sopra anticipato – di vera e propria efficacia diretta può parlarsi quando un rapporto orizzontale lega un privato ad un soggetto pubblico. In tal caso il giudice, dovendo assicurare l’effettività dei principi della Convenzione e facendo questa sorgere direttamente obblighi in capo ai soggetti pubblici, può immediatamente applicare i principi della CEDU alla relazione orizzontale. Si consideri il caso del contratto di lavoro fra un ente pubblico e un docente (il caso Vallauri v. Italia del 2009 ric. n. 30128/05) o le numerose ipotesi nelle quali un soggetto pubblico tollera, sino ad ingenerare un affidamento, una serie di condotte legate all’esigenza di soddisfare il diritto all’abitazione: l’occupazione non autorizzata di proprietà pubbliche (caso Chapman v. the United Kingdom del 2001 ric. n. 27238/95; caso Connors v. Regno Unito, del 2004 ric. n. 66746/01; caso Yordanova and Others v. Bulgaria del 2012 ric. n. 25446/06; caso Winterstein and Others v. France del 2013 ric. n. 27013/07) o l’abitazione di edifici colpiti dall’obbligo di demolizione (caso Ivanova e Cherkezov v. Bulgaria del 2016 ric. n. 46577/15) o l’abitazione di edifici popolari in presenza di eviction (caso Krivitskaya and Krivitskiy v. Ukraine del 2010 ric. n. 14031/09; caso Igor Vasilchenko v. Russia del 2010 ric. n. 34784/02; caso Bjedov v. Croatia del 2012 ric. n. 42050/09). In tali vicende viene operata una diretta proiezione della Cedu e viene garantito, in base all’art. 8, il diritto all’abitazione, in ragione di una ritenuta proporzionalità del sacrificio della posizione pubblicistica a beneficio di un bisogno sociale indifferibile, che sempre il soggetto pubblico deve garantire.
La questione si pone in termini radicalmente differenti quando il rapporto lega unicamente soggetti privati. Se è vero, infatti, che sul giudice grava l’obbligo di garantire l’attuazione dei principi della Cedu, egli tuttavia non può puramente traslare gli obblighi scaturenti dalla Convenzione in capo ai privati.
Quello che, invece, il giudice civile può (e deve) fare è di orientare l’interpretazione delle disposizioni nazionali affinché non violino i principi della Cedu e ne realizzino il più possibile i contenuti precettivi.
Può, tuttavia, verificarsi o che le disposizioni nazionali contrastino in maniera irrimediabile con i principi della Convenzione o che palesino una vera e propria lacuna rispetto all’obbligo positivo di dare attuazione ai principi della Cedu.
E’ in questi casi che viene in ausilio la natura di norme interposte propria delle disposizioni della Convenzione. Nella misura, infatti, in cui i principi della Cedu si integrano e si coordinano con i principi costituzionali, essi, da un lato, consentono di impostare un giudizio di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 C. e, da un altro lato, permettono di considerare la lacuna nell’attuazione delle disposizioni della Convenzione quale lacuna incostituzionale. Ad essa con determinati limiti e con particolari accorgimenti può, dunque, porre rimedio lo stesso giudice civile, traendo spunto dai principi costituzionali nel loro coordinamento interpretativo, ex art. 117 C., con i principi della Cedu.
Affinché tale meccanismo operi deve vertersi in una materia che non implichi un elevato margine di valutazione discrezionale né che la materia sia coperta da una riserva di legge di fonte costituzionale.
Nel rispetto di tali limiti, l’intervento integrativo del giudice, trainato dai principi costituzionali e spinto dalla necessità di colmare una lacuna palesata proprio dal confronto con gli obblighi positivi assunti con la Convenzione, deve cercare, potenziando l’argomentazione, di compensare il deficit di democraticità insito nella regola elaborata dal giudice. Questi deve cioè ricostruire, a partire dai principi, la regola più adeguata al caso attraverso gli orientamenti che trae da quello che può definirsi un ‘sistema giuridico aperto’. Tale espressione sintetizza lo sforzo di concretizzare il bilanciamento di interessi, tenendo conto degli equilibri sottesi al sistema positivo nazionale e traendo spunti e linfa innovativa dal confronto con altri sistemi ispirati ad analoghi principi nonché con la giurisprudenza delle Corti internazionali.
Emblematico di questo tipo di ragionamento può ritenersi il caso deciso dalla Cassazione nel 2017 n. 1946 sul c.d. parto anonimo, nel quale, individuata una ‘lacuna incostituzionale’ determinata dalla mancanza di una normativa attuativa dei principi della Cedu nel loro raccordo con i principi costituzionali, si cerca, attraverso una complessa rete di argomentazioni, di ricostruire la regola mancante, persistendo l’inattività del legislatore.
La teoria degli obblighi positivi e il potere del giudice rispetto alla C.E.D.U. nel diritto di competenza dell’Unione
L’ultima considerazione da svolgere rispetto all’efficacia della Cedu nei rapporti fra privati riguarda la sua rilevanza quale fonte di principi riconosciuti dall’Unione europea.
Il contestuale riconoscimento delle norme della Cedu quali principi dell’Unione e quali strumenti di interpretazione della Carta suscita immediatamente l’alternativa fra un possibile ruolo meramente ancillare nella ricostruzione del significato della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione o l’attribuzione alla Convenzione, nei limiti del diritto dell’Unione, del medesimo potere che ha la Carta di fondare un giudizio di disapplicazione del diritto nazionale.
Sul tema si è espressamente pronunciata la Corte di Lussemburgo che ha negato, sin dai casi Kamberaj (571/10 del 2012) e Åklagaren (C-617/10), la possibilità che il contrasto con le norme della Cedu legittimi un giudizio di non applicazione del diritto nazionale. La ragione è che “l’articolo 6, paragrafo 3, TUE non disciplina il rapporto tra la Cedu e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale”. In sostanza, l’Unione europea può impegnarsi a rispettare nei propri atti la Convenzione, ma non può vincolare gli stati membri al suo rispetto con gli stessi meccanismi tipici del diritto dell’Unione, sicché non può trasformare l’incidenza delle norme Cedu sui diritti nazionali (e lo stesso vale per le tradizioni costituzionali comuni) nella medesima influenza che le stesse hanno sugli atti emanati dall’Unione.
Ebbene, se tale argomentazione è inappuntabile non può non rilevarsi anche l’implicito riconoscimento del rilevante salto logico che è stato realizzato rispetto ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Questi, esattamente alla stessa stregua dei principi della Cedu e delle tradizioni costituzionali comuni, sono stati meramente riconosciuti, dal Trattato di Lisbona, come principi che non estendono le competenze normative dell’Unione. Delle due dunque l’una. O l’Unione ammette di poter assoggettare solo i propri organi al rispetto di principi riconosciuti come fondamentali, ma di non poter coinvolgere nelle conseguenze di tale riconoscimento gli stati membri, o sostiene che, in nome di una concezione ordinamentale unitaria fra Unione e stati, il diritto nazionale, che rientra nell’abbraccio della competenza dell’Unione, dovrebbe essere automaticamente coinvolto dalle scelte dell’Unione.
È allora evidente che nel primo caso la Corte di Giustizia non avrebbe potuto ammettere un potere di disapplicazione per contrasto con la Carta, nel secondo caso lo dovrebbe riconoscere per contrasto con tutti i principi che alla medesima stregua della Carta sono qualificati, nel Trattato, come principi dell’Unione. In definitiva, non può non rilevarsi l’anomalia di un sistema che, per un verso, conferisce alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea il potere di attuare un controllo di costituzionalità diffuso sul diritto dell’Unione, ma, per un altro verso, nega la medesima attitudine a principi che hanno la stessa qualificazione formale della Carta, anzi forse possono vantare di essere stati approvati dagli stati non soltanto con il Trattato dell’Unione, ma anche con un ulteriore accordo (almeno per quanto concerne gli stati dell’Unione che sono anche aderenti alla convenzione) o – come nel caso delle tradizioni costituzionali comuni - che appartengono alle radici costituzionali nazionali.
La verità è che la scelta della Corte di Giustizia di costruire sulla base dell’art. 6 TUE un vero e proprio controllo di costituzionalità diffuso sul diritto di competenza dell’Unione europea è stata una scelta istituzionalmente dirompente, se non eversiva, che ha finito per sovrapporsi e per competere sia con il controllo attuato dalla Corte di Strasburgo sia con il controllo di costituzionalità attuato a livello nazionale, sicché la stessa Corte di Giustizia ha ritenuto opportunamente di porre un argine a tale ingerenza, limitando il controllo attuato secondo le logiche istituzionali del diritto dell’Unione alla sola Carta dei diritti, ossia alla fonte di diretta emanazione dell’Unione. In altri termini, dietro il paradosso giuridico di utilizzare un argomento che delegittima lo stesso operato della Corte di Giustizia rispetto alla Carta dei diritti, si cela una precisa scelta politica. L’intento è quello di costruire un controllo di conformità ai principi fondamentali distribuito su tre poteri giudiziari – la Corte di Giustizia; la Corte di Strasburgo; le Corti costituzionali nazionali – assegnando a ciascuna il potere di dire l’ultima parola su una precisa fonte – la Carta dei diritti, la CEDU, le Costituzioni nazionali – ma imponendo al contempo a tutte di ricercare un coordinamento ermeneutico teso a superare la complessità dei potenziali conflitti.
2) Costituzione e CEDU per il civilista: sovrapposizione, contrapposizione, ordinazione gerarchica?
Nicolò Lipari
La domanda riflette – com’era inevitabile che fosse, visto che è fisiologico che le domande di un’intervista riecheggino il comune sentire – la vecchia teoria delle fonti e quindi ripropone il modello di un diritto che scende dall’alto di atti di posizione e che conseguentemente richiede che questi atti vengano fra di loro coordinati e quindi posti in rapporto di conciliazione o ordinazione gerarchica. E’ questa la cultura alla quale tutti siamo stati educati e che per un certo periodo è apparsa riflessa nella stessa giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, la quale ha a lungo parlato di “rapporto fra ordinamenti” per qualificare la relazione fra ordinamento interno e ordinamento di fonte europea. Quando tuttavia io constato che una delle più attente e colte studiose del problema, Emanuela Navarretta, parla di un “latente conflitto” fra il controllo di costituzionalità diffuso, guidato dalla Corte di giustizia, e il giudizio delle Corti costituzionali nazionali, arrivando a costruire la figura di una “gerarchia funzionale” (che, a ben vedere, è quasi un ossimoro, perché riconduce il rapporto gerarchico, che dovrebbe essere valutato a monte, all’esito delle modalità di esercizio), ne ricavo la conclusione che il problema va risolto nella specificità della vicenda concreta, non nel richiamo a priori ad una categoria classificatoria.
Nel momento in cui noi riconosciamo la realtà di un diritto che si svincola dal vecchio postulato che lo riconduceva alla sola dimensione potestativa e lo qualifichiamo come sapere pratico che, nel modo stesso di svolgersi, trasforma sia il soggetto che l’oggetto della conoscenza, la stessa costituzione ci appare in una nuova veste; va assunta non come espressione di una auctoritas, ma come lettura di un diritto ex parte societatis. La stessa ottica ovviamente va assunta per il diritto di derivazione comunitaria.
Mi sembra che quella che altre volte ho chiamato l’effettività del diritto comunitario oggi non possa che misurarsi sul piano dei rapporti concreti scontando, almeno per un certo periodo, alcune persistenti frizioni. Come è noto, la Corte di giustizia, dopo avere ritenuto inaccettabile ogni limite interno alla piena affermazione delle norme comunitarie, ha riconosciuto a sè stessa l’impegno di garantire i diritti fondamentali collocandoli sull’unica piattaforma delle “tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri”. Certo, nel momento in cui la nostra Carta costituzionale afferma l’esistenza di uno zoccolo duro di principî fondamentali sottratti allo stesso procedimento di revisione costituzionale, non si può, in astratto, escludere la possibilità di un conflitto. E’ chiaro tuttavia che, sul terreno dei diritti fondamentali, ciò appare sempre meno probabile, proprio perchè, come ha ammonito Rodotà, oggi viviamo in una permanente tensione verso l’universalità e l’uguaglianza nei diritti, che pur riconosciamo come effetto di un vitalismo spontaneo, e non semplicemente derivati dall’attribuzione del sovrano o quale esito del potere costituente democratico.
Qualche attrito sarà semmai ancora inevitabile, nella specificità di singoli casi, con riferimento alla difficoltà di bilanciare la tutela del soggetto con altri indici di valore ovvero con ferite che rimangono ancora dolenti nella sensibilità comune di un Paese come il nostro che ha sofferto stagioni difficili di tensioni sociali. E’ quanto, per esempio, è avvenuto con la recente decisione della Corte di Strasburgo sul c.d. ergastolo ostativo. Ma è evidente che si tratta di un problema che non potrà essere risolto alla luce di categorie classificatorie preconfezionate. La logica delle categorie deve ritenersi ormai inesorabilmente perenta proprio perché dobbiamo abituarci a misurarci con una realtà sempre mutevole che può essere finalisticamente orientata in chiave ricostruttiva, e quindi non meramente esecutiva, da principî che la collettività di riferimento condivide in chiave di valore. Quella che oggi i giornali propongono nell’ottica di una contrapposizione istituzionale va letta quindi come un momento di passaggio non risolubile alla stregua di strumenti formali, ma destinato inevitabilmente a stemperarsi nella essenziale coerenza dello svolgimento storico. La ancor più recente decisione della nostra Corte costituzionale volta ad adeguarsi, in buona sostanza, al principio espresso in sede europea sul trattamento da riservare ai condannati ad un ergastolo ostativo dimostra, a ben vedere, la volontà di non creare conflitti indirizzando la sensibilità collettiva verso quello che è ragionevole individuare come un esito in prospettiva inevitabile. Il che naturalmente non esclude che, nel tempo breve, proprio in funzione delle tensioni che attraversano il nostro tempo, la soluzione possa non essere pacificamente accolta e sia quindi gravida di potenziali conflitti. Vicende analoghe si sono verificate e si verificheranno sempre anche all’interno di esperienze giuridiche dai definitivi confini nazionali. Basterebbe pensare al dibattito suscitata dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione sul caso Englaro, che indusse un sistema politico debole, condizionato da modelli culturali superati ma tuttora presenti in una parte della collettività sociale, a sollevare un assurdo conflitto di attribuzioni. Anche lì si trattava di un diritto fondamentale di nuovo conio, che tuttavia incontrava ancora difficoltà ad essere accolto e condiviso dalla totalità dei consociati.
Non si tratta dunque di ricondurre la dialettica alla perentorietà di una formula, ma di ricostruirla, volta per volta, nella specificità di rapporti vissuti nel perseguimento del principio dell’effetto utile che ormai – nel quadro del nuovo ruolo riconosciuto al giudice nel processo attuativo del diritto – significativamente caratterizza il rapporto tra ordinamento interno e ordinamento comunitario. Fermo tuttavia restando che quando parlo di “rapporto” uso una mera convenzione di linguaggio, posto che, nel contesto europeo, ciascun ordinamento nazionale compie un’opera di metabolizzazione (e quindi di sintesi) dei propri principî fondativi con quelli di fonte europea. In un quadro complessivo che tende progressivamente ad omologarsi in chiave di valore.
Emanuela Navarretta
Quanto sopra esposto prelude alla constatazione di una tendenziale sovrapposizione di materie – la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo – fra Costituzione e Cedu, che reca seco una potenzialità di contrapposizioni, destinate ad essere risolte tramite un coordinamento interpretativo, che solo in casi di estrema e non risolvibile conflittualità trova soluzione nella priorità gerarchica del nucleo essenziale dei principi costituzionali. Più precisamente, il rispetto delle norme della Cedu e delle interpretazioni offerte dalla Corte di Strasburgo sollecitano una rielaborazione in chiave europea dei principi costituzionali, ma questi non possono risultare alterati nella loro essenza dalla Cedu. Per il civilista, così come per qualsiasi altro giurista, il ruolo della Cedu rispetto alla Costituzione è, dunque, chiaramente delineato dalla loro qualificazione quali norme interposte.
I principi CEDU e la Corte di Strasburgo esercitano una sollecitazione rispetto a meccanismi di eccessiva fedeltà alla tradizione o di eccessiva tolleranza di talune condotte dei pubblici poteri, ma tale funzione resta soggetta ad una valutazione di sintesi da parte della Corte costituzionale, che deve cercare di cogliere gli stimoli che provengono dalla Corte di Strasburgo, senza stravolgere o violare l’interpretazione dei principi costituzionali, al cui nucleo essenziale spetta in ultima battuta una priorità gerarchica.
A questo tipo di valutazione, alla quale può e deve contribuire anche la giurisprudenza ordinaria, che è a diretto contatto con i problemi reali, non è estranea ovviamente l’ipotesi che si palesino attriti.
Rispetto a tali casi, prima che si possa ravvisare un elemento di rottura con gli impegni assunti con la Convenzione, lo Stato deve rivendicare un ambito di rispetto del margine di apprezzamento statuale.
In questa prospettiva rivestono un significato particolarmente rilevante i Protocolli 15 e 16 della Cedu.
Il primo ribadisce che: “conformemente al principio di sussidiarietà, le Alte Parti contraenti godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei Diritti dell’Uomo istituita dalla presente Convenzione”.
Il secondo lascia presagire, tramite il parere preventivo consultivo, la possibilità di un confronto che non solo dovrebbe agevolare l’avvicinamento fra l’approccio della Corte di Strasburgo e quello delle Corti Costituzioni nazionali, ma presumibilmente dovrebbe lasciare alle Corti un margine di adattamento capace di evitare il diretto contrasto con i principi della Cedu.
3) Quali sono, a suo avviso, in materia civile i settori sui quali i livelli di protezione garantiti dalla CEDU potranno svolgere un peso rilevante nel prossimo futuro?
Nicolò Lipari
Dalle risposte precedenti mi pare emerga in maniera sufficientemente chiara che i diritti dell’uomo si affermano, a mio giudizio, per forza propria. Nel momento in cui la Carta dei diritti fondamentali, abbandonando la prospettiva economica dei vecchi trattati, intitola i suoi sei capitoli a dignità, libertà, eguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia tocca profili ineludibili di garanzia, che il nostro assetto costituzionale non può non riconoscere, quali che possano esserne le articolazioni concrete.
Al di là delle debolezze di un sistema politico come il nostro, ancora troppo legato ad un’ottica di corto raggio e pesantemente condizionato da una persistente dialettica tra convenienze di parte, mi auguro che il nostro quadro istituzionale – soprattutto per la decisiva incidenza del ruolo svolto dalla Corte costituzionale – abbia in sé sufficienti anticorpi per garantire la tutela dei diritti fondamentali. Tanto più che le sentenze della CEDU con le quali viene accertata una violazione della Convenzione hanno un valore meramente dichiarativo, non avendo direttamente possibilità di incidere sull’ordinamento dello Stato convenuto e che gli obblighi in ipotesi imposti per l’eliminazione delle conseguenze della violazione si offrono alle ambiguità applicative dell’art. 41 della Convenzione, che – come è noto – ha consentito molto spesso allo Stato autore di una violazione di non modificare il suo ordinamento così da restituire al ricorrente le chances delle quali egli era stato privato in modo ritenuto dalla Corte non compatibile con la Convenzione.
Per quanto riguarda l’Italia, se una previsione nel tempo breve può ritenersi legittima, io credo che gli interventi più frequenti della CEDU si verificheranno ancora con riguardo alla pesantezza e farraginosità del nostro sistema processuale con conseguente lesione di quel diritto a vedere riconosciuti i propri diritti entro un “termine ragionevole” che il nostro ordinamento processuale incontra tante difficoltà ad attuare e che, a prima vista, non sembra potrà essere risolto neppure dal recente disegno di legge che reca deleghe al Governo anche per l’efficienza del processo civile.
Con riguardo ad altri temi è difficile fare previsioni. La mia personale speranza è che progressivamente si vada affermando la convergenza di due linee: quella di un sistema politico capace di abbandonare gli artifici del passato per intendere che la salvezza del nostro tempo si realizzerà solo nell’ottica di un’autentica politica dei diritti e quella di un sistema giudiziale sempre più attento ad assicurare una simile garanzia al di là delle stesse consapevolezze delle parti e dei loro difensori. Semmai, se una preoccupazione è legittimo formulare, la coglierei in quella meschina venerazione del principio di maggioranza che sembra oggi ottundere le capacità prospettiche dei nostri politici. Come ci hanno addirittura insegnato i sovrani assoluti del passato, l’esercizio del potere, quale che ne sia il fondamento, deve comunque cedere di fronte alla legge di ragione. E questo vale anche per la forza del numero. Troppe volte oggi dimentichiamo che la tutela del singolo – nella sua nudità, nella sua modestia, nella sua povertà – deve inesorabilmente prevalere sulle convenienze dei più, risultino pure queste consegnate alla apparente forza edittiva di enunciati normativi.
Emanuela Navarretta
Gli ambiti civilistici nei quali le garanzie offerte dalla Cedu avranno presumibilmente in futuro maggiore incidenza possono ricondursi a tre macro settori.
Il primo si lega all’incessante sviluppo delle nuove tecnologie, dalla Blockchain all’AI, le cui sconfinate potenzialità applicative implicheranno una peculiare attenzione alla tutela dei diritti umani, tant’è che il Consiglio d’Europa ha costituito un apposito Comitato dedicato proprio a “Intelligenza artificiale e diritti umani”. Al contempo, le nuove tecnologie entreranno sempre più incisivamente negli aspetti più delicati della vita dell’uomo, dal nascere al morire, il che lascia presagire una centralità delle “scelte tragiche” poste dai temi della bioetica.
Tale sviluppo si percepisce chiaramente leggendo il recentissimo caso Cappato, deciso dalla Corte costituzionale (n. 207/2018), nel quale i nostri giudici delle leggi, pur senza cadere nella tentazione di assolutizzare il volontarismo e l’autodeterminazione di cui agli artt. 2 e 8 della CEDU, appaiono tuttavia fortemente condizionati dalle sollecitazioni offerte dalla Corte di Strasburgo, nel suo dialogare a livello europeo con una molteplicità di Corti costituzionali nazionali.
Un secondo ambito di rilevanza resterà, senza dubbio, quello della lotta agli abusi e alle inettitudini dei pubblici poteri, destinati a potenziarsi anche in conseguenza del perpetrarsi di difficoltà economiche e di congiunture di crisi. Emblematico il recentissimo caso Ilva che ha visto la condanna dello Stato italiano (Cordella e altri v. Italia, del 24 gennaio 2019, r. nn. 54414/13 e 54264/15), per l’assoluta incapacità di individuare e di mettere in campo soluzioni idonee a garantire un’adeguata ed effettiva tutela della salute e dell’ambiente, magari preservando anche le ragioni dei lavoratori.
Talora poi l’inettitudine lascia il campo a mera superficialità, come nei casi – anch’essi recentissimi – di minori non ascoltati e irreversibilmente allontanati dai propri genitori per effetto di mere trascuratezze e lentezze che finiscono per rendere definitivi provvedimenti che avrebbero dovuto essere provvisori e limitati nel tempo (si veda il caso R.V. e altri v. Italia del 2019, ric. n. 37748/13).
Da ultimo, a fronte del rinascente populismo e del diffondersi di una memoria obnubilata rispetto agli orrori della prima metà del novecento, non può non presagirsi una rinnovata linfa a favore della primigenia vocazione della Convenzione, che proprio quegli orrori si riproponeva primariamente di combattere. E così ancora nel 2019 siamo costretti a leggere nella sentenza Pastörs v. Germania di nuovi casi di negazionismo della Shoah che, con grande fermezza, la Corte di Strasburgo opportunamente sottrae al velo protettivo della libertà di espressione.
4) Nel ragionamento giuridico che svolge l’interprete chiamato ad applicare la legge in una controversia civile quale incidenza ha prodotto o dovrebbe produrre, a suo avviso, la CEDU?
Nicolò Lipari
La domanda tocca il nocciolo essenziale della giuridicità nell’esperienza contemporanea. Che cosa significa oggi ragionare di diritto? Cosa deve fare l’interprete, e segnatamente il giudice, quando è chiamato ad “applicare la legge”? In che modo e come gli è utile far richiamo ad indici apparentemente esterni ai suoi obbligati punti di riferimento, quale appunto potrebbe essere la giurisprudenza della CEDU? Sono risposte che ho cercato di fornire nel mio ultimo libro e che mi sembra difficile poter riassumere qui.
Si tratta purtroppo di superare le sedimentazioni di una vecchia cultura di stampo positivista, che ancora si trova – come ho detto –, al di là delle apparenze, pesantemente riflessa nella struttura didattica delle nostre Facoltà giuridiche. Per fare un esempio soltanto, la sentenza sul caso Englaro, che sopra ho citato, non è stata soltanto accolta da un ottuso sistema politico come un tentativo di invadere i poteri del legislatore, ma è stata giudicata con sufficienza e diffidenza anche da un’ampia parte del mondo accademico. Uno dei più diffusi manuali istituzionali tuttora la definisce come “eversiva”. Quella sentenza fondava la sua conclusione su di un’ampia e articolata lettura di un intero contesto culturale (che è evidentemente la base fondativa dei diritti), facendo riferimento non solo alla giurisprudenza della CEDU, ma anche ad indici più lontani, oggi tuttavia non eludibili in un mondo globalizzato, come, ad esempio, la legge fondamentale del New Jersey.
Una miope lettura dell’art. 101 cpv. cost. (che giustamente, di recente, Paolo Grossi ha escluso possa esprimere una relazione di tipo gerarchico) – purtroppo sistematicamente riproposta dai mass-media – pretende di offrire al giudice il panorama esclusivo di un testo normativo, per giunta assunto in un suo definito contenuto. Nel momento in cui – come io credo si debba fare – si svincola il diritto dalla datità di un sistema di norme poste e lo si riconduce al modo d’essere di un’esperienza nella realtà di valori condivisi, cade tutta una serie di preconcetti che hanno condizionato i nostri vecchi modelli ricostruttivi e interpretativi. La Corte costituzionale ha usato il paradigma del diritto vivente, anche qui incontrando non poche resistenze: dal rifiuto radicale (si pensi allo scritto sul tema di un maestro del diritto civile come Francesco Santoro-Passarelli) alla lettura riduttiva di quanti lo hanno semplicemente inteso come una valutazione delle norme poste passata al vaglio di una radicata interpretazione giurisprudenziale. Se invece riusciremo finalmente a capire che il diritto va assunto non come scienza teoretica, che quindi presuppone la definita individuazione del suo oggetto, ma come scienza pratica, che si viene definendo nei modi di svolgimento della prassi applicativa, allora non potremo non convenire nel riconoscere che oggetto delle nostre analisi – quale che sia il ruolo del quale siamo investiti come operatori del diritto – non è un sistema di testi, ma la realtà di un contesto che qui esige di essere valutato in tutte le sue componenti. Gli interventi della CEDU vanno letti in questo quadro, senza pretesa di esclusività, ma con riconoscimento della loro crescente incidenza sulla formazione dei correnti modelli culturali. Io ho creduto di ricondurre questo modo di argomentare ad un recupero del principio di ragione che, nella stagione del postmoderno, ha finito per perdere quelle connotazioni di verificabilità che gli erano proprie quando veniva accostato al modello matematico, nella consapevolezza tuttavia che esso viene concepito come approssimazione, come verosimiglianza in un contesto in cui prevale il senso della misura o del limite, fermo restando il disimpegno da qualsiasi implicazione di ordine metafisico.
Se siamo consapevoli che la questione dei diritti ormai inevitabilmente si intreccia non solo con la nostra storia individuale ma anche con i destini stessi del mondo, non possiamo come giuristi non farcene carico. E’ nostro compito far sì che la rappresentazione dei diritti non può più essere ricondotta ad un soggetto astratto, ad un individuo disincarnato, ma esige di essere riferita alla fisicità e alla drammaticità dell’esperienza corrente e quindi chiede a ciascuno di noi – e prima di ogni altro al giudice – di fare quanto necessario per realizzarne la garanzia, quali che siano gli strumenti argomentativi necessari per conseguire il risultato.
Emanuela Navarretta
La risposta a questa domanda emerge in buona parte dal ruolo che riveste la Cedu, già sopra ampiamente illustrato.
Segnatamente, tolti i casi nei quali una controversia civile coinvolge a fronte del privato un soggetto pubblico, sul quale gravano in via diretta gli obblighi positivi e negativi della Cedu, nelle altre ipotesi, le norme della Convenzione influenzano il diritto civile negli stessi termini in cui questo è influenzato dai principi costituzionali, essendo i principi della Cedu evocati dall’art. 117 C.
Il diritto civile, dunque, deve risultare coerente con i principi della Cedu nel loro raccordo con i principi costituzionali, il che vuol dire che le sue disposizioni devono essere interpretate alla luce di quei principi, nel loro reciproco coordinamento.
Ove poi le disposizioni civilistiche si dovessero dimostrare in contrasto rispetto a quei principi, il giudice è chiamato – sempre con lo strumento dell’interpretazione - a tentare di operare delle ricostruzioni riduttive o estensive delle disposizioni in modo da fare spazio ad una ricostruzione della regola attraverso i principi.
E solo ove questo procedimento trovasse ostacoli insormontabili nella formulazione delle disposizioni dovrebbe sollevarsi la questione di costituzionalità.
Infine, l’ultima ipotesi è quella in cui il giudice riscontri, ab imis o a seguito di un procedimento interpretativo, la lacunosità del sistema nell’attuazione dei principi della Cedu, sicché, per il tramite dell’art. 117 C., la lacunosità rispetto alle disposizioni della Cedu può riverberarsi in una lacuna incostituzionale. In tal caso, il giudice dovrebbe cercare di ricostruire, nei termini già sopra illustrati, cioè nel coordinamento fra principi, caso e sistema giuridico “aperto”, la regola mancante. In particolare, il giudice deve cercare di rielaborare una regola per il caso, supportando la sua ricostruzione con argomenti tratti dal modo in cui i principi sono stati in passato interpretati, dal modo in cui il sistema positivo riflette gli equilibri fra gli interessi in conflitto, dal confronto con l’esperienza di sistemi giuridici ispirati a principi analoghi a quelli nazionali e dal confronto con gli orientamenti delle Corti internazionali. Chiaramente, come già in precedenza evidenziato, la lacuna non può essere colmata dal solo interprete in quelle materie che richiedono scelte altamente discrezionali, che solo un parlamento può assumersi, si pensi al matrimonio fra persone dello stesso sesso, o se ricorrono materie sottoposte ad una riserva di legge di fonte costituzionale.
Se l’influenza dei principi della Cedu sul diritto civile, per il tramite dell’art. 117 C., già induce a distinguere l’attuazione di principi che può essere affidata all’interprete da quella che resta di necessità affidata al legislatore, la mediazione dell’art. 117 Cost. non rende ovviamente automatico il richiamo ai principi della Convenzione.
Il giudice civile, infatti, non diversamente da quanto opera la Corte costituzionale, è chiamato a fornire una ricostruzione coordinata delle norme Cedu con i principi costituzionali fondamentali, non potendo l’impegno assunto dallo Stato derogare ai valori fondanti del nostro ordinamento. Per questo le ricostruzioni della Corte di Strasburgo devono essere fonte di ispirazione per il giudice al fine di dare una lettura il più possibile ‘europea’ dei principi costituzionali, ma non possono in via di automatismo essere traslate sul sistema civilistico, senza averne previamente accertato la compatibilità con i principi della Costituzione.
Da ultimo, quanto il giudice sicuramente non può effettuare è la disapplicazione diretta o indiretta di norme di legge per contrasto con i principi costituzionali e, a fortiori, per contrasto con i principi della Cedu. Tale potere si porrebbe, infatti, in insanabile contrasto con la stessa Costituzione che affida in via esclusiva alla Corte costituzionale la competenza della declaratoria di illegittimità. In particolare, occorre prestare attenzione a quei tentativi di applicazione di criteri generalissimi che si presumono applicativi di principi, ma che finiscono per rendere inutili (e dunque di fatto finiscono tacitamente per disapplicare) disposizioni che richiedono presupposti applicativi che verrebbero resi inutili dal criterio generale.
Del resto, come si è sopra precisato, il giudice non ha il potere di disapplicare norme per contrasto con i principi della Cedu neppure nell’ambito di competenza dell’Unione europea e ciò in quanto la stessa Corte di Lussemburgo non ha esteso alla Cedu l’attitudine ad operare un tipo di controllo che già rispetto alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea presenta profili di ‘invadenza’ nei confronti delle competenze delle Corti costituzionali.
5) Quali oneri aggiuntivi, a suo avviso, incombono sul giudice e sull’avvocato che si occupa di civile rispetto alla conoscenza ed applicazione della CEDU e del suo diritto vivente?
Nicolò Lipari
La domanda risente, nei modi della sua formulazione, di quel modello culturale contro il quale mi vado battendo da anni. E’ chiaro che parlare di “oneri aggiuntivi” suppone l’individuazione di una struttura definita, di un paradigma consolidato cui ricondurre il processo interpretativo e applicativo del diritto; sembra cioè fare riferimento ad uno schema procedimentale delineato nei suoi contorni cui appunto si possa, in funzione del riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ovvero dell’applicazione che non ne ha fatto la Corte di Strasburgo, aggiungere qualcosa di non abituale e da indicare semmai in prospettiva come capace di creare nuovi procedimenti operativi.
Mi sembra superfluo richiamare in questa sede l’ampio dibattito che si è venuto negli ultimi tempi svolgendo fra i giuristi sulla crisi della fattispecie. L’operatore giuridico si sente in qualche modo tranquillizzato dal fatto di poter fare riferimento a costruzioni definite, a immagini standardizzate, nella convinzione che solo così si può garantire l’uniformità di trattamento tra casi simili. L’esperienza del postmoderno che, nella frantumazione di vicende sempre diverse, ha condotto a quella che Francesco Viola ha definito “la legalità del caso”, ha rotto questo schema, facendo sempre più della decisione non solo un modo per risolvere i casi correnti sulla base di regole date, ma ancor più un modo di costruire la regola del caso concreto. Come è stato esattamente rilevato (Zaccaria), uno dei problemi fondamentali del diritto di oggi è quello della formazione della regola, sul presupposto che l’interpretazione della norma giuridica non è un’operazione che si possa separare dalla sua applicazione, posto che questa non è una parte accidentale e secondaria del fenomeno da comprendere, ma lo costituisce nella sua essenza fin dall’inizio. Il processo di applicazione delle regole entra a far parte dell’essere stesso del diritto come suo elemento fondamentale.
Ebbene: i diritti dell’uomo sono da questo punto di vista esemplari, perché prescindono da ogni riconduzione a paradigmi astratti ed esigono di essere riconosciuti e garantiti nella specificità delle situazioni concrete in cui si esprimono e possono, in ipotesi, essere compressi e violati. Basterebbe pensare al primo e più essenziale di quei diritti, quello della dignità umana, che – come è stato ormai pacificamente ammesso – si sottrae persino ad ogni possibile tentativo di definizione. E’ stato giustamente detto che, nel caso dell’idea di dignità, una formula sintetica a priori che attragga le fattispecie concrete successive è introvabile, proprio in funzione dell’”essenziale irriducibilità della dignità alla logica e alla grammatica dei diritti soggettivi” (Rosen). Pur con gradi diversi io credo che, ragionando di “diritti dell’uomo”, noi dovremmo, al di là dell’ambiguità del linguaggio, abituarci ad un’ottica di questo tipo. Dovremmo cioè progressivamente capire che esiste una terra in cui la mancanza di un definito (spesso addirittura definibile) contenuto normativo non esclude la tutela proprio perché la persona va garantita nella pienezza (e talora singolarità) dei suoi attributi, che si vanno oltre tutto arricchendo nel progredire della storia.
Non ci dobbiamo spaventare se, nella ricerca del modello antropologico dell’“homo dignus”, non ci sarà possibile fare riferimento a paradigmi applicativi uniformi ovvero riducibili a modalità attuative che siano suscettibili di indicazioni paradigmatiche. Forse è proprio il riferimento ai diritti dell’uomo che consentirà il passaggio dal formalismo egualitario delle vecchie costituzioni all’eguaglianza sostanziale di cui il capoverso dell’art. 3 della nostra Carta fondamentale. In sostanza, se davvero a qualcosa di “aggiuntivo” è necessario pensare, si potrebbe proporre (ma sarebbe una rivoluzione) di cambiare la scritta che campeggia in tutte le aule dei nostri Tribunali. Alla formula “la legge è uguale per tutti”, bisognerebbe aggiungere: “ma il diritto deve essere inesorabilmente diseguale”.
Emanuela Navarretta
L’onere aggiuntivo è certamente rilevante.
Al giudice e all’avvocato è necessaria una profonda conoscenza non solo dei principi della Cedu e degli orientamenti della Corte di Strasburgo, ma anche del modo in cui questi si coordinano con i principi costituzionali.
Solo attraverso questa conoscenza il giudice può tanto applicare in via diretta la Convenzione, nei casi in cui nel rapporto orizzontale sia coinvolto un soggetto pubblico a fronte del privato, quanto applicare la Convenzione tramite la mediazione del raccordo con i principi costituzionali.
Da ultimo, la suddetta conoscenza è imprescindibile anche quando la materia civilistica rientri nell’ambito di competenza dell’Unione europea nel qual caso il riferimento ai principi della Convenzione e alle interpretazioni della Corte risulta un necessario paradigma di riferimento da coordinare con quello dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con gli orientamenti della Corte di Lussemburgo.
4. Le conclusioni
Roberto Giovanni Conti
La tentazione di non aggiungere altro alle riflessioni e agli spunti delle due personalità giuridiche del nostro tempo è forte, ma altrettanto avvertita è la necessità di tesaurizzare al massimo il ricco florilegio di spunti che Lipari e Navarretta consegnano nelle mani dei pratici del diritto. Si è qui usata l’espressione pratico del diritto non già per confinare il potenziale uditorio delle interviste a giudici ed avvocati, ma al contrario per volutamente raccogliere una delle tante provocazioni che il Prof. Lipari ha qui riproposto in estrema sintesi, nel solco delle due recenti riflessioni dogmatiche dedicate a cosa sia e come sia oggi da intendere il diritto (N. Lipari, Il diritto civile fra legge e giudizio, Milano, 2017 – su cui v. R. Conti, Leggendo l’ultimo Lipari, in Questionegiustizia, 11 novembre 2017 – e Diritto civile e ragione, Milano, 2019).
Un diritto inteso come sapere pratico “che si svincola dal vecchio postulato che lo riconduceva alla sola dimensione potestativa” e che nel modo stesso di svolgersi, “trasforma sia il soggetto che l’oggetto della conoscenza, attribuendo crescente valore alla dimensione giudiziale, intesa come luogo eletto per la protezione ed affermazione dei diritti fondamentali, destinati a vivere nel caso concreto.
Un sapere pratico che, dunque, si rivolge allo stesso modo ai giuristi pratici e a quelli teorici, se si volesse rimanere nel solco della tradizionale distinzione fra Accademia, giudici e avvocati e che richiede uno sforzo concentrico delle Facoltà giuridiche (Lipari) e di chi si occupa della formazione di Avvocati e giudici (Navarretta) per realizzare concretamente quell’Europa fondata su diritti fondamentali preesistenti a qualunque riconoscimento normativo (Lipari). Affermazioni che si pongono non solo in ideale linea di continuità con le riflessioni degli avvocati civilisti raccolte in un precedente intervista su Giustizia Insieme( D. Cerri, P. Regina e M. G. Ruo, La Cedu e gli avvocati civilisti. La parola agli Avvocati civilisti sul ruolo della CEDU), ma che disegnano la complementarietà fra dimensione teorica e pratica, quando Lipari e Navarretta hanno fatto cenno a due assai note vicende esaminate dalla Corte di Cassazione in tema di fine vita è di diritto alla conoscenza delle origini, sulle quali a brevissimo si tornerà.
Sdoganata la rilevanza della CEDU nei rapporti interprivati – v. volendo, sul tema, R. G. Conti, La giurisprudenza civile sull’esecuzione delle decisioni della Corte Edu, in Questionegiustizia, Speciale, La Corte di Strasburgo, a cura di F. Buffa e M.G. Civinini, 2019,280 ss.- non restava dunque che chiarirne l’ambito di rilevanza.
Opera nella quale la Professoressa Navarretta è riuscita a tratteggiare con estrema chiarezza in cosa consista l’efficacia diretta della CEDU quando lo Stato e/o le sue articolazioni sono parti di un giudizio ed in cosa invece si risolva l’efficacia indiretta che concerne i rapporti c.d. orizzontali.
Nell’uno e nell’altro caso l’incidenza è enorme e poco fin qui considerata, non maneggiandosi – per scelta dogmatica o per altre forse intuibili ragioni – con la dovuta familiarità concetti quali quelli di obblighi positivi e negativi ricadendo sullo Stato per effetto della sua adesione alla CEDU. Ed infatti, a fronte dell’esigenza di “non danneggiare” un diritto su base CEDU imposta allo Stato, l’obbligo positivo impone a quest’ultimo un comportamento proattivo, obbligandolo a rendere in concreto esercitabile il diritto di matrice convenzionale. Questo obbligo si trasmette dunque a tutti gli organi statali e, quindi, anche alla giurisdizione.
Tale prospettiva è chiarita in modo esplicito dalla Corte edu quando ha riconosciuto che, pur non essendo in teoria tenuta a definire controversie di natura puramente privata, la stessa “ ...nell’esercizio del controllo europeo che le spetta, non può rimanere passiva laddove l’interpretazione da parte di un tribunale interno di un atto giuridico, sia esso una disposizione testamentaria, un contratto privato, un documento pubblico, una disposizione di legge o una prassi amministrativa, appaia illogica, arbitraria, discriminatoria o, più in generale, incompatibile con i principi sottostanti alla Convenzione” – Corte dir.uomo, Pla e Puncernau c. Andorra, 13 luglio 2004, § 59; Corte dir.uomo, 16 dicembre 2008, Shid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia, 33 –
Non vi è dunque rapporto interprivato, caratterizzato da qualsivoglia tipologia di interesse ad esso sotteso, personale o patrimoniale, che fuoriesca dal cappello – cfr. R. Conti, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Roma, 2011, 290 ss. – offerto dalla CEDU alla protezione dei diritti fondamentali, osserva la Navarretta anche per effetto del fare sistema della prima con la Costituzione.
Si ha qui agio di comprendere che il piano dell’interpretazione del diritto interno in modo coerente e conforme alla CEDU prevale naturalmente sul tema delle relazioni fra le fonti, ancorché la lacuna eventualmente riscontrata sul piano giuridico interno possa essere sanata attraverso la mediazione della Costituzione (Navarretta).
Se, infatti, il sindacato sul contrasto fra norma interna e CEDU va riservato in via esclusiva alla Corte costituzionale- secondo le note rime fissate dalle sentenze gemelle della Corte costituzionale rese nell’anno 2007 e dai successivi seguiti –, è sul piano ermeneutico che la Cedu, con la copertura costituzionale introdotta dall’art.117 Cost., può inserirsi negli interstizi lasciati vuoti dal sistema - sul ruolo della CEDU in caso di lacuna normativa, v., volendo, R. Conti, Legge Pinto - ma non solo - Corte di Cassazione e CEDU su alcune questioni ancora controverse, in Questionegiustizia 23 marzo 2015-.
La costruzione della Navarretta, pur con le precisazioni e delimitazioni fornite, conferma dunque il pieno rilievo della Cedu. Rilievo che trae origine diretta ed immediata, a parere di chi scrive, già nella giurisprudenza della Corte edu che è prevista dal Trattato con il quale è stata approvata la CEDU come “fonte interpretativa” dei diritti di matrice convenzionale, ratificato e reso esecutivo con legge dello Stato.
In questo contesto, tanto la sentenza Englaro (Cass. n. 21748/2007), quanto Cass. S.U. n.1946/2017 evocate da Lipari e Navarretta e più sopra ricordate confermano che il giudice, di fronte al "silenzio" del legislatore, non può rimanere inerte rispetto ad una domanda di giustizia, ove questa sia giustificata e tutelata dal quadro dei principî scolpiti all'interno del sistema – integrato nel senso appena descritto – non essendogli consentito un non liquet.
Rispetto all'assenza di un humus comune e condiviso, il giudice non deve né può indietreggiare o deflettere dal ruolo e dalla funzione che questi svolge allorché emergano, in termini sufficientemente chiari e prevedibili, dei principî di base che trovano la loro naturale collocazione all'interno delle Carte dei diritti fondamentali, per come vivificate dai rispettivi diritti viventi[1].
Se, come altra volta si è tentato di affermare (R.G. Conti, Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l.219/2017, Roma, 2019, 33) le due pronunzie sopra ricordate mostrano il volto di un giudice capace di affrontare ‘casi difficili’ e di colmare le ‘lacune del diritto’ (Cass. S.U. n. 22251/2017) senza pregiudizi, senza pre-orientamenti, ci si accorge che la CEDU, anche in ambito civilistico, ha concorso a radicare quel cambiamento che apre le porte al posmoderno (P. Grossi, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 2017, su cui v. E. Scoditti, Scoprire o creare il diritto? A proposito di un recente libro, in Questionegiustizia, 7 novembre 2017), rivisitando il principio di legalità e le altre categorie giuridiche attraverso una valorizzazione del giudizio - e delle parti che lo animano – come luogo in cui viene forgiato il diritto sul caso concreto.
Da qui la centralità dell’interpretazione convenzionalmente orientata.
La Professoressa Navarretta, nella panoramica delle vicende di maggiore impatto in ambito civilistico che hanno visto la Corte edu giocare un ruolo rilevante, ha opportunamente ricordato la parabola dell’occupazione acquisitiva e del contrasto reiteratamente affermato fra il diritto vivente della Cassazione e la protezione di un diritto al rispetto dei beni chiaro, preciso e prevedibile, come previsto dall’art.1 Prot.n.1 annesso alla CEDU.
Preme qui solo rammentare uno degli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia - Cass.S.U. n.735/2015 -.
È noto che la scelta di campo delle S.U. si inquadrò allora nell’ottica di definitivo scostamento dall’indirizzo che aveva pienamente giustificato l’occupazione illegittima, addirittura inquadrandola nei modi atipici di acquisto della proprietà.
Secondo Cass.S.U.n.735/2015 “...Il contrasto dell'istituto dell'occupazione acquisitiva con l'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU è sufficiente per escluderne la sopravvivenza nel nostro ordinamento....”.
A tale conclusione, dunque, le S.U. pervennero non perché l’occupazione acquisitiva era stata “eliminata dal T.U. espropr. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001”, ma in relazione al contrasto dell’istituto con la CEDU, alla quale si attribuì il peso che la Corte europea aveva cercato di rappresentare con le proprie decisioni- plurime- nel corso dell’ultimo quindicennio. Infatti, se è vero che “...l'art. 42 bis non può essere individuato come la causa dell'espunzione dall'ordinamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva...”, non è men vero secondo le Sezioni Unite che “...l'istituto dell'occupazione acquisitiva è stato [dapprima] elaborato dalla giurisprudenza e, successivamente, è stato presupposto da diverse disposizioni di legge...”. Sulla base di tale paradigma le Sezioni Unite considerarono che il principio generale posto a base dell’istituto pretorio si poneva in conflitto radicale con la giurisprudenza europea. Tale disarmonia venne quindi risolta in via interpretativa dando spazio allo “...schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c., il quale non solo non consente l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc.), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell'art. 2043 c.c.: esattamente come sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa...”.
In definitiva, affermarono le Sezioni Unite, “...viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti e, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente”.
La decisione travolse così in radice l’istituto dell’occupazione acquisitiva[2] sulla base di coordinate argomentative che misero in relazione di causa-effetto rispetto al mutamento di giurisprudenza “epocale” non gli interventi normativi succedutisi a partire dal varo del nuovo t.u. espropriazioni, ma la necessità di conformare, sul piano esclusivamente ermeneutico, il sistema interno ai principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, visto che era stata la giurisprudenza nazionale a coniare l’istituto.
In questa prospettiva il giudice di legittimità si diede carico di rileggere le norme che pure nel tempo avevano positivizzato l’istituto pretorio dell’occupazione acquisitiva in una chiave idonea a consentire alle stesse di operare anche in base alla innovativa costruzione in termini di natura permanente dell’illecito alla quale venne quindi ricondotto il fatto dell’occupazione illegittima, fosse esso o meno fondato sulla dichiarazione di p.u.[3].
Ci si è soffermati su tale precedente per marcare quanto con profondità e spessore ben diverso ci hanno proposto Lipari e Navarretta sul poliedrico ruolo della CEDU nei rapporti privatistici e quanto sia – o debba essere – alimentato un vero e proprio cantiere culturale sui temi qui discussi.
Il metodo seguito dalle S.U. nella vicenda sopra tratteggiata sembra infatti contenere, in nuce, gli elementi di una vera e propria tecnica di tutela informata al rispetto del canone dell’interpretazione convenzionalmente orientata che, quando non si incide su un dato normativo testuale, consente recte, impone - all’interprete di modulare la risposta giudiziaria
Ma dietro al ragionamento di Lipari e Navarretta, che si è qui prevalentemente dipanato sul binario specifico della CEDU, vi è dell’altro – recte, del molto altro –.
Uno scenario teso a indagare l’agire del giudice – soprattutto di merito –, per l’un verso tutto a contatto con quella “fattualità dei nostri giorni, [...] indocile, recalcitrante ad ogni irretimento, tanto più a una gabbia legislativa, che è per sua natura tarda e lenta a formarsi, che si sottrae a ogni variazione o che assorbe con difficoltà ogni variazione...” - così P. Grossi, Crisi del diritto, oggi?, in Dir. soc., 2011,1, 45 ed anche in Novecento giuridico: un secolo pos-moderno, Roma/Bari, 2012, 77 –. Fatti che, nella loro innata diversità e nella loro carnalità – per dirla ancora con Grossi - vengono portati al suo cospetto senza che alla base vi sia un suo atto volitivo.
Un giudice che, per altro verso, viene senza sosta chiamato a maneggiare Costituzioni, Carte sovranazionali, pronunzie delle Corti (nazionali e non), fonti, giuridiche e non (soft law) in modo da dovere leggere, conoscere, decifrare, cercare e trovare il diritto rispetto al caso (ancora P. Grossi, Il giudice civile. Un interprete?, in L’invenzione del diritto, cit., 81 –. Ed è proprio l’inserzione del piano sovranazionale nella dinamica delle fonti a costituire “…un altro modo […] accanto alla codificazione di vari diritti e principi in una costituzione rigida, con cui Ulisse si è legato all’albero della nave della civiltà per evitare di farsi ammaliare dalle sirene – finendo ad esse in pasto”- G. Pino, La retorica dei diritti fondamentali?, Le interviste di Giustizia Insieme, a cura di R. G. Conti, 10 luglio 2019-.
La funzione del giudice nello Stato costituzionale finisce così per risultare spesso contro maggioritaria (Lipari) e consiste dunque “…nel vegliare sulle possibili violazioni di quei principi, e possibilmente nel restaurare anche in via interpretativa la coerenza tra legislazione e costituzione.”- ancora G. Pino, op. ult. cit.-
Dunque un giudice destinato a ‘resistere avanzando’ all’interno di un circuito, quello della Costituzione, sul quale ancora oggi sono fortissime le tensioni in ordine al suo ruolo ed alla sua portata – v., volendo, R. Conti, Chi ha paura del Protocollo n.16 – e perché –? , in Sistemapenale.it, 27 dicembre 2019 – come è assai meglio testimoniato dalle dense pagine che Antonio Ruggeri ha dedicato al tema della ratifica del Protocollo n.16 che sta agitando le aule parlamentari- cfr.A. Ruggeri, Protocollo 16 e identità costituzionale, in Diritticomparati –.
Ecco, allora, che il contatto del giudice – di merito e di legittimità – con la fattualità del diritto e con principi elastici, clausole generali, vuoti normativi evoca scenari di ruvida contrapposizione fra sostenitori di un suo ruolo dinamico in continuo confronto con il legislatore e forti oppositori di una figura giudiziale che, nelle parole di alcuni autorevoli esponenti della dottrina, si inscrive autenticamente nell’ambito della eversione organizzata e finalizzata a scompaginare l’impianto voluto dal costituente in tema di divisione dei poteri– R. Bin, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone–.
Insomma, la stagione che si apre innanzi a chi maneggia il diritto è quella dei giudizi di valore sempre più radicali sul ruolo del giudiziario.
Le stesse riflessioni di Lipari e Navarretta lasciano trasparire l’esistenza di forti contrapposizioni sul tema – v. M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, in Enciclopedia del diritto, Milano, 2016, IX, 391– soprattutto nella civilistica italiana (v., sul punto, per estrema chiarezza, G. Vettori, Il diritto ad un rimedio effettivo nel diritto privato europeo, in Persone e mercato, 2017, 15). Contrapposizioni che involgono, del resto, la messa a punto del ruolo dei diritti fondamentali nell’ambito dei rapporti privatistici e nelle operazioni di bilanciamento che possono determinare.
Una stagione nella quale, dunque, c’è ancora molto da approfondire con la certezza che la complessità di un diritto che si fa sempre più complesso per l’interazione e l’integrazione dei documenti che, tutti dotati di efficacia giuridica vincolante, riconoscono i diritti fondamentali– A. Falzea, Complessità giuridica, in AA.VV., Oltre il «positivismo giuridico ». In onore di Angelo Falzea, a cura di P. Sirena, Napoli, 2012, 3 ss.; F. Viola, Il futuro del diritto, in Persona e derecho, 2018, 32 – e problematicità del sistema, alimenta incessantemente di materiali provenienti non soltanto dall’interno ma anche dall’esterno, non potrà essere governata con l’arma del primato del legislatore sui giudici e/o della dottrina sui pratici ma, tutto al contrario, con la cooperazione attiva di tutti gli attori rivolta a fronteggiare la crescente complessità del diritto, sulla quale Paolo Grossi è tornato ad insistere nella prefazione del volume, di imminente pubblicazione, dedicato da Giustizia Insieme a “Il mestiere del giudice”.
Le tracce oggi lasciate da Navarretta e Lipari escludono in radice che la CEDU sia in ambito privatistico poco più che un divertissement, dovendo essa essere presa sul serio da tutti i protagonisti del diritto, pubblici e privati, che hanno a cuore i diritti e la persona che ne è titolare.
[1] In questa prospettiva v. Corte cost. n.1/2013, allorché si afferma che ‘...in tutte le sedi giurisdizionali (e quindi non solo in quella costituzionale) occorre interpretare le leggi ordinarie alla luce della Costituzione, e non viceversa. La Carta fondamentale contiene in sé principi e regole, che non soltanto si impongono sulle altre fonti e condizionano pertanto la legislazione ordinaria – determinandone la illegittimità in caso di contrasto – ma contribuiscono a conformare tale legislazione, mediante il dovere del giudice di attribuire ad ogni singola disposizione normativa il significato più aderente alle norme costituzionali, sollevando la questione di legittimità davanti a questa Corte solo quando sia impossibile, per insuperabili barriere testuali, individuare una interpretazione conforme.’ Per tale motivo ‘...La conformità a Costituzione dell’interpretazione giudiziale non può peraltro limitarsi ad una comparazione testuale e meramente letterale tra la disposizione legislativa da interpretare e la norma costituzionale di riferimento. La Costituzione è fatta soprattutto di principi e questi ultimi sono in stretto collegamento tra loro, bilanciandosi vicendevolmente, di modo che la valutazione di conformità alla Costituzione stessa deve essere operata con riferimento al sistema, e non a singole norme, isolatamente considerate. Un’interpretazione frammentaria delle disposizioni normative, sia costituzionali che ordinarie, rischia di condurre, in molti casi, ad esiti paradossali, che finirebbero per contraddire le stesse loro finalità di tutela.’
[2] Sul tema v., volendo, R. Conti, L’occupazione acquisitiva. Tutela della proprietà e dei diritti umani, Milano, 2006; id., Diritto di proprietà e CEDU. Itinerari giurisprudenziali europei. Viaggio fra Carte e Corti alla ricerca di un nuovo statuto proprietario, Roma, 2012.
[3] V., volendo R. Conti, Addio alle occupazioni illegittime dopo Cass. S.U. n.735/2015, in Corr. Giur., 2015, 3, 319.