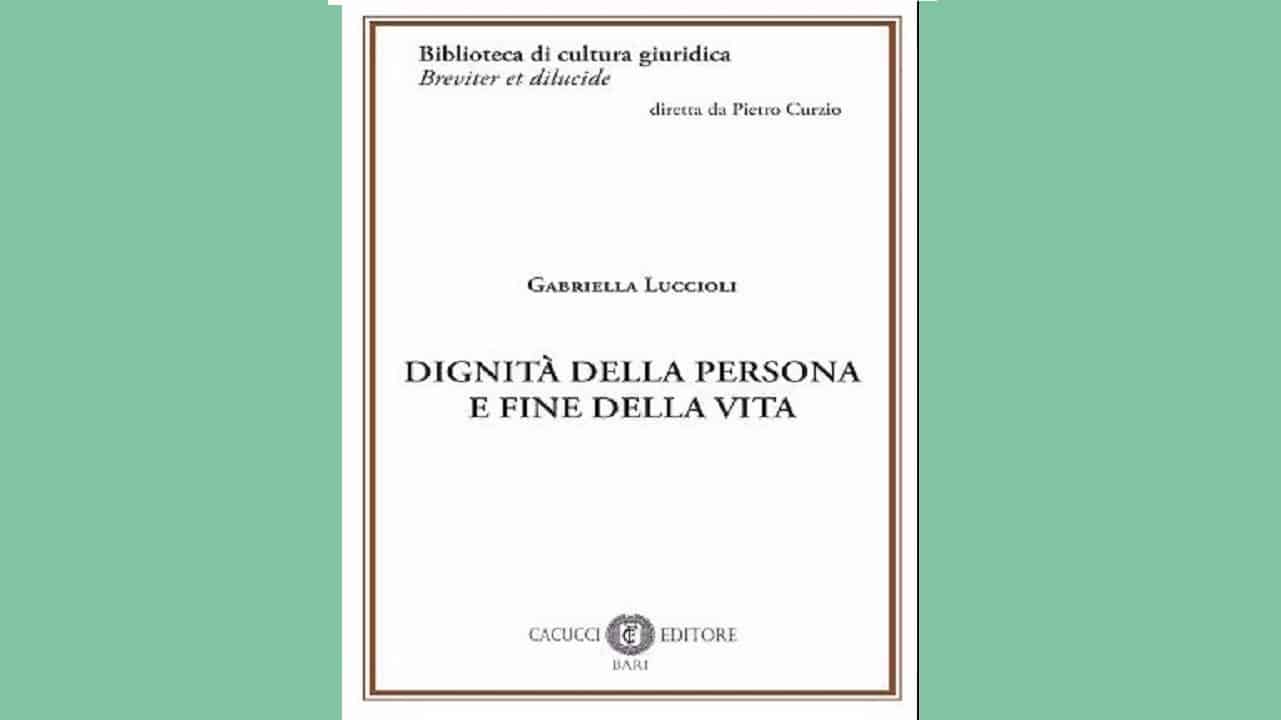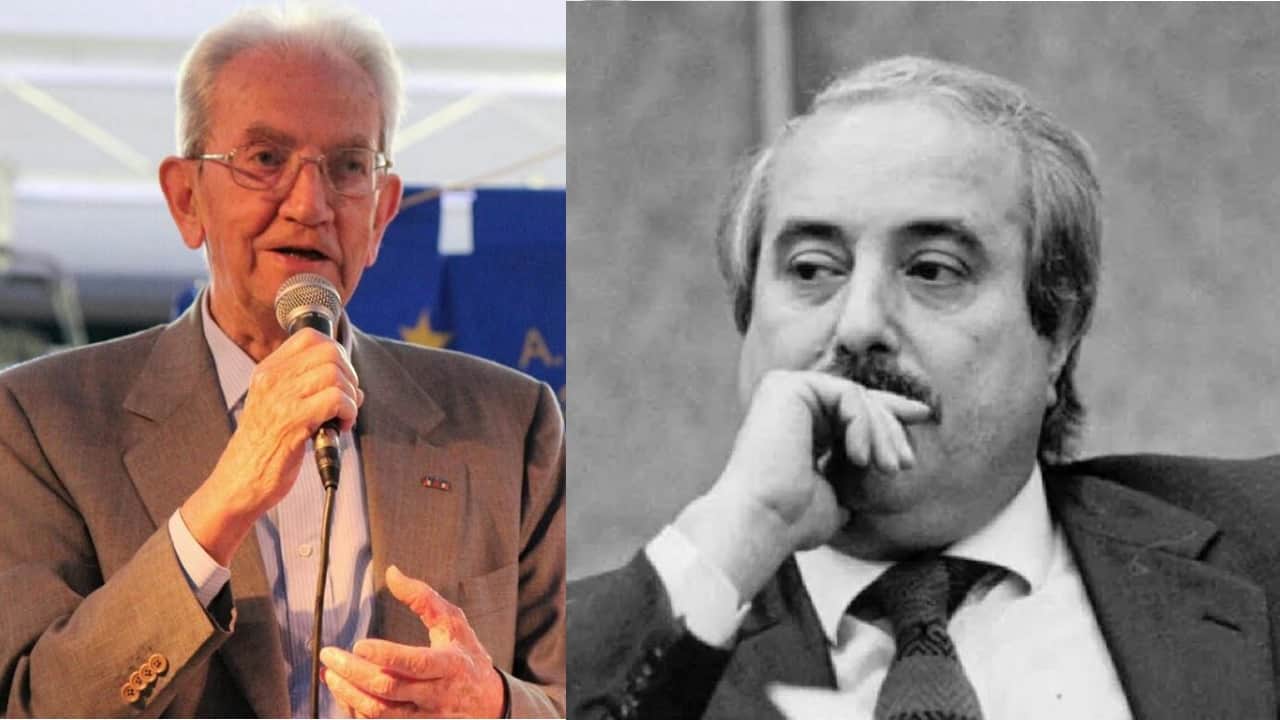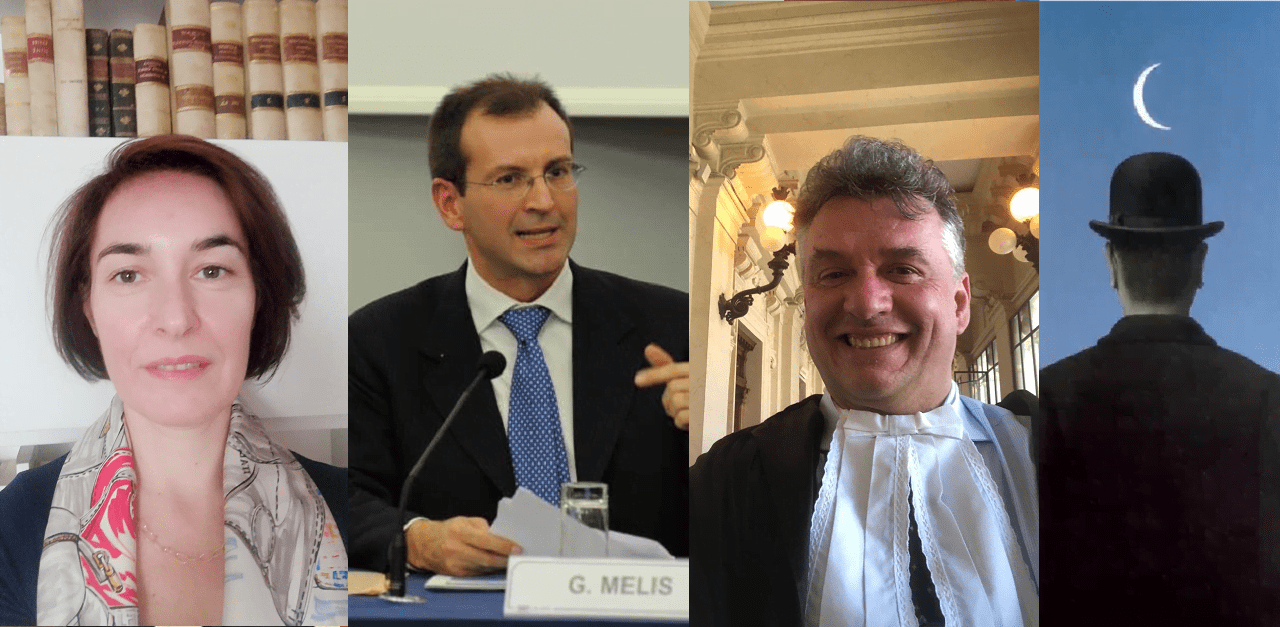
CEDU e cultura giuridica italiana.
8) CEDU e diritto tributario
Roberto Giovanni Conti
intervista
Alberto Marcheselli, ordinario di diritto tributario Università degli Studi di Genova
Valeria Mastroiacovo, ordinaria di diritto tributario Università degli Studi di Foggia
Giuseppe Melis, ordinario di diritto tributario Università degli Studi Luiss, Roma
1. Le domande. 2. La scelta del tema. 3. Le risposte. 4. Le conclusioni. 5. Intervista in pdf.
1. Le domande
1.In quali limiti può dirsi efficace la CEDU nel contenzioso tributario, alla luce della giurisprudenza della Corte edu e della Corte di Cassazione?
2. Quali sono, a Suo giudizio, i nodi che ancora non sono stati adeguatamente affrontati dalla giustizia tributaria a proposito della compatibilità del sistema interno con le garanzie convenzionali?
3. A suo giudizio in che misura può dirsi ormai stabilizzato il diritto vivente in tema di bis in idem, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contenzioso?
2. La scelta del tema.
Roberto Giovanni Conti
Qual è l’influenza della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul diritto e sul processo tributario? Questo è l’interrogativo di fondo che ha animato le domande poste ad Alberto Marcheselli, Valeria Mastroiacovo e Giuseppe Melis, in una prospettiva che intende investire nel - e favorire il - raccordo fra scienza giuridica e giurisprudenza in un campo delicato ed esposto, oggi più che mai, a venti di varia natura e direzione, nei quali tornano a misurarsi l’interessi nazionali di fondamentale portata con non meno meritevoli esigenze di protezione dei diritti del contribuente.
Quello che qui si va ad affrontare assume poi, nell’impianto della ricerca che ruota attorno alla CEDU, una particolare valenza, se è vero che senza diritto finanziario non possono esistere diritti fondamentali.
3. Le risposte.
1) In quali limiti può dirsi efficace la CEDU nel contenzioso tributario, alla luce della giurisprudenza della Corte edu e della Corte di Cassazione?
Alberto Marcheselli
Il rapporto tra la CEDU e il processo tributario è sintomatico delle difficoltà che, più in generale, il sistema del Consiglio d’Europa (e non solo) sconta nello svolgere il proprio ruolo di promotore delle libertà civili negli ordinamenti interni, particolarmente ove siano messi in discussione i settori normativi che appaiono più di altri connessi con l’esercizio della sovranità statale.
L’imposizione fiscale rappresenta, in quest’ottica, uno degli ambiti in cui massimamente si manifesta la potestà pubblica statuale e che, pertanto, mostra una rilevante “vischiosità” nel confrontarsi con le prescrizioni critiche di organi giurisdizionali, a maggior ragione se “esterni”, ancorché, come la Corte edu, di riconosciuta autorevolezza internazionale. Sottoporre a giudizio il sistema fiscale di uno Stato può infatti apparire come un’ingerenza nei suoi meccanismi di reperimento delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione degli indirizzi politici e alla sostenibilità della spesa pubblica; ecco perché il rapporto tra Corte edu e ordinamento tributario interno trascende – talora ma non sempre, in parte ma non del tutto, come si vedrà - il piano del diritto per accedere a una dimensione che potremmo definire “para-politica”, che peraltro è condivisa da gran parte delle Corti Supreme preposte alla garanzia dei diritti (il dibattito, solo per fare un esempio, sulla “politicità” di talune decisioni della nostra Corte Costituzionale è tutt’ora acceso).
Con riferimento all’Italia, è noto come queste problematiche siano state ben rappresentate dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Ferrazzini (12 luglio 2001), in cui il giudice europeo si è interrogato sull’applicabilità al nostro ordinamento tributario del principio del giusto processo che l’art. 6 della Convenzione riserverebbe alle sole controversie di carattere “civile” o “penale”. La questione era delicata: non sfugge, infatti, che la particolare latitudine semantica e prescrittiva del principio del fair trial potrebbe avere ricadute massive sull’assetto fiscale interno, ancor più vigorose ove afferenti ai suoi istituti ordinamentali e processuali, ossia alla forma del controllo della legittimità impositiva.
La Corte, in quell’occasione, ha, allora, preferito muoversi secondo un criterio di prudenza e, operando un vero e proprio self restraint, ha considerato l’azione tributaria inscindibilmente legata alla dimensione pubblicistica statuale, escludendo così la ricorrenza dei presupposti “civili o penali” di applicabilità dell’art. 6 CEDU.
Così facendo, la Corte operava in modo quasi più ispirato a comprensibili cautele che a un puro ragionamento di logica giuridica. È infatti evidente che, sul piano strettamente giuridico, anche ammessa (con difficoltà) la premessa maggiore che la politica fiscale degli Stati, come elemento centrale della sovranità, sia legibus soluta (rectius, non soggetta alla Convenzione e ai principi di giustizia di fonte internazionale), non si vede perché dovrebbe essere anche legibus soluta la giurisdizione tributaria… se lo Stato può liberamente determinare la propria politica fiscale, perché dovrebbe (anche) essere sacrificato il giusto controllo giurisdizionale della attuazione di quelle scelte, liberamente fatte a monte? Detto altrimenti, se Fiscalità equivale a libertà di determinare fini e mezzi finanziari, in quanto appartenenti o intimamente connessi alla sfera politica, perché mai ciò dovrebbe trasformarsi anche in possibilità di attuare arbitrariamente tali scelte da parte della Amministrazione, al di fuori di un giusto controllo giurisdizionale da parte di un giudice giusto e in un processo giusto?
Le due cose non si implicano affatto.
Perché la premessa che sarebbe libera la politica fiscale dovrebbe sdoganare l’applicazione arbitraria delle libere scelte fatte a monte? E, elevando al cubo la problematica, perché mai dalla libertà della scelta politica a monte dovrebbe essere giustificata, non solo la arbitrarietà della fase amministrativa, di esecuzione ma anche, e addirittura, la arbitrarietà del controllo giurisdizionale?
Non solo, ma non può non destare sorpresa l’apparente arretramento dei diritti fondamentali a fronte dell’interesse finanziario: se si dubita – condivisibilmente - della legittimità della compressione di tali diritti rispetto a finalità di salvaguardia contro atti terroristici (in grado di minare direttamente la stessa sopravvivenza fisica di consociati e istituzioni), come può non dubitarsene rispetto ai – certo importanti ma non superiori – interessi di equilibrio finanziario?
Tale via, lastricata di buone intenzioni, ben potrebbe, se realmente praticata, portare a un Inferno di realizzazioni. Se l’interesse finanziario vince sui diritti fondamentali, esso potrebbe sacrificare anche altri interessi diversi da quelli afferenti la sfera dei tributi (il primo dei quali, nell’ordine dei possibili sacrifici asimmetrici, rispetto alla problematica finanza dello Stato è, evidentemente, quello del welfare, della previdenza, e delle pensioni, e il secondo quello del Debito pubblico, quanto alla posizione dei creditori).
In realtà, ciò che pare non è, perché la posizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non è affatto orientata nel modo, quasi distopico, che risulterebbe da una lettura superficiale della sentenza Ferrazzini.
Infatti, in altre decisioni, il giudice di Strasburgo non ha rinunciato a conformare il sistema tributario interno ai diritti fondamentali della Convenzione, esprimendosi stavolta sulla scorta di parametri, potremmo dire, completamente opposti. Detto più chiaramente, in altre decisioni la Corte ha espressamente smentito la premessa, giuridicamente allarmante, del ragionamento appena ipotizzato (la politica finanziaria è senza freni): ha cioè affermato che il Primo Protocollo della Convenzione fa sì salva la politica fiscale, ma sempre che sia rispettato il principio di proporzionalità.
Ciò significa esattamente il contrario dell’assunto apparente della Ferrazzini: e cioè che la politica economica e finanziaria è, in realtà, soggetta alla Convenzione (quantomeno, sotto il profilo della proporzionalità).
Nel rapporto tra sentenza Ferrazzini e tali decisioni non c’è, a ben vedere, un contrasto, ma il segno di una palese tendenza evolutiva, finora non adeguatamente colta.
Ciò è stato affermato, ad esempio, mediante il riscontro della violazione del diritto di proprietà di cui all’art. 1, Prot. 1 CEDU, che pure contempla la possibilità della compressione del diritto nell’ottica di assicurare il pagamento delle imposte, in un caso in cui si era rilevato il difetto di “rimedi interni effettivi” per contrastare misure o procedure fiscali sproporzionatamente gravose rispetto ai diritti del contribuente (Buffalo Srl c. Italia del 3 luglio 2003).
Altre volte ancora è stata l’intensità ablativa del provvedimento ad aver consentito al giudice Edu di superare il muro deferenziale nei confronti del potere pubblico statuale, come testimoniato dal caso Jussila del 2006 che (anche se non direttamente riguardante l’Italia) è stato in grado suscitare effetti benefici anche sul piano interno. La pronuncia applicava alle sanzioni tributarie i “criteri Engel” della giurisprudenza della Corte edu, concludendo che anche la ricorrenza di una finalità dissuasiva, piuttosto che meramente compensativa, della sanzione sarebbe requisito di per sé sufficiente a determinarne la natura sostanzialmente penale, con l’effetto di assoggettare il processo interno di contestazione della sanzione tributaria ai parametri dell’art. 6 CEDU.
I riflessi di questo principio di diritto si apprezzano specialmente nella giurisprudenza di cassazione in tema di equa riparazione ai sensi della L. 89/2001, in cui l’“indennizzo Pinto” è stato ritenuto ammissibile con riguardo a processi in campo tributario, in cui fossero state contestate sanzioni “connotate da un carattere di afflittività a tal punto significativo, da farle apparire alternative a una sanzione penale” secondo un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass., 26 luglio 2012, n. 13322). In maniera non dissimile, la contestazione delle sanzioni caratterizzate da un rilevante grado di severità ha consentito alla Suprema Corte di attribuire valore probatorio alle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, nonostante il generale divieto di assunzione testimoniale nelle liti di imposta (Cass., 16 marzo 2018, n. 6616).
Su un piano più ampio, la Convenzione può acquisire una cogenza, ancorché indiretta, nell’ordinamento interno soprattutto attraverso l’opera di interpretazione sistematica degli istituti processuali realizzata dal giudice nelle controversie vertenti sui diritti del contribuente. In effetti, se si ammette che il livello di protezione delle garanzie sostanziali non può divergere dai migliori standard sanciti nel sistema multilivello, allora anche eventuali limitazioni sul piano processuale dovrebbero venire meno: con riguardo al principio del processo equo, ciò potrebbe tradursi nella possibilità di adeguare in via interpretativa il contenuto sostanziale dell’art. 111 Cost., di rilevanza meramente interna, a quello indicato dalla Corte Europea ai sensi dell’art. 6 CEDU.
Potremmo, quindi, rispondere al quesito osservando come l’efficacia della Convenzione nel diritto interno sia rimessa, in definitiva, alle particolari sensibilità dei suoi interpreti e comunque dipenda dal livello di sintonia dialogica che la nostra Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale e il giudice di Strasburgo possono accordare alla tutela dei diritti fondamentali, che appartengono inscindibilmente a entrambe le prospettive, interna ed esterna, del sistema multilivello.
È interessante rilevare che tale evoluzione e complessa interrelazione attende di essere pienamente colta dalla Corte delle Leggi Italiana. Un segno rivelatore di un percorso non ancora completato è nella giurisprudenza sul rapporto tra principio del pareggio di bilancio e giustizia tributaria. Nella nota sentenza sulla Robin tax è stata avvertita magistralmente la tensione tra i due principi, ma è mancato lo scrutinio di proporzionalità: negare la restituzione di un tributo ingiusto si può ammettere, ma solo quando la soluzione sia necessitata e proporzionata (per l’impossibilità di ipotizzare un tributo sostitutivo e giusto, ad esempio), altrimenti o si afferma che, per così dire, la politica delle valute vince su quella dei valori (l’interesse di cassa vince sui diritti) oppure che ci si dovrebbe incamminare in una pericolosissima graduazione dei diritti (tali che alcuni siano …più diritti degli altri e solo alcuni vincono sulla Finanza).
È appena il caso di notare che una cultura giuridica (ivi comprendendo, in una sana e feconda simbiosi, giurisprudenza e dottrina) che si occupi precipuamente e decisivamente di ponderare i pesi dei valori, invece che applicare regole e clausole generali, sarebbe una cultura giuridica più debole, stranita e potenzialmente meno efficace, non ostanti le apparenze. Da un lato, sul piano della legittimazione strutturale, essa sarebbe più debole, perché dipendente dalla Weltanschauung ideologica prevalente del momento. Dall’altro, sul piano della dogmatica giuridica, essa, invece che avanzare, arretrerebbe pericolosamente, atteso che, come insegna la Storia, sacrificare i Principi sull’altare della Sostanza crea, in ultima analisi, il pericolo di sostituire il Diritto con la Forza (la visione prevalente del contesto politico). Ritenere negoziabili i principi significa, in ultima analisi infatti, abiurare dal ruolo del giurista e rimuovere l’argine a derive pericolose, non essendo in realtà garantito, massimamente nella turbolenta temperie politica di oggi, in Italia e nel mondo, che il sentire politico contingentemente prevalente, nel frullatore accelerato dei media, sia sempre giusto (o determinato democraticamente).
In questo senso, è forte e luminosa la lezione proprio della Corte edu, nel salvifico riferimento al principio di proporzionalità: stanza di compensazione, giuridica, tra cauto formalismo delle regole e propulsiva sostanza dei valori.
Valeria Mastroiacovo
I margini di efficacia della CEDU nel contenzioso tributario sembrano ad oggi piuttosto ridotti, seppure è un dato oggettivamente riscontrabile in termini numerici l’aumento considerevole dei giudizi, anche di merito, in cui le parti articolano le proprie difese con riferimento alle garanzie e alle tutele sancite a livello convenzionale.
La Corte di cassazione, dunque sempre più spesso è chiamata ad argomentare le proprie decisioni anche tenuto conto della «dimensione ermeneutica che la Corte edu adotta in modo costante e consolidato» (Corte cost. n. 49 del 2015), non solo in questioni strettamente attinenti all’ambito procedurale e processuale, ma anche a quello latamente sostanziale.
In questa prospettiva acquistano allora interesse anche quelle pronunce di rigetto – come nel caso della Cassazione n. 26417 del 2018 in materia di tassazione delle indennità da esproprio – in cui i giudici, non hanno potuto esimersi dal motivare con riferimento ai principi desumibili dalla giurisprudenza convenzionale. Nella specie, ad esempio, la Cassazione dopo aver richiamato un suo precedente (sentenza n. 14362 del 2011) in cui aveva ritenuto sostanzialmente inconferente il richiamo all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU per valutare la legittimità della tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità da esproprio (in quanto disciplina riferita ad un momento successivo del tutto distinto dagli aspetti sostanziali indennitari della vicenda espropriativa), si è confrontata con due decisioni della Corte edu del 16 gennaio 2018 (ric. nn. 60633/16 ,Cacciato c. Italia e 50821/06, Guiso e Consiglio c. Italia) che hanno stabilito che l’imposta del 20% sull’indennità da esproprio non è una violazione del diritto di proprietà in quanto l’imposta fissata dal legislatore non può essere classificata come un onere irragionevole a carico del proprietario in quanto la cifra fissata «non ha una portata tale da rendere il pagamento dell’imposta simile a una confisca», ipotesi che avrebbe conseguentemente condotto a conclusioni differenti (Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. Srl e altri c. Italia).
Nello stesso senso si segnala, ad esempio, la Cassazione n. 25464 del 2018, che ha ritenuto non in contrasto con l’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, un caso di contestazione dell’esistenza di un credito d’imposta, qualora l’Amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento di liquidazione del credito esposto nella dichiarazione dei redditi e, al contempo, siano decorsi i termini per operare la rettifica. Secondo la Suprema corte, infatti, il diritto del contribuente non si consolida automaticamente alla data di scadenza dei termini previsti per l’accertamento, restando fermo il potere di contestazione del credito da parte dell'Amministrazione e proprio tale aspetto renderebbe inconferente l’evocato art. 1, in quanto tale norma tutela sul piano convenzionale i soli crediti già accertati, nonché liquidi ed esigibili, ossia a quelli che possano ritenersi parte del patrimonio dell’individuo.
Gli effetti solo indiretti e sostanzialmente “in negativo” (si veda anche Cassazione n. 24252 del 2019) di questo “dialogo tra Corti” produce comunque una stratificazione di enunciati che iniziano a diventare un importante piano di confronto nell’individuazione di limitazioni alla discrezionalità del legislatore, secondo una prospettiva differente da quella interna.
Spostando lo sguardo dal piano sostanziale a quello procedurale e processuale, certo si deve in primo luogo riscontrare una piena efficacia della giurisprudenza della Corte edu su quella della Corte di cassazione in tema di divieto di bis in idem, al quale abbiamo riservato una specifica riflessione (sub 3).
Sembra, invece, ormai destinato a naufragare (Cassazione n. 24899 del 2018) il tentativo di riconoscimento generalizzato nel diritto interno del principio del contraddittorio nella fase procedimentale, attraverso il richiamo al principio del giusto processo di cui all’art. 6, comma 1, della CEDU, mentre sta assumendo progressivamente maggiore rilevanza il principio di effettività della tutela giurisdizionale desumibile dal medesimo art. 6, rafforzato dal recepimento dei principi CEDU in forza dell’art. 6, del TUE come modificato dal Trattato di Lisbona.
In verità non mancano segnali differenti: la Cassazione n. 34258 del 2019, in un caso di asserita illegittimità di una cartella di pagamento per inesistenza giuridica o inefficacia del presupposto giuridico dell’iscrizione a ruolo, ha concluso per il rigetto del ricorso ritenendo peraltro insussistente la lesione del principio del giusto processo con riferimento all’art. 6, comma 1, CEDU; la Cassazione n. 12134 del 2019 ha ritenuto parimenti che non contrasta con il medesimo articolo l’impossibilità, nel processo tributario, di sanare il ricorso introduttivo privo di sottoscrizione del difensore abilitato e della parte, in accordo con la stessa giurisprudenza della Corte edu (Trevisanato c. Italia, 15 settembre 2016) laddove ritiene sufficiente, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, che l’imposizione di condizioni, forme e termini processuali, rispondano ad obiettive regole di giustizia prevedibili corredate da sanzioni prevenibili con l’ordinaria diligenza.
Nella giurisprudenza di Cassazione è risultata del resto altrettanto cedevole la giurisprudenza della Corte EDU in tema di tutela del diritto del legittimo affidamento in particolare ai fini dell’individuazione del termine iniziale del computo del diritto al rimborso nel caso di sopravvenuta incompatibilità della norma interna con il diritto comunitario. Per ribadire queste conclusioni (sentenze nn. 7390 e 14548 del 2019) già a suo tempo raggiunte dalle Sezioni Unite n. 13676 del 2014, la Cassazione ha motivato sulla base di precedenti della Corte edu, osservando che la stessa Corte europea ritiene, inoltre, che la materia della imposizione tributaria faccia parte del cd. “nucleo duro” delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività sarebbe predominante (Ferrazzini c. Italia). Citando la giurisprudenza della Corte edu, la Cassazione conclude allora che «gli Stati godono sicuramente di vasta discrezionalità, sia pure entro i confini della riserva di legge sostanziale (Corte dir.uomo, in caso James c. Regno Unito; conf. in caso Spack c. Rep. Ceca) e del rispetto di taluni diritti fondamentali (Corte dir.uomo, in caso Darby c. Svezia, sul divieto di discriminazione fiscale; conf. in caso N.K.M. c. Ungheria, su abnorme prelievo fiscale a carico di dipendenti pubblici). Il che spiega l’atteggiamento restrittivo di quella Corte nel sindacare le scelte degli Stati, che non siano manifestamente prive di giustificazioni ragionevoli (Corte dir.uomo, in caso National & provincia building society c. Regno Unito)».
Giuseppe Melis
1. Un primo profilo di efficacia della CEDU riguarda il valore che le sentenze della Corte edu assumono rispetto al giudice nazionale.
È noto l’orientamento maturato in seno alla Corte Costituzionale (49/2015), che impone una differenziazione fra il giudice della causa definita dalla Corte edu e qualsiasi altro giudice. Per il primo, si produrrebbe un effetto vincolante assoluto; per il secondo, la produzione di effetti erga omnes sarebbe condizionata alla circostanza che, ad esito di vaglio discrezionale, il giudice ritenga il principio stabilito nella sentenza interessata come “diritto consolidato”.
Nella sentenza GIEM (Corte dir.uomo, 28 giugno 2018), la Corte afferma tuttavia – come peraltro confermato dalle varie opinioni in calce alla sentenza – che “le sue sentenze hanno tutte lo stesso valore giuridico. Il loro carattere vincolante e le loro autorità interpretativa non possono pertanto dipendere dal collegio giudicante”.
La richiamata differenziazione di effetti posta dalla Corte costituzionale collide, dunque, con quanto affermato dalla Corte edu con la sentenza GIEM.
2. Il secondo profilo riguarda le possibili interrelazioni tra i principi sanciti in sede edu ed il diritto tributario italiano, con particolare riferimento alle tre disposizioni (art. 1 prot. 1; art. 6; art. 8) che nell’elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU si sono dimostrate, in riferimento al fronte “civile” delle questioni, della duttilità necessaria ai fini della loro applicazione ad un settore, quello tributario, connotato da indubbi profili di specialità rispetto alle altre branche del diritto.
2.1. Iniziando dall’art. 1 prot. 1, la Corte si è mossa, nello specifico settore tributario, per un verso riconoscendo un ampio margine di apprezzamento statale e così rinunziando ad entrare nel merito del fine perseguito dagli Stati; per altro verso, valorizzando tanto la plasmabilità dei concetti di “beni” ed “interessi patrimoniali”, quanto la proteiforme natura del principio di proporzionalità, al fine di estendere quanto più possibile le tutele del contribuente.
Quanto al primo profilo, è noto come la Corte edu abbia a più riprese ricompreso nel concetto di “interessi patrimoniali” tanto il diritto alla detrazione IVA allorquando lo stesso scaturisca da fatture di acquisto regolarmente registrate ed inserite nella dichiarazione IVA, quanto i crediti tributari rispetto ai quali il contribuente possa vantare una aspettativa legittima.
In tali ultimi casi, peraltro, la legittima aspettativa è stata ritenuta idonea a configurare un diritto patrimoniale tutelabile, sia nel caso in cui la pretesa creditoria non fosse stata contestata dall’amministrazione finanziaria, sia nel caso in cui la pretesa creditoria benché non contestata fosse ancora contestabile secondo il diritto interno, sia infine nel caso in cui, ancorché contestata nel caso specifico, fosse stata cionondimeno confermata in via di prassi o in sede giudiziale in casi simili.
Sotto questo punto di vista, non del tutto coerente a tale quadro di tutela appare l’orientamento assunto dalla Suprema Corte la quale (Cass. 25464/2018 e 33018/2018) non ritiene applicabile l’art. 1 tutte le volte in cui il credito sia sic et simpliciter contestato dall’Amministrazione Finanziaria.
Quanto al principio di proporzionalità, la giurisprudenza della Corte edu lo ha declinato ora quale limite massimo all’imposizione, ora quale limite all’introduzione di norme retroattive e di interpretazione autentica, ora quale parametro di legittimità delle molteplici disposizioni che garantiscono una posizione di “privilegio” all’Amministrazione Finanziaria rispetto al contribuente, ora quale limite al disconoscimento del diritto di detrazione IVA ora, ancora, quale parametro della qualità della legge tributaria. Profilo, detto ultimo, poi ulteriormente valorizzato soprattutto sul fronte del legittimo affidamento, declinato quale certezza del diritto tanto in punto di genesi – rientrandovi sia ipotesi caratterizzate dall’indeterminatezza e/o contraddittorietà normativa sia dall’incertezza dell’interpretazione giurisprudenziale – quanto in punto di conseguenze in caso di sua lesione venendo meno, nella prospettiva EDU, non solo la debenza della sanzione ma finanche quella del tributo.
Tali profili sono stati variamente recepiti dalla Corte di Cassazione.
Quanto al limite massimo di imposizione la Corte di legittimità ha ad esempio recentemente reso una pronuncia sulla compatibilità alla CEDU della tassazione dell’indennità di esproprio ex art. 11 L n. 413/1999 muovendo proprio “[d]all’inidoneità dell’aliquota fiscale ad incidere sostanzialmente sul valore del bene, in misura tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di proprietà da risarcire” (Cass. 26417/2018).
Quanto al legittimo affidamento, se originariamente la Corte aveva sposato una impostazione sostanzialmente in linea con quella di Strasburgo, affermando la non debenza anche del tributo nel caso in cui il contribuente si fosse conformato ad indicazioni provenienti dall’Amministrazione finanziaria (Cass. 17576/2002, 21513/2006, 18218/2007), essa ha successivamente mutato orientamento limitando l’efficacia esimente ai soli profili sanzionatori e agli interessi (Cass. 18718/2019, 18405/2018, 8197/2015).
Quanto al diritto di detrazione IVA, la giurisprudenza della Suprema Corte si pone, almeno formalmente, in sintonia con quella di Strasburgo, laddove richiede che l’Amministrazione Finanziaria, nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, provi che il contribuente “sapeva o avrebbe potuto sapere” la natura fraudolenta della prestazione (Cass. 29319/2018; 12258/2018; 9851/2018). Allo stesso tempo, però, non si può nascondere come l’applicazione pratica della regola finisca per differire e non di poco, posto che nell’ottica della Corte EDU particolare attenzione è data alla circostanza che l’Amministrazione provi sino in fondo l’elemento di cui è onerata (Corte dir.uomo, 14 giugno 2018, Euromark Metal Doo c. Repubblica di Macedonia; Corte dir. uomo, 22 aprile 2009, Bulves AD c. Bulgaria), mentre invece, sul fronte nazionale, spesse volte il tutto si riduce de facto in un’inversione dell’onere della prova dovendo provare il contribuente la propria incolpevole estraneità alla vicenda.
Quanto all’esistenza di un diritto acquisito in ragione di una giurisprudenza costante, trattasi di un profilo che la Corte edu aveva inizialmente negato, arrivando poi invece a censurare il mutamento di orientamento interpretativo da parte dei massimi organi giurisdizionali nei casi in cui esso abbia caratteristiche tali da “minare” la prevedibilità della portata del precetto normativo. La giurisprudenza italiana distingue, invece, i mutamenti giurisprudenziali riguardanti l’interpretazione di norme sostanziali, naturalmente retrospettivi, da quelli riguardanti norme processuali che, ove imprevedibili e suscettibili di comportare un effetto preclusivo del diritto di azione o difesa della parte, hanno effetto solo per il futuro, violandosi altrimenti l’affidamento delle parti nella stabilità delle regole del processo (Cass. 13087/2012).
2.2. Venendo all’articolo 6 CEDU, è nota la posizione nel caso Ferrazzini.
Purtuttavia, le potenzialità applicativa dell’articolo in commento sono poi state meglio definite e perimetrate ad opera della giurisprudenza successiva, ricomprendendosi oggi nell’ambito di tutela dell’art. 6 sia il rimborso di imposte indebitamente pagate (dubbio tuttavia essendo se in tali ipotesi debbano rientrate le controversie da rimborso tout court o solo quelle nelle quali la pretesa di rimborso non abbia natura fiscale), sia le ipotesi in cui nella controversia si discuta anche delle sanzioni e non solo del tributo.
Peraltro, ai fini della predetta estensione, non si richiede che la sanzione tributaria sia stata concretamente irrogata, essendo invero sufficiente che la procedura di determinazione dell’imposta di per sé possa dare luogo, anche solo potenzialmente, all’irrogazione della stessa. Non è nemmeno necessario che la controversia presenti esclusivamente dei profili sanzionatori, essendo ricorrente l’affermazione per la quale, nell’ipotesi in cui la vicenda presenti sia profili sanzionatori sia profili squisitamente tributari, avvinti però da un legame inscindibile (come è di regola nel diritto tributario), anche a questi ultimi andranno riconosciute le tutele dell’art. 6.
Ulteriore estensione è poi garantita mediante la ricomprensione nell’all’art. 6 di tutte quelle controversie nelle quali si discuta (anche) della legittimità e della regolarità delle ispezioni domiciliari o, comunque, di tutti quegli atti istruttori che influiscano sul diritto al rispetto della vita privata e del domicilio stabilito dall’art. 8 CEDU.
In riferimento a quanto sopra, la giurisprudenza della Suprema Corte parrebbe aver ben recepito tali delimitazioni nella misura in cui è frequente l’indagine circa la ricorrenza di profili sanzionatori ai quali ricollegare l’applicabilità dell’art. 6.
Allo tesso tempo, però, tale giurisprudenza non appare del tutto coerente con l’orientamento della Suprema Corte avente ad oggetto all’applicabilità della Legge Pinto al processo tributario risultando in ultima analisi dipendenti, entrambe le questioni, dal riconoscimento della natura penale della sanzione amministrativa.
Se questo è il piano attuale, in un’ottica futura parrebbe possibile intravedere nell’orientamento della Corte edu un tendenziale superamento dei principi della sentenza Ferrazzini con conseguente piena applicabilità dei principi del giusto processo anche al nucleo duro della materia tributaria.
In questo senso, assume rilievo la recente ordinanza Wallace (Corte dir.uomo, 28 novembre 2018) nella quale la Corte ha preferito non pronunciarsi sulla questione, pure sollevata in via preliminare dal governo resistente, circa l’inapplicabilità dell’art. 6 CEDU al processo tributario optando, invece, per una pronuncia di irricevibilità per manifesta infondatezza.
Se così fosse, troverebbero allora nuova voce i ripetuti dubbi in ordine alla compatibilità tra il modello di processo tributario accolto nel nostro ordinamento ed i principi del giusto processo soprattutto per quel che concerne i profili della parità delle armi, dell’imparzialità, dell’indipendenza, del diritto al silenzio e a non rendere dichiarazioni autoincriminanti, del diritto di accesso ai documenti contenuti nel fascicolo dell’Ufficio e non allegati all’atto di irrogazione delle sanzioni, nonché della prova testimoniale e della presunzione di innocenza, costantemente oggetto non solo di censure dalla dottrina ma finanche di continue questioni di legittimità costituzionale.
2.3. Venendo infine all’articolo 8, lo stesso è suscettibile di trovare, come anche testimoniato dal recente caso Brazzi c. Italia (Corte dir.uomo, 27 settembre 2018), una considerevole applicazione nella materia tributaria.
Ai fini che qui interessano due sono gli elementi che devono essere sottolineati.
In primo luogo, il concetto di domicilio è inteso non solo in senso sostanzialista e, come tale, insensibile rispetto alle qualificazioni formali dei singoli stati membri, ma altresì con estrema elasticità ricomprendendovi al suo interno sia l’abitazione e gli altri luoghi adibiti a privata dimora, sia quelli in cui venga esercitata l’attività economica e finanche la sede legale di una ditta individuale o di una società di capitali.
In secondo luogo, la peculiare valorizzazione della circostanza che l’ingerenza nei diritti tutelati dall’art. 8, per essere legittima, debba avvenire “in conformità alla legge”.
A tale fine, si richiede che il diritto interno offra delle garanzie adeguate e sufficienti contro eventuali abusi o comportamenti arbitrari poi declinate, almeno in linea teorica, nell’esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo sulla misura che sia idoneo anche a garantire un rimedio risarcitorio per riparare la lesione del diritto in questione. Tale controllo, nell’ottica della Corte, può essere tanto preventivo quanto successivo, da ciò dipendendo esclusivamente la severità dell’esame da parte di quest’ultima, più rigido nel secondo e più elastico nel primo.
Se così è, appare allora evidente la portata dirompente dell’applicazione di simili principi nell’ordinamento nazionale nella misura in cui nelle ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche le quali rappresentano di per sé un’ingerenza nel diritto ex art. 8, la legge non prevede alcun controllo giurisdizionale preventivo.
In un simile contesto la Suprema Corte ha dapprima teorizzato un modello di tutela differita ritenendo affetto da illegittimità derivata quella parte dell’avviso di accertamento che dipenda dall’attività istruttoria illegittima. Tale illegittimità derivata non è peraltro assoluta, ma viene espressamente limitata a quella parte della pretesa funzionalmente dipendente dall’attività istruttoria illegittima, oltreché operante nei soli casi che abbiano concretamente inciso sul godimento di diritti fondamentali e alle sole prove e/o fonti di prova per le quali l’accesso abbia costituito una condizione necessaria (SS.UU. 11082/2010; Cass. 33026/2019).
Successivamente le Sezioni Unite hanno anche teorizzato un modello di tutela immediata dinanzi al giudice ordinario, eventualmente assistita anche dal rimedio cautelare, per tutte quelle ipotesi in cui l’atto impugnato prescinda dall’istruttoria illegittima ovvero per i casi di mancata emanazione dell’atto impugnabile ovvero ancora per i casi di sua mancata impugnazione (SS. UU. 8587/2016).
Se tale conclusione ha sicuramente il pregio di ridurre i possibili attriti rispetto alle garanzie richieste dalla Corte EDU, essa parrebbe purtuttavia istituzionalizzare una disparità di trattamento nella misura in cui ricollega l’esperibilità del rimedio cautelare alle medesime condizioni preliminari cui viene sottoposta la ricorribilità al giudice ordinario la quale cosa, a monte, finisce per negare la stessa efficacia del rimedio, dovendosi attendere di verificare se l’Amministrazione emanerà o meno l’avviso di accertamento e, a valle, finisce per discriminare la tutela ottenibile dal contribuente in funzione della circostanza che l’illegittimità istruttoria si condensi o meno nell’atto tipico impugnabile.
Tale discriminazione, peraltro, non diminuirebbe neanche ipotizzando l’esperibilità della via risarcitoria in sede tributaria in quanto in tale ipotesi emergerebbero comunque i profili di compatibilità del rimedio rispetto all’art. 6 CEDU più sopra richiamati.
Se a tali considerazioni si aggiunge la circostanza che, in virtù della giurisprudenza edu, si richiede che tale tutela sia effettiva e non già meramente teorica, i dubbi sulla compatibilità di tali rimedi rispetto al quadro di tutele offerte dalla Convenzione non possono che aumentare giusta l’origine solo pretoria del rimedio apprestato e l’assenza di qualsivoglia precedente in materia.
2) Quali sono, a Suo giudizio, i nodi che ancora non sono stati adeguatamente affrontati dalla giustizia tributaria a proposito della compatibilità del sistema interno con le garanzie convenzionali?
Alberto Marcheselli
Probabilmente, le frizioni maggiori tra il nostro sistema di giustizia tributaria e la Convenzione Edu vanno ravvisate non sul piano della dinamica processuale, ma su quello della statica.
In effetti, sul piano della legge processuale, sarebbero sufficienti pochi ritocchi, tali da scolpire anche legislativamente un approdo già raggiunto dalla giurisprudenza: il giudizio tributario è un giudizio di controllo sul corretto esercizio del potere impositivo: il tributo viene accertato dal Potere Amministrativo, nell’esercizio puntuale e armonioso dalla pubblica funzione, corredata ormai di sacrosanti e potentissimi strumenti investigativi, e il giudice controlla. Nella fase amministrativa, lo Stato è sovrano, nel giudizio, invece egli è – e deve essere, per inderogabile precetto costituzionale - una parte, in posizione paritaria davanti a un giudice terzo e imparziale. Sul piano delle regole del processo basterebbe, allora, scolpire meglio i principi di parità e la delimitazione dell’oggetto del contendere in modo concentrato ed efficace.
Più complessa la questione relativa alle regole ordinamentali. Una prima riflessione porterebbe a ravvisare una forte discrasia con i parametri convenzionali della Convenzione Edu, nell’assenza nel nostro ordinamento di un giudice professionale tributario, che sarebbe fisiologicamente in linea con i principi di terzietà e imparzialità. Si tratta di un profilo forse non decisivo, risultando in parte mitigato dalla regola per cui la presidenza dei Collegi è sempre riservata a un giudice di ruolo: in astratto la competenza potrebbe essere comunque preservata anche altrimenti.
Ciò che mostra in modo più persuasivo una tensione con i principi del giusto processo parrebbe essere invece la struttura organizzativa e finanziaria della nostra giurisdizione fiscale. Basti pensare che il relativo personale amministrativo risulta inquadrato all’interno del Dipartimento delle finanze del MEF, che si occupa, tra l’altro, anche della gestione finanziaria delle Commissioni. Ciò che desta perplessità è la circostanza che nel medesimo Dipartimento sia ricompresa anche la struttura preposta al coordinamento delle Agenzie fiscali: controllori e controllati afferirebbero così al medesimo plesso amministrativo, dando luogo a qualche dubbio circa l’opportunità di tale scelta.
Ancora, può aggiungersi che anche la determinazione del compenso dei giudici tributari viene disposta dalla Direzione regionale delle entrate, ossia dal vertice dell’amministrazione controllata.
Nel tempo si sono avvicendate diverse proposte di riforma di questo assetto; da ultimo, si è avanzata l’ipotesi di far confluire le Commissioni tributarie nell’ordinamento contabile, ma ciò dovrebbe essere oggetto di attenta meditazione, dal momento che il fine dell’azione della Corte dei Conti, la tutela dell’erario, è solo occasionalmente collegato con quello del giudice tributario, ossia la salvaguardia dei diritti del contribuente. Si tratta però di un’impostazione innovativa perché consentirebbe, in prospettiva, di sottoporre a responsabilità amministrativa gli accertamenti più gravosi, ove manifestamente infondati e pertanto oggetto di un contenzioso evitabile.
Una soluzione poterebbe provenire dalla comparazione. Nel sistema tedesco, ad esempio, il giudice tributario è un soggetto professionale articolato su due livelli, il Finanzgericht nei singoli Land, e il Bundesfinanzhof, a livello federale; quest’ultimo è anche espressamente previsto all’art. 95 della Grundgesetz.
Nel Regno Unito, da poco tempo si è formato un sistema di Administrative Courts in cui è previsto anche il contenzioso tributario. Sulle decisioni gerarchiche del Her Majesty Revenue and Custom Department (HMRC) si può infatti adire la Tax Chamber, i cui pronunciamenti, a determinate condizioni, sono appellabili dinanzi all’Upper Tribunal. Per motivi di diritto, poi, si può portare il giudizio dinanzi alla Court of Appeal e, in casi di particolari rilevanza, alla Supreme Court.
Insomma, la questione della compatibilità della giustizia tributaria con i parametri edu non andrebbe limitata ai profili di ordine quantitativo, ossia ai gradi della giurisdizione e agli atti impugnabili, ma piuttosto essere declinata in senso qualitativo, contemperando le esigenze di giustizia con la necessaria efficienza del sistema. La Convenzione non detta un percorso obbligato, ma impone a tutti gli Stati aderenti di conformarsi a degli standard minimi; ecco perché può essere prezioso il confronto con i sistemi giuridici a noi contigui o alternativi, i cui assetti potrebbero essere spunto per una riforma interna, prestando però attenzione a che ciò non conduca a “trapianti normativi” privi di compatibilità sistemica nel contesto tributario nazionale.
Valeria Mastroiacovo
La compatibilità del sistema interno con le garanzie convenzionali è frutto di un percorso segnato da una pluralità di passaggi significativi nell’evoluzione delle fonti: l’incedere di un diritto che viene dal basso (con lo stratificarsi della giurisprudenza interna, convenzionale e comunitaria) e il procedere di un diritto che continua a venire dall’alto (ad esempio con il Trattato di Lisbona e il riconoscimento dei diritti fondamentali come risultanti dalla CEDU quali principi del diritto dell’UE).
In questa dinamica più ampia, sul fronte del nostro diritto interno, si possono distinguere dei passaggi essenziali: taluni hanno suscitato accelerazioni di velocità (e penso innanzitutto alle note sentenze “gemelle” della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007), altri sono stati intesi quali decelerazioni (in particolare mi riferisco alla pronuncia della Corte costituzionale n. 49 del 2015 che ha circoscritto gli effetti alla «dimensione ermeneutica che la Corte edu adotta in modo costante e consolidato»). Tuttavia ciascuno di essi ha pur sempre contribuito a procedere nella medesima direzione: verso una più piena compatibilità delle garanzie riconosciute a livello convenzionale.
Anche il “comparto tributario” è stato segnato da questo percorso: come conseguenza della progressiva applicazione ed estensione di alcuni principi convenzionali da parte della Corte edu, avuto riguardo non solo ad ambiti di tutela procedurale e processuale, ma anche sostanziale. Ciò ha consentito ai giudici nazionali, nei limiti sopra individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, di renderli effettivi direttamente nelle loro decisioni.
Tuttavia, proprio muovendo dalla varietà della casistica della Corte edu (tra l’altro solo in minima parte italiana) e dalle peculiarità strutturali delle relative regole processuali, resta, a mio avviso, il dubbio metodologico che i modelli stranieri da oggetti di pura osservazione, siano talvolta trasformati in modelli dei quali servirsi disinvoltamente (come qualcosa da innestare direttamente all’interno del proprio discorso in funzione ricostruttiva o meramente argomentativa senza preoccuparsi di apprestare, dalla parte del contesto ricevente, «quelle piattaforme di decantazione normativa e concettuale necessarie alla prima assimilazione» - citando Castronovo, L’eclissi del diritto civile, Milano, 2015).
Proprio in questa prospettiva, a mio avviso, il principale “nodo” ancora non adeguatamente affrontato dalla giustizia tributaria a proposito della predetta compatibilità, su cui vorrei svolgere alcune considerazioni è quello che riguarda l’interpretazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU. Una previsione introdotta per regolare la protezione della proprietà e applicata dalla giurisprudenza convenzionale anche in ambito fiscale.
In effetti, non appare ancora del tutto definito il livello di compatibilità – innanzitutto sul piano valoriale – della tutela al diritto di proprietà apprestata in ambito convenzionale in applicazione del citato art. 1 con le limitazioni al medesimo diritto consentite sul fronte dell’ordinamento nazionale in ragione del “nucleo duro” dei principi costituzionali, quali, in particolare, quello di uguaglianza e di solidarietà. Non sembra, poi, altrettanto chiarito se e in che termini le scelte del legislatore nazionale nella disciplina sostanziale dei tributi possano essere ricondotte a “ingerenze” sulla proprietà dei singoli, così da renderne necessaria una tutela secondo il diritto convenzionale. Ciò soprattutto in una prospettiva ricostruttiva – a me cara – che tende a considerare il tributo come un elemento fondamentale dell’appartenenza/realizzazione del singolo alla/nella Comunità statuale, piuttosto che come soggezione ad un potere costituito. A ben vedere dalla giurisprudenza convenzionale emergono dei segnali su cui riflettere in termini evolutivi.
Come è noto, l’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU è frutto del compromesso tra diversi orientamenti politici e influenze ideologiche, ha da sempre posto una serie di problemi interpretativi. Unico diritto di carattere economico tutelato in ambito CEDU (rectius in un protocollo addizionale), la previsione vuole essere «une formule générale interdisant les confiscations arbitraires, scandaleuses et illégales de la propriété». A tal fine in essa si distinguono tre norme: una di carattere generale, che enuncia il principio del rispetto della proprietà, un’altra che prevede l’esproprio solo a talune condizioni e, infine, l’ultima, che riconosce agli Stati il potere di regolamentare con le leggi l’uso dei beni in conformità dell’interesse generale.
Questa ultima norma afferma che il riconoscimento del diritto di proprietà non arreca pregiudizio al diritto dei legislatori nazionali di emanare leggi «da essi ritenute necessarie» per assicurare il pagamento delle imposte.
La giurisprudenza della Corte EDU ha precisato che l’imposizione fiscale è riconducibile alla ratio del citato art. 1 in quanto «costituisce in principio un’ingerenza nel diritto» ivi garantito incidendo sul complesso dei beni di cui dispone la persona (laddove per beni si intendono anche rapporti obbligatori e legittime aspettative di patrimonio, come nel caso dei rimborsi di crediti d’imposta; Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia, sentenza 3 luglio 2003).
Tuttavia è evidente che il margine di discrezionalità riservato agli Stati nella materia fiscale è piuttosto ampio. Del resto, quasi in tutte le pronunce della Corte EDU il baricentro delle motivazioni viene spostato dal predetto art. 1, del Protocollo Addizionale n. 1, all’art. 14 CEDU, che ne costituisce “cassa di risonanza”, divenendo, sostanzialmente, il principale strumento di sindacato del diritto interno sotto il distinto profilo della irragionevolezza di scelte oggettivamente discriminatorie (Beyeler c. Italia, Grande camera, sentenza 28 maggio 2002).
Esattamente venti anni fa, nel commentare una decisione della Corte edu (Giuliana Galeotti Ottieri Della Ciaja più 6 c. Italia, sentenza 22 giugno 1999) in materia di imposta sulle successioni, avevo indicato in quel margine di discrezionalità il segno di confine di una zona impenetrabile da parte dei giudici della Corte edu, «che debbono astenersi dal giudicare l’uso del potere legislativo finché non ne ritengano intrinsecamente violato il limite». Un margine che si identifica sostanzialmente con una valutazione di ragionevolezza a fronte di un «enunciato» dovere di giustificazione delle ingerenze che incidono sull’esercizio del diritto di proprietà.
In altri termini, non ogni ingerenza nel godimento di tale diritto costituisce una violazione. Tuttavia, affinché tali ingerenze – sotto forma di imposizione tributaria – siano compatibili con la Convenzione devono avere una base legale, perseguire uno scopo legittimo e essere proporzionate agli scopi perseguiti (Imbert de Tremiolles c. Francia, sentenza 4 gennaio 2008; Cacciato c. Italia, sentenza 16 gennaio 2018).
Nel tempo la Corte edu ha ritenuto che la protezione del diritto di proprietà come garantita dal citato art. 1 possa venire in conflitto con una disciplina tributaria priva del requisito della chiarezza o comunque imprevedibile, così da identificare l’imposizione fiscale con un’arbitraria interferenza nel godimento del predetto diritto. Sotto il medesimo profilo non sono mancati casi sull’irragionevole retroattività di una norma sostanziale o sull’irragionevole sproporzione dell’imposizione (N.K.M. c. Ungheria, sentenza 4 novembre 2013). La casistica relativa all’art. 1 del 1° Protocollo va ormai oltre quella del rimborso dei crediti di imposta (in cui un eventuale ritardo nel pagamento può comportare la violazione del diritto di proprietà in quanto la Corte ritiene che, in questo caso, l’obbligo fiscale, correttamente adempiuto dall’interessato, che è all’origine del diritto al rimborso, diventi “un peso eccessivo o comunque pregiudichi in maniera sostanziale la sua situazione finanziaria”), e riguarda anche i casi di contestazione relativa alla compensazione tra debiti fiscali e crediti nei confronti dell’amministrazione (S.C. Ghepardul SRL c. Romania, sentenza 14 aprile 2009), al rimborso dell’IVA (<Bulves> AD c. Bulgaria, sentenza 22 aprile 2009), di pagamenti indebiti (S.A. Dangeville c. Francia, sentenza 16 aprile 2002; Eko-Elda AVEE c. Grecia, sentenza 9 marzo 2006) e, in particolare, del mancato rimborso di imposte non dovute perché contrarie al diritto UE (S.A. Dangeville c. Francia, cit.; Aon Conseil et Courtage S.A. et Christian de Clarens S.A. c. Francia, sentenza 25 gennaio 2007).
Si tratta di situazioni in cui l’incidenza finanziaria derivante dall’attesa dei rimborsi (aggravata dall’inesistenza di un ricorso effettivo volto a rimediare l’omissione delle autorità interne e dall’incertezza rispetto al momento della liquidazione dei crediti) ha comportato la rottura del rapporto di proporzionalità tra la tutela del diritto al rispetto dei beni e quella dell’interesse generale della comunità.
Alla luce di questa casistica parte della dottrina aveva sollevato il dubbio che la limitazione della garanzia patrimoniale prevista dall’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU riguardi essenzialmente l’accertamento e la riscossione non potendo in alcun modo incidere sulla disciplina sostanziale dei tributi. Se oggi appare più vicina l’integrazione, quantomeno a livello europeo, dei principi giuridici comuni, tuttavia è ancora lontano il tempo in cui un Paese possa diplomaticamente sottostare alle decisioni di un organo internazionale pronunciatosi sulla sua normativa sostanziale.
In questo contesto i margini di un’effettiva applicazione dell’art. 1 restano ancora un nodo da sciogliere innanzitutto a livello di compatibilità “valoriale”. Pare, allora, potersi concludere, in prima approssimazione, che nell’ambito della Convenzione e delle disposizioni ad essa collegate, il vaglio della legittimità si basa su un principio assimilabile alla nostra valutazione della ragionevolezza, tuttavia, contrariamente a quanto accade nel giudizio italiano di costituzionalità, tale ragionevolezza deve essere verificata alla luce della tutela del diritto della proprietà e del diritto dello Stato di disporne, anche attraverso istituti e discipline volti a regolare l’istituzione e l’attuazione dei tributi in modo da lederne la ratio.
Giuseppe Melis
Dalle considerazioni svolte nella precedente risposta emerge come il bilancio del livello di implementazione da parte dei massimi organi giurisdizionali nazionali possa dirsi solo in parte soddisfacente.
Ed infatti, se è pur vero che oggi, rispetto al passato, sono sempre maggiori i casi in cui il giudice si confronta effettivamente con i principi elaborati dalla Corte edu riconoscendone quindi implicitamente l’autorità, allo stesso tempo sul piano delle ricadute pratiche siamo ancora lontani da quel grado di tutele che pure la Convenzione parrebbe offrire al contribuente.
In questo senso, si pensi anzitutto alla tematica della ricomprensione dei crediti di imposta nell’ambito di copertura dell’art. 1, primo protocollo.
Ed infatti, soprattutto la Suprema Corte, non parrebbe aver ancora valorizzato la portata di quelle pronunce rese a Strasburgo in riferimento alle condizioni integranti la “legittima aspettativa”, focalizzandosi al contrario solo sulla circostanza che il credito sia stato contestato o meno dall’Amministrazione finanziaria. Sotto questo punto di vista, una maggiore attenzione da parte della Corte rispetto alle circostanze per le quali il credito viene contestato e, quindi, se queste siano in fatto o in diritto e, ancora, in tale ultimo caso, se l’interpretazione fornita dall’Amministrazione possa dirsi conforme alla propria giurisprudenza, sarebbe senz’altro auspicabile.
Allo stesso modo, siamo ancora lontani sul tema generale della certezza del diritto e del legittimo affidamento, tanto in riferimento ai presupposti per la sua configurazione quanto, e soprattutto, alle conseguenze a livello di diritto sostanziale nel caso di violazione.
Per quanto invece concerne il principio del giusto processo, si è visto come in realtà le conclusioni oramai ritenute granitiche raggiunte dalla Corte edu potrebbero, in un futuro non troppo lontano, riservare rilevanti sorprese. In un simile contesto, è dunque comprensibile l’orientamento “prudente” da ultimo espresso dalla Suprema Corte, alla quale deve comunque essere meritoriamente attribuita l’implementazione, nella propria giurisprudenza, dei principi stabiliti nel caso Jussila sebbene però la stessa non risulti, dipoi, del tutto coerente rispetto agli orientamenti assunti sul tema della legge Pinto (Cass. 24899/2018).
Punto più dolente è, invece, rappresentato dalla tutela del domicilio laddove, nonostante gli sforzi profusi dalla Corte, siamo ancora lontani da quella tutela giurisdizionale effettiva richiesta dalla Corte edu (28 settembre 2018, Brazzi c. Italia; 5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera; 15 febbraio 2011, Heino c. Finlandia; 21 maggio 2008, Ravon e altri c. Francia, 24 ottobre 2008, André c. Francia).
Ed infatti i nodi ancora da sciogliere sono rappresentati dalla differente geometria che il concetto di “domicilio” assume in ambito europeo rispetto alla sua declinazione nazionale oltre alla circostanza che in ambito europeo ricevono protezione oltre al domicilio anche la “vita privata” e “familiare”.
Ulteriori nodi da sciogliere, sotto questo profilo, sono poi rappresentati dall’inidoneità dei modelli di tutela differita ed immediata teorizzati dalla Corte rispetto a quanto ritenuto dalla Corte di Strasburgo: ragioni, queste, che inducono ad auspicare, sulla scia della dottrina maggioritaria, l’istituzionalizzazione di un rimedio cautelare che prescinda dalle vicende della futura, e solo potenziale, contestazione.
Un buon punto di partenza, in questo senso, potrebbe essere rappresentato da un decisivo cambio di rotta rispetto alla valorizzazione delle garanzie procedimentali previste dall’art. 12 dello Statuto dei Diritti del contribuente.
3) A suo giudizio in che misura può dirsi ormai stabilizzato il diritto vivente in tema di bis in idem, con particolare riferimento alle diverse tipologie di contenzioso?
Alberto Marcheselli
Il principio del ne bis in idem di derivazione CEDU (art. 4, Prot. 7) è un caso esemplare della particolare deferenza in materia tributaria che si può scorgere talvolta nella giurisprudenza edu. Ciò perché è un diritto, quello a non essere giudicato o punito due volte per il medesimo fatto, che ha assunto una piega diversa a seconda che si applicasse o meno a questioni di matrice fiscale.
Se per una prima sistematizzazione a livello europeo del principio occorre fare riferimento a una controversia fiscale – caso Zolotukhin del 2009 - per la prospettiva interna, la fattispecie più celebre è probabilmente di matrice puramente amministrativa. Mi riferisco alla sentenza della Corte Edu Grande Stevens del 2014, in cui era in discussione la sottoposizione di alcuni amministratori e legali delle società organiche al gruppo Fiat alla doppia procedura sanzionatoria amministrativa e penale per un’operazione di sospetta manipolazione del mercato/insider trading.
In particolare, la condotta contestata era riconducibile sia alla violazione amministrativa di cui all’art. 187-ter TUF, sia al reato di cui all’art. 185 del medesimo d.lgs. 58/98. L’irrogazione in via definitiva della sanzione amministrativa, che per la sua severità era stata riqualificata dal giudice di Strasburgo in termini penali, aveva quindi condotto la Corte a ritenere illegittima la contestuale prosecuzione del processo penale, in quanto ciò avrebbe determinato una duplicità di giudizio/punizione per lo stesso fatto.
Detto principio è stato poi ribadito anche in campo tributario con la sentenza Kiiveri del 2015, in cui un imprenditore finlandese lamentava di essere stato condannato per frode fiscale dopo essere già stato destinatario di una sanzione in via amministrativa per illeciti tributari.
Si trattava però di una stabilità solo apparente, destinata ad essere disarticolata dal giudice di Strasburgo con la sentenza A. e B. c. Norvegia emessa nel 2016 dalla Grande Camera, quindi secondo modalità tali da poter integrare una “giurisprudenza consolidata” in principio vincolante anche per il giudice interno (a mente di Corte Cost., n. 49/2015).
Il caso di specie, in cui veniva in rilievo un duplice procedimento sanzionatorio per l’omessa dichiarazione di profitti di fonte estera, è noto per l’affermazione della compatibilità col divieto di ne bis in idem di una doppia incriminazione “frutto di un sistema integrato che permette di reprimere un illecito sotto i suoi vari aspetti in maniera prevedibile e proporzionata e che forma un insieme coerente, in modo tale da non causare alcuna ingiustizia all’interessato”. In campo tributario la Corte edu ha quindi preferito “smussare” gli angoli del divieto di doppia incriminazione, ogniqualvolta questa sia modulata nel senso di costituire un’unità sanzionatoria, alla luce della connessione nel tempo e nella sostanza delle sue diverse componenti punitive.
Queste conclusioni, ribadite successivamente dal giudice europeo - con il caso Jóhannesson e a. c. Islanda del 2017 – non hanno tardato a sortire effetti anche nel sistema interno. Con sentenza n. 43/2018, la Corte Costituzionale ha infatti restituito gli atti al Tribunale di Monza che aveva sollevato q.l.c. dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non estende il divieto di ne bis in idem al concorso tra sanzione penale e tributaria, ove questa sia sostanzialmente afflittiva. Il nostro Giudice costituzionale, rilevando la portata innovativa quale ius superveniens della sentenza A. e B. resa in ambito edu, ha infatti ravvisato una possibile irrilevanza della questione ove “il giudice a quo ritenesse che il giudizio penale è legato temporalmente e materialmente al procedimento tributario al punto da non costituire un bis in idem convenzionale”.
I casi di cui ho parlato confermano il carattere essenziale del diritto vivente, plasmato dal dialogo tra le Corti, nel conferire stabilità e ordine ai diritti più controversi, tra i quali rientrano a mio parere le garanzie del contribuente. Tuttavia, il dibattito sul ne bis in idem sconta ancora una certa magmaticità perché demanda all’apprezzamento di fatto del giudice la sussistenza dei presupposti della violazione. Allo stato, parrebbe quindi che una maggiore certezza applicativa possa riscontrarsi in controversie in cui non siano in questione normative di natura tributari; un quadro più completo, però, potrà essere costruito solo nel tempo, perché la questione del ne bis in idem fiscale pare ineludibilmente collegata ai caratteri che assumerà la figura del giudice tributario, alla sua sensibilità giuridica e al ruolo che intenderà svolgere nell’economia complessiva delle giurisdizioni.
Si può semmai rilevare che, più ancora del problema del doppio binario (sanzione amministrativa-sanzione penale), che appare avviato a una sistemazione definita, quantomeno concettualmente, sembrerebbe attuale la questione, ancora non del tutto avvertita, del triplo binario. Lo strumentario giuridico si è infatti arricchito di un nuovo strumento, la confisca per equivalente, cui la giurisprudenza attribuisce natura sanzionatoria (da me fermamente non condivisa per ragioni sistematiche la cui trattazione è tuttavia incompatibile con la presente sede), e che merita la massima attenzione.
Si tratta di uno strumento di formidabile efficacia di cui è urgentissima una adeguata sistematizzazione, sia quanto al suo oggetto, sia quanto alle modalità e scansioni della sua applicazione, anche processuale, sia quanto all’oggetto e al grado di prova, sia quanto al coordinamento con una vera e propria galassia di provvedimenti ablativi (es. la c.d. confisca per sproporzione), penetranti ma poco coordinati, che un legislatore – meritoriamente - attivo ma - non meritoriamente - poco avvertito tecnicamente mette a disposizione per l’attuazione effettiva del giusto tributo.
Valeria Mastroiacovo
Anticipando il finale, premetto subito che, a mio avviso, lo spostamento del principio del divieto di bis in idem dal piano meramente processuale a quello sostanziale, appare, dal punto di vista sistematico, la soluzione più rispettosa dell’autonomia degli Stati nella valutazione dell’antigiuridicità nei diversi ambiti dell’ordinamento. In questo modo si tiene conto delle specificità dei distinti settori, senza – al contempo – sacrificare la tutela delle posizioni dei singoli, garantite dai principi applicativi da ultimo enucleati dalla giurisprudenza convenzionale. Resta tuttavia ambiguo il compito del giudice nazionale chiamato, in concreto, a svolgere valutazioni astrattamente complesse, salvo a trincerarsi dietro formule precostituite e limitati ambiti di manovra.
Cercando di fare rapidamente il punto del “dialogo tra Corti” su questo tema, ritengo opportuno premettere che con la sentenza n. 48 del 1967 la Corte costituzionale ha escluso la riconducibilità del ne bis in idem processuale all’ambito dell’art. 10 Cost., in quanto non costituisce una norma di diritto internazionale generale, ma uno strumento di diritto internazionale pattizio. In particolare, l’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU disciplina il ne bis in idem interno a uno stesso Stato e tale garanzia si applica, ormai, secondo i consolidati «criteri Engel», non solo ai procedimenti penali in senso stretto, ma anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori, appunto in quanto riconducibili alla “materia penale”.
Se l’individuazione dell’idem factum si è subito consolidata su quella giurisprudenza che la aveva intesa in senso materiale (GC, Zolotukhine c. Russia, sentenza 10 febbraio 2009), la nozione di bis è stata oggetto di una significativa evoluzione: da una concezione strettamente processuale (in materia di market abuse, Grande Stevens c. Italia, sentenza 4 marzo 2014, confermata in materia tributaria da Nikanen c. Finlandia, sentenza 20 maggio 2014) si è pervenuti a una concezione sostanziale di connessione dei distinti giudizi (in materia tributaria, A e B c. Norvegia, GC, 15 novembre 2016, confermata in materia tributaria da Johannesson e altri c. Islanda, sentenza 18 maggio 2017; Armasson c. Islanda, sentenza 16 aprile 2019 e, in materia di market abuse, Nodet c. Francia, sentenza 6 giugno 2019). La trasformazione della garanzia da processuale a sostanziale ha pertanto legittimato i sistemi nazionali di cosiddetto doppio binario sanzionatorio, purché conformi ai criteri della close connection (sostanziale e temporale) elaborati dalla Corte edu.
In ambito unionale il principio del divieto di bis in idem è attualmente sancito dall’art. 50 CDFUE, cui la Corte di giustizia ha riconosciuto efficacia diretta ai fini della disapplicazione del diritto interno. In tale contesto il divieto si riferisce a sanzioni che abbiano entrambe natura penale. La sentenza Fransson (C-617/10 del 26 febbraio 2013) ha stabilito che in materia di reati tributari (iva), il principio al citato art. 50 non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale alla luce dell’identità del fatto e del contravventore (oltre all’unità dell’interesse tutelato), elementi che è compito del giudice nazionale verificare in concreto. Successivamente, con la sentenza Menci (C-524/15 del 20 marzo 2018) la CGUE ha riconosciuto che il divieto può subire giustificate limitazioni in ragione della necessità di garantire la riscossione integrale delle entrate provenienti dall’iva, in quanto trattasi di un obiettivo di specifico interesse della stessa Unione europea. A tal fine la giurisprudenza ha condizionato la valutazione della proporzionalità della normativa nazionale in deroga ad una serie di circostanze tra cui, in particolare, la prevedibilità per l’interessato del cumulo di procedimenti e sanzioni e la necessità che il coordinamento dei distinti procedimenti assicuri la proporzionalità dell’apparato sanzionatorio complessivamente inteso. Ancorché questa pronuncia non possa che rimettere al giudice nazionale la valutazione in concreto della normativa, da essa emerge un giudizio generale di astratta compatibilità dell’art. 50 con il sistema sanzionatorio a doppio binario previsto dall’ordinamento tributario italiano, cosicché al giudice nazionale residuerà sostanzialmente l’applicazione in ciascun caso concreto della normativa interna.
Sul fronte interno, la giurisprudenza della Cassazione in materia penale tributaria ha immediatamente recepito i criteri enunciati dalla Corte EDU nella sentenza A e B c. Norvegia (Cass. pen. n. 6993 del 2018 e n. 42897 del 2018, con principi richiamati in Cass. trib. nn. 7131 e 34219 del 2019). In particolare, in materia di market abuse, la Cassazione penale ha affermato che al fine di garantire che la complessiva risposta sanzionatoria possa considerarsi proporzionata al disvalore delle condotte sanzionate, il giudice del secondo processo, in sede di commisurazione della pena, dovrà valutare, secondo i criteri dell’art. 133 c.p., anche la sanzione già irrogata nel primo procedimento, ben potendo procedere alla disapplicazione delle norme interne incompatibili con il principio del ne bis in idem (Cass. pen. n. 5679 del 2019, n. 49869 del 2018).
Dal canto suo, invece, la Corte costituzionale chiamata più volte a pronunciarsi sulla illegittimità di normative nazionali con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al divieto di bis in idem stabilito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, finora non è mai arrivata alla trattazione del merito della questione limitandosi – in ragione delle singole circostanze – a pronunce di inammissibilità (in materia di market abuse Corte cost. n. 102 del 2016, per difetto di rilevanza; in materia tributaria Corte cost. n. 54 del 2018 e 222 del 2019, per carente motivazione) o di restituzione degli atti al giudice a quo proprio in ragione del mutamento della giurisprudenza della Corte edu in ordine alla natura e ai presupposti del divieto convenzionale di bis in idem (in materia tributaria Corte cost. n. 112 e 209 del 2016; n. 43 del 2018).
La Corte costituzionale, dopo aver ribadito che la decisione non può che passare da un giudizio casistico, affidato all’autorità che procede, ha concluso sottolineando «che la nuova regola della sentenza A e B contro Norvegia rende meno probabile l’applicazione del divieto convenzionale di bis in idem alle ipotesi di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, ma non è affatto da escludere che tale applicazione si imponga di nuovo, sia nell’ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori dell’ordinamento, ogni qual volta sia venuto a mancare l’adeguato legame temporale e materiale, a causa di un ostacolo normativo o del modo in cui si sono svolte le vicende procedimentali». Resta perciò attuale l’invito al legislatore a “stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni” che il sistema del cosiddetto doppio binario “genera tra l’ordinamento nazionale e la CEDU (sentenza n. 102 del 2016)” (sentenza n. 43 del 2018)».
Se tale interpretazione sembra – allo stato – chiudere, in concreto, la partita con riferimento alla materia tributaria, meno certi sembrano gli scenari nell’ambito dei mercati finanziari e in generale del market abuse dove le sollecitazioni per un intervento del legislatore potrebbero riaprire nuovi scenari su cui riflettere.
Giuseppe Melis
Per rispondere alla domanda, occorre premettere come successivamente alla sentenza A e B c. Norvegia – cfr. i casi Johannesson c. Islanda, Armasson c. Islanda e Nodet c. Francia – la Corte EDU abbia avuto modo di precisare due profili essenziali del principio del ne bis in idem: in primo luogo, la necessaria compresenza di tutti i c.d. material factors per un proficuo superamento del test di connessione sostanziale e temporale e, in secondo luogo, una rimodulazione dell’importanza del criterio di proporzionalità della pena.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur richiamando sempre in apicibus gli insegnamenti della Corte edu, tende tuttavia ad applicare solo in parte il test della connessione sostanziale e temporale, arrestando la propria indagine al primo material factor volta per volta riscontrato.
Le singole pronunce si distinguono poi per approcci ora eminentemente “formalisti”, finalizzati a rilevare la mera connessione temporale tra i rispettivi procedimenti, ora più “sostanzialistici”, protesi esclusivamente a saggiare la complessiva proporzionalità della sanzione irrogata al contribuente.
Si vedano due recenti pronunce.
Nella prima (Cass. pen. 6993/2018), la Corte si arresta alla rilevazione che tra i due procedimenti vi sarebbe stata una connessione temporale sufficiente stretta. Tale affermazione viene peraltro argomentata sulla base della mera contemporaneità dell’irrogazione delle rispettive sanzioni, senza indagare né l’effettiva connessione sostanziale tra i procedimenti (rectius, la connessione fra le rispettive istruttorie) né la presenza degli altri material factors pure richiesti.
Nella seconda (Cass. pen. 45829/2018), la Corte adotta invece un approccio sostanzialista, arrestando la propria indagine alla sola rilevazione della proporzionalità della pena complessivamente irrogata senza sondare, nuovamente, la presenza degli altri elementi ai fini della connessione sostanziale e temporale tra procedimenti.
In questo contesto si inserisce la nota pronunzia 222/2019 della Corte costituzionale, che, pur avendo tracciato a livello di obiter dictum un itinerario argomentativo di generale compatibilità dell’ordinamento italiano rispetto al divieto di bis in idem in virtù della presenza astratta di istituti che possano garantire la connessione sostanziale e temporale, allo stesso tempo ha esplicitato, giusta le modalità con cui ha condotto il test, l’imprescindibilità di tutti i material factors indicati, dovendosene pertanto indagare in concreto l’effettiva sussistenza.
Più coerente appare allora la pronuncia 52142/2018 della Suprema Corte sez. penale, che ha rinviato gli atti al giudice di merito affinché valuti in concreto il rispetto di tutti i requisiti richiesti.
Tale ultimo profilo è tuttavia quello più critico e suscettibile di ampi sviluppi.
Se infatti si analizzano le interrelazioni tra procedimento penale e procedimento tributario come rese possibili dai diversi istituti, ora di matrice legislativa ora di matrice pretoria, presenti nel nostro ordinamento, può nutrirsi più di un dubbio circa l’astratta riscontrabilità di tutti i material factors richiesti affermata dalla Consulta.
Se è pur vero che una certa “circolabilità” del materiale probatorio è sicuramente possibile, allo stesso tempo ciò che viene a mancare è la comunicabilità sul piano valutativo, essendo pacifica la necessità che i rispettivi giudici procedano ad un assessment del tutto autonomo rispetto a quello compiuto nell’altro procedimento per tener conto delle peculiarità proprie dei rispettivi giudizi (ivi compresi gli effetti dei giudicati).
Lo stesso dicasi sul fronte della complementarietà di scopo tra sanzioni penali e amministrative, posto che alle sanzioni amministrative non può essere attribuita la funzione “compensatoria” dell’attività di accertamento attribuita dalla Corte EDU nella sentenza A e B al sistema norvegese, condividendo esse quindi uno scopo del tutto omogeneo a quello delle sanzioni penali.
Il costo dell’attività di accertamento, infatti, è pacificamente a carico della fiscalità generale, diversamente da quanto avviene con l’attività di riscossione, finanziata con l’aggio, e le cui proposte di eliminazione poggiano proprio sul fatto che, come per l’attività di accertamento, anche i costi dell’attività di riscossione dovrebbero ricadere sulla fiscalità generale anziché sui trasgressori che tali costi finiscono per determinare.
Sul punto, peraltro, è recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione (5154/2017), la quale ha confermato – dinanzi all’eccezione della retroattività di una disciplina ritenuta dalla difesa “afflittiva e sanzionatoria” – che “l’aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l’attività esattoriale”.
Né convince l’ulteriore ragionamento della Consulta laddove afferma che le sanzioni penal-tributarie sarebbero caratterizzate, rispetto a quelle amministrative, da due elementi non coincidenti: segnatamente, nelle prime si assisterebbe ad un rafforzamento dello scopo deterrente proprio delle seconde e, inoltre, le prime sarebbero caratterizzate dalla funzione di garantire l’effettività della riscossione per il tramite di meccanismi premiali che garantiscono la non punibilità del fatto a fronte dell’intero pagamento del dovuto.
In particolare, non persuade l’affermazione secondo cui le sanzioni penal-tributarie avrebbero lo scopo di assicurare l’effettività della riscossione, grazie agli strumenti premiali previsti dal nostro ordinamento. Così facendo si mette a fuoco non già lo scopo della sanzione penale in quanto tale, quanto e piuttosto, quello degli istituti alla cui attivazione l’ordinamento ricollega i predetti effetti premiali. La garanzia dell’effettiva riscossione non può essere ricollegata direttamente alla norma penale, ma può essere al più ricollegata alla diversa norma che, agendo sulla prima, effettivamente incentiva il contribuente ad un celere adempimento rispetto a quanto accertato.
Nulla questio per il criterio della prevedibilità e quello della proporzionalità che, effettivamente e secondo comunque una valutazione caso per caso, potrebbero dirsi rispettati. Stesso dicasi per il profilo temporale, legato alle specificità del caso concreto.
Purtuttavia si tratta pur sempre di soli tre requisiti su cinque: conclusione, questa, che soprattutto a fronte della rimodulazione da parte della Corte EDU dell’importanza del criterio della proporzionalità e alla luce della necessaria compresenza di tutti i presupposti, induce a ritenere tuttora suscettibile di ampi sviluppi la giurisprudenza della Suprema Corte in materia.
5. Le conclusioni.
Roberto Giovanni Conti
Un cantiere aperto. Questo sembra essere lo scenario che emerge dalle risposte fornite dall’Accademia tributarista sui temi esposti nelle domande.
Un risultato di straordinaria importanza per i modi, le forme e le prospettive che esso apre rispetto ad un futuro dialogico fra la giurisprudenza, gli operatori giudiziari che operano in campo tributario e la scienza giuridica.
Una premessa, quest’ultima, che non fa, evidentemente, venire meno i punti di vista diversi.
Anzi, la lettura delle risposte mette in chiara evidenza come non vi sia affatto una linea che possa definirsi unitaria rispetto all’impatto della CEDU nel diritto tributario, sul versante sostanziale e processuale. Ma sembra che queste diversità di approccio costituiscano la vera ricchezza del compendio di riflessioni qui raccolte, mostrando in maniera nitida che solo mettendo insieme la diversità si affina l’analisi complementare delle questioni.
Il pratico, dunque, si avvicina in punta di piedi alle riflessioni contenute nelle risposte non già per sintetizzarne i contenuti e, meno ancora, per cercare di selezionarne o valorizzarne alcuni, quanto piuttosto per offrire a chi legge i punti di caduta dei diversi ragionamenti sull’esercizio della giurisdizione tributaria, soprattutto di legittimità.
Interessante, in una prima prospettiva, è la verifica della centralità del quesito in ordine al ruolo della “regola” del giusto processo in ambito tributario.
Netta sembra essere la dicotomia fra un approccio dichiaratamente favorevole all’ingresso delle regole (plurime) del giusto processo in ambito tributario, a più riprese fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, ed un metodo riduzionista che, invece, permane, strisciante, in altra parte della giurisprudenza di legittimità a proposito degli indennizzi in materia di legge Pinto.
I due fenomeni meritano, probabilmente, un’analisi differenziata.
Per un verso, infatti, pare radicata nella giurisprudenza di legittimità della sezione tributaria l’idea che le garanzie del giusto processo prevista dall’art.6 CEDU trovino spazio nel giudizio tributario, bastando sul punto ricordare alcune pronunce rese nel corso degli anni 2014 e 2015 – Cass.n.961/2015, Cass.n.23627/2014, Cass.n.23510/2014, Cass.n.23427/2014, Cass.n.23326/2014, Cass.n.23325/2014 – che pure si affiancano ad un indirizzo a volte proteso a negare spazio al giusto processo di matrice convenzionale in base alla giurisprudenza resa dalla Corte edu.
Tutt’altro che concluso si mostra, allora, lo stato dell’arte in punto di giusto processo e diritto tributario. E non sembra affatto che il tema possa esaurirsi in una prospettiva che fin qui ha mostrato di non individuare evidenti discontinuità fra protezione convenzionale e assetto del processo tributario.
Il fatto, cioè, che l’esito della verifica di conformità alle regole del giusto processo di matrice convenzionale si sia per lo più concluso nel senso di escludere l’esistenza di una violazione – e si presenti, dunque, con un saldo negativo rispetto alla protezione dei diritti in gioco – non elide per nulla la centralità del controllo di convenzionalità, essendo chiaramente in corso un processo di estrema valorizzazione del piano convenzionale e della tutela dei diritti fondamentali anche in ambito tributario. Il che significa soltanto garantire che il sistema si muova e viva nel rispetto di quei diritti che devono tuttavia essere presi in considerazione nel processo.
In questa prospettiva può essere utile dare un’occhiata ad alcuni precedenti, anche recenti, che in diverse materie hanno mostrato di muovere dal dato convenzionale per verificare la fondatezza o meno delle censure esposte in sede di legittimità (Cass. n.22627/2017; Cass. 27074/2016, Cass.n.13453/2017, Cass.n.3361/2017, Cass. n. 2889/2017, Cass.n.22629/2017, Cass.n.527/2018; Cass.S.U.n.14916/2016).
Né sembra privo di significato un approccio apertamente rivolto ad introiettare tematiche ontologicamente collegate al giusto processo anche in ambito tributario, bastando ricordare Cass.n.174/2015 che, nel definire un procedimento in tema di agevolazioni prima casa, si è data carico di affrontare il tema del mutamento giurisprudenziale sotto la prospettiva dell’art.6 CEDU per trarne la conclusione che i giudici di merito non hanno un obbligo incondizionato di seguire gli orientamenti della Cassazione, da quest’ultima potendosene discostare motivatamente senza che ciò determini una lesione del parametro convenzionale. Salvo poi ad affinare ulteriormente il ragionamento –Cass.n.15530/2016, in tema di Irap e decorrenza del termine per l’istanza di rimborso – ed a chiarire che i principi in tema di prospective overruling presuppongono un mutamento imprevedibile della giurisprudenza su una regola del processo, che comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.
Né sembra essere senza significato che la corte di legittimità, chiamata a confrontarsi con il tema dell’utilizzazione nell’ambito del procedimento tributario di prove acquisite illecitamente secondo la disciplina processuale penale, ha inteso verificare se tale illiceità a monte potesse refluire negativamente rispetto al parametro convenzionale del giusto processo protetto dall’art.6 CEDU. Ipotesi esclusa espressamente, a proposito della nota “Lista Falciani” da Cass. nn.8605 e 8606/2015- conf. Cass. n.16950/2015 e, più di recente, anche se in diverso contesto, Cass.n.29132/2018- che, affrontando ex officio la questione, hanno dapprima ritenuto applicabile la previsione convenzionale (artt.6 e 8 CEDU) in relazione all’oggetto del giudizio (coinvolgente anche sanzioni sostanzialmente di natura penale) e nel merito escluso la violazione, ricordando che la Corte di Strasburgo è ferma nel ritenere che l'utilizzazione di una prova acquisita illegalmente non determina ex se la lesione della CEDU, per poi riconoscere in concreto l’assenza di lesione, tenuto conto dei beni in gioco, dell’assenza di lesioni di canoni costituzionali e del bilanciamento fra interesse dello Stato a combattere l’evasione e diritti del contribuente – riservatezza e giusto processo–, in ogni caso protetti quanto all’acquisizione in giudizio di elementi trasmessi dall’amministrazione finanziaria straniera in forza di regolamentazione di matrice UE. Una posizione, quest’ultima che successivamente avrebbe trovato sponda nella giurisprudenza della Corte edu – v. Corte dir.uomo, 22 dicembre 2015, GSB c. Svizzera, ric.n.28601/11 –.
Passando al tema degli indennizzi in materia di legge Pinto per l’irragionevole durata dei processi tributari, quello sul punto espresso dalla Cassazione sembra essere un approccio tuttora ancorato ai principia espressi in epoca assai risalente dalla giurisprudenza della Corte edu. Si tratta di una chiusura che si mostra addirittura in maniera più marcata rispetto alle considerazioni esposte nelle risposte, benevolmente orientate a sottolineare la tendenza ad ampliare l’ambito delle limitazioni rispetto alle ipotesi di compresenza di sanzioni e di materia fiscale sostanziale all’interno del contenzioso.
Se, infatti, si segue un approccio ancora più affinato alla giurisprudenza di legittimità, non può affatto sfuggire quanto sia chiuso l’indirizzo che non riconosce l’indennizzo Pinto anche a proposito delle sanzioni arrivandosi, in definitiva, a scompaginare i criteri c.d. Engel al punto di pretendere che in tanto si possa essere in presenza di una sanzione tributaria penale (che giustificherebbe l’indennizzo), in quanto sia la legge a qualificarla come penale (Cass.n.5422/2016, Cass.n.25944/2016, che richiamano a loro volta Cass.n.16212/2012 e Cass.n.22872/2014). Laddove è evidente che simile approccio tralascia di considerare che il richiamo alla “tipicità” delle sanzioni penali non può essere decisivo ai fini della qualificazione richiesta dai criteri Engel, ponendosi la prima a tutela del diritto fondamentale dell’imputato alla libertà personale ed invece la seconda a presidio del diritto alla ragionevole durata del processo.
Sulla base di queste coordinate chi scrive accarezza con maggior favore una prospettiva in progress, piuttosto che quella che si accontenta dell’attuale assetto, magari scontando questo approccio un’adesione ad un’idea di base generale che guarda alla giurisprudenza come fattore evolutivo, se e quando esso tende a realizzare la massimizzazione della tutela dei diritti fondamentali.
Certo è che la riflessione generale su diritto tributario e CEDU debba oggi fare i conti con alcuni “fatti sopravvenuti” di particolare valore ed importanza, fra i quali si inscrive la piena vincolatività dell’art.47 della Carta di Nizza Strasburgo che, quanto meno sul versante dei tributi armonizzati, ha letteralmente frantumato il dato testuale sul quale si era sviluppata l’enclave rappresentata dalla non applicazione dell’art.6 CEDU in ambito tributario.
Ora, non è certo necessario ricordare come la CEDU sia strumento “vivente” destinato ad evolversi, quanto al suo ambito di operatività, in relazione al quadro che riguarda i diritti ivi tutelati anche per effetto di altri strumenti internazionali e costituzionali interni ai quali occorre riferirsi ai fini del contenuto di senso delle sue disposizioni (v., Corte dir. uomo, Goodwin c. Regno Unito [GC], (ric. n. 28957/95) sul ruolo della Carta di Nizza-Strasburgo; Corte dir. uomo, 9 marzo 2004, Glass c. Regno Unito, (ric. n. 61827/00), § 75; Corte dir. uomo 12 novembre 2008, Demir e Baykara c. Turchia (ric.n.34503/07) e, volendo, le riflessioni espresse su questa Rivista, in R. Conti, Ruggeri, i giudici comuni e l’interpretazione, spec. par.9).
Va allora acceso un riflettore sull’impatto rappresentato dall’art.47 Carta di Nizza-Strasburgo
e, non ultimo, quello offerto dall’art.111 Cost., che nulla fa ritenere abbia inteso escludere il processo tributario dal suo ambito applicativo. Anzi, proprio l’approccio della sezione tributaria pià aperto sul tema della garanzia convenzionale del giusto processo finisce col costituire una smentita a chi propone un’idea dei rapporti fra giurisdizionale nazionale e Corte edu improntata al carattere servente della prima rispetto alla seconda, invece dimostrando l’assoluta centralità del ruolo del giudice nazionale nell’attuazione dei diritti fondamentali della persona. Ruolo che, pur esso, non potrà non costituire un ulteriore elemento di valutazione per verificare la persistente plausibilità di un indirizzo che esclude dal giusto processo il giudizio tributario.
E ci si avvede, allora, di quanto sarebbe essenziale, in questa prospettiva, lo strumento della richiesta di parere preventivo introdotto dal Protocollo n.16 annesso alla CEDU- ma non ancora ratificato e reso esecutivo in Italia, per come emerso da diversi interventi già raccolti in questo ciclo di interviste dedicate alla CEDU – di agevole reperimento su questa Rivista (v., in particolare, fra le altre, le interviste a cura di chi scrive a P. Biavati, G. Costantino ed E. D’Alessandro, La CEDU e i processualcivilisti, nonché quella a A. Di Stasi, M. Castellaneta e A. Tancredi, La CEDU e l’Accademia europeista-internazionalista e quella a G. Raimondi e V. Zagrebelsky, La Corte edu vista dai suoi giudici,– per favorire uno scambio di opinioni fra le giurisdizioni nazionali di ultima istanza e la Corte edu.
Uno strumento che, quando sarà a regime – auspicabilmente presto – non potrà che costituire
un vero e proprio pungolo per la Corte edu, poiché in difetto di giurisprudenza sul punto ritenuto decisivo vedrà il giudice di ultima istanza nazionale naturalmente obbligato a rivolgersi alla prima, in modo da colmare le lacune della giurisprudenza europea in sede giurisdizionale attraverso la giurisprudenza consultiva stimolata dalla richiesta di pareri preventivi. L’evoluzione normativa e del diritto vivente in tema di “giusto processo” emersa tanto a livello interno – di cui si è appena detto – che all’interno della stessa giurisprudenza convenzionale – Corte dir. uomo, 19 aprile 2007, V. E. c. Finlandia (ric. n° 63235/00) – consentirebbe dunque di verificare se la posizione espressa dalla Corte edu in un certo contesto storico – capace fin qui di condizionare la stessa Corte costituzionale (Corte cost.n.56/2009) – possa o debba essere rimeditata anche alla luce della linee evolutive della sua stessa giurisprudenza in tema di ricorso effettivo al giudice.
Del resto, andando al fondo del problema, le ragioni ostative all’apertura dell’art.6 CEDU all’ambito del processo tributario risalgono alla matrice sovrana del diritto tributario, ma esse non sembrano agevolmente sopportabili a meno di favorire, a livello convenzionale, una discontinuità fra la ben radicata affermazione circa la tutela convenzionale di natura sostanziale rispetto ai parametri rappresentati dagli artt.1 Prot.n.1 e 8 CEDU e la restrizione in tema di giusto processo, ancorpiù incomprensibile se si guarda alla discontinuità fra sovranità degli Stati in ambito UE (che impone comunque il rispetto del giusto processo) e sovranità fiscale interna che andrebbe invece esentata in nome di una ragion di Stato.
Ora, vi è da chiedersi se questa discontinuità risponda a razionali spiegazioni e giustifichi una risposta normativa interna diversa senza impingere sui canoni convenzionali e costituzionali.
Passando ora al tema generale del rapporto fra CEDU e diritto tributario non sembra potersi negare che l’ingresso all’interno delle dinamiche giudiziali di concetti quali quelli della proporzionalità, ragionevolezza, bilanciamento, legalità, prevedibilità ed affidamento, margine di apprezzamento correlati al diritto vivente della Corte edu, chiami inevitabilmente il giudice (di merito e di legittimità) ad un confronto con prospettive ancora non ben focalizzate.
La prima è senz’altro quella rappresentata dal ruolo dell’interpretazione.
Occorre ancora una volta insistere sulla funzione del giudice interno rispetto all’attuazione del diritto di matrice convenzionale, al fine di fugare definitivamente l’idea che detto ruolo sia esclusivamente “ancillare” rispetto al diritto vivente proveniente da Strasburgo, nel senso che mancando il primo non vi sarà applicazione della Convenzione sul piano interno.
Idea, quest’ultima, fallace e strumentalmente agganciata a letture poco accorte delle sentenze c.d. gemelle del 2007 e dei seguiti della Corte costituzionale, fortunatamente emarginata dalla stessa giurisprudenza costituzionale. In questa direzione si inscrive, con certezza, Corte cost.n.109/2017 (§ 3.1) ove si è, fra l’altro, affermato: “...[n]ell’attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie (neretto aggiunto n.d.r.) quando il caso sia riconducibile a precedenti di quest’ultima”.
Poco tempo prima, la stessa Corte – sent. n.68/2017– non aveva mancato di sottolineare che ‘...è parimenti da respingere l’idea che l’interprete non possa applicare la CEDU, se non con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di puntuali pronunce da parte della Corte di Strasburgo.
Al contrario, «[l]’applicazione e l’interpretazione del sistema di norme è attribuita beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri» (sentenze n. 49 del 2015 e n. 349 del 2007). Il dovere di questi
ultimi di evitare violazioni della CEDU li obbliga ad applicarne le norme, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti della giurisprudenza del giudice europeo (sentenze n. 276 e n. 36 del 2016). In tale attività interpretativa, che gli compete istituzionalmente ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune incontra il solo limite costituito dalla presenza di una normativa nazionale di contenuto contrario alla
CEDU. In tale caso, la disposizione interna va impugnata innanzi a questa Corte per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., ove non sia in alcun modo interpretabile in senso convenzionalmente orientato (sentenza n. 239 del 2009). Nel caso di specie, pertanto, non è risolutiva la circostanza che la Corte di Strasburgo, con la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri contro Italia abbia applicato l’art. 7 della CEDU alle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste in materia di abuso di informazioni privilegiate, senza occuparsi della confisca per equivalente, che non era oggetto di quel contenzioso. L’interprete nazionale è infatti tenuto a sviluppare i principi enunciati sulla base dell’art. 7 della CEDU per decidere se valgano anche con riferimento alla confisca di valore, e, come si è visto, la risposta al quesito deve essere affermativa”.
La piena riconferma dei superiori principi da parte di Corte cost.n.63/2019 rende ormai pienamente consolidato il principio in forza del quale l’interprete è tenuto ad applicare la CEDU anche in assenza di pronunzie della Corte edu.
Ne esce, così, confermata l’idea che è l’interprete, e primo fra tutti il giudice comune, a dovere fare vivere (o morire, seguendo le indicazioni di Corte cost.n.49/2015) la CEDU all’interno dei casi posti al suo vaglio in una prospettiva che guarda, a me pare in ogni caso, alla CEDU come strumento di innalzamento di tutela dei diritti fondamentali.
Colpisce, anzi, nelle pronunzie da ultimo ricordate, come l’attività di interpretazione della legge sia essa stessa valorizzata e protetta sotto l’ombrello dell’art.101 Cost. che viene spesso individuato come elemento che i giudici violerebbero apertamente facendo ricorso ad interpretazioni creative, per l’appunto impedite dall’art.101 Cost.
Quando la Corte costituzione riconosce che “… nell’attività interpretativa che gli spetta ai sensi dell’art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune ha il dovere di evitare violazioni della Convenzione europea e di applicarne le disposizioni, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU…– Corte cost.n.109/2017 – essa dimostra, ancora una volta, quanto centrale sia il riferimento al canone ermeneutico nell’attività giudiziale, pur con le inevitabilità complessità che si aprono innanzi all’esercizio della giurisdizione.
In questo contesto si inserisce a pieno titolo il tema del c.d. bis in idem, che rappresenta forse la migliore cartina di tornasole rispetto al ragionamento qui espresso. Proprio l’analisi di uno dei più recenti precedenti della Corte di Cassazione tributaria in materia (Cass.n.34219/2019) sembra confermare quanto appena detto. Il giudice di legittimità è stato infatti chiamato a verificare l’esistenza di un bis in idem con una memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis, c.1, c.p.c., in una vicenda nella quale, a dire del ricorrente, il legale rappresentante della società contribuente era già stato giudicato, in sede penale, per gli stessi fatti, con sentenza ormai divenuta irrevocabile. Ragion per cui i giudici di merito avrebbero anche dovuto valutare, a suo dire, proprio in ossequio ai principi di diritto stabiliti dalla Corte Europea e richiamati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 43 del 2018, se nel caso di specie fosse stato violato il divieto di bis in idem.
Ora, la Corte di Cassazione ha ritenuto, in rito, di potere (e dovere) esaminare tale “censura”, non occupandosi, peraltro, della non meno spinosa questione relativa ai tempi processuali entro i quali è possibile depositare nel giudizio di legittimità gli atti a sostegno di una prospettata violazione del giudicato - nel caso concreto parrebbe di capire già prodotti innanzi al giudice di merito (ma v. in precedenza, Cass.n.950/2015)–.
Il punto non è di secondario rilievo.
Il giudice di legittimità ha in definitiva riconosciuto che la lesione di un diritto di matrice fondamentale protetto dalla CEDU può essere prospettata oltre i termini ritualmente previsti per la formulazione dei motivi del ricorso per cassazione.
La questione è di grande rilievo (v., volendo, R. Conti, Legge Pinto - ma non solo - Corte di Cassazione e CEDU su alcune questioni ancora controverse, in Questione giustizia, 23 marzo 2015 - 24 febbraio 2015 - poiché sembra strettamente connessa con quella ulteriore della rilevabilità ex officio della violazione di un diritto fondamentale - v. volendo, R. Conti, Contrasto fra norma interna e CEDU: fra rilevabilità ex officio e controllo diffuso di convenzionalità, in Questione giustizia, 24 febbraio 2015 -.
Del resto, in tema non può sfuggire il richiamo ad una recente pronunzia della Corte di Cassazione penale.
Cass.pen. n.31282/2019, in tema di lottizzazione abusiva e degli effetti della prescrizione sulla confisca dei beni, ha infatti avuto modo di precisare che “è rilevabile d'ufficio anche in sede di giudizio di legittimità la questione relativa alla violazione delle disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, poiché, quando evidenzino una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna con la Convenzione europea, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale sono state pronunciate (Sez. 1, n. 24384 del 03/03/2015, Mandarino, Rv. 263896; Sez. 3, n. 19322 del 20/01/2015, Ruggieri, Rv. 263513; Sez. 3, n. 11648 del 12/11/2014, dep. 2015, P., Rv. 262978). In quest’occasione il giudice di legittimità non mancò di precisare che “… Essendo il giudice tenuto ad applicare il diritto nazionale in conformità ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117, primo comma Cost.), deve ritenersi che, laddove la Corte EDU abbia individuato un profilo di (possibile) incompatibilità tra l'ordinamento di uno Stato membro del Consiglio d'Europa e i principi convenzionali – peraltro, per la prima volta e con una sentenza resa dalla Grande Camera, che quindi certamente rappresenta il diritto consolidato in materia (cfr. Corte cost., sent. 49/2015) – la Corte di cassazione debba rilevare d'ufficio la questione ai sensi dell'art. 609, comma 2, cpp., come se ci si trovasse di fronte al ius superveniens.” Tale conclusione, secondo la Corte confermata dalla posizione assunta da Corte cost.n.43/2018, che restituì gli atti al giudice remittente perché valutasse gli effetti di una pronunzia della Grande Camera della Corte edu successivamente intervenuta rispetto all’ordinanza di rimessione, è dimostrativa di quanto sia in corso una fase destinata a modificare in modo profondo lo stesso sistema processuale interno. Scrutinare gli effetti che tale pronunzia, esportata in ambito civilistico, potrebbe determinare è compito degli interpreti e della scienza giuridica, confermando ancora di più quella complessità del sistema alla quale si accennava sopra.
Ora, è evidente che il fascio di questioni appena accennate si collega a quella di ancora più ampio respiro della convergenza dei parametri che proteggono diritti fondamentali, a prescindere dalla fonte dalla quale promanano – Costituzione, CEDU, Carta dei diritti fondamentali –.
Il terreno sembra davvero ancora tutto da dissodare se si considera il trend che, per un verso, tende a mantenere una netta differenziazione fra i parametri e le norme di ingaggio dei rispettivi sistemi e, in definitiva, la regola della “competenza” – alla base della quale vi è, per dirne una, l’impossibilità di applicare il diritto UE fuori dai suoi ambiti come delineati dal sistema UE –. Per altro verso, il continuo flusso di comunicazione fra le Carte e le Corti rende inarrestabile un processo esattamente opposto, rivolto a favorire la continua opera di armonizzazione fra i diversi parametri e sistemi, in una prospettiva di continua e mutua alimentazione che si pone agli antipodi del sistema di competenza e guarda, invece, ai canoni di cooperazione, confronto, dialogo, tendenziale uniformità di tutele a prescindere dal parametro preso in considerazione.
E questa sensazione si rafforza quando, per l’appunto, proprio le risposte offerte rispetto alla questione sul “che fare” per verificare l’esistenza del bis in idem dimostrano quanto il giudice (di merito e di legittimità – tributario e penale–) cominci ad interrogarsi sui confini del proprio ruolo di “controllore” della convenzionalità e su quanto e fino a quando si estenda il controllo di legittimità sull’operato del giudice di merito.
Interrogativi che attendono ancora una risposta di sistema ma che, già ora, sembrano dimostrare quanto il sindacato giudiziario tenda a modificarsi radicalmente.
Basti riflettere, ancora, sulle questioni che reclamano una verifica di convenzionalità a proposito della prevedibilità, accessibilità e chiarezza della legge, o della proporzionalità delle misure limitative di posizioni giuridiche soggettive, per non dire di quelle che evocano il tema del bilanciamento fra i diritti fondamentali – per cui v. Cass., S.U. 21 dicembre 2018, n.33208, in Giur.it., 2019,1072, con nota di R. Conte –.
Insomma, un ruolo che guarda al rapporto del giudice con la legge in termini profondamente diversi, caratterizzando in termini ancora da scoprire quel controllo di garanzia che la Costituzione affida proprio al giudice, oggi notevolmente arricchito anche se ancora da ben determinare, per effetto della piena considerazione della CEDU e del diritto vivente che da essa promana.
Ora, certo, si dirà che vi sono più indici che sembrano deporre per una valenza attenuata della CEDU nelle questioni “di fisco”. Così è stato fino a poco tempo fa. Ma l’orizzonte, onestamente, sembra destinato a modificarsi, apparendo deboli le giustificazioni che tendono a ridurre l’impatto dei diritti fondamentali nel diritto tributario. L’analisi richiederà, dunque, l’apporto degli studiosi e la capacità della giurisprudenza di ascoltare, dialogare, collaborare.
Il che non vuol certo dire fomentare una rappresentazione della giustizia (qui tributaria) capace di scompaginare il ruolo delle fonti e dello stesso potere giudiziario. Ma nemmeno ci si sente di accarezzare l'idea che l’avvento del diritto di matrice convenzionale rechi con sé fenomeni astronomici catastrofici o che l’ambito dei compiti affidati al giudice diventi per ciò stesso ambiguo, in questa direzione preferendo, per quel nulla che vale, la prospettiva di recente espressa nell’intervista dedicata al tema CEDU e diritto civile da Nicolò Lipari ed Emanuela Navarretta – cfr. CEDU e cultura giuridica italiana. 5. La Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e i civilisti, R. G. Conti intervista N. Lipari e E. Navarretta–.
Prospettiva che qui sommessamente si caldeggia e che non si alimenta, del resto, del diritto straniero ma, semmai, di un diritto convenzionale che è pleno iure diritto interno, reso esecutivo con legge dello Stato, rispetto al quale l’atteggiamento dell’interprete non sembra poter essere quello di mera verifica di ciò che accade ab externo, ma tutto al contrario di ciò che sul piano interno assume per l’interprete forza di legge. La giurisprudenza mastodontica della Corte edu in materia di diritto al rispetto dei beni (art.1 Prot. n. 1 annesso alla CEDU), del resto, è lì a dimostrare che le frontiere fra CEDU e diritto tributario sono meno lontane di quanto possano apparire.
La Corte dei diritti umani ha infatti da tempo chiarito che è la seconda parte del secondo paragrafo dell’art. 1 Prot. n.1 a consentire l’imposizione fiscale come limite del godimento dei beni, anche se spetta ad essa Corte valutare se la misura fiscale preserva il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti dell’uomo. Il che esclude che l’imposizione fiscale possa importare un carico eccessivo idoneo a pregiudicare la situazione finanziaria del contribuente – Corte dir. uomo, 3 giugno 2004, Di Belmonte c. Italia –.
La Corte edu non manca poi di ricordare che spetta, in primo luogo, alle autorità nazionali decidere i tipi e i livelli di imposizione fiscale, poiché tali decisioni implicano normalmente un esame di problemi politici, economici e sociali che la Convenzione affida alla competenza dei Paesi aderenti che, essendo in grado di apprezzare in modo diretto tali problematiche, godono sul punto di un significativo potere discrezionale. E proprio sulla base di tali presupposti si è giunti alle più recenti decisioni in tema di indennità di esproprio ricordate nelle risposte.
Sarà, dunque, il terzo binario al quale si è perspicuamente accennato in alcune delle risposte a costituire, probabilmente, terreno di elezione per discutere sul punto di caduta della tutela proprietaria, anche dal punto di vista procedurale, rispetto alla confisca, nelle multiformi e variegate forme con le quali essa si atteggia quale misura sanzionatoria. Ciò senza per nulla porre in discussione la centralità della politica fiscale e della stessa partecipazione alle spese pubbliche come momento espressivo della stessa dignità della persona.
Certo, entrano a questo punto in gioco riflessioni di sistema talmente complesse da reclamare, a viva voce, la necessità di un approccio interdisciplinare – che pure la vicenda del bis in idem dimostra in maniera lampante –. La compresenza di giurisprudenza delle Corti nazionali e sovranazionali che discutono e decidono rispetto ad uno stesso diritto fondamentale che magari si declina in modo non perfettamente sovrapponibile nelle fonti di riferimento espone sicuramente il giudice a compiti aggiuntivi di estrema delicatezza che egli deve sapere governare e maneggiare in modo adeguato anche e soprattutto grazie all’apporto di chi studia e fa cultura giuridica. Sicché i migliori frutti si potranno ottenere abbandonando l’idea di una primazia fra scienza giuridica e diritto vivente ed invece favorendo, in concreto, processi di confronto equiordinati e di mutuo servizio dell’uno verso l’altro.
Le risposte che hanno caratterizzato questa intervista sembrano essere, allora, il migliore viatico verso una stagione di riflessione congiunta che non potrà non trovare nel diritto vivente quelle risposte a dubbi e sollecitazioni che la dottrina offrirà al servizio, essa come i giudici e gli avvocati, della giustizia.