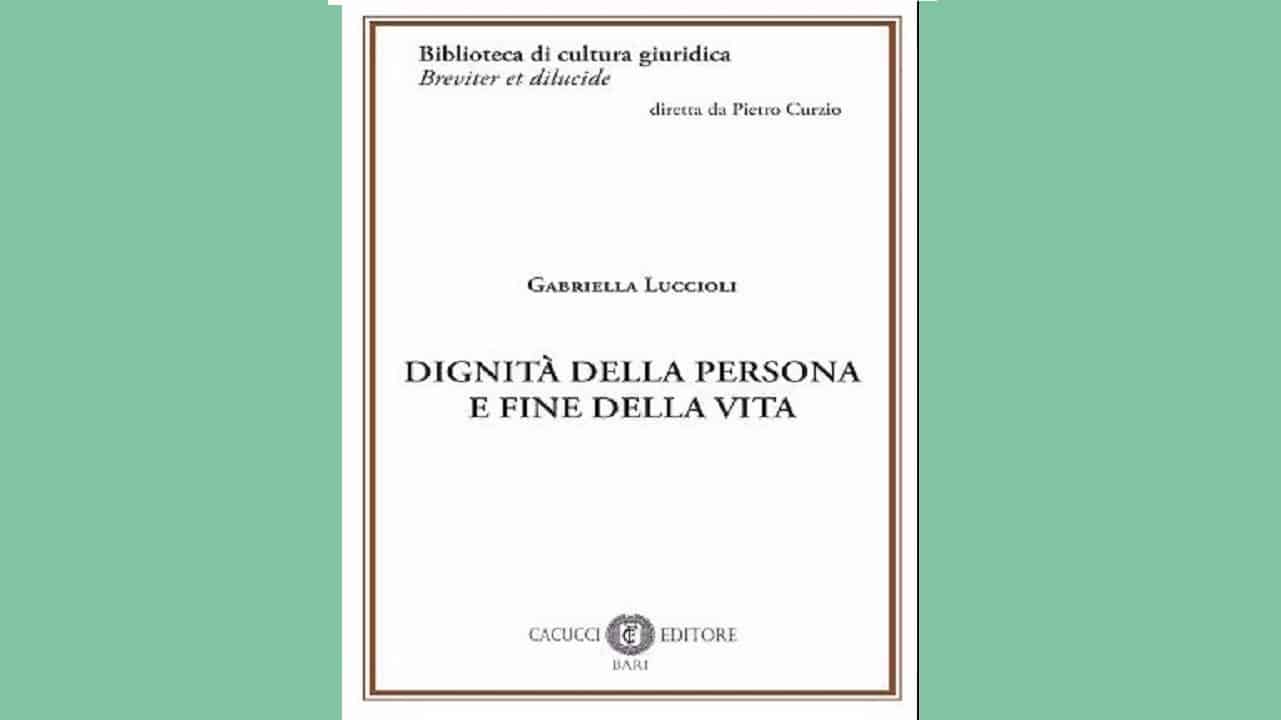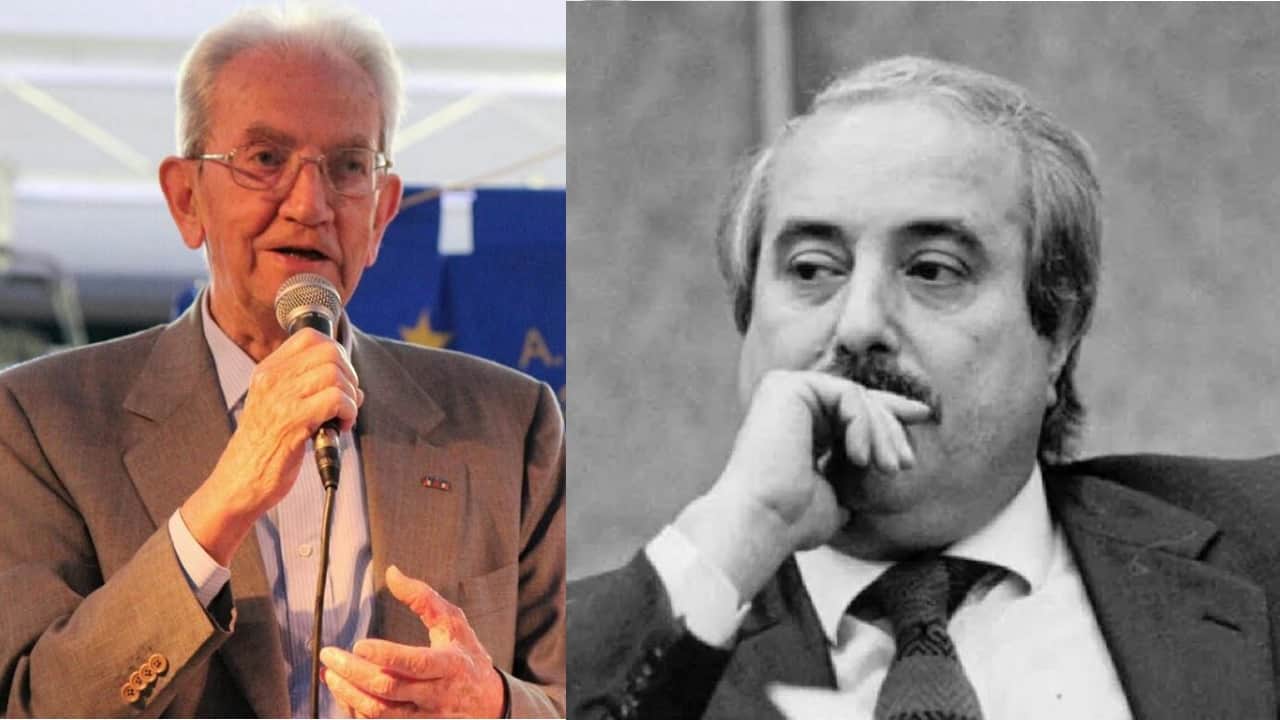Le interviste di Giustizia insieme
di Roberto Giovanni Conti
La retorica dei diritti fondamentali?
1. Qual è il peso dell’interpretazione giudiziale in un sistema nel quale le Carte dei diritti fondamentali nazionali e sovranazionali e il loro intrecciarsi, spesso difficoltoso anche a causa dei diversi plessi giurisdizionali chiamati ad intervenire impone al giudice un controllo di garanzia che lo induce anche e non per sua scelta a decisioni contromaggioritarie, prestando il fianco a critiche di varia portata fra le quali quella più urticante o preoccupante – a seconda dei punti di vista – è forse quella del giudice che “scende in campo per fare politica”?
2. Quali sono le maggiori insidie che l’attività interpretativa nasconde rispetto all’operato del giudice?
3.Come si atteggia il canone della soggezione del giudice alla legge in caso di lacuna legislativa e qual è in tal caso, a Suo giudizio, il peso ed il ruolo dei diritti fondamentali?
Baldassare Pastore, ord. filosofia del diritto Univ. Ferrara
Giorgio Pino, ord. filosofia del diritto Univ. Roma 3
1. La scelta del tema. 2. Le interviste. 3. Le repliche. 4. Conclusioni. 5. Intervista in pdf.
La scelta del tema.
Il titolo dell’intervista che chiude la rassegna di approfondimenti dedicati al ruolo del giudice nel sistema di protezione dei diritti fondamentali, iniziata alcuni mesi fa con l’intervista ai Professori Bin e Ruggeri e proseguito con i contributi di autorevoli giuristi ed accademici di diverse branche del diritto (costituzionale, del diritto penale, dell’Unione europea) intende riannodare i fili fin qui sparsi questa volta coinvolgendo due autorevoli filosofi del diritto, appartenenti per loro stessa ammissione a scuole del pensiero filosofico diverse.
In questa prospettiva il richiamo alla retorica dei diritti umani che campeggia nel titolo ha inteso sottoporre all’attenzione degli intervistati la critica di fondo spesso rivolta a chi insiste sulla centralità dei diritti fondamentali senza adeguatamente ponderare i rischi di uno sviluppo sconsiderato e sregolato del piano dei diritti capace di favorire un clima di enfatizzazione o deificazione dei diritti medesimi per l’un verso non sostenibile dal punto di vista finanziario e, per altro verso, capace di minare alla radice il sistema democratico, spostando il baricentro della produzione giuridica dal piano legislativo a quello, innaturale, del giudiziario.
Le risposte di Baldassare Pastore e Giorgio Pino, ordinari presso le Università di Roma 3 e Ferrara, insieme alle repliche ed alle conclusioni, sono come di consueto compendiate nel documento in pdf da scaricare.
1. . Qual è il peso dell’interpretazione giudiziale in un sistema nel quale le Carte dei diritti fondamentali nazionali e sovranazionali e il loro intrecciarsi, spesso difficoltoso anche a causa dei diversi plessi giurisdizionali chiamati ad intervenire impone al giudice un controllo di garanzia che lo induce anche e non per sua scelta a decisioni contromaggioritarie, prestando il fianco a critiche di varia portata fra le quali quella più urticante o preoccupante – a seconda dei punti di vista – è forse quella del giudice che “scende in campo per fare politica”?
Giorgio Pino
Che il ruolo, l’incidenza, e anche il carattere innovativo (creativo?) dell’attività interpretativa sia esponenzialmente aumentato nel contesto dello Stato costituzionale contemporaneo, è un dato di assoluta evidenza. Di fronte a questo dato, si possono adottare le posizioni più diverse.
La prima, è di considerarlo una patologia, una deviazione dai venerabili canoni iscritti nel codice genetico stesso dello Stato di diritto. Questa posizione ha tra i suoi meriti una certa passione civile e un chiaro attaccamento a valori democratici, alla separazione dei poteri e alla certezza del diritto – e ciò la rende del tutto rispettabile, e degna di attenzione.
Una seconda posizione è forse un po’ più articolata, e guarda non solo al dato di fatto (l’accresciuto ruolo dell’interpretazione giudiziale), ma al significato che essa ha negli Stati costituzionali contemporanei. E da questo punto di vista, il ruolo sempre più centrale assunto dal momento interpretativo si presenta non come una patologia, ma come una vera e propria fisiologia dello Stato costituzionale: un tratto caratteristico del costituzionalismo contemporaneo, iscritto nel suo modo ordinario di funzionare. Le ragioni di ciò sono ben note: nello Stato costituzionale contemporaneo, al primato della legge si sostituisce il primato della costituzione, una costituzione che è concepita come pienamente normativa, come una fonte del diritto a tutti gli effetti, passibile di applicazione giudiziaria. Allo stesso tempo, però, la costituzione è una fonte del diritto un po’ particolare, perché non contiene la precisa disciplina di fattispecie e casi della vita, ma piuttosto principi – norme generiche e indeterminate, esplicitamente portatrici di un contenuto di valore, la cui applicazione passa necessariamente attraverso operazioni di concretizzazione e di bilanciamento.
È del tutto evidente come la congiunzione di questi due fattori (la costituzione che viene considerata come fonte del diritto suscettibile di applicazione giudiziale, e che contiene norme di principio) si traduca in definitiva in un notevole aumento dei poteri interpretativi e anche nomopoietici dei giudici.
Sarebbe però riduttivo rendere questo quadro nei termini di un mero aumento “quantitativo” rispetto al passato, cioè rispetto all’immagine tradizionale della gerarchia delle fonti e della separazione dei poteri (con annessa soggezione dei giudici alla legge): una fonte in più (la costituzione), un po’ di discrezionalità interpretativa in più... Il mutamento, in realtà, è ben più profondo. Lo Stato costituzionale non si limita a rendere i giudici un po’ più liberi nelle loro operazioni interpretative, ma piuttosto attua una distribuzione di potere di produzione normativa tra legislatore e giudici.
Infatti, il diritto giurisprudenziale – ammesso che ci si metta d’accordo su cosa significhi esattamente questa locuzione – ha una natura affatto particolare: attenendo esso primariamente al momento “interpretativo”, e non esplicitamente a quello produttivo, del diritto, il diritto giurisprudenziale finisce per sovrapporsi, come una patina, a tutte le altre fonti. Non è una fonte in più, che si pone accanto alle altre, ma piuttosto una fonte (se è una fonte) che tende ad inglobare le altre. Faccio due esempi, per rendere più chiaro ciò che sto dicendo.
Primo esempio. Supponiamo che si presenti la necessità di tradurre qualche principio costituzionale, o qualche congiunzione di principi costituzionali, in più maneggevoli regole (come ho già detto, i principi non si prestano ad applicazione immediata: devono prima essere concretizzati, bilanciati, e in tal modo trasformati in regole). Questa operazione di “traduzione” può essere effettuata dal legislatore, oppure dalla giurisprudenza. Ebbene, se questa operazione è effettuata dal legislatore, il prodotto è, palesemente, una o più regole legislative. Di contro, se questa operazione è effettuata dalla giurisprudenza, che cos’è ciò che viene prodotto? Quantomeno in teoria, trattandosi di regole direttamente derivate dalla costituzione, o comunque presentate come implicite nella costituzione, dovremmo concludere che si tratta di regole di rango costituzionale. O quantomeno di rilevanza costituzionale. Con tutto ciò che ne seguirebbe riguardo alla possibilità che quelle regole siano poi emendabili da parte del legislatore – pur trattandosi di regole in effetti prodotte dalla giurisprudenza. Ciò che intendo dire, all’osso, è che quando il legislatore attua un principio costituzionale, scrive leggi. Ma quando la giurisprudenza interpreta “estensivamente” la costituzione, individuando nuovi diritti o principi costituzionali non scritti, essa scrive nuovi pezzi della costituzione.
Secondo esempio. (In fondo, è poco più che una variante del primo.) Quando la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità di una legge, essa si comporta da legislatore ordinario, ancorché legislatore “negativo” à la Kelsen: nel senso che emette un atto che nella gerarchia delle fonti ha lo stesso rango della legge (pur essendovi, ovviamente, altre differenze rilevanti tra una dichiarazione di incostituzionalità e un atto di abrogazione). Di contro, quando la Corte emana sentenze additive o manipolative, essa non si limita a cassare una soluzione incostituzionale, ma piuttosto riscrive pezzi della legge. Ebbene, si può affermare che in questi casi la Corte sia semplicemente un legislatore ordinario “positivo”, che opera a fianco del legislatore riscrivendo pezzi di leggi ordinarie? In realtà non sembra che le cose siano così semplici. Infatti, in questi casi, la Corte statuisce che una certa addizione o manipolazione del testo di legge rappresentano la soluzione costituzionalmente obbligata. E questo non è esattamente come emendare la legge in sede parlamentare, cioè con un’altra legge. Ma allora, che ne è della legge “riscritta” in tal modo dalla Corte? È questa ancora una semplice legge ordinaria, liberamente emendabile dal Parlamento? O forse quella legge ora è irrimediabilmente fusa con la costituzione, per effetto della riscrittura operata dalla Corte costituzionale?
Non solo. A tutto ciò, l’architettura normativa del costituzionalismo contemporaneo aggiunge un’ulteriore dimensione: quella sovranazionale. Stavo per dire che aggiunge “un piano in più”, ma qui ancora più che altrove la metafora spaziale risulta inadeguata a rendere conto di quanto sta succedendo. In effetti, la dimensione sovranazionale non è affatto un piano in più nella gerarchia delle fonti, ma un ulteriore elemento di complessità e destabilizzazione del sistema, un’ulteriore variabile interpretativa – come dimostrano in modo precipuo le alterne vicende dell’uso giudiziario della Cedu negli ultimi tre decenni. L’immagine più adatta non è quella verticale dei “nuovi” piani che si aggiungono a quelli precedentemente esistenti, ma piuttosto quelle assai meno ordinate e rassicuranti dell’arcipelago, della rete, o perfino del caleidoscopio.
L’inserzione del piano sovranazionale nella dinamica delle fonti, ovviamente, non è un mero accidente storico o un’evoluzione aberrante degli ordinamenti giuridici contemporanei: è anch’essa iscritta nel codice genetico del costituzionalismo contemporaneo. È figlia, cioè, di quella stessa diffidenza verso i poteri incontrollati, per l’assenza di limiti, di freni e contrappesi che ha portato alle (o quantomeno ha docilmente accompagnato le) catastrofi del Novecento. L’aggancio alla dimensione sovranazionale è un altro modo, dunque, accanto alla codificazione di vari diritti e principi in una costituzione rigida, con cui Ulisse si è legato all’albero della nave della civiltà per evitare di farsi ammaliare dalle sirene – finendo ad esse in pasto.
È non solo possibile, dunque, ma anche perfettamente coerente che questo quadro produca la possibilità di decisioni giudiziarie contromaggioritarie. La legge, ovviamente, non è scomparsa dal quadro, ma è sempre più ostaggio di interessi particolari, così come dell’emotività indotta dal marketing politico. Fermo restando che il legislatore democratico gode comunque di ampi margini di manovra e di discrezionalità politica (i principi costituzionali e sovranazionali, proprio in quanto principi, non dettano mai una soluzione univoca), la funzione del giudice nello Stato costituzionale consiste esattamente nel vegliare sulle possibili violazioni di quei principi, e possibilmente nel restaurare anche in via interpretativa la coerenza tra legislazione e costituzione.
Come si vede, il quadro che ne risulta è complesso: il costituzionalismo contemporaneo vive di molteplici interazioni e tensioni. E ho detto che questo fa parte in un certo senso della fisiologia, e non della patologia, dello Stato costituzionale. Ovviamente, anche il modello dello Stato costituzionale può generare aberrazioni e torsioni dei propri stessi assunti normativi – di modo che, ad esempio, la maggiore discrezionalità giudiziale diventi un nuovo “diritto libero”, o che la pratica del bilanciamento tra principi costituzionali diventi un imperscrutabile esercizio di decisione equitativa e casistica. La sfida, in definitiva, è di incorporare quanto più possibile le esigenze – rispettabili, importanti – cui ho accennato in apertura (democrazia, separazione dei poteri, certezza del diritto), con il nuovo assetto normativo e istituzionale che deriva dall’architettura del costituzionalismo contemporaneo. La scommessa dello Stato costituzionale è che dal caleidoscopio dei centri di produzione normativa – il legislatore, la Corte costituzionale, i giudici comuni, corti sovranazionali – emerga una migliore, più equilibrata tutela dei diritti fondamentali. La scommessa, in altre parole, è di imbrigliare la decisione sovrana nella pratica discorsiva dello scambio degli argomenti.
Nello Stato costituzionale, nessuno ha l’ultima parola. È inevitabile che questo esponga le corti alla volgare accusa di “voler fare politica”, perché nello Stato costituzionale le corti non sono meramente soggette alla legge, ma prima di tutto alla Costituzione, e dunque sono autorizzate e talvolta perfino obbligate a mettersi in rotta di collisione con il legislatore. Parimenti scorretto sarebbe confondere una decisione contro-maggioritaria con una decisione antidemocratica: anche lasciando da parte la difficoltà di stabilire che cosa voglia “la maggioranza”, che già di per sé è un problema non da poco, resta il fatto la democrazia non inizia e finisce nel giorno delle elezioni. È la democrazia stessa a richiedere limiti e controlli su chiunque detenga il potere.
Baldassare Pastore
I diritti fondamentali, ai quali fanno riferimento i documenti normativi nazionali (in primo luogo le costituzioni) e sovranazionali, costituiscono una pratica che ha segnato profondamente l’esperienza giuridica del nostro tempo. Tali diritti configurano la strutturazione (sempre in fieri) delle esigenze degli esseri umani lette sub specie iuris.
Il linguaggio dei diritti, invero, si è rivelato particolarmente duttile ed è stato adottato per il ruolo essenziale da esso svolto, consistente nella tutela delle spettanze proprie delle persone. I diritti estrinsecano un nucleo di senso che si articola come “unità di misura dell’azione” nello spazio dell’interazione, sotto il segno dell’eguale considerazione e rispetto e della correzione dell’iniquità e del torto, rinviando alla tutela e al soddisfacimento dei bisogni vitali e delle capacità basilari che definiscono la condizione umana. La loro attuazione richiede impegno, vigilanza, iniziativa, attitudine critica, congenialità ermeneutica, precomprensioni condivise, capaci di sfuggire alla retorica della proclamazione, che sconfina in esiti di ineffettività.
I diritti fondamentali si caratterizzano per la loro sovraordinazione normativa e per la priorità che essi hanno nell’ambito del diritto positivo, ponendosi come “nucleo duro” escluso dalla transazione, dalla negoziazione, sottratto al potere di disposizione dell’autorità legislativa, nonché come limite assoluto alla revisione costituzionale.
Tali diritti presentano come loro connotazione strutturale una “apertura semantica”, che non può essere colta in modo adeguato se viene ricondotta completamente alla indeterminatezza tipica del linguaggio giuridico. Va intesa, invece, come potenzialità di senso, che gli enunciati sui diritti hanno e che trova la sua attualizzazione nelle differenti situazioni.
È in ragione di tale proprietà che il catalogo dei diritti è in evoluzione e procede per specificazioni, legate al riconoscimento di “nuovi” diritti o alla precisazione in forme diverse di diritti in precedenza riconosciuti.
“Apertura semantica” significa non esaustività, ossia impossibilità di una determinazione completa dei diritti rispetto ad ogni possibile situazione. È richiesta, a questo proposito, una delicata e complessa opera ermeneutica volta a regolare, con riguardo ai casi particolari, le modalità del loro esercizio. La dimensione interpretativa e argomentativa risulta, così, connaturata ai diritti, la cui attuazione avviene tenendo conto di varie condizioni normative e fattuali (il tessuto giuridico complessivo e le esigenze dei casi). Solo in tal modo diventano praticabili e praticati. Il loro funzionamento implica la complementarità tra il livello del riconoscimento formale – che riguarda la formulazione generale e astratta in documenti normativi – e quello della concretizzazione nei casi individuali, che richiede un esercizio interpretativo, vincolato al rispetto del nucleo valoriale che essi costitutivamente esprimono.
Viene in evidenza, a questo riguardo, l’intervento dei giudici. La giurisdizione, negli Stati di diritto, si pone come garante dei diritti. Per un verso, infatti, nessun diritto c’è davvero se non è assistito dalla tutela giurisdizionale. Vi è, dunque, un legame intrinseco tra l’effettiva esistenza di un diritto e la possibilità di farlo valere in giudizio in caso di violazione o di mancata attuazione. Per altro verso, lo Stato costituzionale di diritto – inteso come modello istituzionale volto ad assicurare l’equilibrio tra l’esercizio dell’autorità politica legittimata democraticamente e i diritti fondamentali, che rappresentano l’altro polo di legittimità delle organizzazioni giuridico-politiche, ponendosi come limiti contenutistici invalicabili alle decisioni dei governanti e dei legislatori – è finalizzato a impedire le possibili derive “dispotiche” della democrazia. Negli Stati costituzionali, pertanto, la democrazia non è solo governo della maggioranza, ma implica anche la tutela di alcune opzioni assiologiche basilari che non possono essere lese dalla maggioranza stessa senza che un giudice intervenga per restaurarle e proteggerle. Non va mai dimenticato – lo ha evidenziato, tra gli altri, Ronald Dworkin – che le maggioranze politiche sono parte in causa nelle controversie tendenti a stabilire se qualcuno abbia diritto a qualcosa, poiché gli interessi (nonché le idiosincrasie) della maggioranza possono opporsi al riconoscimento di un certo diritto, producendo discriminazioni e/o privilegi. Le pressioni cui sono sottoposti i legislatori escludono che essi siano i soggetti istituzionalmente più qualificati per decidere questioni concernenti i diritti. L’argomento contromaggioritario, così, va compreso considerando la dualità che il diritto presenta in ragione del suo essere strumento disponibile in mano al potere politico e modalità indisponibile, fuori dalla portata della sua volontà. L’ordinamento giuridico, sicuramente negli Stati costituzionali, vive nella tensione tra due momenti: quello della strumentalità di un diritto al servizio del potere (anche di quello legittimato democraticamente) e quello dell’indisponibilità di un diritto operante nella composizione giudiziaria dei conflitti e – come ci ricorda Jürgen Habermas – il momento dell’indisponibilità rappresenta un contrappunto alla strumentalizzazione del medium giuridico. Una delle peculiarità dello Stato costituzionale consiste proprio nella presenza di un’area del diritto positivo “protetta” nei confronti degli stessi poteri democratici.
Gli ordinamenti giuridici contemporanei sono attraversati da notevoli trasformazioni. Si compongono di svariati materiali normativi, dotati di diversi gradi di determinazione. Si strutturano come insiemi complessi, policentrici, in una dinamica interattiva tra livelli differenti (nazionali e sovranazionali) che generano connessioni tra plessi di regolamentazione. Attraverso la giurisdizione i diritti trovano il loro inserimento e il loro uso all’interno dei processi di positivizzazione giuridica. Guardando all’Europa, come è noto, la garanzia dei diritti rinvia all’interazione tra livelli di tutela riguardante i rapporti, invero complessi, tra giurisdizioni (ordinarie e costituzionali) nazionali, Corte di giustizia dell’Unione europea, Corte europea dei diritti umani, nella prospettiva di un “costituzionalismo multilivello”. Siamo di fronte ad un processo osmotico in cui le fonti nazionali e quelle sovranazionali si combinano e si integrano. In questo senso, nessun ordinamento può essere considerato chiuso in sé e autosufficiente, sicché quello dei diritti è, in buona misura, un “gioco senza frontiere”.
I diritti non vivono senza l’interpretazione. Se non vi sono diritti senza interpretazione, e se l’interpretazione è sempre inventiva, dovendosi misurare con i problemi di vaghezza e ambiguità del linguaggio con cui sono costruiti i testi normativi, nonché con le incognite relative ai casi singoli e con quelle riguardanti i mutamenti e l’evoluzione storica, sicché l’attribuzione di significato alle disposizioni costituisce sempre un arricchimento dello schema semantico in esse contenuto, allora vanno riconosciuti ai giudici alcuni irriducibili spazi di libertà, che però esigono un impegno ad esercitarla in modo controllato e responsabile attraverso scelte e valutazioni trasparenti, consapevoli e motivate. Da un punto di vista deontologico, appartiene ai compiti del giudice la ricerca e la formulazione della norma migliore tra quelle possibili in un determinato ordinamento e in un determinato momento. “Migliore” significa “giusta”, adatta al caso, argomentata correttamente, fatta tecnicamente bene; “possibile” significa che la norma va ritrovata entro il corpus giuridico, coerentemente con i princìpi ordinamentali.
L’interpretazione non costituisce il mezzo per identificare un significato normativo precostituito, fisso, autosufficiente, ma concorre a determinare tale significato. Non è possibile stabilire se enunciati e parole hanno o non hanno un significato chiaro indipendentemente dal contesto di riferimento e di ricezione: un contesto che è linguistico, socio-culturale, situazionale, istituzionale.
L’interpretazione, comunque, ha bisogno di un perimetro testuale che si configura quale elemento delimitante, benché in modo approssimativo, l’ambito entro il quale essa si esercita. Vi è, dunque, una strutturale relazione tra la disposizione da interpretare (che può essere configurata come “norma in potenza”) e la norma, prodotto dell’interpretazione (che può essere configurata come “norma in atto”).
Ogni testo giuridico è “muto” fino a quando non viene sollecitato da un caso concreto. Ha bisogno sempre di essere interpretato al fine di esplicitarne il senso oscuro o non sufficientemente determinato per definire la rilevanza giuridica di fatti, eventi, accadimenti particolari. Abbiamo a che fare, allora, con problemi di indeterminatezza semantica (non si sa bene cosa significhi la disposizione) e di indeterminatezza casistica (non si sa bene quali fattispecie concrete rientrino nella fattispecie astratta). Il testo, propriamente, opera come progetto che diviene attuale, grazie all’interpretazione e alle diverse successive “lavorazioni”. In tal modo, da “semi-lavorato” diventa “prodotto finito”, almeno con riferimento a uno specifico caso concreto.
I giudici interpretano disposizioni normative a fini applicativi, e non possono non farlo. La loro attività consiste nel reperimento della soluzione giuridicamente adeguata alla situazione particolare e nel ritrovamento della regola del caso, cercata nei depositi normativi. L’interpretazione si pone come componente essenziale della giuridicità (come sua realtà profonda), nonché come mezzo stesso del suo operare in concreto. I giudici sono inoltre chiamati a integrare il diritto. Posto il divieto di non liquet, hanno l’obbligo di decidere tutte le controversie di cui sono investiti sulla base di materiali normativi validi, da loro non creati, ma elaborati in modo derivato, muovendo dalle fonti.
In questa prospettiva, assumono rilievo quelle che potremmo definire “operazioni reinterpretative” e quelle forme di creazione giurisprudenziale dei diritti che si configurano come enucleazione ed esplicitazione di diritti già collocati all’interno del contesto ordinamentale. Le operazioni reinterpretative sono volte ad affermare le opportunità offerte dai testi al fine di assicurare ai diritti il massimo rilievo. Le operazioni reinterpretative consentono una funzionalizzazione rights-oriented dell’ordinamento nel suo complesso e sono messe in pratica quando viene realizzata una apertura interpretativa, fondata sull’uso, come criterio di valutazione da parte degli organi giurisdizionali, di una o più disposizioni relative ai diritti da cui vengono fatte discendere conseguenze reinterpretative tramite l’utilizzo di strumenti normativi al fine della protezione di un diritto. In tal modo al diritto vengono forniti specifici mezzi di tutela a seguito della “nuova” interpretazione di disposizioni esistenti.
La creazione giurisprudenziale dei diritti è il risultato di un intervento integrativo dal quale emerge il carattere dinamico dell’attività interpretativa orientata a cogliere la forza espansiva, generativa dei diritti stessi. Il fondamento positivo di diritti in precedenza non contemplati, in quanto non ancora riconosciuti, è rinvenuto, per via sistematica, sotto il vincolo della coerenza normativa, nella totalità delle fonti. I “nuovi” diritti, pertanto, si pongono come aspetti o sviluppi di diritti già esistenti grazie al loro aggancio ai testi (che ne costituiscono il sostegno istituzionale) e, in tal modo, ricevono riconoscimento e garanzia. A tale creazione risultano legate reinterpretazioni di disposizioni giuridiche, che consentono la predisposizione di strumenti operativi di tutela.
La sede applicativa risulta essenziale per l’attuazione dei diritti, e per la loro continua riformulazione attualizzatrice, rendendo centrale l’atto del giudicare. Il come, il quando, la misura, le circostanze, i limiti della loro tutela ricevono qui una precisa configurazione. È nel giudizio giurisdizionale, infatti, che i criteri di misura dell’agire, costituiti dai diritti, ricevono una pregnanza di significato, in connessione con i concreti ambiti esistenziali e i problemi specifici che essi pongono. La decisione giudiziale scaturisce dalla messa in relazione dell’universale e del particolare. Nel riunire l’universale al particolare si realizza, invero, l’impegno ermeneutico che caratterizza la pratica interpretativa dei diritti. Essi trovano concretizzazione sempre e soltanto nella situazione data. La loro specifica portata normativa si coglie in base al caso, alle esigenze di protezione che qui si fanno sentire, e in vista di questo.
La giurisdizione è una componente cruciale nell’elaborazione e nella produzione giuridica, non riducibile alla politica, tenendo presente la specificità del suo operare. Si struttura, infatti, intorno ad alcuni princìpi, rinvianti a specifiche tecniche che ne configurano l’attività e ne consentono il controllo. Si tratta dell’indipendenza della magistratura, della legittimazione processuale, del diritto di difesa, del principio del giudice naturale precostituito, della pubblicità dei processi, del principio del contraddittorio, dell’obbligo di motivazione delle sentenze, della loro pubblicazione, della loro impugnabilità.
Il giudice diventa sicuramente protagonista di interventi estesi e incisivi, connessi all’espansione delle aree coperte dalla sua azione. Si trova inserito in una realtà caratterizzata da rilevanti mutamenti sociali, economici, politici, culturali; partecipa delle dinamiche proprie di una società pluralistica, che segnano profondamente l’ordinamento; gli sono affidati compiti di tutela giuridica, di rielaborazione di istituti, di supplenza del potere legislativo e/o di attuazione di direttive legislative spesso generiche, con il relativo ampliarsi del suo potere di carattere integrativo; diventa un co-produttore del diritto, impegnandosi nella ricerca delle fonti, che assumono una articolazione sempre più disordinata, reticolare, risultato di complesse combinazioni e interdipendenze con insiemi normativi collocati anche al di là dei confini nazionali; deve fare i conti con molteplici gradi di legalità (ordinaria, costituzionale, euro-comunitaria). Tutto ciò ha ricadute spesso significative sul piano della politica, intesa come ambito complessivo riguardante la convivenza organizzata. Da questo punto di vista, va ribadito che la crescita del potere giudiziario, in quanto potere diffuso e orizzontale, è un aspetto tipico delle società contemporanee ed è comune a tutte le democrazie liberali. Ma, per restare fedele al suo ruolo e ai vincoli che prescrivono le finalità al cui servizio i suoi poteri sono esercitati, tale potere deve essere espressione della ragione giuridica, volta a cogliere ed esplicitare le linee portanti di un ordinamento, sempre più intrecciato con il diritto sovranazionale e internazionale, che assume i diritti come aspetti irrinunciabili.
2. Quali sono le maggiori insidie che l’attività interpretativa nasconde rispetto all’operato del giudice?
Giorgio Pino
Parto da una premessa che, pur nella sua ovvietà, mi preme rimarcare sin da subito. Dell’interpretazione, semplicemente, non si può fare a meno. L’interpretazione è un aspetto ineliminabile, e ubiquo, dell’applicazione del diritto. Questa ovvia verità ha implicazioni profonde su tutte le domande che sono oggetto di questa conversazione, ma mi pare del tutto condivisibile farne oggetto di una riflessione a sé.
Ora, tra le moltissime cose che si potrebbero dire a questo riguardo, mi limiterò qui a menzionare tre “insidie” nascoste nell’attività interpretativa. La prima è che la decisione giudiziale, qualunque decisione giudiziale, ha a mio parere una natura bifronte. Per un verso, essa decide un caso concreto, applicando norme giuridiche in qualche senso preesistenti. Per altro verso, essa va a costituire un frammento, una tessera del mosaico del “diritto vigente” (con ciò intendo il diritto quale di fatto esiste in un certo momento). Il diritto, infatti, consta non solo dei testi ufficialmente prodotti dal legislatore, ma anche delle sue interpretazioni – specialmente le interpretazioni rese da quei soggetti dotati di potere autoritativo che sono i giudici. Certo la “tessera” prodotta da alcuni di questi soggetti (ad es., la Corte di Cassazione) potrà essere più grande e significativa di quella prodotta da altri (ad es., giudici di merito), ma resta il fatto che qualunque decisione interpretativa resa in sede giudiziaria produce un qualche effetto “conformativo” – a volte notevole, a volte minimo e sostanzialmente impercettibile – rispetto al diritto vigente. Ebbene, ciò che cerco di dire è che la decisione giudiziale si muove su un delicato crinale – o un “equilibrio riflessivo” – tra l’adottare la migliore decisione per il caso concreto da decidere, da una parte, e l’inserirsi coerentemente in una linea di decisioni pregresse e altresì non predisporre il terreno per future decisioni aberranti, dall’altra parte.
Non ho la minima idea di come, in concreto, queste diverse esigenze – quelle dell’oggi e quelle prospettiche – possano essere tenute in equilibrio, o quale sia la loro migliore miscela. So solo che un’ipotetica arte del “buon giudicare” non può fare a meno di tenerle tutte in considerazione.
La seconda insidia è quella di pervertire l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari. Ciò può avvenire in due modi, mi pare. Il primo modo, è quello della motivazione apodittica, che sostanzialmente non dà conto in maniera apprezzabile del ragionamento giuridico che fonda la decisione. Il secondo modo, opposto, è quello della sentenza-trattato, in cui il giudice affoga il ragionamento giuridico che fonda la decisione in un esercizio di virtuosismo dottrinario che si estende magari per svariate decine di pagine. Sono entrambi modi, a mio parere, in cui le funzioni perspicue della motivazione vengono tradite. Nuovamente, quale sia il giusto mix tra esigenze di sintesi ed esigenze di completezza della motivazione, non sono in grado di dire.
La terza insidia riguarda il rapporto tra ciò che i filosofi del diritto, sulla scorta dei filosofi della scienza, chiamano “contesto di giustificazione” (l’esplicita argomentazione di una decisione), e il “contesto di scoperta” (i fattori – psicologici, sociologici, ideologici – che di fatto condizionano il decisore nel prendere una certa decisione). Il problema, cioè, della corrispondenza, o della tensione, tra la motivazione di una decisione giudiziaria quale di fatto viene scritta ed esplicitamente enunciata, e le ragioni che di fatto sono alla base di quella decisione. Su questo punto, è del tutto probabile che le neuroscienze mostreranno cose molto interessanti già nel prossimo futuro. Qui, mi vorrei limitare solo a qualche considerazione rapsodica sul ruolo che, nella motivazione dei provvedimenti giudiziari, può avere ciò che Jon Elster ha chiamato “la forza civilizzatrice dell’ipocrisia”.
L’idea è la seguente: le decisioni giudiziali devono essere motivate, e nella motivazione il giudice deve esplicitare le ragioni idonee a giustificare la decisione; queste ragioni contano come “buone” ragioni, come ragioni “corrette”, solo se possono essere tratte in maniera convincente dal diritto positivo, ampiamente inteso (cioè come un insieme composito di fonti, regole, principi, canoni interpretativi, ecc.). La motivazione assolve a funzioni endo- ed extra-processuali ben note, che in linea di massima possono essere ricondotte alla garanzia delle parti nel processo (dando alla parte soccombente e ai giudici dell’impugnazione un punto di riferimento per contestare la fondatezza della decisione assunta), e alla accountability del potere giudiziario nei confronti dell’opinione pubblica. Ma si può anche ipotizzare che, di fatto, l’obbligo di motivazione produca o possa produrre un risultato ulteriore, quasi subliminale, che consiste nell’addestrare il giudice a ragionare (solo) sulla base di argomenti giuridici spendibili in una motivazione pubblica. L’ipotesi, cioè, è che l’addestramento e la pratica professionale dei giudici possano incidere anche sul loro modo di ragionare, e che l’obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie funzioni non solo nel contesto di giustificazione, ma anche come strumento di disciplinamento del contesto di scoperta.
Si tratta solo di una ipotesi, che personalmente ritengo molto plausibile ma che non ho la possibilità, qui, di argomentare in modo lontanamente soddisfacente. Mi limito solo ad osservare che, per quanto la mente umana sia in definitiva insondabile, e senza voler affatto risuscitare le viete immagini del giudice-automa, sarebbe comunque ben strano che anni e anni di formazione giuridica e di addestramento e pratica professionale non lasciassero altra traccia, nel modo di ragionare del giudice, che la possibilità di usare norme e schemi di argomentazione giuridica unicamente come paravento posticcio e razionalizzazione a posteriori di una decisione presa su basi totalmente indipendenti. Peraltro, se l’immagine del giudice che emerge da quanto appena detto può sembrare troppo edulcorata, si provi a sostituire qui la figura del giudice con quella di uno scienziato o di un medico: se è implausibile pensare che un medico non ragioni sulla base di categorie e concetti medici, e uno scienziato sulla base di categorie e concetti scientifici, perché dovrebbe essere implausibile immaginare che un giudice ragioni (e non solo motivi formalmente le sue decisioni) sulla base di categorie giuridiche?
Tre brevi precisazioni per concludere su questo punto.
In primo luogo, che la motivazione operi come una mera razionalizzazione a posteriori di una decisione presa per ragioni opportunistiche o comunque inconfessabili (simpatie o antipatie personali, affinità politica, piaggeria verso i potenti, corruzione, cattiva digestione, lancio di una monetina, visione mistica, ecc.) è, evidentemente, sempre possibile; ciò che sto dicendo è però che è assai probabile che un ragionamento propriamente giuridico rappresenti la modalità di default anche del contesto di scoperta; e che anzi sarebbe patologico se un giudice (nonostante anni e anni di formazione e pratica professionale ecc.) non ragionasse mai, nel contesto di scoperta, sulla base di norme e argomenti giuridici.
In secondo luogo, nulla in ciò che sto dicendo implica che vi sia una esatta corrispondenza tra contesto di scoperta e contesto di giustificazione (cioè che la giustificazione formalmente prodotta sia identica al ragionamento giuridico di fatto maturato nella testa del giudice): il ragionamento giuridico formalizzato nella motivazione esplicita della decisione giudiziale rappresenta certamente una versione “presentabile”, una “bella copia”, rispetto al ragionamento giuridico sviluppato, in maniera certamente più disordinata, sincopata, non lineare, nel contesto di scoperta.
In terzo luogo, l’ipotesi qui avanzata della possibile, tendenziale convergenza (o parziale sovrapposizione) tra contesto di scoperta e contesto di giustificazione, ammesso che la si consideri plausibile, può certamente avere un notevole interesse teorico (per una migliore, più completa conoscenza e ricostruzione del ragionamento giudiziale) e pratico (dal punto di vista della prevedibilità delle decisioni giudiziarie), ma non scalfisce l’idea fondamentale su cui si basa la distinzione tra i due contesti e cioè che, ai fini della valutazione della correttezza del percorso argomentativo che fonda la decisione, normalmente contano solo le ragioni esplicitamente addotte nella motivazione, e resta del tutto sullo sfondo, e di solito in gran parte irrilevante, il profilo della sincerità del decisore quanto alla sua intima adesione alle ragioni esplicitamente addotte nel contesto di giustificazione.
Baldassare Pastore
L’attività interpretativa del giudice presenta, invero, una serie di insidie. Mi soffermo su quella che ritengo la più grave e che riguarda il rischio che sia esercitata in modo arbitrario.
Nel giudizio giurisdizionale emerge l’ineliminabile tratto soggettivo della decisione. Il mondo del diritto è il mondo delle decisioni. Decidere vuol dire scegliere, optare per una soluzione piuttosto che per un’altra. Si sceglie nell’ambito di possibilità plurime, tra alternative. La decisione, nel campo della prassi, è inevitabile: si deve decidere attraverso un atto di volontà personale, che risulta intrecciato con attività valutative. L’aspetto volitivo è assolutamente prioritario e non completamente razionalizzabile. La decisione, infatti, si pone come atto creativo, largamente discrezionale. Questa dimensione, però, non può condurre ad assumere un orientamento volontaristico che raffigura la stessa decisione come evento autofondato, irripetibile, i cui motivi restano celati nella soggettività inconoscibile e incomunicabile del decisore stesso. Ogni atto decisionale, invece, se non vuole essere espressione del porsi assoluto di un soggetto svincolato da ogni esigenza giustificativa, va definito, pur riguardando l’esplicarsi creativo della volontà, in relazione a canoni di razionalità e di giustezza. Pertanto, l’aspetto giustificativo contribuisce a liberare la decisone giuridica dal sospetto di essere arbitraria.
Segnalo, su questo tema, l’apporto della teoria ermeneutica del diritto. L’ermeneutica giuridica pone attenzione all’attività svolta dall’interprete, prendendo in considerazione le due polarità entro cui si esplica la formazione giudiziale del diritto: da un lato, la libertà, in una certa misura ineliminabile, del soggetto interpretante; dall’altro, l’esigenza di razionalità del suo operato, con riferimento alla accettabilità della decisione in un contesto unitario che contribuisce a controllarne l’esercizio interpretativo.
L’interpretazione non può non tener conto della discrezionalità legata alla determinazione della regola in riferimento al caso. Lo sviamento, il tradimento della funzione giudiziaria possono trovare terreno fertile laddove l’esercizio della discrezionalità, di per sé inevitabile e spesso opportuna, degeneri nell’uso capriccioso e illegittimo del potere. Il rischio che la decisione del giudice si traduca in scelta totalmente soggettiva è una possibilità quotidianamente presente nella prassi giudiziale. Cercare di stabilire il confine tra decisione discrezionale e decisione arbitraria diventa, dunque, di importanza fondamentale.
La peculiarità dell’attività giurisdizionale risiede nel fornire la “certa” riconoscibilità delle norme, la “certa” dimostrabilità dei fatti rilevanti per l’applicazione della norma, realizzata con l’acquisizione e la valutazione delle prove, e la “certa” applicabilità del diritto posto. Il giudice incarna il momento dello ius dicere, coniugando un’attività interpretativo-conoscitiva, diretta alle regole ed ai fatti, con un’attività decisoria in concreto, che implica una comprensione equitativa in relazione alle specificità del caso.
Invero, guardando all’attività interpretativa, non è possibile nascondere la presenza di alcuni innegabili margini di libertà nel lavoro dei giudici. Un primo margine di libertà è quello relativo al riconoscimento dei materiali giuridici, all’individuazione delle disposizioni vigenti adatte a fornire la soluzione del caso, tra le tante che possono essere prese in considerazione. Da questo punto di vista, la stessa ricerca delle fonti, vieppiù nell’odierno scenario giuridico, altamente complesso, costituito da plessi normativi stratificati spesso disordinatamente, e variamente connessi, diverta un’attività libera. Un secondo margine di libertà è quello relativo alla determinazione del significato delle disposizioni ritenute appropriate a disciplinare il caso. Qui il giudice è chiamato ad elaborare la norma, facendo uso dei metodi interpretativi, che non possono eliminare gli spazi di libertà dell’interprete, ma possono contenerli e strutturarli, dal momento che segnano i passi che l’interprete deve fare nel suo ragionamento per offrire una argomentazione convincente, evitando errori e abusi. Non può non evidenziarsi, in proposito, che i giudici usano differenti argomenti interpretativi, che danno luogo a specifiche strategie interpretative. Sarebbe opportuno, allora, che, per esigenze di trasparenza, esplicitassero i metodi utilizzati, dandone conto in sede di motivazione. Un terzo spazio di libertà è quello relativo alla fase di applicazione delle disposizioni, individuate e interpretate, alle circostanze di fatto. Essa ha a che fare con la selezione, entro la varietà di elementi fattuali che un caso presenta, di quelli rilevanti. Il diritto positivo, così, consente un ventaglio di soluzioni possibili, configurandosi come un’area, i cui confini non sono invero rigorosamente delimitati, entro cui deve cadere la decisione.
Se non si vuole che l’interpretazione appaia come un’attività lasciata al giudizio irrazionale o comunque non motivabile del giudice chiamato alla decisione, diventa essenziale vagliarne il percorso e i possibili risultati. Vengono in evidenza, a tal proposito, una serie di questioni legate al ruolo della metodologia giuridica.
Alla metodologia giuridica spesso è assegnato (esclusivamente) il compito di esame della via interpretativa che il giurista segue. Si tratterebbe di un compito descrittivo, consistente nell’indagare quali sono i tipi di argomento mediante i quali gli interpreti compiono le loro operazioni. Tale idea, però, non mi convince. La metodologia, invero, svolge ulteriori compiti. Nel riflettere sugli argomenti, soppesandone le ragioni pro e contro, essa predispone strumenti per controllare le argomentazioni degli interpreti, le loro scelte e, dunque, le loro decisioni. La controllabilità delle decisioni ha a che fare con un insieme di regole (accettate all’interno di una cultura giuridica), tendenti tutte, in vario modo, a restringere per quanto possibile l’ambito di quel che può essere, in relazione ad una situazione concreta, correttamente deciso. Si tratta delle regole che riguardano la selezione delle premesse di diritto dell’argomentazione giuridica, delle regole di procedura (o del gioco processuale), delle regole di svolgimento dell’argomentazione stessa. Tali regole lasciano all’organo decidente spazi di discrezionalità. È da evitare, però, che l’organo decidente possa esimersi dall’assumere su di sé l’onere della giustificazione delle scelte compiute e la relativa responsabilità. La controllabilità della decisione giudiziale, oltre a garantire la ragionevole prevedibilità del risultato dell’atto con cui si pone la norma individuale a conclusione di un ragionamento giuridico, esprime anche una irrinunciabile esigenza di giustizia ed è finalizzata ad evitare che il campo della pratica giudiziale sia lasciato al decisionismo.
La decisione giudiziale deve mostrare la sua correttezza e adeguatezza. Giocano un ruolo cruciale, in proposito, i controlli di razionalità, atti a testarne la tenuta. Tali controlli – riprendendo la riflessione di Josef Esser – riguardano la concordanza della soluzione prescelta con il sistema giuridico positivo; la sua giustezza materiale, rivolta agli aspetti di contenuto sostanziale del caso, intesa come plausibilità e ragionevolezza sociale di tale soluzione; la sua evidenza, cioè l’innegabilità logica (valutabile invero solo a posteriori), che attiene alla capacità di “consenso” della decisione, in quanto non confutabile, risultando inutile il ricorso ad ulteriori argomentazioni. Assume rilevanza, inoltre, il riferimento alla comunità interpretativa, che lega tra loro i membri di una tradizione giuridica, i quali, risultando situati in un tessuto di pratiche collettive sedimentato nel linguaggio e nella cultura, accettano e condividono un sostrato di atteggiamenti, convenzioni, orientamenti, opinioni professionali (pur in presenza di disaccordi e conflitti). La comunità dell’interpretazione giuridica può rappresentare un ulteriore criterio regolativo, intersoggettivamente caratterizzato, in base al quale controllare le scelte e le soluzioni sul versante della consistenza e della tenuta delle argomentazioni fornite.
Sottoporre a controllo significa far riferimento a vincoli, di forma e di sostanza, e a ragioni giustificative, atti ad impedire che una decisione, risultato dell’esercizio di un potere normativo, sia presa sulla base di se stessa, sia cioè autofondata e dunque infondata.
L’esercizio del potere giudiziario può considerarsi legittimo solo se è riconducibile, per via diretta o indiretta, in forme metodologicamente corrette, ai testi normativi. L’etica del giudice, pertanto, si converte nell’etica del ragionamento giuridico, che riguarda appunto la sua correttezza. È ovvio, infatti, che un ragionamento non corretto conduce ad un’applicazione errata, omissiva, distorta del diritto, prestandosi ad essere considerato un vizio del procedimento decisionale.
I giudici trovano la loro fonte di legittimità nei compiti affidati di applicazione delle regole e di protezione dei diritti, nonché nei requisiti di competenza (legata al loro sapere), terzietà e indipendenza che essi devono possedere. È essenziale che non cedano alla tentazione di mettere al centro della propria attività le valutazioni personali e/o esterne all’ordinamento, sulla base di interessi che inquinino l’imparzialità del comportamento e del giudizio. Qui si annida quella insidia che rinvia alla seduzione del potere, inteso come volontà incontrollata, e trovano spazio quelle possibili perversioni della funzione giudiziaria che minano le fondamenta del patto fiduciario che lega i cittadini e le istituzioni.
3.Come si atteggia il canone della soggezione del giudice alla legge in caso di lacuna legislativa e qual è in tal caso, a Suo giudizio, il peso ed il ruolo dei diritti fondamentali?
Giorgio Pino
Come ho già notato, il giudice non applica la legge, ma la legge in una sua possibile interpretazione. E anche qui, sono costretto a partire da una considerazione affatto banale: il giurista ha a disposizione un arsenale molto ricco di tecniche, con le quali stabilire l’interpretazione (secondo lui) migliore, più corretta, più giusta, ecc., della legge. Peraltro, ho parlato di “tecniche interpretative”, ma intendo qui questa categoria in modo da includere non solo le tecniche dell’interpretazione “in senso stretto” o “testuale” (ricorso al significato letterale, all’intenzione del legislatore, ecc.), ma anche tecniche ulteriori talvolta chiamate “produttive” o “integrative” (come l’analogia, il bilanciamento, la concretizzazione di principi, l’individuazione di principi impliciti, la defettibilità…) che non consistono semplicemente nell’ascrizione di un significato ad un testo giuridico.
A ben vedere, peraltro, il punto non è solo che le tecniche interpretative normalmente ammesse all’interno di una cultura giuridica sono molteplici; si deve infatti tenere presente che ciascuna di queste tecniche può essere usata in maniera diversa (si pensi ai diversi possibili significati di “significato letterale” o di “intenzione del legislatore”); e, infine, che uno stesso problema interpretativo può trovare risposte diverse a seconda della tecnica interpretativa utilizzata (o del modo in cui si utilizza una stessa tecnica interpretativa). Tutto ciò rende necessario per il giurista, o quantomeno per il giurista metodologicamente “consapevole”, dotarsi di uno schema di organizzazione, per quanto generico e defettibile, delle tecniche interpretative disponibili: uno schema che, nella trattazione della quaestio iuris, gli indichi (ripeto: anche in maniera generica e rivedibile): a quali tecniche interpretative fare ricorso, e in che modo (ad esempio: l’intenzione del legislatore deve essere intesa in senso storico e psicologico, cioè “soggettivo”, oppure in senso “oggettivo”?), e con quale ordine di priorità (ad esempio, fare ricorso all’interpretazione sistematica solo quando il significato letterale è incerto); a quale tecnica dare preferenza nel caso in cui più tecniche disponibili diano risultati contrastanti; come “legare”, gerarchizzare, e fare interagire i diversi materiali normativi come la costituzione, le leggi, le fonti sublegislative, le fonti straniere, i precedenti giurisprudenziali, le opinioni dottrinali, ecc.
Ovviamente, non si può escludere la possibilità che il giurista, occasionalmente, prenda decisioni in maniera metodologicamente inconsapevole, non riflessiva. Ma sarebbe decisamente patologico il caso di un giurista che non si ponesse mai il problema di quali tecniche interpretative usare, di come usarle, e con quale ordine di preferenza.
Propongo di chiamare questo schema di lavoro del giurista “ideologia giuridica”. La scelta del termine “ideologia”, a questo proposito, non intende rimandare ad accezioni spregiative come quella marxista di “falsa coscienza”, o di manipolazione propagandistica. Intende piuttosto veicolare, in maniera del tutto neutra, l’idea che la scelta e l’uso da parte del giurista di un certo schema di lavoro anziché di un altro ha un carattere decisamente etico-politico: attiene infatti al modo in cui il giurista, in special modo se “pratico” (il giudice), concepisce il proprio lavoro all’interno – e la propria posizione nei confronti – del diritto positivo.
Ad evitare equivoci, è opportuno sottolineare subito che l’ideologia giuridica non deve essere intesa come un algoritmo, o comunque come un insieme di criteri fissi e precisi che il giurista andrà ad applicare assiomaticamente nella trattazione di ogni quaestio iuris che gli si presenti: come ho già detto, i criteri che compongono l’ideologia giuridica, e la loro ordinazione, possono essere generici e rivedibili, e possono anche legittimare risposte diverse ad uno stesso problema interpretativo o applicativo; inoltre, è del tutto possibile che il giurista non arrivi alla decisione semplicemente mettendo in pratica un metodo, ma piuttosto facendo interagire, in una sorta di circolo ermeneutico, il risultato che gli sembra giusto con i metodi interpretativi che considera appropriati, selezionando e affinando reciprocamente l’uno alla luce degli altri (su questo punto ho già fatto qualche veloce accenno rispondendo alla domanda precedente).
Ora, venendo al problema specifico delle lacune, la soluzione passa evidentemente dal tipo di ideologia giuridica adottato dall’interprete. Un interprete di stampo “formalista-legalista”, tenderà a minimizzare l’impatto delle lacune, in due modi. Per un verso, un interprete di questo tipo potrà sostenere che se una certa condotta non è chiaramente regolata, ad esempio in termini di divieto, allora ciò significa che quella condotta è permessa (questo è un tipico esempio di argomento a contrario utilizzato in applicazione della c.d. norma generale esclusiva). Per un altro verso, l’interprete potrà semplicemente affermare che l’ideale della soggezione alla legge richiede al giudice di rimettere al legislatore il compito di introdurre una disciplina per il caso non regolato.
Diversamente, un giurista che aderisce ad una ideologia giuridica di stampo “sostanzialista”, quale certamente è quella del costituzionalismo contemporaneo, tenderà a esaltare il ruolo del giudice in casi di lacune: come abbiamo visto, in questo contesto il panorama giuridico è saturo di principi, che sono peraltro suscettibili di applicazione giudiziaria (previa concretizzazione). E a causa della genericità e indeterminatezza delle norme di principio, qualunque caso non interamente insulso ha buone speranze di poter essere ricondotto sotto l’ombrello protettivo di un principio costituzionale. La conseguenza è che, in questo contesto, una lacuna legislativa sarà sempre colmabile rivolgendosi a qualche principio costituzionale: o direttamente, o tramite analogia (dove la eadem ratio tra il caso regolato e il caso non regolato è fornita, appunto, da qualche principio costituzionale). Il diritto dello Stato costituzionale tende dunque a diventare (o a sembrare) “completo”, cioè privo di lacune, anche se non necessariamente “coerente”, quantomeno nel senso che è del tutto possibile che, davanti a una lacuna, giudici diversi individuino analogie diverse, o applichino in modi diversi i principi costituzionali rilevanti. E questa è esattamente un’ulteriore manifestazione della dilatazione della discrezionalità interpretativa resa possibile dal costituzionalismo contemporaneo, di cui ho parlato in precedenza.
Infine, quanto ho detto poco sopra sul concetto di ideologia giuridica dovrebbe rendere chiaro che la scelta per l’una o l’altra soluzione non è mai una questione esclusivamente tecnico-giuridica, ma inevitabilmente anche etico-politica.
Baldassare Pastore
Nel quadro degli equilibri costituzionali ispirati al principio della divisione dei poteri, i giudici, estranei al circuito di produzione politica delle disposizioni giuridiche, sono “soggetti soltanto alla legge”. Ciò realizza la garanzia dell’indipendenza funzionale del giudice, nel senso che, in sede di applicazione, e della previa interpretazione, a lui demandate dall’ordinamento, è fatto divieto a qualsiasi altro soggetto o autorità di interferire, in alcun modo, nella decisione del caso concreto.
La soggezione del giudice alla legge deve essere letta come soggezione alla legge in quanto coerente con la Costituzione. La soggezione richiama l’obbedienza del giudice alla legge. Ma questa è da intendersi – riprendendo l’espressione di Philip Heck – come “obbedienza pensante”, che, a partire dall’uso delle fonti del diritto come risorse ufficiali da cui si devono trarre le norme da applicare ai casi, discende da una complessa ricerca interpretativa e argomentativa.
Uno degli elementi costitutivi dello Stato di diritto, insieme alla divisione dei poteri, è il principio di legalità, in base al quale l’esercizio di ogni potere pubblico è legittimo se e solo se è previsto e regolato da norme preventivamente poste. Il principio di legalità si identifica con l’idea della superiorità della legge (intesa in senso ampio) e richiede prevedibilità ed eguaglianza nella sua interpretazione e applicazione, legate all’imparzialità e alla correttezza nell’amministrazione della giustizia. Tale principio opera nell’attività giurisdizionale, posto che ogni decisione giudiziaria va fondata su una norma giuridica (generale e astratta) preesistente in congiunzione con le proposizioni fattuali descrittive delle circostanze del caso provate. È per questa ragione che le decisioni giudiziali devono essere motivate sulla base del diritto. Il rapporto tra legge e sentenza può essere configurato come una relazione tra programma di decisione e decisione.
L’interprete si proietta nel processo di formazione del diritto, partecipando attivamente alla costruzione/enucleazione di regole che specificano, puntualizzano, correggono la “volontà” del legislatore, anche se, da qualche tempo, di fronte ad un universo giuridico sempre più complesso, con la presenza di svariati centri di regolazione, alcuni dei quali sono “al di là dello Stato” e si intrecciano con il diritto nazionale (si potrebbe parlare, in proposito, di un “pluriverso”), si assiste alla perdita di centralità, nonché allo svilimento, del ruolo del Parlamento.
Al giudice è affidato un compito di attualizzazione del modello d’ordine rappresentato dalle disposizioni legislative, ma – come sottolinea Martin Kriele – “la legge lascia più problemi aperti che risolti” e, nella legge – riprendendo Hermann Kantorowicz – “le lacune non sono minori delle parole”. L’integrazione diventa, pertanto, decisiva. Siamo nel campo della completabilità dell’ordinamento, attraverso il ricorso, in molti ambiti, alla “norma generale inclusiva”, che impone al giudice di fare riferimento all’analogia o ai princìpi.
Il diritto positivo porta con sé una riserva di potenzialità. Possiede una sorta di sporgenza e di capacità espansiva, che non può fare a meno di un esercizio “sapienziale”, che entra in gioco quando manca una norma, ricavata da specifiche disposizioni, idonea a disciplinare un caso.
La norma generale inclusiva, con i metodi integrativi che la sostanziano, trova il proprio fondamento positivo nell’obbligo di soggezione del giudice alla legge e rende possibile che siano colmate le lacune in relazione alla tutela a beni, interessi, bisogni, posizioni soggettive non espressamente tipizzati. L’opera degli interpreti, chiamati a colmare le lacune, non può non seguire una logica di sviluppo interno, volta a cogliere ed esplicitare le linee portanti dell’ordinamento.
L’analogia si pone come canone volto ad assicurare coerenza e parità di trattamento. È da evidenziare, comunque, che ogni applicazione del diritto e ogni Rechtsfindung configurano un’attività di tipo analogico, che mette in campo procedimenti di natura teleologico-valutativa. In questo senso, l’argomento analogico funziona come direttiva sulla produzione giuridica, che interviene nella ricerca e nella formulazione di una regola nuova che estenda la qualificazione normativa di un soggetto o una classe di soggetti in ragione della somiglianza con fattispecie già esistenti. Propriamente, l’analogia è da intendere come quell’operazione che si compie risalendo da una norma espressa ad un principio (la ragione, il motivo, lo scopo) in essa contenuto e dal quale si ridiscende verso la formulazione di una norma inespressa, che contiene la regola del caso “analogo” a quello disciplinato espressamente. L’argomento analogico in funzione integrativa implica l’equiparazione del trattamento giuridico, riconosciuta la rilevanza della somiglianza delle situazioni. Da questo punto di vista, si pone come corollario del principio di eguaglianza e svolge la funzione di rendere ragionevole, cioè non arbitrario, il diritto.
I princìpi generali e fondamentali, che nelle nostre organizzazioni giuridiche sono tipicamente princìpi costituzionali, espressi e impliciti, operano come standards che favoriscono la revisione, la riformulazione, l’arricchimento, nonché l’integrazione, delle norme. Tali princìpi trovano applicazione diretta in relazione ai rapporti giuridici e presentano una capacità propulsiva ed espansiva, talché è possibile ricavare dal principio, attraverso tecniche argomentative che vanno esplicitate e sottoposte al controllo della comunità interpretativa, una regola idonea a disciplinare il caso. La costruzione di questa regola specifica costituisce una concretizzazione del principio, che pertanto svolge un ruolo essenziale nella giustificazione della premessa normativa. Anche qui l’eguaglianza gioca un ruolo centrale nella dinamica interna del diritto, connettendosi alle sue potenzialità, secondo una logica che, al fine di fornire soluzioni a nuovi problemi, interviene attraverso l’elaborazione di considerazioni incluse nel diritto stesso. L’eguaglianza rileva, propriamente, come ragione operativa che fornisce la forza motivante, indicando il percorso da seguire, e va intesa anche esito di determinati processi decisionali, finalizzato a dare attuazione alla promessa, propria del costituzionalismo, di garantire rispetto e giustizia per tutti gli individui.
In questa prospettiva “soggezione” significa fedeltà al diritto ed esige che sia rispettata l’integrità dell’ordinamento. Essa rinvia all’idea di coerenza come unità di senso del discorso giuridico, come consonanza e congruenza, come concatenamento contenutistico e adattabilità della decisione giudiziale al corpus normativo, come aderenza delle norme di formazione giurisprudenziale ai princìpi costitutivi della struttura generale della pratica giuridica.
Negli Stati costituzionali tali princìpi si configurano, in buona misura, come enunciati vertenti sui diritti fondamentali, che acquistano una dimensione ordinamentale producendo conseguenze importanti nell’articolazione interna del diritto. Partecipando ai processi di positivizzazione, gli interpreti sono chiamati ad un’opera ricostruttiva e ordinatrice. I princìpi, contribuendo al recupero della dimensione unitaria dell’impresa giuridica, ne custodiscono il senso e possono essere paragonati alle colonne che reggono le volte di una struttura che evolve.
Si può parlare, in proposito, di un “effetto di irradiazione” – così lo definisce Robert Alexy – sicché l’attività giurisdizionale va vista come vincolata alla garanzia dei diritti, che, interagendo con tutte le fonti, diventano linee-guida di ricomposizione delle categorie giuridiche. I diritti fondamentali fissano il punto di incrocio nel quale si sostanziano le convergenze tra ambiti ordinamentali nazionali e sovranazionali. Si configurano come ragioni normative che compongono la griglia interpretativo-integrativa dei materiali giuridici, rendendo possibile la correzione progressiva del diritto positivo alla luce dei contenuti assiologici che lo sostanziano e che gli Stati costituzionali incorporano.
Repliche
Baldassare Pastore
Molte sono le consonanze con quanto dice Giorgio Pino, come sempre in modo chiaro e accurato, pur nelle differenze delle nostre prospettive teoriche. Mi piace pensare che le convergenze che emergono nelle nostre analisi, a seguito delle domande formulate da Roberto Conti, possano condurre ad un più intenso confronto tra le due tradizioni di ricerca filosofico-giuridiche alle quali ci richiamiamo: quella ermeneutica, per quanto mi riguarda, e quella analitica, coltivata lucidamente da Giorgio Pino. Sollecitato dalla lettura delle sue risposte, cercherò di evidenziare brevemente alcuni punti che ritengo meritino di essere rimarcati.
La costituzionalizzazione dell’ordinamento realizza un aumento del peso del diritto sapienziale rispetto al diritto legislativo. Ma, invero, il diritto sapienziale ha sempre svolto un ruolo cruciale nell’esperienza giuridica. Si tratta di una costante nella storia del diritto e nel funzionamento delle organizzazioni giuridiche.
La costituzione dipende dalla sua interpretazione e applicazione, che la rendono effettiva, “vivente”. I suoi contenuti non parlano da soli, ma occorre che si dia loro voce. Hanno bisogno dell’intervento di appositi organi dotati di competenza normativa. E questo ha ricadute importanti sul versante dei rapporti tra legislazione e giurisdizione, nella direzione della presa d’atto della loro complementarità. Giudici e legislatori sono sottoposti entrambi ai vincoli discendenti dalla costituzione. Al giudice spetta, fisiologicamente, un compito produttivo, insieme ad una funzione critica di controllo sulla corrispondenza (congruenza, coerenza) della legge alla costituzione.
La costituzione si iscrive nel circuito deliberativo-decisionale, che vede protagonisti gli organi legislativi, quelli amministrativi, i giudici comuni e quelli costituzionali, e si colloca strutturalmente all’interno del complesso ciclo della positività giuridica. Qui entra in gioco la “comunità interpretativa”. Essa collega i partecipanti ad una tradizione giuridico-istituzionale aventi in comune un medesimo sapere e un linguaggio, frutto di quell’addestramento, tipico dell’educazione giuridica, essenziale per accedere a, e poter utilizzare, questo sapere, che rinvia ad un insieme di competenze operative. Sotto un profilo soggettivo, indica l’insieme dei soggetti che svolgono il compito specifico di “trattare” regole: le individuano, le riformulano, le adattano, le integrano, le applicano, le conoscono, le mettono in ordine. Sotto il profilo oggettivo, rimanda ad un orizzonte epistemologico, metodologico, di credenze, nozioni, pratiche condivise, che rende possibile l’accettabilità delle scelte interpretative e condiziona la validità del ragionamento giuridico. Tutto ciò, comunque, non esclude disaccordi e conflitti, né il riferimento a ideali e valori diversi e alle varie “ideologie giuridiche” adottate. I significati normativi sono in ogni caso il risultato sia della prestazione dei legislatori sia di un’elaborazione collettiva della comunità interpretativa.
Va detto, a questo proposito, che la costante discussione tra giuristi (teorici e pratici), da un lato, serve a garantire contro le indebite intrusioni di prospettive soggettivistiche (e pertanto arbitrarie), contro il cristallizzarsi di opinioni incontroverse, contro il persistere di indirizzi conformistici; dall’altro, consente di vagliare, nel confronto discorsivo e dialettico, la consistenza delle argomentazioni, la loro asseribilità e la loro giustificazione.
Le trasformazioni del diritto contemporaneo incidono potentemente sulla conformazione dell’ordinamento, talché la costituzione si trova inserita in uno scenario caratterizzato da un pluralismo delle fonti e da un policentrismo dei luoghi di produzione normativa che si connette al declino dell’impenetrabilità dello Stato-nazione. Ciò richiede una interpretazione degli enunciati costituzionali orientata verso il diritto sovranazionale: europeo, ma anche internazionale (che include i documenti – le dichiarazioni, le convenzioni – sui diritti umani). L'ordinamento dello Stato costituzionale, in tal modo, è il risultato in fieri di continue combinazioni e integrazioni normative e rende possibile l’affermarsi di un diritto che si positivizza in rapporto alle interdipendenze e interrelazioni presenti in uno spazio sempre più globale.
Quello che emerge, alla luce di quanto detto, è una concezione dinamica della regola giuridica, in cui diversi soggetti contribuiscono alla sua formazione. Abbiamo a che fare con una positività “plurale” del diritto, che implica uno spostamento di focus orientato ai modi dell’interpretazione e applicazione dei materiali normativi, operanti come parametro di giudizio, ritenuti più appropriati a risolvere i casi. Si amplia, così, la funzione degli interpreti, insieme alla loro responsabilità (che non è solo tecnico-giuridica, ma etico-politica), nel ricercare le ragioni che sostengono la soluzione, sulla base di una precomprensione, cioè di una valutazione anticipata del risultato ritenuto congruo soggetta a correzioni, che possono condurre a modificare le aspettative con cui ci si accosta ai testi (siamo nel “contesto di scoperta”). In questo senso, si tratta di coniugare interpretazione e argomentazione, talché i loro confini si assottigliano di molto (siamo nel “contesto di giustificazione”).
L’ultimo punto che vorrei sinteticamente affrontare riguarda il rapporto tra giudici e democrazia. Giorgio Pino afferma che sarebbe scorretto «confondere una decisione contro-maggioritaria con una decisione antidemocratica». Sono d’accordo, ma con una precisazione.
La sfera pubblica democratica si caratterizza per l’interazione tra processi informali di determinazione dell’opinione e della volontà e procedure deliberative articolate nei settori formali di produzione delle decisioni giuridiche (tra le quali un posto non secondario è occupato dalla giurisdizione). La democrazia non si risolve nel suffragio universale e nella regola della maggioranza. Ha bisogno di condizioni giuridiche prestabilite da norme: norme riguardanti le forme delle decisioni validamente prodotte, idonee a garantire che queste siano espressione delle scelte dei loro destinatari; norme che definiscono le competenze degli organi istituzionali, a presidio della separazione/divisione di poteri; norme riguardanti i contenuti delle decisioni, idonee a garantire il rispetto dei limiti stabiliti a tutela dei diritti e degli interessi di tutti, al fine di impedire la degenerazione del potere in forme dispotiche (nelle quali rientra la tirannia della maggioranza). Tra democrazia e diritto, pertanto, vi è una connessione costitutiva.
Le democrazie, però, non possono fare a meno di “comunità epistemiche”, di comunità di esperti legittimati dal loro sapere (in esse è compresa la “comunità interpretativa” a cui ho fatto riferimento), esterne, per molti versi, al circuito democratico. Il tema riguarda, più in generale, il ruolo delle élites professionali e il loro rapporto con l’idea di sovranità popolare, che sta a fondamento del modello democratico. I giudici, ovviamente, sono una élite; in quanto funzionari pubblici specializzati, svolgono un’attività sottoposta al principio di legalità, che li vincola alla fedeltà ordinamentale e alla consistenza formale e sostanziale delle loro pronunce. Contro ogni visione semplificatoria, allora, va ribadito che la democrazia, per ben funzionare, ha bisogno che sia temperata e corretta da strutture di tipo élitario che comportano (e ciò vale tipicamente in relazione al potere giudiziario) saggezza, lungimiranza, rigorosa indipendenza.
Giorgio Pino
Ho letto con molto interesse, come sempre, le risposte di Baldo Pastore all’intervista propostaci da Roberto Conti. E non ho potuto fare a meno di rilevare – come credo farà qualunque lettore – l’ampia convergenza tra molte nostre affermazioni. Questa non era, di per sé, cosa scontata vista la diversità delle tradizioni filosofico-giuridiche da cui rispettivamente proveniamo – nel mio caso la filosofia del diritto di tradizione analitica, nel caso di Baldo Pastore la filosofia del diritto di tradizione ermeneutica (della quale, mi permetto di dire, egli è uno degli esponenti più perspicui).
D’altronde, è anche vero che sul terreno specifico dell’interpretazione giuridica, su cui vertevano sostanzialmente tutte e tre le domande poste da Roberto Conti, la filosofia di indirizzo ermeneutico è partita parecchio avvantaggiata (come peraltro rivela il suo stesso nome). Infatti, la filosofia del diritto di indirizzo analitico ha tradizionalmente centrato la propria attenzione su temi come la teoria della norma e dell’ordinamento giuridico, oltre che sulla natura del linguaggio giuridico e sulla logica giuridica, arrivando a “scoprire” il grande campo aperto dell’interpretazione giuridica solo in una fase più matura della propria evoluzione – tendenzialmente verso la fine degli anni ’70, a partire dai magistrali lavori di Giovanni Tarello. Di contro, la filosofia del diritto di indirizzo ermeneutico ha da sempre posto il tema dell’interpretazione al centro della propria attenzione, e anzi al centro dell’esperienza giuridica stessa. Ovviamente, tra i due approcci restano alcune differenze, in gran parte di linguaggio e di concettuologia – nonché una certa diversità di enfasi sul valore da riconoscere all’esistente in quanto tale (la filosofia del diritto ermeneutica è spesso sospettata di una eccessiva accondiscendenza verso la “prassi”, mentre la filosofia del diritto analitica si pregia – non sempre meritatamente – di svolgere un controllo critico sulle argomentazioni giudiziarie). Ma sul merito dell’analisi svolta da entrambe vi è un’innegabile convergenza, come credo mostrino bene i contributi presentati in questa occasione da Baldo Pastore e da me, e con utili prospettive di cross-fertilization tra due tradizioni filosofico-giuridiche che solitamente tendono, nel migliore dei casi, a ignorarsi.
Oltre alle numerose occasioni di accordo con Baldo Pastore, per amore di argomento chiuderò questo mio intervento con alcune brevi osservazioni in dissenso. Sono ben consapevole che il genere letterario in cui ci siamo cimentati in questa occasione invita (o costringe) alla sintesi, e che il pensiero di Baldo Pastore sui punti che indicherò è certamente più articolato di come lo farò apparire in queste mie brevi osservazioni. Ma non riesco a trattenermi.
1) Nella sua risposta alla prima domanda, Baldo Pastore osserva che «nessun diritto c’è davvero se non è assistito dalla tutela giurisdizionale». Questa affermazione è condivisibile, ma solo a patto che ci si intenda sul significato di quel “davvero”. Se si vuole dire che un diritto che non riceve tutela giurisdizionale è un diritto “debole”, “vuoto”, “di carta”, “non effettivo”, allora d’accordo. In effetti, è quasi tautologico che un diritto le cui violazioni non siano sanzionate in sede giudiziaria è un diritto che non riesce a svolgere quella funzione di “scudo” che ci aspettiamo esso svolga nei confronti dell’interesse (o bene della vita) che dovrebbe garantire. Di contro, se il “davvero” in questione significa che un diritto non esiste se privo di tutela giudiziaria, allora non credo di poter essere d’accordo. A mio modo di vedere, la tutela giudiziaria appartiene non alla definizione del diritto (e dunque alle sue condizioni di esistenza), ma alla sua protezione. Un diritto non garantito non è un diritto inesistente, ma un diritto il cui regime giuridico è lacunoso. E questa lacuna può essere colmata tanto con un intervento legislativo/amministrativo, quanto (se del caso) con un intervento giudiziario. E inoltre, i diritti fondamentali hanno un potenziale trasformativo nei confronti dell’ordinamento che può innescarsi anche in mancanza della possibilità di intervento giudiziario: un diritto fondamentale proclamato in costituzione ma non (ancora) dotato di tutela giurisdizionale può essere invocato in sedi politiche e sociali senza con ciò risolversi in una mera invocazione del diritto naturale.
2) Sempre nel corso della risposta alla prima domanda, Baldo Pastore illustra molto efficacemente il ruolo dei giudici nello Stato costituzionale, non solo come garanti dei diritti fondamentali, ma in definitiva anche come “creatori” dei diritti stessi, in quanto il momento giurisdizionale è parte essenziale del “processo di positivizzazione” dei diritti fondamentali proclamati in termini solo molto astratti nei testi costituzionali, e sottratti agli stessi “poteri democratici”. Anche qui ho una piccola riserva. A mio modo di vedere, infatti, perfino nello Stato costituzionale non si può del tutto marginalizzare il ruolo della legislazione (e anche dell’amministrazione peraltro) nei processi di positivizzazione dei diritti fondamentali. Intanto perché, di fatto, l’attuazione di molti diritti fondamentali richiede una complessa architettura fatta appunto di elementi legislativi, amministrativi e giudiziari. Ma oltre a ciò, vi è una ragione anche più profonda: ed è che il costituzionalismo contemporaneo non elide del tutto il ruolo della legislazione, neanche nella materia dei diritti fondamentali (basti vedere quanti rinvii alla legge sono presenti nella prima parte della nostra Costituzione). Il costituzionalismo contemporaneo non si limita a sostituire il primato “ottocentesco” del legislatore con un nuovo primato del giudiziario, nemmeno nella materia dei diritti fondamentali: piuttosto, il costituzionalismo contemporaneo scommette sul mettere in relazione i poteri, anche in tensione reciproca se è il caso, ma senza che nessuno di questi poteri abbia mai davvero l’ultima parola. Nello Stato costituzionale nessuno – nemmeno una Corte costituzionale, nemmeno una corte sovranazionale – ha davvero l’ultima parola, esercita il potere sovrano. Lo Stato costituzionale frammenta la sovranità in molteplici centri decisionali che talvolta collaborano e talvolta entrano in reciproca tensione, scommettendo sulla possibilità che da questa frammentazione risulti una migliore tutela dei diritti.
3) Nella risposta alla terza domanda, Baldo Pastore fa riferimento alla funzione ordinante svolta dagli interpreti, e guidata dai principi costituzionali. Anche qui, mi trovo d’accordo solo in parte. Per un verso è certamente vero che i principi abbiano una funzione “ordinante”, perché fa parte della natura dei principi (di qualunque principio: non solo dei principi “generali” di cui all’art. 12 preleggi, ma anche dei principi costituzionali) ricondurre ad unità assiologica alcuni materiali normativi di partenza. Un principio giustifica “verticalmente” una serie di norme (regole, o anche altri principi) ad esso inferiori, e così facendo le riconduce ad unità. Ma per altro verso, se guardiamo “orizzontalmente” al complesso dei principi costituzionali, qui quel “recupero della dimensione unitaria dell’impresa giuridica” diventa un po’ più problematico. E la ragione è che i principi costituzionali sono tra loro potenzialmente conflittuali, come portato sia del pluralismo assiologico che le costituzioni contemporanee incorporano, sia dell’indeterminatezza e strutturale apertura di ciascun principio costituzionale (la quale fa sì che nei casi concreti ogni principio tenda fatalmente ad invadere il campo di applicazione di altri principi). La conclusione è che quando si rivolge al piano dei principi costituzionali, ad esempio per colmare una lacuna legislativa, l’interprete raramente troverà una risposta univoca. Da questo punto di vista, dunque, il ragionamento per principi è destinato a svolgere tanto una funzione “ordinante” quanto una funzione “entropica” nei confronti dell’ordinamento giuridico. I principi portano ordine e coerenza tra i materiali giuridici, ma sono anche fonte di incertezza e conflitti interpretativi.
Le conclusioni.
Roberto Giovanni Conti
Lo spaccato emergente dalle riflessioni di Giorgio Pino e Baldo Pastore non può dirsi né preoccupante né rassicurante ed è, forse, compendiabile con il rinvio al concetto di complessità al quale soprattutto il primo non ha mancato di rinviare più di una volta.
Le interviste dei due filosofi sembrano voler rassicurare sul ruolo ineliminabile del giudiziario per le democrazie occidentali.
Un ruolo che vede proprio nel controllo di garanzia il fine ultimo dell’esercizio della giurisdizione e che pone i giudici in una posizione estremamente delicata rispetto agli altri poteri dello Stato, proprio per il rilievo assunto dalla Costituzione e dai diritti ivi protetti.
Pino e Pastore sono d’accordo sul fatto che senza giurisdizione i diritti declinati in astratto non possono vivere, pur esprimendo posizioni non proprio coincidenti sul risultato finale al quale la giurisdizione deve giungere per il tramite dell’attività ermeneutica.
Croci e delizie del giudiziario, i diritti fondamentali occupano nella prospettiva di Baldo Pastore una posizione sovraordinata e prioritaria rispetto al diritto positivo, costituendone il nucleo duro “escluso dalla transazione, dalla negoziazione, sottratto al potere di disposizione dell’autorità legislativa, nonché … limite assoluto alla revisione costituzionale”. Sono proprio i diritti fondamentali ad impedire le possibili derive “dispotiche” della democrazia.
È dunque il DNA dei diritti fondamentali, elastico ed aperto a richiedere, ineludibilmente, “la dimensione interpretativa e argomentativa”.
Qual è, dunque, lo strumento più appropriato per realizzare un’attività osmotica di riduzione del diritto positivo ai diritti fondamentali?
Nell’ottica di Pastore la risposta sembra chiara ed è data dal fatto che “I diritti non vivono senza l’interpretazione” e che proprio l’interpretazione offre al giudice “alcuni irriducibili spazi di libertà, che però esigono un impegno ad esercitarla in modo controllato e responsabile attraverso scelte e valutazioni trasparenti, consapevoli e motivate”.
L’interpretazione non è dunque patologia, ma si atteggia come pure fisiologia, senza poter nascondere che questa distribuzione di potere normativo possa, poi, assumere la forma della “leale collaborazione”, ma anche della tensione e del conflitto, come puntualizza Pino.
Le operazioni reinterpretative di cui parla Pastore sono dunque ciò che a monte consentono la protezione di una situazione giuridica che inizialmente non sembra godere di riconoscimento alcuno e che invece, nel caso concreto, acquista forza giuridica attraverso l’interpretazione di un testo normativo nel significato che il giudice gli dà.
Le decisioni contromaggioritarie che i giudici dovessero adottare non producono, così, un momento di rottura della democrazia, ma al contrario in modo pieno la sua realizzazione, rappresentando quando si alimentano dei diritti fondamentali e comprimono il diritto positivo, un surplus realizzato dalla giurisdizione.
Quest’attività creatrice deve comunque avere dei limiti. Pastore li individua nella necessità che il potere esercitato dal giudice “deve essere espressione della ragione giuridica, volta a cogliere ed esplicitare le linee portanti di un ordinamento, sempre più intrecciato con il diritto sovranazionale e internazionale, che assume i diritti come aspetti irrinunciabili”.
Ecco così aprirsi il tema delle insidie che l’attività interpretativa presente, se intesa nel modo pregnante che i due filosofi del diritto hanno esposto.
Pino coglie nella duplicità del valore del precedente e nella sua forza al contempo endo-processuale ed extra-processuale la possibilità di conflitti - in termini di coerenza - che potrebbero nascere rispetto a decisioni che, nel decidere il caso concreto, si inseriscano nella trama dei precedenti in modo distonico. Ma il nodo davvero insidioso è rappresentato dall’uso che il giudice fa della motivazione.
Una motivazione che, insiste Pino, se non deve essere né apodittica né sentenza-trattato, ha necessità di essere completa e, forse, si potrebbe aggiungere persuasiva, logica, coerente, calibrata rispetto alla vicenda decisa, non orientata ad affermazioni espresse in obiter dicta ovvero ad astrarre dal caso concreto principi che potrebbero risultare non adeguati fuori dalla vicenda scrutinata.
Pino, forte delle matrici teoriche della scuola alla quale si inscrive si preoccupa, poi, di indagare sulla tendenziale convergenza fra contesto di scoperta e contesto di giustificazione in una prospettiva che, evidentemente, guarda con attenzione al problema delle rotture fra dato normativo e decisione giudiziaria che integra il primo in nome della Costituzione e/o dei principi fondamentali di matrice sovranazionale, richiedendo una limitazione interna alla motivazione, dovendo essa fotografare il ragionamento giuridico che ha condotto il giudice alla decisione. Tema, questo indubbiamente complesso e difficile da monitorare.
Anche Pastore coglie le insidie rappresentate dall’interpretazione ritenendo imprescindibile l’aspetto giustificativo della decisione, esso contribuendo “a liberare la decisone giuridica dal sospetto di essere arbitraria”.
Come vincere questo sospetto?
Pastore riconosce al giudice la discrezionalità nell’individuazione delle fonti rilevanti per il decidere e nella determinazione del significato di quelle fonti, ma lo imbriglia imponendogli di dare conto del metodo utilizzato per scegliere un certo significato della norma, in una prospettiva indefettibile di controllabilità del ragionamento che ha determinato la soluzione del caso. Da qui la necessità di quei “controlli di razionalità” sui quali egli si sofferma e fra i quali assume un peso rilevante il controllo operato dalla comunità interpretativa, capace di ulteriormente verificare le scelte e le soluzioni adottate, impedendo che essa siano autofondate e, quindi, infondate.
Il richiamo al senso di responsabilità del giudice si aggancia o meglio si converte in etica del ragionamento giuridico.
Scolpisce il suo pensiero, Pastore, ricordando ai giudici di non cedere “alla tentazione di mettere al centro della propria attività le valutazioni personali e/o esterne all’ordinamento, sulla base di interessi che inquinino l’imparzialità del comportamento e del giudizio.”
Ecco qui l’insidia rappresentata dall’enfatizzazione del canone interpretativo che, secondo Pastore, “… rinvia alla seduzione del potere, inteso come volontà incontrollata, e trovano spazio quelle possibili perversioni della funzione giudiziaria che minano le fondamenta del patto fiduciario che lega i cittadini e le istituzioni.”
Pino, per parte, sua, propone quale limite al ricorso incontrollato all’interpretazione la necessità che il giurista faccia proprio lo schema di lavoro definito come “ideologia giuridica”, al cui interno i diversi metodi e criteri utilizzati vengano nel singolo caso governati dal giudice nel modo che egli riterrà di approntare rispetto al caso di specie e purché egli dia conto dei processi che hanno orientato la decisione.
Pastore riconosce che il diritto stesso “possiede una sorta di sporgenza e di capacità espansiva, che non può fare a meno di un esercizio “sapienziale”, che entra in gioco quando manca una norma, ricavata da specifiche disposizioni, idonea a disciplinare un caso.”
Sono, dunque, i princìpi a trovare applicazione diretta, naturalmente dotati di “una capacità propulsiva ed espansiva”, purché le tecniche argomentative che il giudicante utilizza siano “esplicitate e sottoposte al controllo della comunità interpretativa, una regola idonea a disciplinare il caso”.
Ma cos’è il diritto giurisprudenziale?
Esso ha senz’altro un carattere sui generis, andando oltre la legge ordinaria e camminando insieme, accanto, tenendosi per mano con la Costituzione, assumendone dunque i tratti, anche in termini di forza di resistenza.
È proprio questo camminare con la Costituzione che giustifica il controllo di garanzia attribuito all’ordine giudiziario e la continua opera di rimodulazione delle fonti di produzione legislativa ai canoni costituzionale per mano del giudice.
Un camminare insieme che, a volte, sembra orientare verso la prevalenza della fonte giurisprudenziale su quella scritta.
A questo si aggiunge il “piano in più” rappresentato dalle fonti sovranazionali sul quale Pastore e Pino insistono ancora una volta in sintonia fra loro. Essi, in definitiva, ritornano sul piano dei “tre cappelli” – costituzionale eurounitario, convenzionale - al quale chi scrive ha più volte fatto cenno e che costituisce un ulteriore elemento di complessità e destabilizzazione del sistema, ci ricorda giustamente Pino. Fonti di grande apertura verso un’idea di diritti fondamentali che stenta sempre di più ad essere confinata nell’ambito di un sistema normativo nazionale e che si alimenta incessantemente e vicendevolmente proprio grazie alle fonti “fuori confine”, e al loro fare sistema con quelle domestiche.
Ed ecco l’immagine assai esteticamente appagante che propone Pino, quella dell’arcipelago, della rete, o perfino del caleidoscopio.
Qual è il fine di queste fonti non interne?
Pino lo descrive accostandole alla Costituzione per dire che esse sono un modo “con cui Ulisse si è legato all’albero della nave della civiltà per evitare di farsi ammaliare dalle sirene – finendo ad esse in pasto.”
Insomma, ossigeno senza il quale la democrazia non potrebbe vivere, sembrano voler dire i nostri professori.
Il giudice è dunque chiamato, nello stato costituzionale a “vegliare sulle possibili violazioni di quei principi” operandosi nell’attività di restauro anche in via interpretativa della coerenza tra legislazione e costituzione.”
Se, dunque, sono palesi i rischi ai quali va incontro l’attuale assetto, costellato da complessità, la sfida, prosegue Pino, sta tutta nella garantire che “dal caleidoscopio dei centri di produzione normativa – il legislatore, la Corte costituzionale, i giudici comuni, corti sovranazionali – emerga una migliore, più equilibrata tutela dei diritti fondamentali.
Anche nelle repliche Pastore e Pino hanno generosamente colto lo spunto delle risposte da ciascuno date per ulteriormente chiarire il loro punto di vista.
Pastore ha ribadito che la centralità della Costituzione è centralità del giudice chiamato a farla vivere nel contesto del caso posto al suo vaglio, pur sotto il controllo della motivazione e della comunità interpretativa, senza il quale il compito produttivo riservato al giudice diventa incontrollabile.
Pastore ritorna così al concetto di responsabilità etico-politica del giudice, al cui interno è necessario coniugare interpretazione e argomentazione.
In questa prospettiva la decisione contromaggioritaria non può mai essere antidemocratica.
La democrazia, dice Pastore, non si risolve nel suffragio universale e nella regola della maggioranza, ma si compone anche di quelle comunità di esperti – di élite specializzate, che sono interne al circuito stesso delle democrazie, svolgendo un’attività sottoposta al principio di legalità “che li vincola alla fedeltà ordinamentale e alla consistenza formale e sostanziale delle loro pronunce” e che offre alla democrazia “saggezza, lungimiranza, rigorosa indipendenza”.
Pino, per parte sua, si è mostrato più attento a fissare i paletti dell’attività interpretativa rispetto a quella “creazione del diritto” che la Costituzione sembra legittimare. Ricorda, allora, che il costituzionalismo moderno non elide del tutto il ruolo della legislazione, nemmeno nella materia dei diritti fondamentali, frammentando, certo, in molteplici centri decisionali senza tuttavia “che nessuno di questi poteri abbia mai davvero l’ultima parola, in quanto “lo Stato costituzionale frammenta la sovranità in molteplici centri decisionali che talvolta collaborano e talvolta entrano in reciproca tensione, scommettendo sulla possibilità che da questa frammentazione risulti una migliore tutela dei diritti.” Pino non sembra dunque voler affatto chiudere le porte al ruolo del giudiziario rispetto all’attuazione dei diritti fondamentali, ma non si nasconde che “i principi portano ordine e coerenza tra i materiali giuridici, ma sono anche fonte di incertezza e conflitti interpretativi.”
Fin qui gli intervistati.
Qualche minimale riflessione su quanto affermato dai due filosofi.
La prima è sicuramente collegata al “peso” che ricade sulla giurisdizione per effetto della Costituzione.
L’esempio che Pino fa a proposito delle sentenze additive della Corte costituzionale per individuare la specificità dell’interpretazione nel processo di inveramento dei diritti fondamentali sembra davvero fecondo per cogliere la centralità del ruolo del giudiziario, se soltanto si rifletta sui seguiti giurisprudenziali rispetto alla pronunzia di incostituzionalità.
Come già altra volta evidenziato, quando il giudice costituzionale fa luogo ad una pronunzia additiva di principio consegna la sua indicazione contemporaneamente al legislatore perché adotti le regole opportune al fine di attuarla ed al giudice affinché, nel frattempo, possa estrarre dal principio somministrato dalla Corte la regola buona per il caso, considerando altresì il quadro normativo generale esistente.
Il giudice comune viene così autorizzato a far qualcosa che la Corte costituzionale nega di potere fare essa stessa e cioè produrre una regola con valenza precaria (in attesa dell’intervento del legislatore). Spetta, così, al giudice comune l’attività che si compendia (come pure afferma Cass., S.U., n.1946/2017) nell’ interpretare, nel trovare, nel reperire, nel ricercare (Cass.S.U.n.22784/2012) - P. Grossi, L’invenzione del diritto, Bari-Roma, 2017, 115 e 127, specificamente ricordando Cass. S.U. n.1946/2017 –.
Attività che conduce il giudice a trarre linfa dai principi costituzionali, come ci ricordano Pino e Pastore, non più visti come ricavabili da norme particolari, ma nella loro dimensione elastica e potenziale, direttamente proveniente dal complesso e variegato sistema che va individuato attraverso operazioni ermeneutiche ben lontane dall’angusto piano dell’art.12 delle preleggi al codice civile – sul ruolo dell’interpretazione nell’individuazione dei principi v. T. Mazzarese, Interpretazione della costituzione. Quali i pregiudizi ideologici? , in Donati, Sassi (eds.), Fondamenti etici del processo. Vol. 1 di Diritto privato. Studi in onore di Antonio Palazzo, Torino, 2009,439 ss.–
Certo, le regole aggiunte dalla Corte costituzionale sono efficaci erga omnes, diversamente da quelle prodotte dal giudice comune, la cui efficacia resta circoscritta al caso.
Ciò non toglie che la carica d’innovatività (o, diciamo pure, di “normatività”) insita nella pronunzia del giudice ha modo ugualmente di spiegarsi (intervenendo il giudice comune sull’istanza di giustizia della parte privata), mentre la decisione della Corte costituzionale, nella circostanza, è obbligata a limitarsi alla mera indicazione del principio. Qui, forse, si tocca con mano quella vicinitas fra giurisdizione e Costituzione che Pino evoca.
La centralità dei diritti di matrice costituzionale ha indotto poi Pastore a ricordare la dottrina che aveva parlato di effetto di irradiazione per descrivere il ruolo e la dimensione ordinamentale dei principi costituzionali.
Un piano d’indagine, quest’ultimo, in piena sintonia con un’importante – anche se non recente – pronunzia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – Cass., S.U., n.22601/04 – ove si ricordò l’esperienza giurisprudenziale tedesca che, inizialmente orientata ad escludere che competesse al giudice di legittimità il compito di interpretare la legge in senso conforme a Costituzione, ha definitivamente superato quell’indirizzo, pervenendo ad una visione diffusa del potere-dovere di interpretazione conforme, così attribuito al giudice che applica alla legge, al giudice costituzionale ed alla stessa p.a.
Proprio in quel contesto le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare come sia ormai riconosciuta negli ordinamenti continentali l’opera di adeguamento di un testo normativo polisenso ai precetti costituzionali “senza che ciò comporti necessariamente una caducazione della norma di legge”.
Ed in quella prospettiva venne appunto richiamato il c.d. “effetto di irraggiamento” (Ausstrahlungswirkkung) che, nel linguaggio tedesco, descrive l’effetto adeguatore delle norme di legge ordinaria da parte di quelle costituzionali, soprattutto quando queste esprimono la tutela di diritti fondamentali. La concordanza fra dottrina e giurisprudenza sul tema è, in questo caso forse più che in altri, fattore di estrema importanza.
In questa stessa direzione, del resto, la Corte costituzionale italiana non ha mancato di evidenziare le potenzialità dell’attività interpretativa, anche con riguardo al peso delle fonti sovranazionali.
È l’interprete, e primo fra tutti il giudice, a dovere fare vivere la CEDU all’interno dei casi posti al suo vaglio in una prospettiva che guarda, a me pare in ogni caso, alla Convenzione come strumento di innalzamento di tutela dei diritti fondamentali (Corte cost.nn.68 e 109/2017, nonché 63/2019-.
Per altro verso, Corte cost.n.24/2019, premurandosi di chiarire che in campo penale l’interpretazione anche se costante “non vale a colmare l’eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale, non potendosi surrogare integralmente alla praevia lex scripta, ma soltanto ad individuare “il significato corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza a che la persona può raffigurarsi leggendo” aggiunge che, al di fuori della materia penale “…non può del tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione”. Sono proprio il piano costituzionale e quello convenzionale a rendere possibile che “tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l’applicazione della misura stessa”.
Interpretazione che, per altro verso, non può porsi in contrasto con l’univoco tenore testuale della legge- cfr., da ultimo, Corte cost.n.207/2018, cons.n.2 in diritto-.
Ecco, quindi dispiegarsi la centralità delle interpretazioni, se si guarda alla naturale vocazione del giudice ad essere all’un tempo chiamato a rileggere i dati normativi in chiave costituzionale, convenzionale e del diritto dell’Unione Europea.
Bene ha fatto, allora, la Giunta nazionale dell’ANM lo scorso 3 luglio a ricordare che “I giudici, nei tribunali e nelle corti, applicano le leggi interpretandole secondo la Costituzione e le norme sovranazionali” ciò costituendo “ineludibile garanzia per la tutela dei diritti e delle libertà di tutti i cittadini".
Si giunge, così naturalmente al nodo della motivazione delle decisioni che già nelle precedenti interviste dei Presidenti della Corte di Cassazione era stato giustamente sottolineato.
Pino e Pastore non hanno mancato di sottolineare i “controlimiti” che il giudice deve autoimporsi.
Oggi è forse soltanto il caso di rammentare che la piena libertà del giudice di merito di dissentire dall’indirizzo della Corte di Cassazione, al quale il sistema affida il ruolo di uniforme interpretazione del diritto, va salvaguardato ad ogni costo – come opportunamente ha ricordato Corte cost.n.230/2012 nel marcare la differenza fra diritto scritto e diritto giurisprudenziale – , a patto che il giudice stesso si dia carico di sviluppare una trama argomentativa capace di – ed idonea a – discostarsi dalle indicazioni offerte dal giudice di legittimità, magari valorizzando elementi che traggono origine e linfa dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali.
Se però quello stesso giudice dovesse sottrarsi a quest’obbligo prediligendo forme di disobbedienza superficialmente motivate e apodittiche egli finirebbe col rendere un cattivo servizio alla giustizia che gli affida, come hanno sottolineato Pastore e Pino, un ruolo estremamente delicato, incrinando il senso di fiducia nell’ordine giudiziario della collettività, dando così la stura alle critiche di quanti continuano a mettere all’indice il ruolo della giurisdizione e dell’interpretazione nello stato costituzionale.
Fortunatamente, il tempo è spesso è galantuomo.
Valga solo un esempio, assai significativo, rappresentato dalla sentenza Englaro della Corte di Cassazione che, apostrofata talvolta come esempio di giurisdizione narcisistica, creatrice del diritto e sconfinata nel delirio di onnipotenza è stata finalmente sdoganata, dopo l’intervento della Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni (Corte cost.n.334/2008, su cui, v., vedi, R. Conti, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo del giudice, Roma, 2011,286 ss.)
e della Corte edu (Corte edu, 16 dicembre 2008, Ada Rossi e altri c. Italia, su cui, ancora, R. Conti, Scelte di vita o di morte. Il giudice è garante della dignità umana?, Roma, 2019, 45 – a distanza di quasi dodici anni, dopo il varo della l.n.219/2017 e dell’ordinanza della Corte costituzionale n.207/2018, potendo a ragione essere indicata come la pronunzia capostipite di ciò che oggi significa esercitare la giurisdizione nello Stato costituzionale.
Le considerazioni di Pastore e Pino si attagliano perfettamente alla vicenda appena ricordata e si collegano armonicamente alle precedenti interviste pubblicate da Giustizia insieme sul ruolo del giudice, offrendo alla giurisdizione una solida base di riflessione sul suo essere al centro del sistema di protezione dei diritti fondamentali non retoricamente intesi, con il carico di complessità e responsabilità che ciò comporta.
Riflessioni che, infine, dimostrano come la giurisdizione non possa fare a meno di mantenere un contatto continuo con quella comunità interpretativa capace di selezionare, valutare e criticare le sentenze, richiamando continuamente i giudici a quell’etica della funzione giudiziaria che proprio Nicolò Lipari, riportando le espressioni del Presidente emerito della Corte costituzionale Paolo Grossi, è tornato di recente ad invocare con forza, invitando il giudice a “...ritrovare in sé la consapevolezza etica e la forza psicologica che, unita alla sensibilità storica e alla sua sapienza tecnica, gli possano permettere di adempiere il munus arduo che la crisi dello Stato e delle sue fonti fa piombare sulle sue spalle”.