
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Intervento dello Stato e trasformazioni dell’amministrazione*
di Giancarlo Montedoro
Negli ultimi anni di vita e sviluppo delle economie capitalistiche nel mondo occidentale abbiamo affrontato numerose crisi sistemiche: la crisi finanziaria del 2007 2008, la pandemia, ora la guerra.
Questo incedere di crisi che si inscrive nella tradizionale instabilità delle economie di mercato studiata da Max Weber e da Keynes ha portato ad un ritorno dello Stato, sottolineato anche in una sintetica analisi di questa fase storica da Giuliano Amato.
Nel farsi ancora incompiuto di un’architettura istituzionale internazionale o sovranazionale è allo Stato che continua a guardarsi per predisporre rimedi alla crisi, per contrastare il declino, per approntare rimedi che costruiscano il futuro.
Lo Stato – sin dai tempi del contratto hobbesiano – è essenzialmente un meccanismo securitario.
Il giudice amministrativo – a seguito dell’avvento dello Stato di diritto amministrativo - garantisce il rispetto della Rule of Law a fronte del Leviatano, lo ingentilisce.
Tempo è passato dal momento in cui lo Stato come forma politica si è affacciato nella storia umana.
E di recente – fino all’11 settembre del 2001 - lo Stato ha lasciato il campo al mercato come avviene in tempi di pace e prosperità.
Il ritorno dello Stato – a fronte delle multiformi crisi del mercato - potrebbe leggersi come un aspetto dei vichiani corsi e ricorsi della storia, come un movimento pendolare ricorrente.
Ma la storia umana è un libro aperto ; è storia della libertà umana; essa è stata letta secondo obiettivi destinali o eterne circolarità; nodi teologici e filosofici che pur legati alla dottrina dello Stato possono qui essere solo accennati per dire con semplicità che lo Stato è una produzione immaginaria storico- sociale che si connota per i tratti caratteristici di ogni epoca che attraversa (e che potrà cogliersi nel suo senso solo a lunga distanza dai fatti che vengono vissuti).
Il ritorno allo Stato, il ritorno dello Stato non è mai un mero ritorno al passato.
Il nuovo intervento pubblico – spesso di stampo emergenziale (non eccezionale perché una cosa è l’emergenza altra cosa è lo stato di eccezione) – si dispiega in un contesto molto differente da quello del passato e che condiziona l’agere pubblico.
È ormai una realtà l’esistenza di poteri pubblici sovranazionali (l’UE e le altre organizzazioni sovranazionali di dimensione continentale).
È quindi al diritto sovranazionale che occorre guardare per cogliere esattamente le dimensioni del ritorno dello Stato.
Il Next Generation UE è – in proposito – secondo la lettura di molti un vero e proprio cambio di paradigma nel senso della solidarietà fra Stati europei.
Nello stesso tempo emerge – e non va ignorata – una pericolosa tendenza al risorgere dei confini e degli egoismi nazionali come risposta alle multiformi ed aggressive dimensioni della crisi.
L’incertezza sulle regole dell’austerità finanziaria europea – per ora sospese come sappiamo - una volta finita la fase emergenziale andrà superata definendo un nuovo quadro di compatibilità; grande compito per una politica europea all’altezza dei tempi, politica concorde che auspichiamo e che dovrà garantire l’unità nella diversità, vero e proprio punto di forza e peculiarità della costruzione europea e del suo equilibrio.
La crisi energetica in atto complica il quadro ma non preclude il futuro: piuttosto ci conferma nella scelta necessaria di riconversione verso l’ecologia e le risorse rinnovabili delle politiche energetiche con l’obiettivo al medesimo tempo di assicurare la nostra autosufficienza come sistema paese ed il rispetto del principio di precauzione nel contrasto al cambiamento climatico.
Si può guardare con fiducia alla strategia europea Repower UE come risposta alla crisi energetica in atto al fine di diversificare le fonti di approvvigionamento e di vedere pienamente attuato a livello europeo il principio di solidarietà energetica di cui vi sono ampie tracce nella giurisprudenza comunitaria.
La de-carbonizzazione è una nuova politica industriale oltre che una sfida essenziale per il nostro futuro : ad essa si lega il ritorno di uno strumentario giuridico del passato la pianificazione.
Il diritto pubblico dell’economia in passato era fatto di pianificazioni, direttive, concessioni, aiuti, discrezionalità amministrativa; poi è venuta l’epoca dello Stato regolatore, legata alle tante privatizzazioni, all’incedere dell’economia di mercato, al crescere degli indicatori della calcolabilità economica dei comportamenti umani nei più diversi settori e lo strumentario è stato incentrato su definizione di regole di mercato nella attività delle amministrazioni indipendenti e su meccanismi autorizzatori e di controllo connotate da una forte riduzione della discrezionalità amministrativa.
Nel contempo –a quell’altezza di tempo - si registrava il mutamento di ruolo del giudice amministrativo da giudice del potere pubblico a giudice della legittimità delle attività di regolazione, giudice dell’economia si è detto con formula sintetica e sicuramente di indubbia efficacia descrittiva ma spesso travisata (nel senso che mai l’economia va intesa come tiranna sulla regola giuridica) e oggi forse non adeguata (nel senso che il ritorno dello Stato comporta il ritorno di pianificazione e discrezionalità amministrativa e con ciò restaura alcune caratteristiche del controllo giudiziario del passato).
Gli assi della nuova politica industriale europea investono le funzioni del giudice amministrativo: in maniera totale (e anche in parte contraddittoria lo si vedrà si pensi alla questione dell’impatto degli impianti di energia rinnovabile sul paesaggio o al costo ecologico della digitalizzazione niente affatto trascurabile) comportando una centralità delle questioni della conversione ecologica dell’economia (verso l’economia circolare che per mitigare l’economia degli scarti in favore del riciclo comporta una generalizzazione dei modelli consortili o “per filiera” di organizzazione delle imprese) e della digitalizzazione delle attività produttive di beni e servizi (verso un capitalismo digitale che insieme a tanti indubbi vantaggi sul piano dell’intensità comunicativa comporta non pochi rischi di omologazione e perdita di autonomia delle soggettività individuali e collettive).
Ci attendono delicati bilanciamenti di valori e di interessi, sempre orientati alla logica del concreto e della risposta di giustizia, nella consapevolezza che la democrazia costituzionale è un sistema poliarchico che funziona in modo armonico quando ogni sfera pubblica funziona nella distinzione - leale collaborazione fra poteri e la sfera privata fa la sua parte.
Nei procedimenti amministrativi si dovranno individuare sempre gli interessi pubblici primari prevalenti e l’esistenza di queste direttive giuridico pianificatorie di fondo – delineate da una vera e propria politica industriale europea – finirà per avere un influsso profondo sulle attività dello Stato e dell’amministrazione.
Centrale in questo ridisegno dell’amministrazione è la ri-definizione delle regole dei meccanismi finanziari : come sappiamo essendo ora sospese le regole di austerità ed anche i controlli proconcorrenziali per consentire aiuti di Stato in un quadro temporaneo di risposta alla crisi, lo sguardo deve essere rivolto alla sede europea ove si rinegoziano le regole di bilancio, da concepirsi in modo più flessibile tale da consentire cammini di rientro dagli alti deficit e debiti che sono stati e sono necessari per fronteggiare le crisi sistemiche che stiamo attraversando.
Va sottolineato che il Green Deal ed il digitale si appalesano come politiche strutturali, come obiettivi che nemmeno la situazione bellica rimette in discussione, solo imponendo di aggiornare il quadro regolatorio comunitario per affrontare e contenere le spinte inflattive e per salvaguardare il nucleo duro del nostro sistema produttivo.
Naturalmente i processi descritti non saranno senza effetti sul sistema delle imprese pubbliche (sempre risorgente nel clima storico in cui si ripresentano le guerre).
Il federalismo del Titolo V – al di là delle sue necessità di revisione o di accentuazione oggetto della domanda di federalismo differenziato – non esclude un forte ruolo di intervento dello Stato nell’economia, nel senso di conservazione di un nucleo duro di Stato interventore e si pensi al ruolo di CDP (Cassa depositi e prestiti) finanziatore dei comuni, finanziatore del sistema delle imprese nei settori previsti, azionista di grandi imprese pubbliche, investitore strategico.
Si pensi al ruolo delle società partecipate pubbliche alle quali sono affidati servizi pubblici essenziali che devono vivere un rapporto più proporzionato con la fiscalità generale per garantire la sostenibilità complessiva degli oneri del sistema economico: spesso il giudice amministrativo è giudice della legittimità dei sistemi tariffari legittimità che va letta anche nel prisma del concetto di sostenibilità come metodo di ogni decisione pubblica (la pressione dei sistemi tariffari sui bilanci delle famiglie e delle imprese è sempre più evidente e va considerata come un problema prioritario da affrontare con equilibrio anche al fine di segnalare ai decisori politici gli assetti regolatori raggiunti per effetto spesso di stratificazioni normative risalenti a diverse fasi storico economiche) .
Si presenta interessante anche il rafforzamento del c.d. golden power inteso come sistema di poteri discrezionali a protezione degli interessi pubblici cruciali della collettività nazionale.
L'esercizio di tali poteri – per essere compatibile con l’UE - deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su "criteri obiettivi, stabili e resi pubblici" e se è giustificato da "motivi imperiosi di interesse generale". Riguardo agli specifici settori di intervento, la Commissione ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su mere considerazioni di ordine economico che introdurrebbero meccanismi capaci di alterare il corretto funzionamento dell’economia di mercato.
I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi "strategici" e, in casi eccezionali, opporsi all'acquisto stesso.
Potere di ultima istanza : ennesimo segno di un ritorno dello Stato nell’economia con le caratteristiche specifiche di questa epoca che segue l’epoca del trionfo (e poi della multiforme crisi) dell’economia di mercato.
Va anche fatto un cenno al tema degli investimenti esteri diretti spesso oggetto di arbitrati che vedono le imprese multinazionali agire contro lo Stato quando cambiano regole ad es. ambientali incidenti sulle condizioni originarie dell’investimento. Basterà qui richiamare i casi Corte UE Acmea BV v. Repubblica slovacca e Repubblica di Moldova v. Komstroy per delineare il quadro della partita in corso sulla ridefinizione dei confini fra giudizi arbitrali internazionali e sistema giudiziario europeo.
Il giudice amministrativo nazionale che agisce come parte del sistema giudiziario dell’UE riceve nuova linfa e legittimazione dalla giurisprudenza comunitaria che preclude gli arbitrati intra-UE; la linea di confine è delicata poiché da una parte occorre limitare il ricorso alla giustizia arbitrale dall’altra evitare che lo spazio giuridico europeo venga percepito come non sicuro dagli investitori internazionali; ciò richiede giudici nazionali attrezzati e sensibili e un’amministrazione forte nel maneggiare lo strumentario del partenariato pubblico privato.
Un’altra caratteristica dell’intervento dello Stato è quella legata al salvataggio delle imprese in crisi.
Si tratta dello Stato salvatore.
Anche in questo caso però il salvataggio non ha le caratteristiche del passato, si presenta (caso ILVA a tutela di un’impresa siderurgica strategica, o in prospettiva TIM a tutela della rete, ed alla risalente vicenda Monte Paschi a tutela della stabilità finanziaria) come un intervento intermittente, temporaneo per la restituzione al mercato delle imprese dopo il loro risanamento.
Stato risanatore, quindi, scommessa non facile non sempre riuscita per la complessità delle variabili in giuoco e per la necessità di una forte e intelligente guida dei processi industriali e finanziari ossia per il ritorno alla politica industriale.
In questo quadro si torna nel dibattito giuridico a riflettere sulla necessità di rendere più trasparenti (e quindi anche controllabili ed eventualmente giustiziabili) le direttive dello Stato azionista sottraendole al dominio del mero diritto privato (pur ottimamente e sapientemente svolto dalla Direzione Generale del Tesoro) e reintroducendo spazi di diritto pubblico che rendano trasparente il rapporto fra politica ed amministrazione nel governo dell’economia.
Anche qui non un ritorno impossibile al Ministero delle Partecipazioni Statali ma un ridisegno attento dei confini fra diritto privato e diritto pubblico che restituisca un quadro più preciso delle competenze della politica e dell’amministrazione nel governo dell’industria.
Scelte politiche che devono trovare i loro tempi di maturazione.
Il Consiglio di Stato nel suo ruolo consultivo può ben ausiliare il Governo – man mano che crescerà lo spazio del nuovo intervento dello Stato nell’economia - a progettare nuove efficienti e più trasparenti norme di governo politico delle partecipazioni pubbliche in un’ottica di riforma organica dell’ intervento dello Stato nell’economia.
In ultimo le procedure di spesa: qui il Consiglio ha segnato il passo con l’elaborazione del codice dei contratti pubblici secondo quanto richiesto dalla Commissione nel processo di attuazione del PNRR.
Gli innovativi principi che reggono il codice dei contratti, l’orientamento al risultato, la semplificazione delle regole, il carattere autoapplicativo del codice, l’eliminazione del gold plating, gli incentivi al PPP ed alle concessioni si segnalano come novità che devono però necessariamente accompagnarsi alla riforma ed all’accorpamento delle stazioni appaltanti, alla digitalizzazione delle procedure, alla qualificazione del personale competente a svolgere le gare.
In particolare si segnala la centralità del PPP sul piano finanziario: i documenti comunitari sono chiarissimi nel promuovere questa tipologia di contratti nella quale è centrale l’investitore privato, con effetto di moltiplicazione delle risorse pubbliche stanziate dal PNRR, moltiplicazione molto utile in tempi di crescita inflazionistica che rischia di depotenziare il quadro macroeconomico atteso dall’attuazione della pianificazione europea senza l’apporto intelligente di progetti e risparmi privati.
Ciò richiede un’amministrazione competente e qualificata tecnicamente ed impone di investire maggiormente nel personale amministrativo, incentrando gli interventi riformatori non tanto sugli aspetti procedimentali quanto su quelli organizzativi.
Importante è anche l’insieme delle funzioni di coordinamento riservate allo stato nella nuova attività programmatoria. Il PNRR nasce in Europa ma si attua nei singoli Stati nazionali attraverso gli enti del polimorfismo amministrativo, tipici del sistema delle autonomie, sistema nel quale il rischio di paralisi decisionali e di poteri di veto può essere evitato solo mediante l’esistenza e l’esercizio – legalmente previsto- di poteri statali sostitutivi, altro terreno sul quale si gioca una partita decisiva per la corretta e tempestiva spendita delle risorse europee.
Centrale è anche per affrontare le emergenze – lo ha insegnato la pandemia – il rapporto fra l’amministrazione e la scienza.
Questo rapporto andrebbe meglio strutturato non solo investendo nell’Università e nella ricerca ma anche mediante la costituzione di organismi che abbiano alte funzioni consultive di carattere scientifico e non legati alle singole emergenze (il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici è un modello ma se ne possono indicare altri L’AIFA e l’ISS).
Il giudice amministrativo dal 1999 ha ampliato il proprio sindacato sulla discrezionalità tecnica e tale sindacato è sempre più rilevante in un’epoca – quella postpandemica caratterizzata da un’elevata complessità – in cui molte decisioni pubbliche hanno bisogno di solide basi tecniche e scientifiche per essere adottate.
In ultimo risorge lo Stato sociale, il suo bisogno, sul delicato terreno dei diritti sociali all’istruzione ed alla sanità, è stato sentito fortemente nel periodo pandemico ( basti pensare alle questioni, dibattute in giurisprudenza, relative alla didattica a distanza ed alle questioni relative ai trattamenti sanitari obbligatori o aventi elementi di coercitività anche indiretta ) ma anche nel mondo postpandemico si pone il tema di una riconversione delle attività dell’amministrazione nel ridisegno di uno Stato sociale in un’epoca di rientro da deficit e debito e di possibile stagflazione.
Il perimetro delle prestazioni esigibili e le questioni dei costi delle medesime e delle modalità del loro finanziamento non sono solo questioni politiche che si intrecciano ai temi della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e delle competenze delle regioni che reclamano un federalismo differenziato, ma sono destinate a diventare, assai probabilmente, la materia di un contenzioso amministrativo fra amministrazioni o fra cittadini ed amministrazioni in vista della definizione del perimetro esatto dei diritti sociali sostenibili in base alle concrete condizioni della finanza pubblica.
Non si può poi ignorare la questione dei nuovi poteri privati sovrani, questione che nonostante i segni di ritorno dello Stato, rimane al centro della scena come un convitato di pietra.
Le aziende multinazionali che operano nel campo del digitale e della farmacologia, ma anche delle armi e dell’energia, sono, anche per difetti delle azioni delle autorità nazionali Antitrust operanti in paesi esteri extraeuropei, anche nella dimensione del mondo anglosassone, divenute aziende dotate di potere analogo a quello degli Stati sovrani (quanto a possesso di know how tecnico scientifico e possesso di capacità operative che consentono di operare alla pari con gli stati e gli ordinamenti sovranazionali).
Si pone non solo un problema di intervento delle autorità di regolazione dei mercati e di contrasto ai cartelli ed agli abusi di posizione dominante ma anche un vero e proprio problema di ripensamento di procedure ed istituti della nostra classica democrazia parlamentare nell’epoca del digitale.
Il Consiglio di Stato in passato ha incontrato la tematica della decisione algoritmica facendo da apripista ora sarà il tempo di formare un diritto giurisprudenziale, in argomento, più sofisticato e maturo anche sulla base delle suggestioni e delle indicazioni normative che vengono dalla sede europea.
La normativa europea sui servizi digitali si concentra sulla creazione di un ambiente online più sicuro per gli utenti e le imprese digitali e sulla protezione dei diritti fondamentali nello spazio
Definisce una serie di responsabilità e un quadro chiaro in materia di trasparenza e responsabilità per i prestatori di servizi intermediari come mercati online, social network, piattaforme per la condivisione di contenuti, piattaforme ricettive e di viaggio online
Di conseguenza, tutti gli intermediari online che offrono i loro servizi nel mercato unico, siano essi stabiliti nell'UE o al di fuori di essa, devono conformarsi alle nuove norme.
L'obiettivo della normativa europea sui mercati digitali è garantire condizioni di parità a tutte le imprese digitali, indipendentemente dalle loro dimensioni. Essa intende garantire un settore digitale competitivo ed equo:
vietando le pratiche sleali delle piattaforme online che detengono la quota maggiore del mercato
riconoscendo agli utenti commerciali la possibilità di offrire ai consumatori maggiori possibilità di scelta
fornendo ai consumatori servizi migliori e prezzi più equi
imponendo diritti e obblighi chiari alle piattaforme online di grandi dimensioni
promuovendo l'innovazione e un ambiente di piattaforma online più equo per le start-up tecnologiche
La legge sui mercati digitali definisce norme chiare per le grandi piattaforme.
Intende garantire che nessuna piattaforma online di grandi dimensioni agisca da "gatekeeper", vale a dire come un attore privato che può stabilire le regole sui mercati digitali controllando almeno uno dei cosiddetti "servizi di piattaforma di base".
Tematiche complesse che sono ineludibili per evitare che i processi della digitalizzazione sfocino nelle prospettive distopiche del capitalismo della massima sorveglianza, il Consiglio di Stato italiano, come i suoi omologhi europei farà la sua parte a tutela degli utenti e delle imprese perché l’amministrazione ed i mercati costruiscano un ambiente digitale nel quale fioriscono i diritti.
In definitiva siamo – come si è accennato – in una fase storica complessa.
Forse la categoria della crisi non è più sufficiente per interpretare la realtà.
Più idonea alle necessità dell’analisi è la categoria di declino.
Il succedersi di eventi catastrofici dalla crisi finanziaria del 2007-2008 alla crisi climatica, dalla pandemia alla guerra può essere visto come un affastellarsi di fatti casuali oppure può essere letto come un succedersi concatenato di eventi che possono prestarsi ad una lettura in chiave esplicativa unitaria.
Un tentativo può farsi in questo secondo senso.
Ed è allora che soccorre la categoria del declino o tramonto della civiltà.
Si tratta del declino di una forma specifica di civilizzazione, quella occidentale, quella della civiltà del tramonto, che, è stato detto, ha il declino nel suo patrimonio genetico (basti pensare alle ormai risalenti visioni spengleriane).
La ragione strumentale e l’uomo calcolante, la dominanza dell’economico sul politico, una globalizzazione troppo veloce, un diffondersi di tecniche che insieme ad indubbi vantaggi nascondono pericoli per l’autonomia del soggetto moderno, la politica di appropriazione indiscriminata della natura concepita come un universo illimitato e a disposizione degli umani, sono tutte dimensioni della nostra organizzazione di vita che costituiscono fonti di tensioni e conflitti da sottoporsi profondamente a critica sul piano scientifico e da fronteggiarsi sul piano istituzionale.
Naturalmente si è in tempo per correggere la rotta verso una globalizzazione ben temperata nel senso indicato da Rodrik .
Sono tutti punti di tensione che al giudice è dato osservare nel contenzioso emergente che spesso diviene contenzioso su emergenze.
Emergenze che trovano una risposta nel nuovo intervento dello Stato.
È in questo cantiere – a ridosso di un immaginario storico-sociale ancora in formazione sul rapporto ad es. fra Stato e mercato - che si vanno ridefinendo le funzioni della Giustizia amministrativa.
Naturalmente il declino di una forma di civilizzazione non comporta alcuna fine della storia ma semplicemente il succedersi di una civilizzazione giovane ad altra più risalente, fenomeno nell’ambito del quale sono possibili passaggi di testimone e conservazione e difesa dei valori.
La risposta della Rule of Law
Uno dei punti più alti del sistema dei valori della società occidentale è la Rule of Law.
In Europa la Rule of Law ha preso le forme dello Stato di diritto amministrativo.
Naturalmente si potrebbe ipotizzare che l’epoca dell’espansione del potere giudiziario sia alle batture finali.
Le vicende israeliane relative alla Corte Costituzionale ; la situazione polacca o ungherese; l’autoritarismo asiatico presentato come modello vincente, le torsioni che lo Stato di diritto inevitabilmente subisce in tempi di guerra sono sotto i nostri occhi.
Tuttavia con questa consapevolezza sullo sfondo si può tentare di rilanciare sui valori dello Stato di diritto e dello Stato di diritto amministrativo capace di controllare la legalità sostanziale dell’esercizio dei pubblici poteri.
Stato di diritto amministrativo significa esistenza di un giudice amministrativo come garante della legalità dell’esercizio dei pubblici poteri.
Si è molto cercato negli scorsi anni di definire il ruolo del giudice amministrativo.
Non c’è dubbio che alla sua originaria funzione – legata alla nascita della IV Sezione – di giudice della legalità dell’esercizio del potere si siano affiancate altre funzioni, specie evidenziatesi nella crescita delle funzioni non autoritative e contrattuali della pubblica amministrazione, tanto da condurre a quello che è stato definito il giudice dell’economia.
Giudice dell’economia sorto dal mutamento delle funzioni dei pubblici poteri intesi come strumenti necessari al corretto gioco delle dinamiche economiche e di mercato, all’ordinata convivenza civile che favorisce il ciclo di produzione e riproduzione del capitale e lo sviluppo delle industrie.
Ciò è avvenuto registrando nelle aule di giustizia il cruciale passaggio dallo Stato interventore allo Stato regolatore con la nascita e l’affermazione delle amministrazioni indipendenti e delle svariate agenzie di regolazione connotanti la complessa evoluzione del capitalismo contemporaneo .
Non c’è dubbio che al processo tradizionale sull’atto amministrativo, sia succeduto – in parallelo alle trasformazioni dello Stato amministrazione- un processo amministrativo capace di guardare al complesso dell’attività – dotato di azioni che lo spingono verso l’effettività della tutela - arrivando poi con il crescere dei casi di giurisdizione esclusiva per scelte del legislatore, fino alla cognizione piena del rapporto amministrativo e – in tutti i casi anche al di fuori della giurisdizione esclusiva - ad un pieno dominio della prova e del fatto.
Questo processo è visibile anche nella crescita del contenzioso in materia di appalti che ha acquisito una indubbia centralità nell’esperienza giuridica, testimoniata dalla mole degli studi giuridici in materia, finalizzati a fare luce nelle più recondite pieghe del sistema giuridico settoriale del codice dei contratti.
I ruoli del giudice amministrativo nella crisi sono tuttavia progressivamente cresciuti ben al di là della sua ormai tradizionale connotazione di giudice dell’economia.
Il giudice amministrativo diviene giudice della complessità le quante volte, nell’incontro Stato-mercato del diritto della regolazione o nel diritto ambientale o sanitario è chiamato ad arbitrare su complesse questioni relative a frontiere dei saperi tecnico-scientifici ciò che fa più ordinariamente mediante il suo esteso ma responsabile sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.
Il giudice amministrativo diviene giudice dei servizi pubblici a carattere sociale le quante volte è costretto a decidere su casi che impattano sull’organizzazione dei servizi pubblici, specie sanitari (come è accaduto in tempi di pandemia) sulle loro forme di finanziamento, sui partenariati pubblico privati specie di tipo istituzionale.
Il giudice amministrativo diviene sempre più giudice dei diritti fondamentali, in tutti i campi di giurisdizione esclusiva in cui questo tema si ponga (sempre più occorrono controversie che hanno importanti riflessi sul diritto alla salute, sul diritto all’ambiente salubre, sui diritti dei disabili o dei consumatori ed investitori , sulla correlazione di tali diritti con i modelli di mercato come ad es, in un recente caso in cui si è posta la questione della definizione del concetto di homo oeconomicus ai fini del diritto della concorrenza).
A questa dimensione della tutela si affianca quella - menzionata nella Relazione del Presidente Maruotti – di giudice degli interessi legittimi fondamentali che sono quegli interessi legati allo sviluppo della persona umana o che hanno la loro base nei diritti fondamentali (nozione diversa da quella dei diritti inviolabili tutelati dal giudice ordinario) tutelati dalla Costituzione e dalla Cedu ed astrattamente conformabili dal potere di nuovo conio di stampo emergenziale (e si pensi ai D.P.C.M. in pandemia).
Il giudice amministrativo diviene altresì giudice delle regole dello sviluppo tecnologico come avviene nelle numerose cause che hanno ad oggetto il sistema delle telecomunicazioni sul piano infrastrutturale e dei programmi fino alle questioni relative alla sindacabilità degli algoritmi usati dalle pubbliche amministrazioni.
In ultimo il giudice amministrativo si appalesa come giudice dei nuovi poteri privati sovrani nel contenzioso sorto fra poteri pubblici e Big players del mondo economico legato ad aspetti della crisi che da una parte reclamano un nuovo incisivo intervento dello Stato e dall’altra vedono crescere il ruolo dei grandi giganti dell’economia come fornitori di servizi (il riferimento può farsi ai poteri di golden power ed al diritto antitrust).
Ed ancora il giudice amministrativo – insieme al giudice ordinario – è il giudice del corretto dimensionamento della apertura internazionale del nostro ordinamento in tutte le questioni migratorie e relative ai problemi di integrazione degli stranieri.
Queste sono le nuove frontiere del nostro intervento giurisdizionale.
Un cantiere aperto, si è detto.
Per orientarsi abbiamo la Costituzione e la centralità dei diritti della persona umana.
Una sfida appassionante alla quale la magistratura amministrativa non deve sottrarsi consapevole della necessità di dialogare con le altre magistrature, nazionali (cercando di risolvere le questioni di giurisdizione che insorgono nelle nuove materie) e sovranazionali (cercando di veicolare i bisogni di giustizia ed i dubbi interpretativi che devono essere sciolti dalle corti sovranazionali ed evitando rimessioni puramente difensive sapientemente utilizzando gli spazi lasciati ai giudici nazionali dalla nuova giurisprudenza Cilfit).
*Introduzione alla tavola rotonda “Il giudice amministrativo - nel tempo dell’emergenza e del ritorno dello Stato - fra interessi legittimi fondamentali e diritti fondamentali”, Roma, 28 marzo 2023, LUISS Guido Carli.
La lettura del libro di Paola Di Nicola Travaglini è un’esperienza insolita, perché in realtà non si tratta di un libro.
È vero, apparentemente siamo di fronte ad un insieme di fogli stampati, delle stesse dimensioni, rilegati insieme e racchiusi in una copertina (ho preso in prestito la definizione di “libro” di Wikipedia, perdonatemi).
Ma basta leggerne poche righe per avere la sensazione di trovarsi in realtà al cospetto (anzi, all’interno) di una persona, tanta è la immedesimazione dell’autrice in ciò che scrive, e talmente forte la passione con cui ha riversato la sua vita sulla carta.
Nel descrivere cosa vuol dire oggi, nel nostro Paese, essere “una giudice”, l’autrice attinge infatti a piene mani dalla sua esperienza, come è logico; ma non si limita a questo.
Paola Di Nicola Travaglini ci porta infatti nel profondo della sua vita di magistrata, descrivendo le sue giornate di lavoro, la vita in udienza, l’esperienza solitaria della camera di consiglio dei processi trattati come giudice monocratica e la condivisione delle idee nei processi collegiali, il travaglio interiore della decisione e la clausura della scrittura della motivazione e disvela al lettore gli infiniti altri momenti quotidiani che scandiscono il lavoro che ha scelto e che svolge con passione.
Ma nel farlo, con coraggio e trasporto, ci apre anche le porte della sua vita familiare, descrivendo l’atmosfera della sua casa e i suoi abitanti, testimoni, complici e a volte vittime del dipanarsi quotidiano dei mille incombenti della vita di un magistrato, ci descrive gli umori e i caratteri di ognuno di essi, ci fa sentire gli odori della cucina che interrompono e cadenzano le sue giornate lavorative passate in una stanza a scrivere, accompagnandoci dietro le quinte del suo personale vissuto.
Ed anche le giornate in Tribunale sono descritte nello stesso stile vivido e personale: insieme alle riflessioni giuridiche il lettore apprende così delle sue paure, dei momenti di gioia personale e dei rapporti con i cancellieri, gli avvocati e gli imputati dei suoi processi. Non mancano cenni alle necessità corporali che costellano la vita professionale di Paola come quella di tutti, dalla organizzazione del pranzo quando l’udienza si protrae al fastidio di portare i tacchi.
Giunti al termine del suo saggio, i lettori sapranno il nome del compagno e le sue principali caratteristiche, quelli dei figli e della cameriera dell’autrice, nonché degli imputati, dei colleghi e dei cancellieri del suo Tribunale.
Insomma, Paola non ci offre uno spaccato del suo lavoro di giudice ma un ritratto a tutto tondo della sua vita; sorprendente, sincero e proprio per questo estremamente prezioso. Unico come uniche sono le biografie di ciascuno di noi; ma al contempo implicitamente corale perché mira ad essere simbolico.
Si tratta infatti di una scelta consapevole e non di un vezzo stilistico per rendere più appetibile la descrizione di un lavoro a tratti (come tutti i lavori) inevitabilmente noioso in quanto tecnico. Una scelta che ha molto a che fare con il particolare punto di vista che ci offre l’autrice.
Sin dal titolo, è infatti manifesta la volontà di Paola Di Nicola Travaglini di non descrivere la professione di giudice in generale, ma quella di “una” giudice, portando all’attenzione del lettore il tema di cosa vuol dire appartenere all’ordine giudiziario per una donna.
Il libro inanella in un ideale percorso ogni aspetto del procedimento penale, dall’interrogatorio di un indagato detenuto – che rappresenta spesso per un GIP quale lei è stata per tanti anni il primo contatto del giudice con il fascicolo di cui si dovrà occupare – alla fase del dibattimento, sino alla sua conclusione con la lettura del dispositivo e la scrittura della motivazione della sentenza ed infine il deposito che segna il distacco del magistrato dalla sua “creatura”.
Ma lo fa da un punto di vista dichiaratamente partigiano, dal quale non si può prescindere in nessun momento del suo scritto: il punto di vista di chi svolge questo compito come donna, quindi partendo da un retaggio di pregiudizi, fastidio, malcelato senso di superiorità di buona parte dell’altra metà della razza umana, quella maschile.
Si parte con la descrizione di un dato storico che non va mai dimenticato, e cioè che fino ad epoca assai recente le donne non erano ammesse al concorso in magistratura perché ritenute non degne di esercitare la funzione di magistrati, e sono prese in rassegna tutte le attuali forme di discriminazione, spesso involontarie, gli stereotipi, le trappole cognitive ancora oggi ben presenti e radicate a tutti i livelli nei Tribunali e nelle Corti del nostro paese e provenienti da imputati, avvocati, colleghi.
Si tratta di fenomeni e scivolosi e particolari, ci avverte l’autrice: sei convinto che non esistano anche se vivi circondato dagli stessi, ogni giorno. Finché tu (se sei donna) o una persona a te cara (se sei uomo) non ci fate dolorosamente i conti. Allora cominci a riconoscerle. Ma spesso la reazione allora è di dire: c’erano prima, ma ora non ci sono più. Purtroppo, ammonisce Paola dalle pagine della sua vita-saggio, non è così.
È indubitabile che molto sia cambiato, in meglio, negli ultimi decenni, in tutti i settori (qualche giorno fa ho letto su un giornale un articolo su Tina Abselmi in cui si descrivono i gesti di ostilità di cui la grande esponente politica è stata oggetto da parte dei suoi colleghi uomini, che non si rassegnavano al fatto di avere accanto un’onorevole e poi una ministra di sesso femminile: comportamenti tragicamente simili all’atmosfera descritta in molti punti del libro di Paola Di Nicola Travaglini).
Contro tutti questi ragionamenti, non solo le discriminazioni in sé ma anche le minimizzazioni, le autoassoluzioni, gli sviamenti da reazione delle coscienze, punta il dito Paola Di Nicola.
E lo fa coraggiosamente partendo proprio da se stessa e dal lavoro che ha fatto sulla sua coscienza prima per rendersi conto delle trappole e auto-trappole che si era inflitta e poi del percorso per liberarsene.
Parla del rifiuto che incontra ogni donna di essere considerata come istituzione, del rifiuto della parte intellettuale, della sensazione di essere considerata e accettata solo come corpo. E lo fa, paradossalmente, mettendo il suo corpo e la sua persona, tutta intera, al centro della scena.
Perché in fondo è proprio in questo portare in ogni aspetto della sua vita, senza infingimenti e cesure, tutta intera la sua sensibilità e il suo essere che si sostanzia l’essere giudice al femminile.
Il contrasto con il modello maschile, basato tradizionalmente sul processo come “stare in scena”, sulla astrazione del giudice dalle sue pulsioni corporee nell’utopistico tentativo di farsi “bocca della legge” (ed in un passato non molto lontano, di Dio), sulla cancellazione dell’uomo dietro il paramento della toga, non potrebbe essere più evidente.
Il libro porta al lettore un modo diverso, altrettanto ricco e prezioso di quello maschile che siamo abituati a riconoscere come unico modello da millenni, e dopo aver enfatizzato contrasti e stereotipi di genere si conclude con il riconoscimento che negli ultimi anni moltissimo è stato fatto in termini culturali e organizzativi.
Siamo forse pronti, dopo il tempo lunghissimo della negazione e quello, recente, del contrasto e dello svilimento, al tempo della simbiosi e del completamento dei modelli.
Sommario: 1. Il fatto. - 2. La responsabilità in tema di bonifiche di siti inquinati. - 3. La creazione giurisprudenziale di un ossimoro: la responsabilità del proprietario incolpevole. - 4. Le ordinanze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e il rinvio alla Corte di Giustizia UE. - 5. La sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. III, n. 534/13. Considerazioni conclusive.
1. Il fatto.
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate su una questione già ampiamente nota nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale del diritto ambientale in tema di distribuzione delle responsabilità ambientali in caso di danno ambientale.
La Società ricorrente aveva costruito nel 2001, con gestione fino al 2003, una discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (RSU) presso una cava, utilizzata come sito di stoccaggio dei rifiuti raccolti. A seguito di accertamenti condotti da ARPA per l’ispezione dello stato della falda acquifera, era emerso il superamento dei valori-limite di plurime sostanze contaminanti e, quindi, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Di conseguenza, il Ministero dell’Ambiente aveva ingiunto alla Società l’attivazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza (m.i.s.e.) delle falde acquifere contaminate, unitamente all’adozione di misure di prevenzione e di bonifica dei suoli e della falda, a pena di interventi sostitutivi, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, il cd. Codice dell’Ambiente, con iscrizione di onere reale sull’immobile e accertamento di danno ambientale.
Tali provvedimenti erano stati impugnati dalla Società ricorrente, prima avanti al TAR e, successivamente innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP), contestando la violazione di plurime disposizioni del Codice dell’ambiente e, soprattutto, censurando l’estraneità del titolo ad ottemperare (posto che la Società non si riteneva responsabile del danno ambientale), nonché l’omessa dovuta identificazione del responsabile della contaminazione e l’estraneità ad ogni responsabilità, dovendo gli eventi ricondursi a fenomeni d’inquinamento non repentini, ma diffusi in zona.
Il TSAP, pur condividendo le conclusioni cui era giunto il TAR in merito ad un’assenza di dimostrazione che il processo d’inquinamento dei terreni fosse iniziato con l’insediamento della Società ricorrente, concludeva che l’onere di adottare le misure di messa in sicurezza di emergenza (m.i.s.e.) gravasse anche sul proprietario o sul detentore qualificato di un sito, nel contesto di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, prescindendo dall’accertamento del dolo o della colpa. Al riguardo veniva, come già in passato, sottolineato il principio del “chi inquina paga” del diritto UE, in base al quale è sufficiente la materiale causazione del danno o del pericolo ambientale, proponendo e sostenendo una responsabilità oggettiva ambientale, pur se non di posizione).
Avverso la predetta sentenza la Società proponeva ricorso in Cassazione. La questione devoluta all’esame delle Sezioni Unite involge “la contestazione nella vicenda del principio ‘chi inquina paga’ di cui alla Direttiva 2004/35/CE e comunque di ogni responsabilità ambientale, anche a titolo oggettivo o prescindendo da una condotta causativa del danno, in capo al proprietario/gestore richiesto di provvedere alla messa in sicurezza di emergenza, in difetto della individuazione del responsabile della potenziale contaminazione”.
Con i primi due motivi di ricorso, ritenuti fondati dalla Suprema Corte, la Società ricorrente contestava l’applicazione alla vicenda del principio del “chi inquina paga” (in base al quale sul proprietario/gestore grava comunque ogni responsabilità di provvedere alla messa in sicurezza di emergenza: m.i.s.e.) e l’erronea mancata individuazione del responsabile della potenziale contaminazione.
Decisiva, secondo il Collegio, è risultata la constatazione secondo cui, nel caso in esame, risultava pacifico che in capo alla Società non fosse intervenuta la dimostrazione, ad opera delle competenti Amministrazioni, di alcuna correlazione causale tra l’attività svolta in situ e, per via di percolazione dei rifiuti trattati, la contaminazione del sottosuolo e della falda acquifera.
A partire da tale accertamento, la Suprema Corte rileva, pertanto, che il titolo che ha giustificato per il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la legittimità delle prescrizioni adottate dalla P.A., “pur nel formale distanziamento dalla responsabilità da posizione”, è consistito in una peculiare relazione della Società ricorrente con il sito (la proprietà o la detenzione qualificata) secondo il criterio di responsabilità oggettiva ritenuto conforme alla Direttiva 2004/35/CE.
In maniera incisiva, le Sezioni Unite contestano tale conclusione, ritenuta non condivisibile avendo riguardo alle acquisizioni prodotte dal dialogo tra giurisprudenza nazionale, amministrativa ed europea in relazione al principio “chi inquina paga”, di cui si darà conto nel proseguo per completezza d’analisi sistematica della vicenda.
Fondamentale nell’impianto motivazionale della pronuncia in esame risulta, invero, l’analisi della disciplina multilivello in tema di prevenzione e di riparazione del danno ambientale, all’interno della quale si colloca il principio del “chi inquina paga” (artt. 1 e 7 Allegato II della Direttiva 2004/35/CE ed art. 191 TFUE).
In base a tale principio “l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale” (considerato 2 della Direttiva 2004/35/CE).
La ratio del principio “chi inquina paga”, come rilevato nell’analisi economica di tale sistema, viene dunque individuata nel fatto che “imporre al soggetto inquinatore l’obbligo di riparare il danno o, in alternativa, quello di tenere indenne la comunità territoriale che l’abbia evitato o rimosso, significa pertanto addossare (…) le esternalità negative (conseguenti alla produzione o al commercio di beni e servizi) a carico del soggetto cui sia riferibile l’attività, evitando alterazioni di mercato (per qualità dei prodotti e livelli di concorrenza), senza oneri per la collettività ovvero costi assunti in via definitiva dall’ente pubblico; viene così scongiurato ogni scenario di alternativa monetizzazione dell’inquinamento, disincentivato dallo scaricarsi sui soli prezzi, senza altri interventi ed invece declinandosi il principio riassuntivo ‘chi inquina paga’ nella riparazione più diretta del danno ambientale (nei contesti di acque, terreno e biodiversità, i soli dell’art.2 Direttiva), ad opera dell’autore (operatore in attività classificata pericolosa o terzo imputabile ad altro titolo) o, in sua vece e con recupero dei costi, a cura dell’ente pubblico”.
Se, dunque, appare chiara la definizione e la portata del principio in esame, molto più controverso appare il criterio di imputazione della responsabilità per danno ambientale, essendo in dubbio se occorra valorizzare un modello di responsabilità di tipo oggettivo (quantunque la più efficace a tutela dell’ambiente) o se, diversamente, debba prevalere un criterio di imputazione soggettiva di tipo psicologico della relativa condotta. Obiettivo dell’indagine condotta nella sentenza in commento è, dunque, comprendere se l’interpretazione dell’intero assetto normativo italiano, conseguente alla progressiva armonizzazione con la Direttiva 2004/35/CE, sia di per sé idonea a giustificare una responsabilità oggettiva del proprietario in quanto tale.
Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, dalla lettura sistematica e integrata delle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006) e della Direttiva Europea 2004/35/CE non è possibile rinvenire alcun obbligo diretto ed esplicito del proprietario, ove non sia autore della condotta contaminante, ad adottare interventi di messa in sicurezza di emergenza. Particolarmente rilevante, a questo proposito, deve ritenersi il disposto di cui all’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006, che fissa la responsabilità oggettiva di chi gestisce specifiche attività professionali elencate e quella soggettiva (per dolo o colpa) in capo “a chiunque altro cagioni un danno ambientale”. Inoltre, al ricorrere di specifici presupposti, l’art. 308 esclude, a carico dello stesso operatore esercente un’attività professionale di rilevanza ambientale, i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e di ripristino qualora esso dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo o nelle ipotesi di cd. inquinamento diffuso.
L’azione di risarcimento del danno ambientale, inteso come bene pubblico di carattere unitario, costituente autonomo diritto fondamentale di rilievo costituzionale, oggetto di tutela da parte del Giudice Ordinario, diviene così un’azione di reintegrazione in forma specifica, di competenza esclusiva del Ministero dell’Ambiente.
Da un’attenta analisi del quadro normativo e della giurisprudenza europea e nazionale, la Suprema Corte giunge dunque alla conclusione secondo cui “va esclusa una indicazione comunitaria alla riparazione del danno (…) a carico di chi non abbia svolto l’attività professionale di operatore, bensì venga chiamato a rispondervi nella veste di titolare di diritti dominicali o addirittura, come nel caso, con nesso eziologico escluso dallo stesso giudice dell’accertata condotta, non potendo la mera enunciazione di indizi di posizione, per un’attività non classificata dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 a rischio d’inquinamento, sostituire di per sé la prova del predetto necessario nesso causale” (par. 16 della Sentenza).
All’interno dell’analisi, in chiave sistematica, della responsabilità per danno ambientale offerta dalle Sezioni Unite, centrale rilevanza assume la distinzione tra i doveri incombenti sul proprietario incolpevole dell’inquinamento ed il responsabile dell’inquinamento.
Gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto previsto dall’art. 253 del Codice dell’Ambiente in tema di oneri reali e privilegi speciali immobiliari. Il proprietario, in tale quadro, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione idonee a contrastare un evento che abbia creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile, secondo il canone causale civilistico, di verificazione di un danno sanitario o ambientale, al fine di impedire o minimizzare tale minaccia. In tale logica, “le norme contemplanti il proprietario (artt. 245 e 244 cod. amb.) dovrebbero essere rilette come un coinvolgimento per un verso doveroso (….) per l’attuazione, senza distinzione, di tutte le misure di prevenzione (…) e, per altro verso, pienamente partecipativo dell’iter procedimentale preventivo” (par. 25 della sentenza).
Dalla figura del proprietario incolpevole deve essere tenuta nettamente distinta la figura del responsabile dell’inquinamento, obbligato in modo più stringente e sempre, ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, già nelle prime 24 ore, ad adottare le misure necessarie di prevenzione, le misure di messa in sicurezza di emergenza (m.i.s.e.) e di bonifica del sito inquinato. L’Amministrazione, dunque, non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di realizzare le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati alle previsioni di cui all’art. 253, in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare, oltre che all’adozione delle sole necessarie misure di prevenzione.
Infine, anche alla luce degli artt. 9 e 41 della Cost., modificati con l. cost. n. 1/2022 viene considerato non irragionevole il sistema distributivo della responsabilità ambientale tuttora vigente, imperniato proprio sul perseguimento della riparazione e fino alla estrema attuazione dell’intervento pubblico sostitutivo rispetto all’inerzia o alla non individuazione del responsabile.
Sotto il profilo civilistico, l’inapplicabilità degli artt. 2050 c.c. “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose” e 2051 c.c. “Danno cagionato da cose in custodia” discende direttamente dalla natura interamente speciale propria del Codice dell’Ambiente; a seguito dell’introduzione della Direttiva 2004/35/CE, come chiarito dalle Sezioni Unite, si è di fronte ad un corpo normativo appositamente dedicato alla tutela dell’illecito ecologico slegato dal sistema regolativo dell’illecito civile ordinario di cui agli artt. 2043 e ss. c.c..
2. La responsabilità in tema di bonifiche di siti inquinati.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione può ritenersi certamente apprezzabile nella misura in cui, valorizzando una lettura sistematica ed integrata della normativa europea e nazionale, nonché gli apporti della giurisprudenza civile, amministrativa ed europea, afferma che il criterio di imputazione della responsabilità per danno ambientale, secondo il principio “chi inquina paga”, non può prescindere dall’accertamento del nesso causale tra l’attività posta in essere dall’operatore e l’inquinamento, nonché dall’accertamento del necessario elemento psicologico (colpa o dolo del responsabile dell’inquinamento). Data la rilevanza e l’attualità del tema, pare opportuno collocare tale sentenza in un più ampio dibattito che ha visto protagonisti da tempo giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10/2019), giudice europeo e dottrina.
Dall’analisi del Titolo V (Bonifica dei siti inquinati), artt. 239-253 del d.lgs. n. 152/2006, il cd. Codice dell’ambiente, emerge come il legislatore abbia scelto di porre l’onere della bonifica di un sito inquinato[1] in capo a colui che sia stato individuato come responsabile di tale evento, e questo evidentemente rappresenta una delle più importanti e immediate applicazioni, a livello di normativa statale, del principio comunitario “chi inquina paga”[2], oggi trasfuso all’art. 3 ter del Codice.
Tuttavia, se il quadro legislativo pare chiaro ad una prima lettura, si è posto soprattutto a livello giurisprudenziale un profilo di criticità che merita di essere analizzato, ossia quello relativo alla natura della responsabilità che viene attribuita al soggetto autore dell’inquinamento. Infatti, in relazione a tale responsabilità sono emersi diversi orientamenti giurisprudenziali, i quali negli ultimi anni e fino alle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2013 e alla sentenza della Corte di Giustizia del 2015 di cui si dirà, hanno alimentato il dibattito sul rilievo da attribuire all’elemento soggettivo della colpa.
Si è così affermato un primo orientamento a sostegno della tesi secondo la quale il responsabile dell’inquinamento deve realizzare gli interventi di bonifica solo sulla base di una responsabilità di tipo oggettivo. Pertanto, l’obbligo di bonifica spetta al soggetto a prescindere dalla sua colpevolezza e solo sulla base dell’esistenza del nesso causale tra condotta, commissiva ovvero omissiva, e il danno perché vi sia il dovere di riparare, senza la necessità dei profili soggettivi.
Questa posizione si è presentata in continuità con la disciplina dell’ormai abrogato d.lgs. n. 22/1997[3] e del successivo D.M. n. 471/1999[4], ai sensi del quale l’imputazione della responsabilità avveniva con l’accertamento del nesso esistente tra la situazione di pericolosità e il verificarsi dell’evento e l’attività posta dal responsabile, senza dover dimostrare l’elemento soggettivo del comportamento del soggetto in questione. In definitiva, una volta verificatosi il danno, l’ente competente diffidava il responsabile affinché attuasse a proprie spese le necessarie misure di prevenzione, di messa in sicurezza e di bonifica del sito inquinato[5].
In seguito, parte della giurisprudenza si è pronunciata a favore di questa tesi nei confronti della quale sono state avanzate due argomentazioni[6].
La prima trova le proprie radici nell’esigenza di oggettivizzazione della tutela ambientale.
In altri termini, la necessità di individuare un nesso soggettivo tra un fatto e un evento avrebbe potuto rendere più difficile l’individuazione del responsabile della contaminazione, con l’immediata conseguenza di dover fare ricadere sull’amministrazione e, quindi sulla collettività[7], troppi casi di ripristino ambientale. Quindi, sostenendo la teoria della responsabilità oggettiva e ipotizzando una responsabilità “da posizione”[8], svincolata da profili soggettivi, l’operatore sarebbe stato incentivato a valutare e a prevedere gli effetti negativi del proprio operato nei confronti dell’ambiente[9], rispetto alla situazione in cui sarebbe tenuto a rispondere solo in caso di accertamento della colpa.
La seconda argomentazione a favore di una responsabilità oggettiva si basa sulla circostanza secondo la quale nel nostro ordinamento l’accidentalità di un evento è sostenuta dal legislatore per le procedure semplificate per la bonifica di aree di dimensioni ridotte[10]. Si potrebbe così ritenere che tale requisito, oltre a trovare applicazione in tali procedimenti, rappresenti un presupposto generale da applicare alla disciplina delle bonifiche[11].
Sebbene la tesi della responsabilità oggettiva sia stata ampiamente sostenuta, ha trovato un maggiore sostegno quell’orientamento giurisprudenziale, sia del giudice amministrativo, sia del giudice comunitario[12], che ha argomentato a favore di un criterio soggettivo di imputazione della responsabilità e questo soprattutto dopo l’entrata in vigore del Codice, nel quale, come si diceva, non si trova alcun riferimento alla responsabilità derivante dall’accidentalità della condotta di un soggetto[13]. Pertanto, secondo la tesi della responsabilità soggettiva, per essere il destinatario di un’ordinanza di bonifica sono sempre necessari un’adeguata istruttoria al fine di accertare in concreto la responsabilità della contaminazione[14], gli elementi soggettivi della colpa o del dolo, oltre al nesso di causalità, il quale se considerato da solo risulterebbe insufficiente per poter giustificare l’attribuzione in capo al soggetto responsabile dell’inquinamento degli oneri di bonifica, in un’ottica in cui il criterio di imputazione della responsabilità è quello della colpa. Questa previsione del Codice trova il proprio fondamento nel principio comunitario “chi inquina paga”, oltre che nell’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale soggettiva, attraverso una lettura combinata degli artt. 242 e 311 del Codice[15].
Infatti, l’art. 311 del Codice[16] disciplina l’azione risarcitoria per danno ambientale, la quale prevede una responsabilità di tipo soggettivo e quindi la definizione della colpa. Pare, dunque, difficile immaginare un profilo oggettivo della responsabilità di colui che provochi un inquinamento ambientale, con la conseguenza che sia obbligato ad un intervento di bonifica.
In entrambi i casi si è in presenza di un danno ambientale da cui consegue l’applicazione dell’art. 311 del Codice. Tale lettura determina la necessità di accertare una responsabilità di tipo soggettivo dell’autore dell’inquinamento[17]. La giurisprudenza maggioritaria ha sostenuto questa argomentazione interpretativa da considerarsi oggi in buona parte pacifica. Tuttavia, il tema della natura della responsabilità di cui si tratta appare più complessa di quanto possa far pensare la presenza nel nostro ordinamento di diversi filoni giurisprudenziali, soprattutto se si esaminano le disposizioni contenute nella direttiva 35/2004/CE sulla responsabilità in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale[18].
Le maggiori problematiche derivano dalla circostanza secondo la quale la direttiva citata prevede un regime differenziato di responsabilità per i danni ambientali, sulla base della pericolosità o meno dell’attività professionale dell’operatore.
Innanzi tutto viene menzionato il danno causato da quelle attività che, contenute nell’Allegato III[19], ai sensi del considerando8 della direttiva[20] “presentano un rischio per la salute umana e per l’ambiente”. In tale caso, ai fini dell’imputazione del danno è necessaria e sufficiente la sola presenza del nesso di causalità tra condotta dell’operatore e danno ambientale, emergendo così una responsabilità di tipo oggettivo[21]. Di contro, è necessaria la presenza del dolo o della colpa, oltre al nesso di causalità, nel caso in cui si tratti di attività non contenuta nell’Allegato III, la quale, ai sensi del considerando 9[22], abbia causato un danno “alle specie e agli habitat naturali protetti”, prevedendo in questo caso una responsabilità di tipo soggettivo.
La direttiva citata ha avuto anche su tale questione l’avallo della Corte di Giustizia dell’UE, ad esempio con la sentenza 9 marzo 2008, in causa C-378/08[23], nella quale si evidenziano due profili specifici.
Il primo è inerente alla possibilità di presumere il nesso di causalità nell’imputazione della responsabilità in caso di danneggiamento ambientale[24]. La Corte, nel caso di un inquinamento diffuso come quello oggetto della causa, pur richiedendo la presenza del nesso di causalità, è consapevole della difficoltà per le autorità nazionali di individuarlo con esattezza, e di conseguenza lascia aperta la possibilità per gli Stati membri di presumere siffatto nesso tra l’inquinamento e le attività professionali svolte, seppur nel rispetto di determinate condizioni[25].
Il secondo profilo, invece, riguarda il duplice regime di imputazione della responsabilità in materia di danno ambientale a seconda delle attività professionali svolte dagli operatori[26].
Da quanto fin qui detto, appare chiaro come il quadro generale delineato in materia di responsabilità oggettiva e soggettiva definito a livello comunitario si differenzi in modo significativo dall’approccio al tema delineato sia dal legislatore nazionale, sia dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria[27], dalle quali emerge la necessità di una definizione della responsabilità soggettiva senza alternative o doppi regimi di responsabilità. Infatti, il legislatore nazionale, nel recepire la direttiva citata, si è in buona parte discostato dai criteri di imputazione previsti dalla fonte europea. Sia l’art. 311, sia l’art. 242 del Codice richiedono la necessità di accertare la responsabilità soggettiva, per dolo o per colpa di colui che abbia cagionato l’inquinamento. Tale quadro di mancata corrispondenza tra i due sistemi di responsabilità, proposti a livello europeo e nazionale, ha giustificato l’intervento della Commissione europea che ha più volte censurato le scelte del legislatore nazionale[28]. È solo il caso di ricordare come di recente, nel nostro ordinamento, siano state introdotte alcune innovazioni legislative per garantire un migliore recepimento della direttiva citata, e questo è avvenuto con la l. 6 agosto 2013, n. 97, la cd. Legge europea 2013[29]. Essa, all’art. 25, ha previsto, oltre al tradizionale criterio soggettivo, anche un criterio oggettivo per l’attribuzione della responsabilità[30], adeguando in questo modo il sistema nazionale a quello previsto a livello comunitario[31].
3. La creazione giurisprudenziale di un ossimoro: la responsabilità del proprietario incolpevole.
Quanto detto fin qui deve essere messo in relazione con un ulteriore profilo che riguarda i criteri attraverso i quali si dà luogo all’imputazione della responsabilità in materia di bonifica di suoli inquinati: è il caso della controversa posizione del proprietario o gestore di un’area inquinata, ma allo stesso tempo non responsabile del danno ambientale. Questo è il tema dell’attuale dibattito giurisprudenziale nazionale e ora anche europeo a seguito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia operato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Innanzi tutto si deve partire dall’art. 245, c. 1, del Codice, ai sensi del quale “le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono comunque essere attivate su iniziativa degli interessati non responsabili”. Cosi disponendo il legislatore ha voluto coinvolgere nelle opere di bonifica, in questo caso in un’ottica di oggettivizzazione della tutela ambientale, soggetti diversi dall’effettivo responsabile dell’inquinamento, soggetti che possono essere individuati nel proprietario o nel gestore di un’area, ma potendo anche considerare tutti coloro che non siano responsabili dell’inquinamento, ma che possano avere interesse a verificare le condizioni del sito e quindi in seguito bonificarlo.
In sintesi, poiché siamo in presenza di soggetti che non sono gli autori materiali dell’inquinamento, essi avrebbero la facoltà, ma non l’obbligo di avviare un procedimento di bonifica. Tuttavia, emergono profili di criticità in riferimento al contenuto e ai limiti del livello di coinvolgimento che sono previsti nei confronti del proprietario dell’area in questione.
L’art. 245, c. 2, del Codice, afferma che “fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all’art. 242, il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione della soglia di contaminazione (CSC), deve darne comunicazione alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti, e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all’art. 242”. Pertanto, in capo al proprietario incolpevole, secondo quanto disposto dall’articolo citato, graverebbe un vero e proprio obbligo d’inoltrare alle autorità competenti la prima comunicazione prevista nel procedimento di bonifica, seguìto dalla necessità di adottare le misure di prevenzione. Tutto questo non è da considerare come una facoltà, ma come un vero e proprio obbligo previsto dal Codice, il quale, tuttavia, non ricomprende gli eventuali e ulteriori interventi di messa in sicurezza né di bonifica[32].
A seguito di tale comunicazione del proprietario non colpevole, la provincia dovrà attivarsi al fine di individuare il soggetto responsabile[33]. Ancora all’art. 245, c. 2, del Codice, si afferma che “E’ comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità”. Pertanto, il legislatore, dopo aver previsto un generale dovere di attuazione di misure di prevenzione, ha disposto una mera facoltà per le concrete opere di bonifica. Su quest’ultima previsione del Codice si è sviluppata una giurisprudenza non pacifica in tema di responsabilità del proprietario non colpevole dell’inquinamento, da cui in definitiva prendono le mosse le due ordinanze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato di cui si dirà.
La giurisprudenza maggioritaria nega che gli oneri del proprietario del suolo, privo di qualunque forma di responsabilità dell’inquinamento, possano essere paragonati a quelli che gravano sul soggetto responsabile dell’inquinamento. È soltanto quest’ultimo ad avere un obbligo di bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale[34]. Al proprietario incolpevole dell’area, invece, non possono essere imposti tali oneri per il solo fatto di essere proprietario del bene, escludendo anche la possibilità di richiamare l’istituto della responsabilità civile per le cose in custodia, ex art. 2051 c.c.[35]. Infatti, in capo ad esso, secondo l’interpretazione letterale del Codice, incombe solo la facoltà di eseguire gli interventi sopra citati[36] e una responsabilità diretta del proprietario dell’area potrebbe ipotizzarsi solo nel caso in cui venga accertato un suo coinvolgimento nella realizzazione dell’inquinamento, tornando nella definizione e individuazione di un elemento soggettivo della responsabilità.
Le argomentazioni avanzate dalla giurisprudenza maggioritaria per giustificare siffatta impostazione sono sostenute dal dettato normativo ed è quindi confermato dalla vigenza del criterio soggettivo di imputazione della responsabilità. Tuttavia, deve essere ricordato l’orientamento giurisprudenziale di minoranza, il quale argomenta a favore di una maggiore partecipazione del proprietario incolpevole nell’attività di bonifica.
In particolare, si ricorda la sentenza del TAR Lazio, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263[37], nella quale viene riconosciuto un suo coinvolgimento nella procedura de qua, coinvolgimento che va oltre il rischio di subire le garanzie fino al valore del bene, qualora gli interventi siano stati effettuati dalla pubblica amministrazione[38]. È questa un’argomentazione criticata, la quale se considerata in riferimento alle conclusioni cui giunge il Tar Lazio, mal si concilia con il dato normativo[39]. Tuttavia, pare di poter affermare che le premesse da cui si muove il Tar Lazio appaiono condivisibili. È difficile poter obiettare alle argomentazioni iniziali della sentenza le quali appaiono conformi alla giurisprudenza di maggioranza, ma soprattutto con il quadro legislativo di riferimenti. Infatti, al punto 6 della sentenza citata viene stabilito che gli obblighi che gravano sul responsabile dell’inquinamento non coincidono con quelli che incombono sul proprietario e che è inoltre fatta ricadere sull’autore dell’inquinamento la responsabilità da illecito con i consequenziali obblighi di intervento, di bonifica e di ripristino[40]. Ancora viene affermato che il proprietario non responsabile non è immune da ogni coinvolgimento in siffatte procedure e questo è evidentemente riconducibile all’obbligo di realizzare misure di prevenzione, così come alla facoltà di intraprendere il procedimento di bonifica e ancora al fatto che su di esso, qualora il responsabile non sia individuato, gravano i costi connessi all’esistenza dell’onere reale[41]. Tutte queste sono da considerare argomentazioni introduttive in linea di massima accettate dalla giurisprudenza e soprattutto previste dalle norme vigenti.
Tuttavia, a partire dal capo 7 della sentenza si assiste ad un’argomentazione del TAR Lazio e ad una conclusione non più condivisibile. Infatti, sostenendo quella che viene chiamata “responsabilità da posizione” di tipo oggettivo del proprietario incolpevole, il giudice di primo grado afferma che “il proprietario dell’immobile, pur incolpevole, non è immune da ogni coinvolgimento nella procedura relativa ai siti contaminati, essendo il soggetto al quale, pur senza una propria responsabilità, vengono poste a carico le obbligazioni conseguenti l’inquinamento (e ciò solo perché proprietario). Pertanto ben può lo stesso essere reso destinatario di un obbligo di attuare i necessari interventi, salva successiva rivalsa nei confronti del responsabile”[42].
In sintesi, il TAR citato individua il proprietario incolpevole come il destinatario di un obbligo di dare attuazione agli interventi di bonifica in sostituzione del responsabile dell’inquinamento e questo alla luce delle obbligazioni risarcitorie che graverebbero sul proprietario dell’area in virtù dell’onere reale. In questo modo la titolarità delle obbligazioni risarcitorie realizzerebbe anche l’attribuzione, se pur provvisoria, delle obbligazioni ripristinatorie[43]. Probabilmente tale soluzione (mal) celerebbe l’esigenza di semplificazione dell’intera procedura e forse ancor di più l’inadeguatezza, soprattutto economica, delle amministrazioni nell’attività di ripristino.
Una posizione in parte simile la si può trovare in una giurisprudenza in cui si è radicata l’idea che il proprietario incolpevole sia sempre obbligato ad intervenire nelle opere di bonifica[44], e questo anche per la sola necessità di conclusione delle opere di bonifica, una volta avviato il relativo procedimento[45]. Tuttavia, bisogna considerare che l’interpretazione del tema in questione contenuta nella sentenza del TAR Lazio citata, sotto diversi aspetti contrasti con il dato normativo, forzando soprattutto quanto statuito dagli artt. 244, c. 4, e 252, c. 5, del Codice, dai quali emerge chiaramente come sia esclusa l’obbligatorietà di eseguire direttamene la bonifica in capo al proprietario incolpevole[46].
In sintesi, quindi, si possono avanzare alcune considerazioni di carattere generale sul tema de quo.
Innanzitutto, nel rispetto del principio comunitario, e quindi costituzionale ai sensi dell’art. 117, c. 1, Cost., del “chi inquina paga”, dovrebbe essere sostenuto senza alcun dubbio interpretativo che le misure di bonifica ambientale siano a carico del soggetto direttamente responsabile dell’inquinamento. È, quindi, necessario che le amministrazioni, prima d’imporre tali misure di riparazione, verifichino chi sia il soggetto direttamente coinvolto e di conseguenza solo in capo a quest’ultimo dovrebbero essere posti gli oneri di bonifica. Il proprietario di un’area inquinata, ma non responsabile di avere cagionato tale contaminazione, non potrebbe/dovrebbe, solo perché proprietario, avere tale onore, ancor più se il soggetto in questione è un operatore economico per il quale l’onere di bonifica, soprattutto se ingente, avrebbe un impatto significativo sulla propria attività. Invece, nel caso in cui il responsabile dell’inquinamento ambientale non venga individuato o decida di non dare corso agli interventi di bonifica, le opere necessarie devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione. Quest’ultima, tuttavia, una volta bonificata l’area, secondo le disposizioni del Codice, non può farsi carico delle spese sostenute e conseguentemente esse vengono a gravare sul responsabile o, nel caso in cui non provveda o non sia individuabile, sul proprietario dell’area. In questo secondo caso, dunque, egli è tenuto a sostenere siffatti costi in ragione dell’esistenza dell’onere reale presente sul sito e sul quale si tornerà in seguito[47].
4. Le ordinanze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e il rinvio alla Corte di Giustizia UE.
La questione degli obblighi gravanti sul proprietario di un sito, non colpevole dell’inquinamento, è ormai da anni oggetto di un dibattito giurisprudenziale particolarmente inteso. La necessità di tutelare la posizione del soggetto in questione acquista un significato nella circostanza in cui l’autore del danneggiamento ambientale non sia individuabile e tale situazione ha reso necessario un intervento interpretativo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, così che si possa chiarire, in via definitiva, come il principio “chi inquina paga” si relazioni con la posizione giuridica del proprietario incolpevole[48].
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è occupata più volte di tale questione e per il rilievo che ha assunto e soprattutto per il fatto che è stato richiesto in via pregiudiziale una pronuncia della Corte di Giustizia UE, esse meritano di essere brevemente esaminate.
Innanzi tutto si segnala l’ordinanza del 25 settembre 2013, n. 21, resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato a seguito della remissione effettuata da quest’ultimo in Sez. VI nel maggio dello stesso anno[49]. Nell’ordinanza in questione il giudice d’appello si è espresso a favore della giurisprudenza maggioritaria sul tema, sostenendo che “sulla base del quadro normativo nazionale vigente, l’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica (…) in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 in tema di onere reale e privilegio speciale immobiliare”[50]. Di queste deve farsi carico l’Amministrazione[51]. Pertanto, l’Adunanza Plenaria nell’ordinanza citata conferma che il proprietario di un’area contaminata, non essendo obbligato ad attuare la bonifica e nemmeno le misure di messa in sicurezza d’emergenza, possa tuttavia decidere di porle in essere volontariamente. Inoltre, si osserva che “è il responsabile dell’inquinamento il soggetto su cui gravano, ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione (…). Il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere, che riguarda però soltanto l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’art. 242”[52].
L’unico obbligo previsto in capo a questo soggetto è contenuto all’art. 245, c. 2, del Codice in cui si statuisce il dovere di attuare le misure di prevenzione al momento della scoperta di una contaminazione[53]. Il Consiglio di Stato, pur nella consapevolezza di aver sostenuto la posizione della giurisprudenza maggioritaria[54], ha comunque deciso di rinviare la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per valutare in via pregiudiziale se l’impianto normativo in materia di bonifiche così interpretato sia in linea con quanto disposto a livello comunitario[55].
Le ragioni alla base di questa scelta sono sintetizzate nell’ordinanza stessa, là dove l’Adunanza plenaria espone i motivi che l’hanno indotta ad interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione. Sussistono dubbi di compatibilità essenzialmente tra il quadro legislativo nazionale e i princìpi di derivazione comunitaria, quali il principio del “chi inquina paga”[56], il principio di prevenzione e di precauzione[57], ed infine quello della correzione, in via prioritaria alla fonte[58]. Infatti, dalle norme nazionali si evince che il proprietario incolpevole assume una mera responsabilità patrimoniale, limitata al valore del sito a seguito degli interventi di bonifica, senza che venga disposto un obbligo di attuare le misure di riparazione, facendo gravare tali oneri sull’amministrazione[59]. Tuttavia, in merito a tali dubbi di compatibilità, l’Adunanza Plenaria, anche sulla base delle motivazioni prima citate, non pare avanzare un cambio di orientamento sul tema de quo[60]. Infatti, sostiene nuovamente la precedente linea interpretativa, considerando che l’assetto normativo nazionale e quello comunitario, in materia di responsabilità, non presentano particolari incompatibilità[61].
È opportuno ricordare, tuttavia, come il Consiglio di Stato si sia nuovamente trovato a dovere decidere sulla legittimità dell’ordine imposto al proprietario dell’area inquinata ad eseguire gli interventi di bonifica. Così, il giudice amministrativo, nel giugno del 2013, ha deciso di rimettere nuovamente la medesima questione[62] all’Adunanza Plenaria, la quale, a seguito di un’articolata e complessa analisi della problematica, ha emanato l’ordinanza del 13 novembre 2013, n. 25[63]. Trattandosi della medesima questione affrontata già in precedenza, anche in quest’ultimo provvedimento le argomentazioni dell’Adunanza Plenaria sono state le medesime. Innanzi tutto, l’Adunanza Plenaria si è occupata di dirimere la questione se, in base al principio del “chi inquina paga”, l’amministrazione possa imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche autore della contaminazione, l’obbligo di porre in essere misure di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, ovvero, se in tali circostanze, i doveri previsti in capo a tale soggetto si limitino solo a ciò che è previsto dall’art. 253 del Codice in materia di onere reale e privilegio speciale[64].
Sul punto l’Adunanza plenaria ripercorre i due orientamenti emersi nel nostro ordinamento e individua le principali argomentazioni. Il primo di essi, di certo minoritario, è favorevole alla possibilità d’imporre l’esecuzione delle suddette misure[65], argomentando sulla valorizzazione del dato normativo sul coinvolgimento del proprietario nell’adozione delle misure di cui agli artt. 240 ss. del Codice, su una lettura dei princìpi comunitari di precauzione e dell’azione preventiva tale che le conseguenze dell’inquinamento non ricadano sulla collettività e ancora sulla sussistenza di precisi doveri di custodia a carico del proprietario dell’area indipendentemente dal suo coinvolgimento nella contaminazione[66].
Seguendo, invece, la possibile seconda interpretazione, è da escludere la possibilità di prevedere in capo ai proprietari incolpevoli dell’area inquinata obblighi di adozione delle misure di sicurezza e bonifica[67]. Si tratta, come si è già detto, della tesi accolta anche dall’Adunanza Plenaria, nel momento in cui afferma che “da questo rapido excursus giurisprudenziale emerge, quindi, come l’orientamento interpretativo di gran lunga prevalente escluda la possibilità per la Pubblica Amministrazione nazionaled’imporre al proprietario non responsabile della contaminazione misure di messa in sicurezza d’emergenza o di bonifica del sito inquinato (…) e a tale indirizzo questa Adunanza plenaria ritiene di dover dare continuità, in quanto esso, alla luce delle considerazioni già svolte, esprime l’unica interpretazione compatibile con il tenore letterale delle disposizioni in esame”[68].
L’argomentazione sul punto dell’Adunanza Plenaria è articolata e in sintesi si può affermare che: “1) il proprietario, ai sensi dell’art. 245, c. 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, c. 1, lett. 1); 2) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento (art. 244, c. 2); 3) se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati dalla pubblica amministrazione competente (art. 244, c. 4); 4) le spese sostenute per effettuare tali interventi potranno essere recuperate, sulla base di un motivato provvedimento, agendo piuttosto in rivalsa verso il proprietario, che risponderà nei limiti del valore di mercato del sito a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, c. 4); 5) a garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato di un onere reale e di un privilegio speciale immobiliare (art. 253, comma 2)”[69].
Inoltre, l’Adunanza plenaria pone a fondamento della sua tesi anche una particolare argomentazione relativa alla natura e ai caratteri dell’onere reale, dalla quale emerge come nei confronti del proprietario incolpevole sia prevista la sola facoltà di intervenire nelle procedure di bonifica[70]. A questo punto l’Adunanza plenaria, come è accaduto nella precedente ordinanza n. 21/2013, affronta il problema della compatibilità tra il quadro legislativo nazionale e i principi dell’ordinamento comunitario. Quanto delineato dall’Adunanza plenaria del 2013 è tale per cui la collettività sia onerata di provvedere, attraverso l’intervento della pubblica amministrazione, all’esecuzione delle misure di bonifica. Si tratta di valutare la compatibilità tra i principi comunitari richiamati anche in precedenza, finalizzati alla promozione di un elevato livello di protezione ambientale e il quadro appena delineato[71]. Questo, infatti, esclude il coinvolgimento pieno del proprietario incolpevole, sul quale incombe solo l’obbligo di adottare le misure di prevenzione e assume una mera responsabilità patrimoniale, limitata al valore del sito dopo gli interventi di bonifica, escludendo in questo modo l’obbligo di porre in essere misure di riparazione, mentre tali costi verrebbero a gravare sulla collettività in generale.
L’Adunanza Plenaria, pur ritenendo i due quadri normativi compatibili[72], ha deciso ugualmente di richiedere l’intervento interpretativo della Corte di Giustizia[73], soprattutto perché “la questione pregiudiziale è certamente rilevante nel presente giudizio, in cui si discute proprio della legittimità dei provvedimenti con cui l’autorità amministrativa ha ordinato la messa in sicurezza d’emergenza e lapresentazione di un progetto di variante di bonifica agli attuali proprietari dei siti inquinati, che risultano, pacificamente, non responsabili dell’inquinamento: la soluzione della questione pregiudiziale è, quindi, in grado di condizionare sensibilmente l’esito del giudizio”[74].
5. La sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. III, n. 534/13. Considerazioni conclusive.
Sulla conformità della normativa nazionale italiana che non prevede la possibilità per la pubblica amministrazione di imporre ai proprietari di terreni inquinati che non abbiano contribuito a tale inquinamento l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione è intervenuta, infine, la Corte di Giustizia UE, Sez. III, 4 marzo 2015, in causa C-534/13[75].
La Corte si è pronuncia a seguito operato dal rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato con l’ordinanza 8 luglio 2013[76].
La Corte, in linea con quanto proposto dall’avvocato generale Juliane Kokott nelle sue conclusioni, dichiara che “la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi”.
Quindi, in sintesi, secondo quanto previsto dall’art. 242 del Codice, il soggetto obbligato in via principale, in applicazione del principio del “chi inquina paga”, è il responsabile dell’inquinamento, mentre ai sensi dell’art. 250 del Codice il soggetto obbligato in via secondaria è la pubblica amministrazione. Inoltre, in caso d’intervento d’ufficio, l’art. 253 del Codice consente alla pubblica amministrazione di rivalersi sul bene bonificato dei costi sostenuti per le operazioni di bonifica, anche se tale attività di rivalsa non solo non è automatica, in quanto subordinata a diversi adempimenti, ma non garantisce neppure l’effettivo e integrale ristoro dei costi sostenuti nel caso in cui l’area valga meno dei costi di bonifica.
La scelta del legislatore, avallata dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria e ora anche da quella europea, è in parte da condividere perché si ritiene che nel caso in cui il responsabile dell’inquinamento di un sito non provveda alle operazioni di bonifica o non sia individuabile, e non provveda altresì in modo volontario il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi dovranno essere predisposti dalla pubblica amministrazione. Ad esempio, attraverso un adeguato intervento del cd. Fondo di rotazione vincolato alle bonifiche di siti inquinati[77], le bonifiche dovrebbero essere effettuate non tanto dai comuni, anche per un profilo di adeguatezza[78], quanto piuttosto dal Ministero dell’Ambiente, il quale potrà avvalersi a tal fine dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, delle regioni interessate e dell’Istituto superiore di sanità[79]. Difatti, si ritiene che il conto sociale della bonifica non possa ricadere sul proprietario incolpevole perché essere responsabile e allo stesso tempo incolpevole è una contraddizione in termini.
Si verifica, così, alla luce delle disposizioni del Codice, un arretramento delle regole della responsabilità e una non condivisibile fuzionalizzazione della proprietà privata in chiave ripristinatoria.
La funzione sociale della proprietà, ex art. 42 Cost., nella disciplina della bonifica dei siti inquinati, diventa il rimedio volto a garantire una effettiva tutela ambientale, giacché le regole della responsabilità non garantiscono l’individuazione dell’effettivo responsabile della contaminazione in base a parametri soggettivi. Invece, si ritiene che tale conto sociale debba ricadere sulla pubblica amministrazione, e quindi evidentemente sulla collettività, quanto meno sotto il profilo della culpa in vigilando, se di responsabilità oggettiva si deve parlare, considerando i poteri di controllo e di monitoraggio in possesso della pubblica amministrazione, in applicazione dei princìpi di prevenzione e di precauzione[80] e che evidentemente non sono stati adeguatamente esercitati se si è realizzato un inquinamento (si pensi agli artt. 28 e 29 del Codice, in tema di VIA, ovvero al ruolo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, art. 29 decies del Codice, in tema di AIA).
Allo stesso tempo suscita qualche perplessità la previsione del Codice di un’obbligazione gravante sulla res, il sito contaminato, (l’ordine di bonifica non è una misura sanzionatoria, ma è un atto ablativo) e che avrà come conseguenza che il proprietario incolpevole e subentrante, titolare del diritto reale sul bene immobile onerato, sarà destinatario di obblighi di dare e di facere connessi alla garanzia reale che grava sul fondo. Inoltre, la scelta del proprietario incolpevole di procedere alla bonifica del sito contaminato si configura spesso come una scelta obbligata (ulteriore contraddizione in termini) da preferire alle conseguenze dell’iscrizione dei vincoli che conseguiranno sul sito qualora l’amministrazione procedesse d’ufficio[81]. Da qui segue il profilo di criticità nei confronti dell’opportunità di addossare esclusivamente sul proprietario non responsabile i costi per la salvaguardia dell’interesse sociale alla tutela dell’ambiente, cui l’onere reale è preposto. Tale onere, così come proposto dal Codice fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., ma anche in relazione al principio comunitario del “chi inquina paga”, il quale imporrebbe al soggetto che fa correre un rischio d’inquinamento di sostenere i costi della prevenzione e della riparazione, e, a danno avvenuto, si dovrebbero far ricadere i medesimi costi su chi avrebbe dovuto vigilare. Parte della dottrina, per superare tali dubbi, ha proposto d’inquadrare l’onere reale come un semplice contributo alla miglioria del sito contaminato, individuabile non tanto nel valore complessivamente del fondo, quanto unicamente nell’incremento di valore di quest’ultimo, direttamente connesso all’avvenuta bonifica. L’iscrizione dell’onere reale sul fondo del proprietario incolpevole varrebbe così a giustificarsi come un recupero dei costi d’intervento da parte della pubblica amministrazione, nell’alveo di un’azione d’ingiustificato arricchimento promossa da quest’ultima nei confronti del proprietario del sito e non responsabile della contaminazione[82].
Tale ricostruzione se in parte cerca di superare i dubbi sulla natura giuridica dell’onere reale, allo stesso tempo pare non considerare una valutazione comparativa costi-benefici delle diverse soluzioni adottabili, a seguito di un’adeguata istruttoria[83], nonché la reale posizione del proprietario incolpevole, ovviamente privo di dolo o di colpa, e il danno che gli può derivare se obbligato a sopportare i costi della bonifica, soprattutto se si tratta di un operatore economico qualificato. Quest’ultimo avrà avuto innanzi tutto un danno economico perché di certo avrà acquistato il sito, poi scoperto inquinato, ad un prezzo di mercato probabilmente superiore al suo reale valore e, in secondo luogo, avrà un danno economico perché dovrà affrontare un costo di bonifica non preventivato con inevitabili ricadute sulla propria attività e con inevitabili conseguenze di tipo sociale e occupazionale. Si deve, infatti, sottolineare come il principio “chi inquina paga” opera innanzi tutto in una logica preventiva dei fatti dannosi e in secondo luogo in una logica risarcitoria ex post factum, in quanto viene imposto alle imprese l’obiettivo prioritario di internalizzare i costi di alterazione dell’ambiente attraverso l’incorporazione nei prezzi delle merci; tuttavia, tale operazione, di certo legata al rischio d’impresa[84] e in una logica di responsabilità sociale dell’impresa, deve essere ricondotta ad un’attività di impresa svolta da un operatore economico che si assume la responsabilità diretta del proprio agire, mentre il proprietario incolpevole non potrà mai rispondere per fatti altrui e quindi non potrà internalizzare nei prezzi delle proprie merci[85], da cui segue il danno economico, i costi per la bonifica di un inquinamento di cui non sia colpevole e di cui non abbia nemmeno la conoscenza. Si deve, quindi, attribuire una forma di responsabilità all’operatore economico, chiamato ad una “co-gestione” del rischio[86], ma attraverso obblighi precisi che incombono su chi svolga attività di impresa. Si parla, quindi, della necessità di valutazione e di minimizzazione del rischio, della conoscenza delle migliori tecnologie disponibili, della gestione delle nuove informazioni scientifiche, dell’adozione di misure precauzionali d’urgenza e della permanente interazione con l’amministrazione. Dalla violazione di tali obblighi di risultato, manifestazione dei princìpi giuridicamente vincolati come proporzionalità, buona fede e precauzione[87], deriverebbe una responsabilità penale, amministrativa e civile. Di certo si deve parlare di “co-gestione” del rischio tra chi svolge attività d’impresa, l’operatore economico, e chi deve controllarla, l’amministrazione, escludendo obblighi in capo ad un nuovo proprietario incolpevole, i cui obblighi di co-gestione varranno per il futuro.
Quindi, in definitiva, in mancanza dell’individuazione del responsabile dell’inquinamento, l’imposizione dei costi di bonifica alla pubblica amministrazione senza rivalsa sul proprietario incolpevole, rappresenta, a giudizio di chi scrive, il miglior bilanciamento dei valori sanciti dalla Costituzione[88]: la proprietà privata (art. 42 Cost.), la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), la salute umana (art. 32 Cost.) e la tutela dell’ambiente (art. 117 Cost.). Il bilanciamento trova il suo equilibro nel rispetto della centralità della persona (art. 2 Cost.) che di volta in volta individua l’interesse prevalente e nel principio di legalità, ai sensi del quale, come sostenuto condivisibilmente in dottrina[89], non si può formulare un giudizio di preferibilità di valori che conduca a fare prevalere sulla tutela del patrimonio privato l’interesse pubblico sotteso alla misura ablatoria tesa ad aggredirlo, ove la possibilità astratta di quell’aggressione non sia a priori chiaramente scritta in una disposizione di legge che ne prefiguri l’attuabilità.
In un quadro più ampio che si è voluto illustrare per una maggiore chiarezza della questione ambientale, in tema di responsabilità per danno ambientale, in definitiva le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3077/2023 hanno affermato, mettendo un ulteriore punto fermo nella nota vicenda, che “l’Amministrazione non può imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di realizzare le misure di messa in sicurezza di emergenza e bonifica, di cui all’art. 240, c. 1, lett. m) e p), cod. amb., in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole restano limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253, in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare, tale essendo la netta distinzione tra la figura del responsabile dell’inquinamento e quella del proprietario del sito, che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione; così che, come ancora ribadito, il proprietario ‘non responsabile’ dell’inquinamento è tenuto, ai sensi dell’art. 245, c. 2, ad adottare le misure di prevenzione di cui all’art. 240, c. 1, lett. i), ma non le misure di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica di cui alle lett. m) e p)”.
[1] In tema di responsabilità per la bonifica dei siti inquinati, in dottrina, si veda F. Grassi, Bonifica ambientale di siti contaminati, in Diritto dell’ambiente, a cura di, G. Rossi, Torino, 2015, 424 ss.; R. Agnoletto, I settori delle discipline ambientali, in Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da, R. Ferrara, M.A. Sandulli, Milano, Vol. I, 2014, 443 ss.; S. Grassi, La bonifica dei siti contaminati, ivi, 687 ss.; G. Acquarone, L’accertamento del danno ambientale, ivi, Vol. II, 371; A. Sacchi, Profili civilistici, in E. Picozza, P. Dell’Anno, Trattato di diritto dell’ambiente. Principi generali, Vol. I, Padova, 2012, 331 ss.; R. Invernizzi, Inquinamenti risalenti, ordini di bonifica e principio di legalità CEDU: tutto per l’“ambiente”?, in Urb. app., 2014, 8-9, 967 ss.; L. Costato, F. Pellizer, Commentario breve al codice dell’ambiente: d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Padova, 2012, 239-254; V. Corriero, La “responsabilità” del proprietario del sito inquinato, in Resp. civ. e prev., 2011, 2440 ss.; P.M. Vipiana Perpetua, L’istruttoria nei procedimenti di bonifica dei siti inquinati, in Urb. app., 2010, 1133 ss.; V. Cingano, Profili procedimentali nella bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale: tra disciplina generale e disciplina di settore, in Foro amm.-TAR, 2010, 7-8, 2365 ss.; R.F. Iannone, L’azione di bonifica non grava sul proprietario incolpevole del sito contaminato, in Riv. giur. amb., 2010, 2, 379 ss.; E. Pomini, L’onere reale nella bonifica dei siti contaminati, in Riv. giur. amb., 2010, 6, 1015 ss.; A. Carapellucci, “Chi inquina paga”: il punto su responsabilità dell’inquinatore e proprietario incolpevole nella bonifica dei siti inquinati, in Resp. civ. e prev., 2010, 9, 1885 ss.; A.L. De Cesaris, Bonifica dei siti inquinati, in Codice dell’ambiente, a cura di, A.L. De Cesaris, S. Nespor, Milano, 2009, Agg. 2011, 669 ss.; F. Ferrara, La bonifica dei siti inquinati, in Aa.Vv., Studi sul codice dell’ambiente, Torino, 2009, 344 ss.; S. Baiona, Nessuna responsabilità oggettiva in capo al proprietario “incolpevole” per l’abbandono di rifiuti sul fondo di sua proprietà, in Riv. giur. amb., 2009, 10, 2127; D. Dima, Bonifica dei siti inquinati: criteri di imputazione e mezzi di accertamento della responsabilità, in Urb. app., 2009, 11 ss.; L. Prati, La giurisprudenza in tema di bonifiche dopo il d.lgs. n. 152/2006, in Riv. giur. amb., 2008, 838 ss.; M. Lottini, Bonifica di siti inquinati da fanghi di risulta della depurazione delle acque reflue urbane: tra potere di ordinanza extra ordinem e principio di prevenzione, in Foro amm.-TAR, 2007, 4, 1444 ss.; F. de Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio, Milano, 2005, passim; A. Amoroso, Nuovi rilievi sull’attività volta all’accertamento della responsabilità dell’inquinamento del sito, in Riv. giur. amb., 2006, 6, 318 ss.; F. Goisis, La natura dell'ordine di bonifica e ripristino ambientale exart. 17 d.lgs. n. 22 del 1997: la sua retroattività e la posizione del proprietario non responsabile della contaminazione, in Foro amm.-C.d.S., 2004, n. 2, 567 ss.; A.L. De Cesaris, La responsabilità per inquinamento e la “posizione di garanzia” nella normativa sulla bonifica dei siti contaminati, in Riv. giur. amb., 2003, 159 ss.; P. Carpentieri, Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, in Ambiente, 2002, 9 ss.; C. Viviani, Bonifica dei siti contaminati e danno ambientale, in P.M. Vipiana, C. Videtta, a cura di, La bonifica dei siti inquinanti: aspetti problematici, Padova, 2002, passim; G. Manfredi, La bonifica dei siti inquinati tra sanzioni, misure ripristinatorie e risarcimento del danno all'ambiente, in Riv. giur. amb.,2002, 5, 667 ss.; F. Giampietro, Danno all’ambiente e bonifica dei siti inquinati: due discipline a confronto, in Riv. giur. amb., 2002, 649; A.L. De Cesaris, La disciplina per la bonifica e il ripristino dei siti contaminati, in Riv. giur. amb., 2002, 355, ss.; R. Lombardi, Il problema dell’individuazione dei soggetti coinvolti nell’attività di bonifica dei siti contaminati, in P.M. Vipiana Perpetua, a cura di, La bonifica dei siti inquinati: aspetti problematici, Padova, 2002, 111 ss.; L. Prati, Il danno da inquinamento e la disciplina delle bonifiche: l’aspetto della responsabilità civile, in B. Pozzo, a cura di, La nuova responsabilità civile per danno all’ambiente. Le problematiche italiane alla luce delle iniziative dell’Unione europea, Milano, 2002, 147 ss.; M. Santoloci, La responsabilità soggettiva del proprietario del terreno per la bonifica dei siti inquinati, in Dir. giur. agr., 2001, 742 ss..
[2] Il principio “chi inquina paga” è frutto di una elaborazione comunitaria, sia legislativa, sia giurisprudenziale.
Prima di essere inserito nell’art. 191 del TFUE, il principio in esame è stato definito, nel corso degli anni ’70, in alcune direttive, in particolare in tema di rifiuti, per poi trovare un’ampia applicazione in altre fonti del diritto derivato. Si pensi alla direttiva 442/75/CEE, la direttiva quadro in materia di rifiuti, alla direttiva 62/94/CEE, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, alla direttiva 59/91/CEE sui rifiuti pericolosi ovvero ancora alla direttiva 53/2000/CEE sui veicoli fuori uso. In tempi più recenti, il principio “chi inquina paga” ha trovato applicazione nella direttiva sui rifiuti 2008/98/CE e in quella sulla responsabilità ambientale 2004/35/CE.
Allo stesso tempo, il principio “chi inquina paga” è stato oggetto di applicazione da parte della giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, ad esempio, si è occupata di tale principio nella sentenza 29 aprile 1999, in causa C-293/97 (Standley, in Racc., I, 2603), sull’interpretazione della direttiva 676/91/CEE, sulla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle aziende agricole. In tale occasione, la Corte ha statuito che in riferimento al principio del “chi inquina paga”, la direttiva oggetto del proprio esame non comportava che gli esercenti di aziende agricole dovessero assumere a proprio carico oneri riguardanti l’eliminazione di un inquinamento ad essi non attribuibile.
Ancora, la Corte, con la sentenza del 7 settembre 2004, in causa C-1/03 (Van De Walle, in Racc., I, 7613), a proposito della direttiva sui rifiuti 75/442/CEE, ha sottolineato come tale direttiva “distingue la materiale realizzazione delle operazioni di recupero o smaltimento che essa pone a carico di ogni ‘detentore di rifiuti’, indipendentemente da chi sia il produttore o il possessore degli stessi – dall’assunzione dell’onere finanziario relativo alle suddette operazioni, che la medesima direttiva accolla , in conformità al principio ‘chi inquina paga’, ai soggetti che sono all’origine dei rifiuti, a prescindere se costoro siano detentori o precedenti detentori dei rifiuti oppure fabbricanti del prodotto che ha generato i rifiuti”.
Da ultimo, negli stessi termini, v. Corte di Giustizia UE, Sez. II, 11 settembre 2014, n. 525, C. Bonichot c. Repubblica federale di Germania, in Foro amm., 2014, 9, 2206; Id., 9 marzo 2010, n. 378, Soc. ERM e altri c. Ministero dello sviluppo economico, in Riv. it. dir. pub. com., 2010, 1591; Id., 24 giugno 2008, in causa C-188/07, Erika, in Racc., I, 4501.
Sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia, v. M. Clément, Droit européen de l’environnement. Jurisprudence commentée, Bruxelles, 2010, 77 ss..
Per uno studio dei princìpi europei in materia ambientale, v. M. Renna, Ambiente e territorio nell’ordinamento europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2009, 649 ss.; Id., I principi in materia di tutela ambientale, in www.rqda, 1-2/2012.
Sul principio “chi inquina paga”, in dottrina si rinvia a D. Amirante, Profili di diritto costituzionale dell’ambiente, in E. Picozza, P. Dell’Anno, a cura di, Trattato di diritto dell’ambiente, cit., 233 ss.; M. Montini, Evoluzione, principi e fonti del diritto internazionale dell’ambiente, ivi, 33 ss.; R. Rota, Profili di diritto comunitario dell’ambiente, ivi, 151 ss.; O. Porchia, Le politiche dell’Unione europea in materia ambientale, in Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da, R. Ferrara, M.A. Sandulli, cit., 171 ss., e bibliografia e giurisprudenza ivi citata; A. Giuffrida, a cura di, Diritto europeo dell’ambiente, Torino, 2012, passim; F. Goisis, Caratteri e rilevanza del principio comunitario “chi inquina paga” nell’ordinamento nazionale, in Foro amm.-C.d.S., 2009, 2724 ss.; D. Ponte, L’affermazione “chi inquina paga” recepisce un principio comunitario, in Guida al diritto, 2008, 3, 149 ss.; A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, Bari-Roma, 2008, 47 ss.; M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come sistema, complesso, adattivo, comune, Torino, 2007, 238 ss.; P. Dell’Anno, Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, Milano, 2004, 79 ss.; Id., Principi fondamentali della tutela dell’ambiente tra normativa europea e legislazione nazionale, in Dir. e giur. agr., 2006, 281 ss.; R. Ferrara, I principi comunitari della tutela dell’ambiente, in La tutela dell’ambiente, a cura di, R. Ferrara, Torino, 2006, 13 ss.; M. Cecchetti, I principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, 2000; M. Meli, Il principio comunitario “chi inquina paga”, Milano, 1996.
[3] Dalla lettura del d.lgs. n. 22/1997 emergeva una responsabilità di tipo oggettivo. All’art. 117 si affermava che “chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti , ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere”. L’espressione anche in maniera accidentale conduce ad una responsabilità di chi inquina in modo oggettivo.
[4] Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.
[5] Sulla responsabilità per danno ambientale come ipotesi di responsabilità oggettiva, cfr. A. Sacchi, Profili civilistici, cit., 331 ss.; M.P. Giracca, Danno ambientale, in Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da, R. Ferrara, M.A. Sandulli, cit., 591, in cui si osserva che a differenza dell’art. 18, l. n. 349/1986, ove il criterio di imputazione della responsabilità era soggettivo (qualunque fatto doloso o colposo) e si richiedeva un danno effettivo (alterazione, distruzione e deterioramento), la disciplina concernente la bonifica dei siti contaminati di cui all’art. 117, d.lgs. n. 22/1997 era fondata su un criterio di responsabilità oggettiva e poteva applicarsi anche in assenza di danno, ossia per la sola presenza di un “pericolo di danno”, con funzione chiaramente preventiva.
[6] A titolo esemplificativo, v. Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4561, in Riv. giur. amb., 2011, 515 ss., con nota di F. Castoldi, La responsabilità dei soggetti coinvolti nelle operazioni di bonifica.
L’A. osserva che, con tale sentenza, il giudice amministrativo sottolinea il fatto che l’inquinatore sarebbe destinatario di una responsabilità oggettiva, cui consegue l’obbligo di effettuare tutte le operazioni di bonifica, a prescindere dalla verifica della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo al soggetto in questione. La responsabilità dell’autore dell’inquinamento, ai sensi dell’art. 17, c. 2, d.lgs. n. 22/1997, costituisce una forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale, desumibile dal fatto che l’obbligo di effettuare gli interventi sorge in connessione con una condotta “anche accidentale”, ossia a prescindere dall’esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo in capo all’autore dell’inquinamento, fatto salvo il rapporto di causalità tra l’azione (o l’omissione) dell’autore dell’inquinamento e il superamento dei valori di contaminazione.
In giurisprudenza, a sostegno della responsabilità oggettiva, v. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 13 aprile 2011, n. 664; TAR Piemonte, Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 136; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 14 gennaio 2011, n. 57; Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 6055; TAR Liguria, Sez. I, 21 novembre 2005, n. 1494; TAR Liguria, Sez. I, 10 febbraio 2004, n. 141, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
[7] Sul punto si veda, V. Cingano, Bonifica e responsabilità per danno all’ambiente nel diritto amministrativo, cit., 138 ss..
[8] In questi termini, v. TAR Abruzzo, Sez. I, 30 aprile 2014, n. 204, nota di R. Invernizzi, cit.; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 2 novembre 2011, n. 1901, in Dir. e giur. agr., 2012, 5, 358; TAR Piemonte, Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 136, in Riv. giur. amb., 2011, 5, 659; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263, in Foro amm.-TAR, 2011, 3, 832, nota di V. Cingano; TAR Toscana, Sez. II, 22 giugno 2010, n. 2035, in Riv. giur. amb., 2011, 3-4, 536, nota di F. Vanetti.
[9] A.L. De Cesaris, cit., 684 ss., osserva che “se la tesi della condotta dolosa o colposa dell’inquinatore dovesse essere confermata dalla giurisprudenza, ci si troverebbe di fronte ad un arretramento della tutela: l’operatore assoggettato ad una regola di responsabilità oggettiva è certamente incentivato a tener maggiormente conto degli effetti negativi sulla collettività, in termini di rischio d’incidente, della propria attività”.
Ancora parte della giurisprudenza sostiene la responsabilità oggettiva del proprietario incolpevole.
Si veda TAR Campana, Napoli, 4 dicembre 2013, n. 5552, in Foro amm., 2013, 12, 3805, in cui si afferma che “l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco impone al proprietario di un’area di bonificarla dalla situazione di degrado, attinente alla salute pubblica, non ha carattere sanzionatorio, di tal ché non è dipendente dall’individuazione di responsabilità del proprietario in relazione alla situazione inquinante, ma solo ripristinatorio, per essere diretta esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo e prevenire danni alla salute pubblica. Ne consegue che l’ordinanza è legittimamente indirizzata al proprietario dell’area, cioè a chi si trova con questa in un rapporto tale da consentigli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché tale situazione potrebbe non essergli imputata”.
[10] Allegato 4, Parte IV del Codice: “Il presente allegato riporta le procedure amministrative e tecnico operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle CSC per i siti di ridotte dimensioni oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte”.
[11] Sul punto si rinvia a V. Cingano, Oneri istruttori di regioni ed enti locali nei procedimenti per la bonifica di siti inquinati, in Quad. Reg., 2011, 491 ss..
[12] Ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 56, in Foro amm.-C.d.S., 2013, 1, 213, in cui si afferma che “nell’ipotesi in cui il responsabile dell’inquinamento non esegua gli interventi di bonifica ambientale o lo stesso non sia individuabile da parte dell’Amministrazione pubblica, le opere di bonifica ambientale devono essere eseguite dalla Pubblica Amministrazione competente che ha il diritto di rivalersi sul soggetto proprietario del sito nei limiti del valore dell’area bonificata. Pertanto, in capo al proprietario incolpevole non sussiste alcun obbligo di eseguire gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza”.
In senso conforme, v. TAR Basilicata, Sez. I, 26 agosto 2014, n. 561, in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 8 luglio 2014, n. 1768, ivi; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 3 luglio 2013, n. 3374, in Riv. giur. amb., 2013, 79;TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 11 settembre 2012, n. 2117, ivi, 2013, 1, 114, nota di L. Prati; TAR Toscana, Sez. II, 22 ottobre 2012, n. 1687, in Dir. e giur. agr., 2013, 9, 564; TAR Sardegna, Sez. I, 16 dicembre 2011, n. 1239, in Riv. giur. amb., 2011, 434, nota di F. Vanetti, E. Alotta; Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 24 giugno 2008, n. 188, ivi, 2008, 6, 985.
[13] Cfr. F. Castoldi, La responsabilità dei soggetti coinvolti nelle operazioni di bonifica, cit., 515, il quale nota che, sostenendo il criterio della responsabilità oggettiva, emergono problemi soprattutto se esso viene rapportato all’attuale complesso normativo rappresentato dal d.lgs. n. 152/2006, il quale ha abrogato il d.lgs. n. 22/1997 e, pur avendone confermato per la maggior parte la disciplina, non ha inteso replicare il disposto dell’art. 17, c. 2, eliminando dunque l’inciso “anche in maniera accidentale” in merito alla causazione del danno.
In giurisprudenza, v. Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 56, in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Toscana, Sez. II, 11 giugno 2012, n. 1104, in Riv. giur. amb., 2013, 94; Id., 28 agosto 2012, n, 1491, ivi; Id., 19 settembre 2012, n. 1551, ivi; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 11 settembre 2012, n. 2117, ivi; TAR Piemonte, Sez. I, 21 novembre 2008, n. 2928, in questa Rivista, 2009, 230, in cui si afferma che sul proprietario di un’area o sul suo gestore “non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in argomento, ma l’onere (reale) di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite, invece, da privilegio speciale immobiliare”.
Negli stessi termini, v. Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2005, n. 4525, in Foro amm.-C.d.S., 2005, 9, 2667 ss..
[14] La giurisprudenza ha chiarito che la responsabilità della contaminazione deve essere accertata in concreto. In particolare è stato affermato che è illegittimo l’accollo indifferenziato delle attività ed oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano senza il preventivo accertamento, con un procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l’inquinamento riscontrato; a questo fine, è necessario compiere accertamenti relativi all’elemento materiale (id est danno), all’elemento soggettivo della colpa o del dolo e del nesso causale, che dovranno comunque risultare dalla motivazione del provvedimento amministrativo.
In questi termini, v. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 24 gennaio 2014, n. 228, in www.giustamm.it; Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2011, n. 6392, in questa Rivista, 2012, 227; TAR Sardegna, Sez. I, 16 dicembre 2011, n. 1239, in questa Rivista, 2012, 256; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 2 novembre 2011, n. 1901, in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2011, n. 929, ivi; TAR Lombardia, Milano, Sez., IV, 6 settembre 2011, n. 2166, ivi; TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 13 gennaio 2011, n. 6, ivi.
[15] In questi termini, v. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 17 dicembre 2009, n. 837, in Riv. giur. amb., 379, che fonda l’interpretazione a favore di una responsabilità soggettiva sull’art. 311, c. 2, del Codice, secondo il quale “chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 ”.
Sul punto v., D. Camici, A.L. De Cesaris, C. Galdenzi, R. Losengo, E. Maschietto, Bonifica dei siti contaminati, cit., 21 ss..
In giurisprudenza, v. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 17 giugno 2008, n. 1190, in www.giustizia-amministrativa.it; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 20 luglio 2007, n. 1254, in Riv. giur. amb., 2007, 5, 828, nota di A.L. De Cesaris, L. Prati, in cui si afferma che “se, nel vigore del d.lgs. n. 22/1997, poteva dubitarsi della natura della responsabilità (soggettiva, o al contrario, oggettiva) di colui che determina un inquinamento (chiamato a provvedere al ripristino anche se il superamento dei valori standars è cagionato accidentalmente, con conseguente possibile configurazione di un obbligo di intervento che prescinde dallo stato soggettivo dell’agente), ciò invece è sicuramente da escludersi nella disciplina attuale. Infatti il d.lgs. n. 152/2006, all’art. 311, c. 2, disciplina la responsabilità per danni all’ambiente ed è la norma che costituisce e disciplina la situazione giuridica soggettiva di responsabilità, e serve quindi ad orientare l’interprete nella ricostruzione dell’istituto più generale dei siti inquinati”.
[16] Art. 311, c. 2, del Codice, ai sensi del quale “chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE”.
In tema di danno ambientale, sia consentito rinviare a R. Leonardi, L’esclusione della legittimazione ad agire degli enti locali nell’azione risarcitoria in tema di danno ambientale: la negazione del “federalismo ambientale”, in Foro amm.-TAR, 2013, 2925.
[17] L. Prati, Il danno ambientale dopo la novella del 2009 e la decisione 378/2010 della Corte di giustizia, in Riv. giur. amb., 2010, 957 ss..
Secondo la giurisprudenza che si fa portatrice della tesi della responsabilità soggettiva, non è sufficiente un rapporto di causa-effetto tra lo svolgimento di un’attività inquinante e il danno ambientale, per poter fondare la responsabilità dell’operatore, ma occorre anche un elemento di dolo o colpa, in correlazione con la violazione di una norma o con un comportamento negligente.
[18] Direttiva 35/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, in G.U.C.E. del 30 aprile 2004, n. L 143/56.
Sulla direttiva, v. A Sacchi, Profili civilistici, cit., 341 ss., e giurisprudenza e dottrina ivi citata.
È opportuno ricordare come la direttiva in questione non operi una distinzione tra danno ambientale ed interventi di bonifica, ma poiché questi ultimi costituiscono una forma di risarcimento di tale danno è corretto ritenere che i principi di cui alla presente direttiva possano anche applicarsi al tema delle bonifiche.
[19] Le attività in questione sono elencate all’Allegato III, direttiva 35/2004/CE. Esso comprende attività appartenenti a settori potenzialmente inquinanti quali l’industria dell’energia, le raffinerie, l’attività chimica, quella estrattiva, la produzione e lavorazione di metalli e la gestione di rifiuti.
[20] Si legge nel Considerando 8 che “la presente direttiva dovrebbe applicarsi, con riferimento al danno ambientale, alle attività professionali che presentano un rischio per la salute umana o per l’ambiente. In linea di principio, tali attività dovrebbero essere individuate con riferimento alla normativa comunitaria pertinente che prevede requisiti normativi in relazione a certe attività o pratiche che si considera presentino un rischio potenziale o reale per la salute umana o l’ambiente”.
[21] L. Prati, Il danno ambientale dopo la novella del 2009 e la decisione 378/2010 della Corte di giustizia, cit., 957 ss., il quale afferma che“il principio della responsabilità ambientale anche in assenza di dolo o di colpa si applica infatti alle attività incluse in una lista di settori potenzialmente inquinanti, quelle appunto dell’allegato III” e aggiunge che “la direttiva distingue, ai fini della imputazione del danno, tra tipologie di operatori, gravando di una responsabilità certamente più prossima a quella oggettiva, e quindi basata sulla sussistenza del solo nesso di causalità tra azione ed evento, i soggetti esercenti attività ritenute comportare un rischio per la salute umana o l’ambiente”.
[22] Si legge nel considerando 9 che “la presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto riguarda il danno causato alle specie e agli habitat naturali protetti, alle attività professionali che non sono già direttamente o indirettamente contemplate nella normativa comunitaria come comportanti un rischio reale o potenziale per la salute umana o l’ambiente. In tali casi l’operatore sarebbe responsabile ai sensi della presente direttiva, soltanto quando vi sia il dolo o la colpa di detto operatore”.
[23] Corte Giust. UE, 9 marzo 2010, Grande Sez., causa C-378/08, in Riv. giur. amb., 2010, 565, nota di A.L. De Cesaris, La Corte di Giustizia tra imputazione e accertamento delle responsabilità per danni all’ambiente e i poteri dell’Autorità competente per ottenere le misure di riparazione, e in Riv. it. dir. pubb. com., 2011, 83 ss., con nota di G. Lo Schiavo, La Corte di Giustizia e l’interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale: nuove frontiere.
L’autore ricostruisce la fattispecie oggetto della controversia. La sentenza di cui si tratta è stata emanata a seguito della scelta operata dal TAR Sicilia, Catania, di trasmettere alla Corte una serie di questioni pregiudiziali. Le cause principali, cui è stato posto rinvio alla Corte, avevano ad oggetto l’inquinamento ambientale del territorio del Priolo Gargallo e della Rada di Augusta in Sicilia e la controversia originaria era stata instaurata da alcune imprese contro il Ministero dello Sviluppo Economico. L’inquinamento di queste aree risale agli anni ’60, epoca in cui molteplici imprese hanno cominciato ad operare con attività nei settori della petrolchimica e degli idrocarburi. Ciò comportava invasivi sfruttamenti delle zone in questione, che hanno danneggiato lo stato dei terreni, le falde freatiche, le acque costiere e i fondali marini. A fronte di siffatti danneggiamenti le amministrazioni competenti hanno obbligato le imprese operanti nelle aree in questione a risanare i fondali contaminati mediante opere di bonifica. Le imprese a questo punto hanno deciso di ricorrere al giudice amministrativo contestando gli ordini dell’amministrazione la quale non aveva distinto tra inquinamenti pregressi e attuali e non aveva nemmeno accertato la responsabilità a titolo individuale delle singole imprese.
[24] Corte Giust. UE, 9 marzo 2010, Grande Sez., causa C-378/08, in Riv. giur. amb., cit., 957 ss., con nota di L. Prati, in cui si osserva che“la direttiva 35/2004 consente all’autorità competente di presumere l’esistenza di un nesso di causalità, nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un inquinamento accertato, in base all’esistenza di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatoreall’inquinamento accertato e la corrispondenza tra sostanze inquinanti e i componenti impiegati da detto operatore”.
[25] Si può tuttavia affermare che per quanto riguarda il nostro ordinamento, in merito a questa posizione assunta dalla Corte, circa la possibilità di attribuire la responsabilità per danno solo in base a presunzioni, siano esse semplici o legali, possano registrarsi orientamenti differenti.
In senso contrario a quanto affermato dalla Corte, v. Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 56, in Riv. giur. amb., 2013, 556 ss., con nota di P. Bertolini, Il principio di proporzionalità e l’accertamento del nesso di causalità nei procedimenti relativi alla bonifica dei siti inquinati, in cui si osserva che“nei procedimenti relativi alla bonifica dei siti inquinati l’accertamento del nesso di causalità fra il comportamento del responsabile e il fenomeno dell’inquinamento deve essere condotto in maniera rigorosa e deve essere fondato su un’adeguata motivazione e su idonei elementi istruttori, nonché su prove e non su mere presunzioni”.
Invece, in senso favorevole, possono essere ricordate altre pronunce. Cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575 e Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885, in Riv. it. dir. pubb. com., cit., 83 ss., con nota di G. Lo Schiavo. Tali pronunce affermano che l’accertamento della responsabilità dell’inquinamento deve essere rigorosa, ma essa può essere individuata a carico del soggetto autore del danneggiamento, anche sulla base di elementi indiretti riscontrabili con presunzioni semplici.
[26] La sentenza n. 378/200808, cit., in materia di responsabilità oggettiva, stabilisce al punto 62 che “quando un danno sia stato causato all’ambiente da operatori attivi nei settori dell’energia e della chimica.. attività comprese a tale titolo nell’allegato III alla direttiva 2004/35, a questi operatori possono essere pertanto imposte misure preventive o di riparazione, senza che l’autorità competente sia tenuta a dimostrare l’esistenza di un comportamento doloso o colposo in capo a loro”; al punto 63 si legge che “nel caso di attività professionali comprese nell’allegato III alla direttiva 2004/35, la responsabilità ambientale degli operatori attivi in questi ambiti è loro imputata in via oggettiva”. In materia di responsabilità soggettiva stabilisce al punto 61 che “quando un danno è stato arrecato alle specie e agli habitat naturali protetti da una attività professionale non elencata nell’allegato III di questa direttiva, la medesima può applicarsi a condizione che sia accertato il comportamento doloso o colposo in capo all’operatore”.
[27] TAR Toscana, Firenze, Sez. II, del 3 marzo 2010, n. 594, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui si afferma che “la disciplina di cui agli art. 240 ss. del d.lgs. n. 152/2006, al pari di quella previgente (art. 17, comma 2, d.lgs. n. 22/1997), è ispirata al principio secondo cui l’obbligo di adottare le misure, tanto urgenti che definitive, idonee a fronteggiare una situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa, a titolo di dolo o colpa: l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere, invece, addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni responsabilità dello stesso”; Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612, in www.ambientediritto.it, in cui si osserva che “il legislatore ha strutturato la fattispecie in esame in termini indiscutibilmente soggettivi, radicando solo sulla riscontrata presenza di colpevolezza del proprietario la sua concorrente responsabilità e in difetto di accertato concorso, con il terzo autore dell’illecito, di una condotta colpevole del proprietario del fondo, non è dato ricavare alcuna sua responsabilizzazione per la bonifica da effettuare”.
[28] In questo senso, v. G. Lo Schiavo, La Corte di giustizia e l’interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale: nuove frontiere, cit., 83 ss.; G. Taddei, Il rapporto tra bonifica e risarcimento del danno ambientale, in Amb. e Svil., 2009, 417 ss..
La Commissione europea ha inviato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora il 31 gennaio 2008, C(2008)0090, nella quale si ipotizza che la normativa italiana sulla responsabilità in materia di danno ambientale, violi sotto diversi profili i principi statuiti dalla direttiva 35/2004/CE. A questa ha fatto poi seguito un parere motivato risalente al 12 gennaio 2012, C(2012)228, con cui la Commissione torna sulla questione del mancato adempimento da parte del Governo italiano dei principi fondamentali contenuti nella Direttiva 35/2004/CE.
[29] Legge 6 agosto 2013, n. 97, in G.U. del 20 agosto 2013, n. 194,“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”.
[30] Art. 25, c. 1, lett. g): “Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell’allegato V alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione di cui all’allegato III alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all’articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa”.
Quindi nei confronti degli operatori che svolgono certe attività professionali, viene applicato il criterio oggettivo, indipendentemente dalla responsabilità per la contaminazione dell’area; mentre per tutti gli altri casi resta fermo il principio di responsabilità per dolo o per colpa di chi ha svolto l’attività che ha causato la contaminazione.
[31] Cfr. M.P. Giracca, Danno ambientale, in R. Ferrara, M.A. Sandulli, diretto da, Trattato di diritto dell’ambiente, I, cit., 594 ss.; R. Rota, Profili di diritto comunitario dell’ambiente, in E. Picozza, P. Dell’Anno, a cura di, Trattato di diritto dell’ambiente, cit., 151 ss.; A. Sacchi, Profili civilistici, ivi, 331 ss..
[32] In questo senso è ampia la giurisprudenza che sostiene la tesi della necessità di prevedere un obbligo limitato alle misure di prevenzione in capo al proprietario incolpevole.
Cfr. TAR Toscana, Sez. I, 19 settembre 2012, n. 1551, nota di E. Pomini, L’individuazione degli obblighi d’intervento a carico del proprietario incolpevole e volontario, in Riv. giur. amb., 2013, 95 ss..
L’A. rileva come il TAR Toscana, in linea con il dato normativo (art. 245, c. 2) sancisce che “il proprietario dell’immobile, pur incolpevole, non è immune da ogni coinvolgimento nella procedura relativa ai siti contaminati e dalle conseguenze della constatata contaminazione, dovendo egli attuare le misure di prevenzione di cui all’art. 242”.
Il problema che l’A. affronta non è rappresentato tanto dalla sussistenza o meno di siffatto obbligo, dal quale pare difficile che il proprietario possa esimersi, quanto dal tipo d’intervento che esso è chiamato ad attuare. Egli afferma dunque che “in capo ad un soggetto incolpevole del danno arrecato, possano configurarsi soltanto obblighi di portata contenuta, non potendo cioè le misure di prevenzione essere intese in modo estensivo fino a ricomprendere vere e proprie misure di messa in sicurezza del sito”.
Nello stesso senso si sono espressi anche TAR Sardegna, Sez. I, 16 dicembre 2011, n. 1239, in Riv. giur. amb., 2012, 434 ss., con nota di F. Vanetti, E. Alotto, Il punto sulla responsabilità del proprietario incolpevole rispetto agli interventi di bonifica, in cui si afferma che “nell’ipotesi in cui il responsabile dell’inquinamento non esegua gli interventi di bonifica le opere di bonifica ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente che ha il diritto di rivalersi sul soggetto proprietario del sito nei limiti del valore dell’area bonificata. Pertanto, a carico dell’incolpevole proprietario di un’area inquinata non incombe alcun obbligo di porre in essere interventi di messa insicurezza d’emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area libera da pesi. È illegittimo l’ordine di bonifica rivolto al proprietario dell’area contaminata che si fondi solo su detta qualità in assenza di ogni altra verifica tesa ad individuare il responsabile dell’inquinamento”.
Cfr. TAR Toscana, Sez. II, 1° aprile 2011, n. 565, in www. ambientediritto.it, in cui si afferma che “occorre riaffermare il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui non è legittimo l’ordine di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale indiscriminatamente rivolto al proprietario del fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di una esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta”; TAR Toscana, Sez. II, 5 giugno 2009, n. 984, in www.ambientediritto.it, in cui si osserva che “gli obblighi connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica di un sito inquinato sono ricondotti dalla legge ad un presupposto soggettivo ed ad uno oggettivo, venendo meno uno dei quali non si concretizza l’obbligo in questione”; TAR Sardegna, Sez. II, 8 ottobre 2007, n. 1809, in www.reteambiente.it, secondo il quale “il proprietario non responsabile non è obbligato ad eseguire gli interventi di bonifica in quanto la legge riserva la situazione di obbligo solo al responsabile; la sua situazione può ricondursi alla figura dell'onere, rimanendo tale anche in seguito all'attivazione spontanea delle procedure per la messa in sicurezza e bonifica del sito”.
[33] Art. 245, c. 2, in cui si afferma che: “(…) la provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica”.
[34] Sul punto, si rinvia a V. Cingano, La responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione per contaminazione di un sito: l’individuazione degli oneri che gravano sul proprietario, in Foro amm.-TAR, 2011, 836 ss..
[35] In questi termini, v. Tribunale civile di Ferrara, 17 gennaio 2013, n. 65, in Riv. giur. amb., 2013, 3-4, 451, in cui si afferma che “il principio ‘chi inquina paga’ può essere invocato dal proprietario di un sito inquinato esclusivamente a sostegno dell’azione di rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile dell’inquinamento, ma non lo esonera dall’obbligazione pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione conseguente alle opere di bonifica, in base al principio generale fissato dall’art. 2051 del codice civile che non è derogato da alcuna disciplina di settore”.
Negli stessi termini, v. TAR Veneto, Sez. III, 8 febbraio 2013, n. 197, ivi, 452; contra, TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 5 maggio 2014, n. 183, in Foro amm., 2014, 5, 1546; TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 9 aprile 2013, n. 229, ivi, 453, in cui si afferma che “l’obbligo di procedere alla bonifica non può essere desunto dall’applicazione della previsione dell’art. 2051 c.c. (che regolamenta la responsabilità del custode): deve, infatti, rilevarsi come si tratti di un criterio che si presenta in contraddizione con i precisi criteri di imputazione degli obblighi di bonifica previsti dagli artt. 240 e ss. e 252 bis comma 2 del d.lgs. n. 152/2006. In buona sostanza, si tratta di una disciplina esaustiva della problematica che non può certo essere integrata dalla sovrapposizione di principi desunti dalla diversa normativa e che determinerebbero la sostanziale alterazione di un contenuto normativo improntato a ben diversi principi ”; ancora cfr. TAR Toscana, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1664, in Riv. giur. amb., 2013, 252.
Si consideri, inoltre, che il Codice rappresenta una normativa di settore contenente previsioni specifiche e pertanto appare una forzatura voler integrare gli obblighi espressamente indicati da tale disciplina attraverso l’applicazione dell’art. 2051 c.c. che rappresenta una norma di carattere generale. Infatti, secondo il principio di specialità, la norma speciale prevale rispetto a quella generale. Sul tema, v. Cons. Stato, Ad. Plen., 11 maggio 2012, n. 14, in www.giustizia-amministrativa.it.
[36] Ex multis, v. TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 9 aprile 2013, n. 229, in Riv. giur. amb., 2013, 451 ss., con nota di F. Vanetti, M.E. Alotto, Responsabilità del proprietario incolpevole e obbligo di custodia.
Gli AA. rilevano come nella presente pronuncia il TAR escluda che il proprietario incolpevole possa essere obbligato ad intervenire, oltre che sulla base del dato normativo del Codice, anche in riferimento al fatto che ad esso non si può applicare l’art. 2051 c.c. in materia di obblighi di custodia. Infatti emerge come possa apparire una forzatura voler integrare gli obblighi dettati dall’attuale disciplina con l’applicazione dell’art. 2051 c.c.: “l’obbligo di procedere alla bonifica non può essere desunto dall’applicazione della previsione dell’art. 2051 c.c. (che regolamenta la responsabilità del custode) (…) il d.lgs. n. 152/2006 rappresenta una disciplina esaustiva della problematica che non può essere integrata dalla sovrapposizione di principi desunti dalla diversa normativa”.
TAR Toscana, Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 1664, in Riv. giur. amb., 2013, 252 ss., con nota di E. Maschietto, La posizione del proprietario incolpevole nei procedimenti di bonifica e risanamento ambientale.
L’A. sottolinea come la presente sentenza ribadisca l’insussistenza a carico del proprietario incolpevole della contaminazione di alcun obbligo di riparazione ambientale, sia sotto il profilo della messa in sicurezza d’emergenza, sia sotto il profilo della bonifica. L’aspetto che caratterizza la pronuncia in questione è rappresentato dal fatto che la mancanza di siffatti doveri in capo al proprietario incolpevole è giustificata non solo dal dato normativo del Codice, ma si spinge a prendere in considerazione l’istituto della responsabilità per custodia, ai sensi dell’art. 2051 cc. (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il danno fortuito”), escludendo la possibilità di richiamare siffatta disciplina per poter fondare la responsabilità del proprietario incolpevole: “al proprietario incolpevole dell’inquinamento non può essere addossato alcun obbligo di bonifica o di messa in sicurezza neppure ai sensi dell’art. 2051 cc. in relazione all’ipotesi di responsabilità civile per cose in custodia”.
In senso contrario possono essere richiamate TAR veneto, Sez. III, 8 febbraio 2013, n. 196, in Riv. giur. amb., 2013, cit., 451 ss., con nota di F. Vanetti, M.E. Alotto, nella quale il TAR richiama l’istituto della responsabilità per custodia affermando che il proprietario incolpevole sarebbe obbligato ad intervenire, ai sensi dell’art. 2051 cc..
[37] TAR Lazio, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2263, in Foro amm.-TAR, 2011, 837 ss..
[38] Il TAR afferma al punto 7 che “proprio perché il proprietario non è estraneo alle vicende successive all’accertata contaminazione dell’immobile oggetto del suo diritto; proprio perché egli è tenuto ad attuare le misure di prevenzione necessarie; proprio perché egli può – anche in vista delle conseguenze future in cui potrebbe incorrere ex art. 253 – sempre farsi carico volontariamente degli interventi necessari, non sussiste alcun impedimento a ritenere che il proprietario possa essere reso destinatario dall’amministrazione competente – salvo sua rivalsa nei confronti del responsabile – degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, e ciò senza che tale attribuzione consegua o sia indice di una sua responsabilità”.
[39] Sul punto si rinvia a F. Vanetti, Bonifica da parte del proprietario incolpevole, è un obbligo o una facoltà?, in Riv. giur. amb., 2011, 660 ss..
L’A., commentando la sentenza in esame, contesta la posizione assunta dal TAR, soprattutto in considerazione del fatto che essa non solo è in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria, ma anche con il principio comunitario ‘chi inquina paga’ e con il dato normativo derivante dal combinato disposto tra art. 245 e art. 253. In riferimento a queste ultime norme infatti si legge che “non si comprende, dunque, come a fronte di tale chiara ed espressa previsione, si possa giungere a ritenere che il proprietario incolpevole sia obbligatoriamente tenuto ad eseguire gli interventi di bonifica definitivi”. Conclude sostenendo che “è evidente che l’intervento del proprietario nella bonifica sia su base volontaria e in considerazione del proprio interesse privato e che non vi sia un obbligo giuridico discendente dalla legge, idoneo ad imporgli la bonifica di una contaminazione che non ha causato”.
[40] Si legge al punto 6 che “alla luce delle disposizioni citate, appare evidente che, nel sistema sanzionatorio ambientale, il proprietario del sito inquinato è senza dubbio soggetto diverso dal responsabile dell’inquinamento (pur potendo, ovviamente, i due soggetti coincidere); su quest’ultimo gravano, oltre altri tipi di responsabilità da illecito, tutti gli obblighi di intervento, di bonifica e lato sensu ripristinatori, previsti dal Codice dell’ambiente (in particolare, dagli artt. 242 ss.)”.
[41] Sempre al punto 6 si legge che “tuttavia, il proprietario dell’immobile, pur incolpevole, non è immune da ogni coinvolgimento nella procedura relativa ai siti contaminati e dalle conseguenze della constatata contaminazione. Ed infatti, in primo luogo, il proprietario è comunque tenuto ad attuare le misure di prevenzione di cui all’art. 242 (art. 245); in secondo luogo, il proprietario, ancorché non responsabile, può sempre attivare volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (art. 245); infine, il proprietario è il soggetto sul quale l’ordinamento, in ultima istanza, fa gravare – in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione – le conseguenze dell’inquinamento e dei successivi interventi (art. 253)”.
[42] Il TAR afferma che “la titolarità delle obbligazioni risarcitorie rende possibile anche l’attribuzione (provvisoria) delle obbligazioni ripristinatorie”.
In altri termini, secondo il TAR, l’onere reale e il privilegio speciale immobiliare, che legittimano l’amministrazione a richiedere la corresponsione da parte del proprietario incolpevole di una somma massima pari al valore del bene a seguito della bonifica, determinano la sussistenza di una obbligazione risarcitoria che non deve essere assolta solo per equivalente ma anche in forma specifica.
[43] Cfr. V. Cingano, La responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione per contaminazione di un sito: l’individuazione degli oneri che gravano sul proprietario, cit., 837 ss..
[44] Si rinvia a TAR Piemonte, Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 136, in Riv. giur. amb., 2011, 659 ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4561, in Riv. giur. amb., 2011, 515 ss., secondo il quale “il proprietario non responsabile del sito contaminato è destinatario di una responsabilità da posizione, non solo svincolata dai profili soggettivi del dolo e della colpa, ma che non richiede neppure l’apporto causale del proprietario responsabile del superamento o pericolo di superamento dei valori limite di contaminazione”.
[45] Sul punto v. TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 22 giugno 2010, n. 2035, in Riv. giur. amb., 2011, 536 ss., con nota di F. Vanetti, Obbligo di bonifica: sussiste anche nei confronti di un soggetto non responsabile che interviene volontariamente?, in cui si osserva che “una volta avviato il procedimento ex art. 245 del d.lgs. n. 152/2006, l’interessato non può fermarsi alla sola messa in sicurezza e redazione del piano di caratterizzazione, ma deve concludere l’intero procedimento, al fine di dare luogo alla bonifica e al ripristino ambientale già configurate nel piano di caratterizzazione”.
L’intenzione del TAR dunque è quella di prevedere in capo al proprietario non responsabile che abbia avviato volontariamente la procedura di bonifica, un vero e proprio obbligo a concluderla.
L’A. sottolinea come la pronuncia in questione si ponga in netto contrasto sia con il dato normativo nazionale, il quale prevede una mera facoltà, mentre invece il TAR prevede un obbligo, sia con il principio comunitario “chi inquina paga”.
[46] V. Cingano, La responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione per contaminazione di un sito: l’individuazione degli oneri che gravano sul proprietario, cit., 837 ss., secondo la quale “la giurisprudenza in modo costante afferma che solo al soggetto individuato dall’amministrazione come responsabile possono essere addossati gli oneri di bonifica. Mentre la realizzazione di tali interventi non può essere fatta gravare sul proprietario, in considerazione della sola titolarità del bene; l’obbligo di bonifica e di messa in sicurezza non può essere addossato al proprietario ove manchi ogni sua responsabilità. In caso di mancata individuazione del responsabile le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla pubblica amministrazione e le spese per gli interventi di bonifica ricadono in via indiretta sul proprietario ancorché incolpevole, attraverso l’individuazione dell’onere reale e del privilegio speciale immobiliare sulle aree”.
[47] Il Codice sancisce all’art. 250 che, in mancanza di un apposito intervento da parte dei soggetti responsabili della contaminazione o nell’impossibilità di una loro individuazione sia l’amministrazione competente a dover provvedere d’ufficio mediante la realizzazione delle procedure e degli interventi di cui all’art. 242 del Codice.
È proprio in relazione a tali interventi che possono essere introdotti i concetti di onere reale e di privilegio speciale immobiliare.
La previsione di questo istituto nell’ambito delle operazioni di bonifica ha la finalità di evitare che i costi per sostenere tali interventi - che sono stati anticipati dall’amministrazione poiché non è stato possibile individuare il responsabile dell’inquinamento - restino a carico di questa, ma vadano a gravare sul proprietario che beneficia dell’intervento di disinquinamento. L’art. 253, c 1, del Codice statuisce che “gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’art 250”.
In altri termini, affermando che gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica effettuati d’ufficio dalla pubblica amministrazione costituiscono onere reale sui siti inquinati, la conseguenza è che il titolare dell’area sia tenuto a sostenere le spese di siffatte operazioni nei limiti del valore di mercato del sito.
[48] Sul punto v. F. Castoldi, La responsabilità dei soggetti coinvolti nelle operazioni di bonifica, cit., 515 ss..
[49] L’ordinanza in questione ha seguito la remissione operata dalla sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2740, in www.giustizia-amministrativa.it, nella quale viene statuito che “la Sesta Sezione ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione di diritto se, in base al principio di matrice comunitaria compendiato nella formula “chi inquina paga” – l’Amministrazione nazionale possa imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia anche l’autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza di cui all’art. 240, c. 1, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006 (sia pure, in solido con il responsabile e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile per gli oneri sostenuti), ovvero se - in alternativa - in siffatte ipotesi gli effetti a carico del proprietario ‘incolpevole’ restino limitati a quanto espressamente previsto dall’art. 253 del medesimo decreto legislativo in tema di oneri reali e privilegi speciali”.
[50] Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, n. 21, punto 13, in Riv. giur. amb., 2013, con nota di C.L. Coppini, Chi non ha inquinato non paga, 745 ss.., e in Gior. dir. amm., 2013, 365, nota di G. Sabato.
[51] Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, n. 21, punto 15 in cui si afferma che“(…) solo dopo che gli interventi siano eseguiti d’ufficio dall’autorità competente, le conseguenze sono poste a carico del proprietario anche incolpevole, posto che vi è la specifica previsione di un onere reale sulle aree che trova giustificazione proprio nel vantaggio economico che il proprietario ricava dalla bonifica dell’area inquinata”.
[52] Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, n. 21, punto 15.
[53] Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, n. 21, punto 15, in cui si afferma che “a carico del proprietario dell’area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell’inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di facere; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l’area libera da pesi (art. 245). Nell’ipotesi di mancata individuazione del responsabile, o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte dello stesso – e sempreché non provvedano spontaneamente né il proprietario del sito né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale sono eseguite dall’Amministrazione competente (art. 250), che potrà rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (art. 253)”.
[54] Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, n. 21, punto 22, in cui si afferma che “la tesi accolta dal Collegio risulta, del resto, di gran lunga prevalente nella giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado. Il Giudice amministrativo, infatti, in maniera pressoché costante, ha escluso che le norme della parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, possano offrire all’amministrazione una base legislativa per imporre al proprietario non responsabile misure di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica”.
[55] Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, n. 21, punto 50, in cui si afferma che “se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/Ce del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio ‘chi inquina paga’, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica”.
[56] Per quanto riguarda il principio “chi inquina paga”, al punto 32 l’Adunanza Plenaria osserva che “si discute, tuttavia, sui limiti che incontra questa operazione di ‘internalizzazione’ del costo ambientale. Più nel dettaglio, ci si chiede se il danno ambientale possa essere addossato soltanto a ‘chi’ abbia effettivamente inquinato (di cui sia stata, pertanto, accertata la responsabilità) o se, al contrario, pur in assenza dell’individuazione del soggetto responsabile, ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni, il principio comunitario postulicomunque di evitare che il costo degli interventi gravi sulla collettività, ponendo tali costi a carico del proprietario. Ciò in quanto, escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti colpiti da inquinamento vengano sopportati dalla collettività, costituirebbe proprio la ragion d’essere sottesa al principio comunitario del ‘chi inquina paga’”.
[57] In merito ai princìpi di prevenzione e precauzione, l’Adunanza Plenaria, al punto 41, illustra i motivi che l’hanno portata ad interrogarsi sulla compatibilità tra di essi e il quadro nazionale e afferma che “i principi di precauzione e di prevenzione potrebbero legittimare l’imposizione, a prescindere dalla prova circa la sussistenza del nesso di causalità, in capo al soggetto che, essendo proprietario del sito contaminato, si trova nelle migliori condizioni per attuarle, non solo delle misure di prevenzione descritte dall’art. 240, c. 1, lett. i) d.lgs. n. 152/2006, (già previste a suo carico dall’art. 245, c. 2, d.lgs. n. 152/2006), ma anche di misure di sicurezza di emergenza. Anche queste misure, infatti, hanno una finalità precauzionale e una connotazione d’urgenza, essendo dirette a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente”.
[58] Per quanto riguarda infine il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, l’Adunanza Plenaria, al punto 42, conclude statuendo che “tale principio, infatti, dispone che i danni causati all’ambiente vengano contrastati in una fase il più possibile vicino alla fonte, per evitare che i loro effetti si amplifichino e s’ingigantiscano. Nelle situazioni di impossibilità di individuare il responsabile, o d’impossibilità di evitare da questi le misure correttive, la ‘fonte’ cui il principio fa riferimento sembra potere essere ragionevolmente individuata nel soggetto attualmente proprietario del fondo, che, proprio per la sua posizione di proprietario, è quello meglio in grado di controllare la fonte di pericolo rappresentata dal sito contaminato”.
[59] Sul punto si rinvia a C.L. Coppini, Chi non ha inquinato non paga, in Riv. giur. amb., 2013, 745 ss..
L’A. osserva che “è in relazione a tale profilo, al fine di chiarire l’ambito applicativo e gli effetti di tali principi, che si mostra necessario il ricorso alla funzione interpretativa della Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea”.
[60] Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, n. 21, punto 44, in cui si afferma che “l’Adunanza Plenaria ritiene che, nonostante la serietà degli argomenti su cui si fondano i dubbi interpretativi di cui si è trattato, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia possa essere risolta in senso negativo, escludendo cioè che i richiamati principi comunitari in materia ambientale ostino ad una disciplina nazionale che non consente all’Autorità competente di imporre misure di messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica in capo al proprietario del sito non responsabile della contaminazione, prevedendo in capo al medesimo solo una responsabilità patrimoniale limitata al valore del fondo dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica secondo il meccanismo descritto dell’onere reale e del privilegio speciale immobiliare”.
[61] Cons. Stato, Ad. Plen., 25 settembre 2013, n. 21, al punto 49, continua considerando che “tuttavia, ed è questo il punto che sembra decisivo ai fini della risoluzione della questione, i principi del diritto dell’Unione in materia ambientale, pur non ostando ad una responsabilità svincolata dal rapporto di casualità, non sembrano, tuttavia, imporla, demandando la regolazione di queste forme sussidiarie di responsabilità al legislatore nazionale. Tali principi, quindi, non sembrano di per sé interferire con i limiti che il legislatore nazionale ha voluto prevede alla responsabilità del proprietario non autore della contaminazione”.
[62] Cons. Stato, Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3515, cit., 745 ss., in cui si osserva che “è controversa la legittimità dell’ordine imposto al proprietario dell’area inquinata ad eseguire gli interventi di messa in sicurezza del terreno. Va quindi rimessa all’Adunanza plenaria la questione inerente i limiti della responsabilità del proprietario non colpevole dell’inquinamento”.
Infatti, in Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25, al punto 8 si legge che “con sentenza parziale n. 3515/2013 la Sezione VI ha deciso come sopra sintetizzato, ‘rimettendo l’affare a questa Adunanza plenaria’, onde verificare quale sia la concreta distribuzione degli obblighi tra l’autore dell’inquinamento – sia o meno esso proprietario dell’area – ed il proprietario che risulti tale nel momento in cui l’amministrazione ordini le misure imposte dalla legge”.
[63] Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25, in Riv. giur. amb., 2014, 62 ss., con nota di E. Maschietto, Ancora una remissione alla Corte di Giustizia da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: l’ordinanza n. 25 del 2013. Il “proprietario incolpevole” resta fuori dalla responsabilità ambientale rispettando il principio comunitario chi inquina paga.
[64] D. Giannini, Il proprietario di un’area inquinata non autore dell’inquinamento non è tenuto alla bonifica, cit., 567.
[65] Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25, al punto 11 osserva che “in base ad un primo orientamento, al quesito andrebbe data risposta in senso positivo, avuto riguardo al principio di matrice comunitaria compendiato nella formula secondo la quale ‘chi inquina, paga’. In altri termini, secondo questa prima impostazione, il principio appena richiamato dovrebbe essere inteso con un’ampia accezione interpretativa per cui la responsabilità degli operatori economici proprietari o utilizzatori di aree industriali ricadenti nell’ambito di siti inquinati si qualificherebbe quale oggettiva responsabilità imprenditoriale, conseguente all’esercizio di un’attività ontologicamente pericolosa”.
[66] R. Bianchini, Terreno inquinato: legittimo imporre bonifica al proprietario non responsabile?, in www.altalex.it.
[67] Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25, al punto 12 afferma che “in base ad un opposto orientamento (in particolare, Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2013 n. 56 e 18 aprile 2011 n. 2376), non vi sarebbero, invece, ragioni testuali o sistematiche per far gravare in capo al proprietario dell’area gli obblighi di adozione delle misure di cui alle disposizioni più volte citate”.
[68] Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25, punto 24.
[69] Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25, punto 25.
[70] Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 3013, n. 25, punto 17 in cui si afferma che “la scelta del legislatore di evocare la figura obsoleta dell’onere reale può spiegarsi solo ammettendo che il proprietario incolpevole non sia tenuto ad una prestazione di facere (di cui è gravato solo il responsabile), ma sia tenuto solo a garantire, nei limiti del valore del fondo, il pagamento delle spese sostenute dalla pubblica amministrazione che abbia eseguito direttamente gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica. In altre parole, si deve ritenere che il riferimento all’onere reale non valga a far diventare obbligatorio ciò che (l’intervento di bonifica) poco prima (art. 245) il legislatore abbia qualificato in termini di una mera facoltà, quanto, piuttosto, a far gravare sul fondo il rimborso delle spese sostenute dall’autorità che abbia provveduto d’ufficio all’intervento (e, quindi, semmai, a far diventare quella facoltà un onere)”.
[71] E. Maschietto, Ancora una remissione alla Corte di Giustizia da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: n. 25 del 2013, cit., 62 ss..
[72] Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25, Punto 49: “Tuttavia, ed è questo il punto che sembra decisivo ai fini della risoluzione della questione, i princìpi del diritto dell’Unione in materia ambientale, pur non ostando, alle condizioni appena viste, ad una responsabilità svincolata dal rapporto di casualità, non sembrano, tuttavia, imporla, demandando la regolazione di queste forme sussidiarie di responsabilità al legislatore nazionale. Tali princìpi, quindi, non sembrano di per sé poter interferire con i limiti che il legislatore nazionale abbia voluto porre alla responsabilità del proprietario che non sia stato autore della contaminazione”.
[73] Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25, Punto 27: “L’Adunanza plenaria ritiene necessario acquisire dalla Corte di giustizia alcuni elementi interpretativi dei richiamati princìpi comunitari, anche al fine di valutare la compatibilità con essi della normativa nazionale, onde pronunciarsi sulla causa di cui è stata investita”.
[74] Cons. Stato, Ad. Plen., 13 novembre 2013, n. 25, Punto 28.
[75] Corte di Giustizia UE, 4 marzo 2015, in causa C-534/13, in www.lexitalia.it.
[76] Con l’ordinanza 8 luglio 2013 il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, è intervenuto su tre ricorsi presentati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare avverso altrettante sentenze del T.A.R. della Toscana con cui, quest’ultimo aveva accolto i ricorsi di tre società che avevano acquistato delle aree già appartenute ad altra società e interessate da gravi fenomeni di inquinamento. In particolare, le società ricorrenti avevano ottenuto l’annullamento degli atti con cui alcuni soggetti pubblici avevano loro ordinato – in qualità di proprietari delle aree – di avviare specifiche misure di messa in sicurezza di emergenza di cui al Titolo V della parte IV del Codice dell’ambiente, nonché di presentare la variante al progetto di bonifica delle aree risalente al 1995. Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ritenuto che il principio di matrice comunitaria ex art. 191 TFUE, “chi inquina paga”, dovesse essere interpretato nel senso che la responsabilità delle società ricorrenti, in quanto operatori economici proprietari di aree industriali ricadenti nell’ambito di siti inquinati, dovrebbe essere qualificata come responsabilità oggettiva imprenditoriale, a prescindere dalla prova in ordine all’addebitabilità dell’inquinamento alla condotta delle stesse. Quindi, il Ministero ha chiesto che gli oneri per la messa in sicurezza delle aree fossero addebitati a carico delle ricorrenti. La Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti delle sentenze impugnate e ha emesso ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria al fine di comprendere, in base al principio comunitario “chi inquina paga”, quale fosse la distribuzione degli obblighi per la realizzazione delle misure di messa in sicurezza di emergenza delle aree inquinate tra l’autore dell’inquinamento e il proprietario delle aree stesse. All’interno dell’ordinanza di rimessione, il Consiglio di Stato ha evidenziato le differenti posizioni giurisprudenziali che sono state registrate in merito e che hanno ritenuto talvolta legittima (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 settembre 2011, parere n. 2038/2012) e talaltra illegittima (in particolare, Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2376; Cons. Stato, Sez.VI, 9 gennaio 2013, n. 56) l’imposizione, in capo al proprietario non responsabile, dell’obbligo di porre in essere le misure di sicurezza di emergenza.
L’Adunanza Plenaria, in conclusione, ha ritenuto che la pubblica amministrazione non dovrebbe potere imporre al proprietario di un’area inquinata, che non sia stato autore dell’inquinamento, l’obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che gli articoli da 239 a 253 contenuti nel Titolo V, Parte IV, d.lgs. n. 152/2006, operino una netta distinzione tra la figura del responsabile dell’inquinamento e quella del proprietario dell’area che non abbia causato o concorso a causare la contaminazione. Al riguardo, l’Adunanza Plenaria, dopo alcuni cenni in ordine all’assetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 con specifico riferimento agli obblighi ricadenti a carico del responsabile dell’inquinamento e del proprietario dell’area, ha identificato la tesi accolta e lungamente prevalente nella giurisprudenza amministrativa. All’esito di tale analisi, quindi, il Consiglio di Stato ha registrato che: (i) il proprietario di un’area inquinata è tenuto solo ad adottare le misure di prevenzione previste all’art. 240, c. 1, lett. l), misure di riparazione in caso di minaccia imminente o pericolo di danno ambientale nel futuro prossimo; (ii) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano esclusivamente sul responsabile dell’inquinamento; (iii) qualora tale responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato) gli interventi che risultassero necessari sono adottati dalla pubblica amministrazione competente, la quale, successivamente potrà agire in rivalsa contro il proprietario che risponde nei limiti di valore di mercato dell’area risultante a seguito degli interventi medesimi in quanto beneficiario.
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha quindi formulato un quesito pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea volto ad accertare se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’art. 191, par. 2, del TFUE e dalla direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) – in particolare, il principio “chi inquina paga”, il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio, della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dal Codice dell’ambiente, interpretata nel senso sopra indicato.
[77] Sul punto, sia consentito rinviare a R. Leonardi, L’esclusione della legittimazione ad agire degli enti locali nell’azione risarcitoria in tema di danno ambientale, cit., 2925 ss..
[78] F. de Leonardis, Il principio di precauzione, cit., 265, considera il principio di adeguatezza un principio cardine dell’azione amministrativa e dell’organizzazione delle funzioni in materia ambientale.
Osserva l’A. che “il principio di adeguatezza, che postula la differenziazione nell’allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi, ricomprende tutti i principi fondamentali dell’organizzazione ed essi, di fatto, costituiscono sue varianti: esso include il principio di sussidiarietà in senso orizzontale (il potere pubblico può sostituirsi alla società civile esclusivamente nelle ipotesi in cui quest’ultima non riesca adeguatamente a conseguire determinati obiettivi) e verticale (l’organizzazione superiore si sostituisce a quella inferiore con esclusione delle sole funzoni incompatibili con le dimensioni medesime”.
[79] Sul punto la giurisprudenza è pacifica. Ex multis, v. TAR Sardegna, Sez. II, 20 giugno 2011, n. 636, in questa Rivista, 2011, 1372; Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011, n. 2249, in Foro amm.-C.d.S., 2011, 4, 1279; TAR Toscana, Sez. II, 6 luglio 2010, n. 2316, in Foro amm.-TAR, 2010, 2365.
[80] I princìpi di prevenzione e di precauzione vengono fusi in una sorta di ideale endiadi anche da P. Savona, Dal pericolo al rischio: l’anticipazione dell’intervento pubblico, in Dir. amm., 2010, 355 ss..
Il principio di precauzione e di prevenzione sono stati oggetto nel tempo di una crescente attenzione da parte della dottrina soprattutto per la loro trasversalità e le implicazioni sistematiche che essi comportano.
Su tali princìpi, si veda L. Pineschi, I principi del diritto internazionale dell’ambiente: dal divieto di inquinamento transfrontaliero alla tutela dell’ambiente come common concern, in Aa.Vv., Trattato di diritto dell’ambiente, diretto da R. Ferrara, M.A. Sandulli, I, Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno, a cura di, R. Ferrara, C.E. Gallo, cit., 135 ss.; P. Lombardi, Piano regionale di tutela delle acque e infrastrutture necessarie, in questa Rivista, 2014, 111 ss.; M. Montini, Evoluzione, principi e fonti del diritto internazionale dell’ambiente, in E. Picozza, P. Dell’Anno, a cura di, Trattato di diritto dell’ambiente, cit., 33 ss.; R. Ferrara, Precauzione e prevenzione nella pianificazione del territorio: la “precauzione inutile”, in questa Rivista, 2012, II, 61; S. Grassi, Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente, Milano, 2012, 87 ss.; V. Parisio, Principe de precaution et organisation administrative, in Amel Aouij-Mrad, a cura di, Quelles précautions pour quels risques? Regards croisés sous les responsabilités scientifiques de Amel Aouij-Mrad, Collections Forum des Juristes n. XV, Latrah Edition, 2011, 265 ss.; Id., Protection juridique de l’environnement et mondialisation en Italie, in J. Morand-Deviller, J.C. Bonichot, Mondialisation et globalisation des concepts juridiques: l’exemple du droit de l’environnement, Iris, 2010, 271 ss.; F. de Leonardis, Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti, in www.rqda.it, n. 2/2011; B. Marchetti, Il principio di precauzione, in Aa.Vv., Codice dell’azione amministrativa, M.A. Sandulli, a cura di, Milano, 2011, 149 ss.; S. Grassi, Procedimenti amministrativi e tutela dell’ambiente, ivi, 1394 ss.; R. Leonardi, IL principio di precauzione, in Aa.Vv., Il codice dell’ambiente, a cura di, S. Nespor, A.L. De Cesaris, Milano, Agg. 2011; F. de Leonardis, Il principio di precauzione nella recente codificazione, in Studi sul Codice dell’ambiente, a cura di, M.P. Chiti, R. Ursi, Torino, 2009, 77 ss.; M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, Torino, 2007, 245 ss.; G. Cocco, Ambiente. Il sistema organizzativo ed i principi fondamentali, in Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da, M.P. Chiti, G. Greco, Milano, Parte speciale, I, 2007, 181 ss.;A. Barone, Il diritto del rischio, Milano, 2006; F. de Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio, Milano, 2005.
[81] A titolo esemplificativo, v. in giurisprudenza, TAR Piemonte, 21 novembre 2008, n. 2928, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui si afferma che “il terreno sottoposto a fenomeni di inquinamento è senz’altro soggetto ad espropriazione, che il proprietario, ancorché non responsabile, ha l’onere di evitare ponendo in essere gli interventi di bonifica alla stregua del soggetto responsabile”.
[82] Sul punto, v. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 30 maggio 2014, n. 1373, in Diritto e giustizia, 16 giugno 2014.
F. Giampietro, Bonifica dei siti inquinati, cit., 284, afferma che “la previsione dell’art. 253, c. 4, del Codice, derivi dal principio dell’ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e, pertanto, sia criticabile, in quanto pone a carico della pubblica amministrazione i gravosi oneri probatori di cui al c. 3, evitabili, attesa la natura residuale dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
[83] Sul punto, v. TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 4 novembre 2014, n. 2631, in www.lexitalia.it; TAR Marche, Sez. I, 21 marzo 2014, n. 360, ivi; Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 56, in Riv. giur. amb., 2013, 5, 556 ss., nota di P. Bertolini, Il principio di proporzionalità e l’accertamento del nesso di causalità nei procedimenti relativi alla bonifica di siti inquinati.
Inoltre, v. A. Carapellucci, “Chi inquina paga”: il punto su responsabilità dell’inquinatore e proprietario incolpevole nella bonifica dei siti inquinati, nota a TAR Piemonte, Sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575, in Resp. civ. e prev., 2010, 1893, secondo il quale il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del “più probabile che non”. Pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell’inquinamento rilevato all’attività industriale condotta sul fondo.
La regola del “più probabile che non” è stata codificata nel processo civile nel leading case di Cass., Sez. Un. Civ., 11 gennaio 2008, n. 581, in Resp. civ. e prev., 2008, 841.
[84] È di estremo interesse il tema degli effetti della tutela dell’ambiente sul sistema economico e sugli operatori economici.
Per un approfondimento si rinvia a S. Nespor, Regole ambientali e crescita economica: riflessioni su un recente studio dell’OCSE, in www.federalismi.it, 27/2015; M. Cafagno, F. Fonderico, Riflessione economica e modelli di azione amministrativa a tutela del’ambiente, in P. Dell’Anno, E. Picozza, a cura di, Trattato di diritto dell’ambiente, cit., 487 ss.; F. de Leonardis, Precauzione e tutela amministrativa dell’ambiente, in Rischio di impresa e tutela dell’ambiente, a cura di, G. Alpa, G. Conte, V. Di Gregorio, A. Fusaro, L. Perfetti, Napoli, 2012, 19 ss.; M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, cit., 327 ss..
[85] Sul punto, v. F. degl’Innocenti, Contratto e impresa, 2013, 3, 741, il quale osserva che se “il significato facilmente intuibile dell’espressione ‘chi inquina paga’ è che gli effetti negativi dell’inquinamento (e quindi i costi che ne derivano) devono gravare sugli inquinatori, non quindi sui soggetti incolpevoli né sulla collettività, è chiaro che in questo contesto il principio ‘chi inquina paga’ interverrebbe quale strumento che consentirebbe di attribuire alle risorse ambientali coinvolte nelle attività produttive un prezzo che verrebbe ‘contabilizzato’ dalle imprese fra i costi di gestione: operazione, questa, che presuppone la preesistenza delle regole che permettono questa ‘contabilizzazione’ ai comportamenti rispetto ai quali la ‘contabilizzazione’ stessa debba, ma anche possa, essere effettuata”.
[86] Il tema degli obblighi e della responsabilità d’impresa è sviluppato da A. Barone, Il diritto del rischio, cit., 96 ss..
[87] Sul punto, v. ancora A. Barone, ult. cit., 97.
[88] In tema di bilanciamento di valori, osserva M. Renna, I principi, cit., che “la delicatezza del tema si percepisce riflettendo sul fatto che le disposizioni di tutela ambientale costituiscono pur sempre l’esito di un bilanciamento di interessi, il raggiungimento di un punto di equilibrio tra valori antagonisti, e che, pertanto, l’idea di una massima tutela dell’ambiente, a tutti i costi, non è praticabile”.
Il tema è ripreso anche da M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela, cit., 201 s., il quale richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale (ex multis, v. Corte cost., n. 108/2005), secondo la quale l’asserita primarietà dell’ambiente non accredita un postulato di preminenza dell’ambiente sugli altri valori costituzionali. Il principio di primarietà impone piuttosto alle istituzioni di non estromettere il valore dell’ambiente dalle operazioni di bilanciamento che nondimeno restano come tali libere di confluire in equilibri di volta in volta diversi, in rapporto al peso relativo degli interessi in gioco.
In questi termini, v. Corte cost., 28 giugno 2004, n. 196, in questa Rivista, 2004, I, 1137, in cui si afferma che “gli interessi relativi alla tutela del paesaggio come forma del territorio e dell’ambiente, sono qualificabili come valori costituzionali primari, ma tale primarietà non legittima un primato assoluto, ma che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni”.
Sul punto in dottrina, v. G. Caia, La gestione dell’ambiente: principi di semplificazione e di coordinamento, in Aa.Vv., Ambiente e diritto, a cura di, S. Grassi, M. cecchetti, A. Andronio, a cura di, Firenze, 1999, 237 ss..
[89] Sul punto, v. R. Invernizzi, Inquinamenti risalenti, cit., 970.
Comunichiamo che è aperta la call for papers per la quarta conferenza dell’Italian chapter di ICON-S.
La conferenza si terrà presso l'Università Bocconi, a Milano, il 13-14 ottobre 2023 e il tema su cui si rifletterà è "Politica e Istituzioni tra trasformazioni e risorse".
Vi invitiamo a partecipare alla call che trovate in allegato e anche sul sito https://www.icons-italia.it/ e ad inviarci le vostre proposte di interventi singoli e/o di panels entro il 15 luglio 2023, compilando il modulo che trovate qui.
Il contributo si inserisce nell'approfondimento del tema Accesso in magistratura, precedenti contributi Accesso alla magistratura - 1. Pensieri sparsi sul concorso in magistratura di Giacomo Fumu, Riflessioni sul concorso in magistratura di Mario Cigna, Il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. n. 69/2013 di Ernesto Aghina, Il procedimento per la nomina e selezione dei giudici e pubblici ministeri nella Repubblica Federale Tedesca di Cristiano Valle, Percorsi di accesso alla magistratura in Ungheria di Anna Madarasi, sotto la voce della rivista Ordinamento giudiziario.
In un momento in cui la magistratura francese è in piena riflessione su sé stessa e sulle difficili condizioni di lavoro, è utile fare qualche riflessione sulla composizione e le modalità di accesso alla stessa.
Lo scopo del legislatore francese è stato quello di assicurare, nei limiti del possibile e in modo sempre più accentuato, la diversificazione dell’accesso al corpo della magistratura.
La regolamentazione dell’accesso alla magistratura francese si rinviene, oltre che nelle basi costituzionali, nell’ordonnance n° 58-1270 del 22 dicembre 1958 costituente legge organica relativa allo statuto della magistratura (di seguito, l’ordonnance)[1].
Occorre innanzitutto distinguere le modalità di accesso a seconda del fatto che permettano di integrare la magistratura in qualità di uditore giudiziario[2] (I) o direttamente in qualità di magistrato (III). Sussiste peraltro un’ulteriore voie latérale: il concours complémentaire (II)[3].
I. L’accesso in qualità di uditore giudiziario
Le modalità per diventare uditore giudiziario, e cosi beneficiare della formazione completa dell’Ecole Nationale de la Magistrature, sono duplici: (1) i concorsi; (2) l’accesso sulla base dei titoli di studio[4], detta anche voie latérale. Queste due modalità, che sono a loro volta suddivisibili in funzione dei candidati che possono accedere, permettono di effettuare un periodo di formazione di 31 mesi.
1.1. La selezione
Sussistono quattro modalità di accesso che permettono di effettuare la formazione completa all’ENM.
A. Il primo concorso
Il primo concorso è destinato principalmente agli studenti con poca esperienza professionale. I candidati a questo concorso devono:
(a) avere massimo 31 anni;
(b) essere di nazionalità francese;
(c) essere titolari di un diploma di studi giuridici di almeno quattro anni;
(d) beneficiare dei diritti civici ed essere di “buona moralità”;
(e) trovarsi in posizione regolare con il servizio civico nazionale;
(f) essere di sana e robusta costituzione[5].
Questi candidati superano un concorso pubblico, composto da una fase scritta e una fase orale.
Si tratta della parte più importante degli uditori giudiziari, in quanto costituiscono i candidati più numerosi. Sotto una tabella riprende i dati relativi agli uditori giudiziari delle ultime promozioni che hanno superato questo concorso.
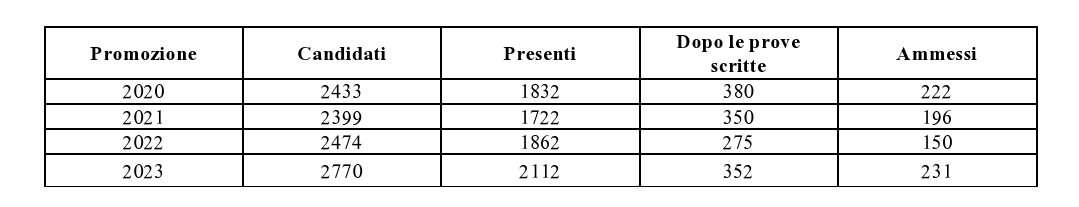
B. Il secondo concorso
Il secondo concorso è destinato agli impiegati pubblici che dispongono di almeno quattro anni di qualsiasi esperienza (ovviamente nel settore pubblico) al 1° gennaio dell’anno in cui il concorso è superato[6]. Il limite di età per tentare questo accesso è fissato a 48 anni e 5 mesi.
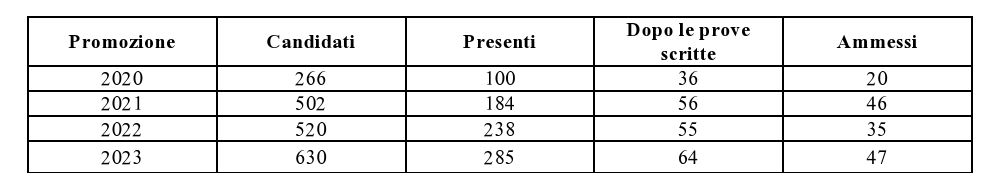
C. Il terzo concorso
Il terzo concorso è destinato a coloro che possono giustificare almeno otto anni di esperienza di attività professionale nel settore privato, di mandato elettivo o di funzioni giurisdizionali[7]. Il limite di età per tentare questo accesso è fissato a 40 anni.
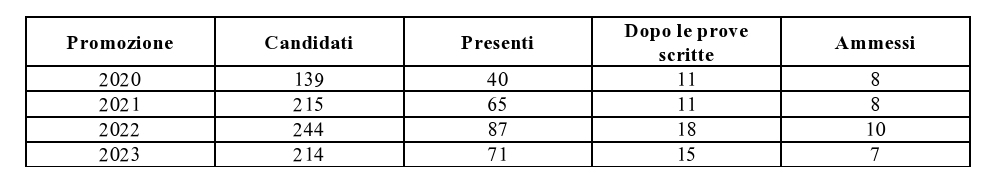
D. L’accesso sulla base dell’articolo 18-1 dell’ordonnance
Si tratta di un accesso all’uditorato sulla base dei titoli di studio. E’ destinato a coloro che dispongono di almeno quattro anni di esperienza professionale e che:
(a) rispettano le condizioni previste per i candidati al primo concorso;
(b) dispongono di un titolo di un titolo di studi giuridici di almeno quattro anni;
(c) hanno sostenuto con successo una tesi di dottorato e che hanno quattro anni di esperienza professionale o che hanno tre anni di esperienza in qualità di assistente giudiziario o che hanno esercitato delle funzioni di insegnamento per almeno tre anni[8].
In tal caso, sebbene non sussista un vero e proprio concorso, i candidati devono sostenere un minimo di tre ed un massimo di cinque colloqui di cui uno con i magistrati della Commission d'Avancement.
Gli uditori giudiziari selezionati sulla base di tale accesso su titoli non possono essere superiori, in numero, ad un terzo di quelli selezionati sulla base dei tre concorsi summenzionati.
Per visualizzare meglio come sono composte le diverse “promotions” negli anni, in funzione della diversità del modo di accesso, si possono rinvenire sotto i dati statistici degli ultimi anni:
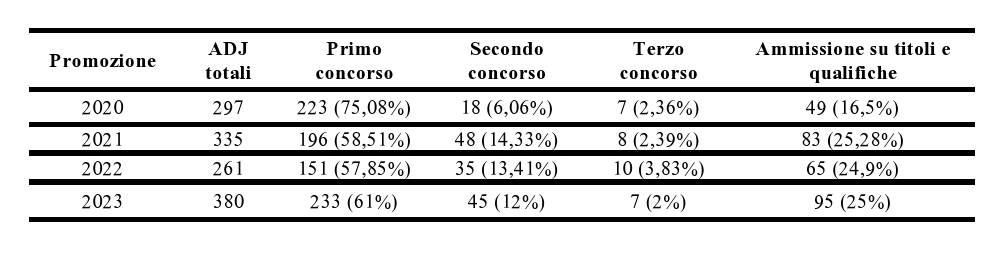
1.1.2. La formazione di 31 mesi
Attualmente, il governo e la stessa scuola della magistratura stanno modificando le sequenze della formazione. Tuttavia, ad oggi, la formazione assicurata dall’Ecole Nationale de la Magistratura è composta come segue[9]:
- 8 mesi di formazione generica all’ENM sita a Bordeaux: gli insegnamenti, principalmente di natura pratica, sono attualmente dispensati da magistrati, avvocati, cancellieri e/o funzionari in funzione dell’apporto desiderato;
- 1 settimana di immersione in un tribunale;
- 1 settimana di tirocinio presso un servizio di polizia;
- 1 settimana di tirocinio presso un servizio di gendarmeria;
- 12 settimane di tirocinio presso un avvocato;
- 32 settimane di formazione generica;
- 2 settimane di tirocinio presso un centro penitenziario;
- 38 settimane di tirocinio generico presso un tribunale;
- 3 settimane di tirocinio presso partner giudiziari (ufficiali giudiziari, servizi di reinserzione e accompagnamento criminalità giovanile);
- 7 settimane di tirocinio pressi enti non-giudiziari e/o presso istituzioni internazionali o istituzioni giudiziarie estere;
- 1 settimana per garduatoria e scelta della prima sede;
- 4 settimane di formazione specifica;
- 1 settimana di tirocinio presso una Corte di appello;
- 11 settimane di tirocinio specifico.
Durante questa formazione gli uditori giudiziari sono sottoposti a delle valutazioni:
- le prove che sanciscono il termine della formazione generica (previste nel mese di febbraio N+1): una prova di diritto penale, una prova di diritto civile e una prova di inglese[10];
- le prove pratiche (gennaio-marzo N+2): la tenuta di un’udienza penale, la tenuta di un’udienza civile e la tenuta di requisitorie orali in qualità di pubblico ministero;
- le prove che sanciscono il termine del tirocinio generico (gennaio N+2): la redazione di una sentenza civile, la redazione di requisitorie scritte e una prova orale di deontologia e attualità giuridica.
Per interesse comparativo con il sistema italiano, è possibile fare due osservazioni.
La graduatoria in base alla quale gli uditori giudiziari francesi scelgono la loro prima sede è unica per tutte le modalità di accesso ed è determinata dalle votazioni ottenute alle sei prove su menzionate. In effetti, a differenza del sistema italiano, la graduatoria di “entrata” non ha alcun valore per la graduatoria di ‘uscita”, essendo la stessa determinata esclusivamente dalle valutazioni espresse durante tutto il tirocinio.
Inoltre, al termine della formazione presso l’ENM, vi è la possibilità per la commissione che valuta gli uditori di considerare che il candidato debba ripetere il periodo di tirocinio generico o che debba essere escluso in quanto inidoneo alle funzioni giurisdizionali. Merita specificare che il tasso di tali situazioni resta decisamente basso.
II. L’accesso attraverso il concours complementaire
Per poter accedere alla magistrature sussiste anche la possibilità di superare il cosiddetto “concours complémentaire” destinato alle persone che:
- hanno meno di 35 anni di éta;
- dispongono di almeno sette anni di esperienza professionale nel campo giuridico.
La formazione in tal caso è di una durata di 12 mesi strutturata come segue:
- 1 mese di formazione generica;
- 6 mesi di tirocinio generico in un tribunale;
- 1 mese di formazione specifica;
- 3 mesi di tirocinio specifico.
In questo caso, il tirocinio è considerato come un periodo di prova, la graduatoria di “uscita” è la medesima della graduatoria di “entrata” ed i candidati devono effettuare, al termine del periodo di formazione, un colloquio volto a valutare l’idoneità del candidato alle funzioni giurisdizionali.
Il carattere probatorio del tirocinio e il fatto che i candidati siano considerati, durante lo stesso, dei magistrati in tirocinio e non degli uditori giudiziari, permette quindi di qualificare tale sistema di accesso come ibrido.
III. L’integrazione diretta nel corpo della magistratura
Esiste infine una modalità di accesso riservata a coloro che hanno già un’esperienza professionale giuridica di almeno 7 anni volta ad integrare la magistratura in modo diretto, senza quindi effettuare il periodo di formazione presso l’ENM.
La disciplina di tale modalità di accesso si rinviene all’articolo 22 dell’ordonnance del 1958.
In tal caso, previa una selezione dei candidati sulla base dei titoli, i candidati effettuano sei mesi di tirocinio generico presso un tribunale, durante il quale sono valutati nelle funzioni svolte. Al termine di tale tirocinio e di un colloquio generale, viene espresso un parere sull’idoneità o non idoneità del candidato all’integrazione diretta.
Si tratta, anche in questo caso di un tirocinio di prova, tuttavia i candidati integrano direttamente la magistratura, senza effettuare il periodo di formazione (generica e specifica) all’ENM.
[1] Vi sono altre fonti relative all’accesso alla magistratura come il decreto n°2001-1099 del 22 novembre 2001 relativo alle modalità di assunzione dei magistrati previsto all’articolo 21-1 dell’ordonnance, il decreto del 22 novemvre 2001 come modificato dai dei decreti del19 aprile 2011, del 10 marzo 2016, del 24 luglio 2018 e de 10 aprile 2019 relativi ai concorsi per l’assunzione dei magistrati previsti all’articolo 21-1 dell’ordonnance.
[2] Tale titolo, sebbene non sussista più in diritto italiano, permane in diritto francese e non vi sono, almeno attualmente velleità governative o di settore, volte a modificare tale denominazione.
[3] Per un esame generale della commission volta a effettuare la selezione dei candidati, vedasi l’ultima relazione disponibile : https://lajusticerecrute.fr/sites/default/files/2023-01/Rapport%20d%27activit%C3%A9
%202021-2022.pdf.
[4] Articolo 15 de l’ordonnance.
[5] Articolo 16 dell’ordonnance.
[6] Articolo 17 dell’ordonnance.
[7] Ibid.
[8] Articolo 18-1 dell’ordonnance.
[9] Accessibile al seguente indirizzo: https://www.enm.justice.fr/sites/default/files/sequencage_fi.pdf. Tuttavia, tale decomposizione può leggermente variare di anno in anno.
[10] La prova di inglese consiste nel superamento della prova di inglese TOEIC (Test of English for International Communication.
[i] Giudice presso il Tribunale di Créteil

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
