
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Prova-mv, motivazione-mv e linguaggio a verità aumentata-mv[1]
Sommario: 1 Ragioni dell’apice-mv - 2. Le cose-mv che possono formare oggetto di prova-mv o di motivazione-mv - 3. Il metodo matematico-mv della prova-mv e della motivazione-mv (la norma d’uso di sé-mv) – 4. Il codice Versiglioni 2.0. - 5. Il codice Versiglioni 3.0 (anticipazione) - 6. Conclusione.
1. Ragioni dell’apice-mv
Il titolo della relazione Prova-mv, motivazione-mv e linguaggio a verità aumentata-mv suggerisce di porre un cenno preliminare alle ragioni dell’apice (-mv). L’economia di questo intervento non consente di illustrare il linguaggio a verità aumentata-mv[2], le sue ragioni esistenziali, la sua tassonomia, le sue nomenclature, i suoi simboli matematici e i suoi segni (tra i quali, appunto si pone anche l’apice-mv).
Posso però evidenziare che le lettere m e v identificano casualmente l’inventore. Come dirò, le funzioni di quelle lettere sono invece concettuali, linguistiche e in-formatiche[3].
In effetti, e vengo al tema odierno, è noto che il «Problema della prova» e il «Problema della motivazione» intersecano il «Problema del giudizio» che interseca il «Problema della verità» che, a sua volta, interseca il «Problema del linguaggio». L’ipotesi che propongo è che i problemi giuridici, ivi inclusi quelli della prova e della motivazione, tendono a divenire dilemmi o drammi, come racconta la letteratura, anche perché sono affrontati con linguaggio naturale. In effetti, il linguaggio naturale è tendenzialmente assolutizzante e tale peculiarità crea conflitto.
Tra l’altro, iniziando a incamminarmi nell’irto sentiero tracciato per questo contributo, il linguaggio naturale non è compatibile con un nuovo concetto di diritto che (con linguaggio a verità aumentata-mv) chiamo diritto-mv, e che è diverso dal concetto tradizionale che (con linguaggio naturale) tutti chiamano diritto. Questo perché il diritto-mv [è costituito da una famiglia di insiemi a struttura tipologica, ossia da strutture concettuali e linguistiche necessariamente relazionali]-mv [4]. In breve, diritto e diritto-mv sono due cose tra loro simili ma non coincidenti o uguali. Ad esempio, mentre diritto è diritto, ossia termine aleticamente assoluto, diritto-mv è invece termine aleticamente relativo, in quanto diritto-mv può essere diritto con verità-mv o diritto senza verità-mv [5]. Analogo è il rapporto che corre tra prova e prova-mv, motivazione e motivazione-mv.
Più in dettaglio, l’uso della parola prova (al naturale) implica il dilemma che dietro quella parola possano annidarsi concetti tra loro esistenzialmente dissimili, ovvero qualitativamente o quantitativamente differenti. Questo dilemma terminologico è fonte di incertezza o di soggezione, e insorge in chiunque affronti, ovunque e in ogni tempo, qualunque problema giuridico mediante linguaggio naturale (come fa l’essere umano) o, similmente, mediante linguaggio correlazionale (come fa l’umanoide). Insomma, i termini giuridici espressi da ogni essere umano con linguaggio naturale sono fortemente ambigui, vaghi, equivoci, incerti, in uno, arbitrari. Talvolta, addirittura, frutto di libero arbitrio. Lo stesso capita all’umanoide. Da ciò, l’ipotesi di conferire al comunicare-mv (ma anche al pensare-mv, come dirò tra breve) nuove forme-mv, nuovi segni-mv, nuovi suoni-mv, all’uopo codificate-mv e identificate, post codificazione-mv, dall’apice-mv.
2. Le cose-mv che possono formare oggetto di prova-mv o di motivazione-mv
Fatta questa doverosa premessa linguistica, mi accingo ora a trattare i concetti oggetto di esame.
Vorrei segnare almeno un paio delle numerose differenze che corrono tra prova e prova-mv, nonché tra motivazione e motivazione-mv.
In primo luogo, ed è questa una delle più importanti novità dell’ipotesi che propongo, chi si accinge a provare o a motivare deve-mv, prima di tutto, qualificare le cose-mv o, meglio, il tipo aletico delle cose-mv, che possono formare oggetto della prova-mv o della motivazione-mv.
In effetti, ragionando o comunicando naturalmente, non c’è pensiero o atto linguistico, concetto o parola, conoscenza o comunicazione, giudizio o comando, la cui prova o la cui motivazione non ponga da millenni il problema della “sua” verità. Verità che, intanto, con linguaggio ibrido, può essere così qualificata: Qual. {La verità (in senso naturale) è una proprietà possibile, positiva o negativa, ma non necessaria, perché suscettibile di assenza}-mv.
Tanto che, la filosofia classica ha distinto tra cose delle quali è predicabile la verità e cose delle quali, invece, non è predicabile la verità. Ma molti filosofi hanno sin dall’antichità osservato e osservano tuttora che, anche laddove fosse davvero «figlia del tempo», la verità nulla aggiungerebbe e nulla toglierebbe a ciò che l’essere umano (e oggi l’umanoide) osserva alla luce di essa. Più in dettaglio, varie correnti di pensiero sostengono – in modo a mio avviso non condivisibile – che, generalmente, “le cose sono così come sono”, a prescindere da tale asserita proprietà.
Vien da pensare, perciò, che, forse, anche per tale motivo, la parola verità sia così raramente usata nei manuali giuridici, nelle sentenze o nei provvedimenti amministrativi. In effetti, almeno in termini naturali, persino ciò che tutti chiamano diritto è cosa tradizionalmente considerata “essere, così com’è”, vale a dire come data dall’autorità, a prescindere, cioè, dalla sua verità.
Tesi questa - appunto assolutizzante - che, invece, è sempre sembrata obiettivamente non condivisibile, in specie a partire dal secondo dopoguerra mondiale. In effetti, almeno nel così detto “occidente”, da molti decenni: [la validità del diritto dipende, in modo necessario, dalla sua attitudine a rendere vera la relazione tra sé e un parametro relazionale di verità, sia esso costituzionale, europeo o internazionale]-mv.
Ciò significa che, per forza di cose, esiste diritto con verità-mv, e che tale diritto (cui fa da complemento al diritto senza verità-mv) qualifica cose-mv suscettibili di divenire oggetto di prova-mv o di motivazione-mv [enti o entità materiali o immateriali, viventi o non viventi, naturali o non naturali, spirituali o non spirituali, razionali o non razionali e così, ad esempio, pensieri o atti linguistici, conoscenze o comunicazioni, norme o leggi, giudizi o comandi e altre non numerabili simili cose]-mv.
Perciò, una prima conclusione è che le cose oggetto di prova sono diverse dalle cose-mv oggetto di prova-mv. Corollario ne è che è rilevante ed efficace sia la funzione concettuale, sia la funzione semantica dell’apice -mv.
Una seconda conclusione è che la distinzione tra diritto con verità-mv e diritto senza verità-mv implica anche un nuovo ambito di esistenza della prova-mv, che include anche la prova-mv del diritto-mv. Infatti, la prova-mv, diversamente dalla prova, non opera soltanto nel diritto, ossianei fatti-mv delle sue attuazioni concrete. In definitiva, questa proprietà mentre appartiene alla prova-mv, non appartiene invece alla prova. Analoga conclusione può ricavarsi per la distinzione tra motivazione e motivazione-mv.
3. Il metodo matematico-mv della prova-mv e della motivazione-mv (la norma d’uso di sé-mv)
In secondo luogo, vorrei occuparmi del carattere funzionale, ossia dinamico, che il linguaggio a verità aumentata-mv associa al termine prova-mv e al termine motivazione-mv.
Si tratta dell’intuizione di fondo che anima l’ipotesi-mv e che sta nel rovesciamento metodologico-mv (scoperto tra il 2005 e il 2007), secondo cui [è la logica della cosa (ossia, la cosicità) che implica la logica della prova o della motivazione e non viceversa]-mv come, invece, per lo più si pensava tradizionalmente e ancora per lo più si pensa.
Questo algoritmo logico è stato poi specificato nel 2020. Nei diritti con verità-mv [tra la logica della cosa (la cosicità) e la logica della prova (la provabilità) o della motivazione (la motivazionalità) esiste una relazione univoca identificabile matematicamente, perciò di volta in volta verificabile come vera o falsa]-mv. Del resto, in ipotesi, proprio la apofanticità-mv del diritto è la proprietà che distingue i diritti con verità-mv, prevalenti nei paesi c.d. “democratici”, dai diritti senza verità-mv, invece prevalenti nei paesi c.d. “non democratici”. Dunque, la verità-mv gioca un ruolo fondamentale, direi imprescindibile, nella società e nell’economia, prima che nell’esperienza giuridica.
D’altra parte, la verità costituisce da sempre il Problema di tutti i problemi. Neppure tradizioni o evoluzioni millenarie sono riuscite a dotare l’essere umano (e oggi l’umanoide) di strumenti idonei a superare o risolvere il «Problema della verità». In specie, quando occorre dare la prova o la motivazione di una cosa-mv. Così, ad esempio, è ancora controverso persino il rapporto che corre tra la verità greca (alétheia = ciò che è) e la verità romana (veritas = ciò che è conforme ovvero veritas = ciò che ha riguardo). Rapporto, questo, la cui obiettiva incertezza è poi ampliata dal fatto che in Italia il lemma verità include singolare e plurale.
La dubbiosità che deriva dal Problema della verità ha sempre condizionato e tutt’ora condiziona in ogni contesto, in specie in quello della prova e della motivazione, il confronto agonistico tra le differenti teorie. A partire dai modi del pensare, dalle forme del ragionamento, dai tipi dei veicoli comunicativi, sino a giungere ai criteri di giudizio, ai canoni interpretativi, agli standard probatori, agli iter logico-motivazionali (…) di ogni operatore giuridico (legislatore, cittadino, giudice, studioso etc).
Per esemplificare, si pensi ai dilemmi: verità formale o verità sostanziale? Verità certa o verità probabile? Verità identità o verità corrispondenza? Verità coerenza o verità consenso? Verità fattuale o verità giuridica? Verità materiale o verità processuale? O, ancor prima, a che può servire la verità, se non è di questo mondo? La verità è solo un mito? O piuttosto è un orizzonte, non raggiungibile ma utile?
Dilemmi che si pongono identicamente per la prova o per la motivazione: prova formale o prova sostanziale? Prova statistica o prova retorica? E così via dicendo. Dilemmi, più in generale, che sorgono quotidianamente ogni volta che l’essere umano (o l’umanoide) è tenuto a “dire la verità”, o perché si impegna volontariamente a farlo o perché deve farlo.
Così, nella prospettiva pluralista, non negazionista, non deflazionista e non monista che questa ipotesi-mv adotta (e che la rende anche per questo falsificabile) tutto ciò implica porre a sé stessi innanzi tutto l’interrogativo: quale verità? E non già l’interrogativo: quanta verità?Infatti, quest’ultimo interrogativo che ancora molti teorici si pongono, così come fa l’intelligenza artificiale, appare invece incompatibile con i valori fondativi dei diritti con verità-mv.
Ecco, dunque, una terza conclusione: tutti i Problemi che ho sin qui nominati si traducono in un problema di metodo: [trovare il metodo che combina correttamente ogni cosa alla sua verità, qualitativamente intesa]-mv. Infatti, le numerose concezioni di “verità” sin qui singolarmente professate dai teorici della verità, da Parmenide sino ai nostri giorni, non sembrano affatto riconducibili o riducibili l’una all’altra. Così, nella vita comune, come nelle sedi decisionali o giudiziali, cognitive o deliberative, ideali o pratiche (…) esse per lo più collidono tra loro.
Al punto che l’essere umano (e soprattutto l’umanoide) o non ricorre affatto alla verità o, se vi ricorre, sceglie, tra “le” verità filosofiche, “la” (sua) verità. Ma lo fa in modo imperscrutabile, seguendo la via dell’arbitrio, dell’ambiguità o della vaghezza, dunque, in modo soggettivo, deterministico o casuale, comunque incontrollabile. Cosa che accade anche all’essere umano che prova o motiva usando il linguaggio naturale e all’umanoide che prova o motiva usando il linguaggio correlazionale.
Da tutto ciò sorgono le ragioni di questa ricerca ormai ventennale. Tipizzare, ordinando in modo isometrico, formale, logico-matematico e, al contempo, senza nascondimento, le norme d’uso di sé stesse-mv delle verità poste all’interno dell’ampio spettro concettuale fornito dalla filosofia e costruire le categorie delle verità-mv attraverso fattori principali o mediante altre analoghe tecniche tassonomiche [6]. Più in dettaglio, rovesciare i metodi classici di approccio monistico al «Problema della verità»; ricostruire la natura tipologica o insiemistica del concetto filosofico di verità; identificare entro un quadro logico formale i tipi o gli insiemi delle verità-mv e associare a essi, mediante determinanti analogiche, i tipi o gli insiemi di verità matematiche-mv.
Così facendo, l’ipotesi-mv giunge a delineare un sistema formale, relativamente chiuso, di indici di verità-mv e di codici di verità-mv. Ecco, dunque, una quarta conclusione: [gli indici di verità-mv e i codici di verità-mv sono operatori essenziali del pensiero e del linguaggio umano o umanoide, così come delle relazioni tra cose, ivi incluso il diritto]-mv. Dunque, essi sono anche operatori essenziali della prova-mv e della motivazione-mv.
4. Il codice Versiglioni 2.0
Un’immagine tabellare del diritto matematico-mv così ottenuto può forse essere utile per farsi un’idea.
Ecco, dunque, un paio di tabelle che sono parte della ben più ampia grammatica-mv prodotta dal codice Versiglioni.
Tabella 1 - Verità matematiche-mv (linguaggio a verità aumentata-mv)
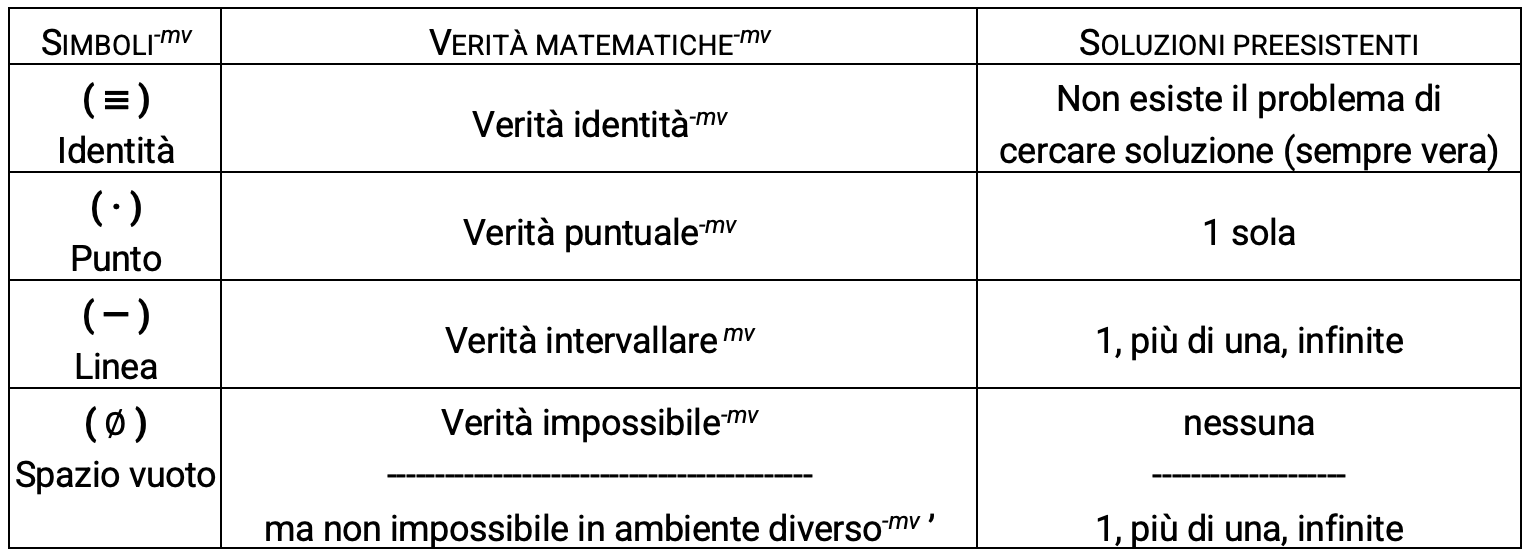
Tabella 2 – Verità filosofiche (dal linguaggio naturale al linguaggio a verità aumentata-mv)
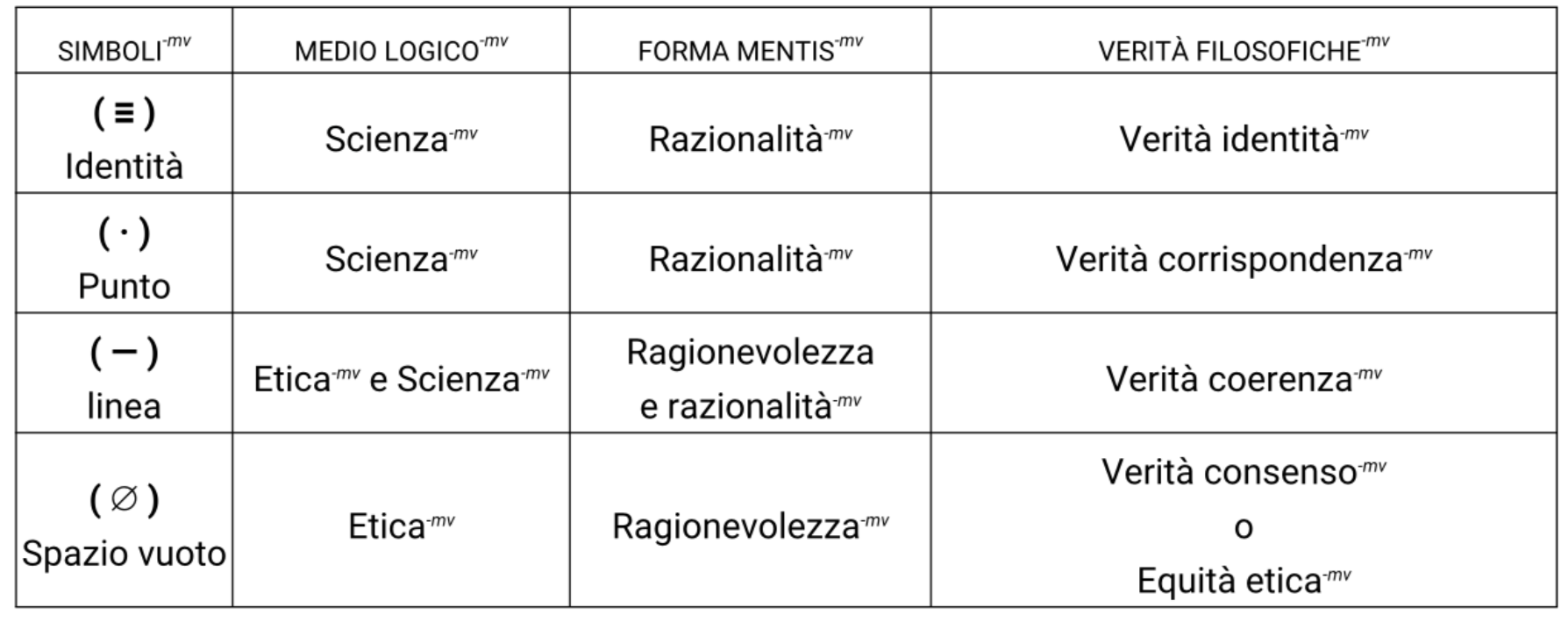
Rinviando per eventuali approfondimenti al sito https://marcoversiglioni.it o al sito https://dirittomatematico.it, se tuttavia si osserva l’ultima colonna della tabella 2, essa dimostra chiaramente che il codice Versiglioni rispetta, nel senso che recepisce, l’ampissimo pluralismo di idee e concezioni elaborate nei millenni riguardo alla verità. Infatti, identità, corrispondenza, coerenza e consenso costituiscono tipi di verità offerti dalla storia della filosofia e della letteratura, umanistica e scientifica. Tuttavia, questa ipotesi innova rispetto a ogni altra ipotesi, perché non si limita a elaborare una concezione nuova di verità, ma trova, decodifica-mv e codifica-mv un meta-codice-mv, ossia, appunto, una grammatica superiore de le-verità-mv , che ne tipizza i criteri, ne governa la convivenza, ne disciplina gli statuti, ne fissa gli effetti in termini di credibilità o di validità, sempre indicando (soltanto) il metodo-mv, tanto delle regole astratte e generali, quanto delle loro attuazioni concrete e speciali.
In effetti, poste in disparte le impostazioni scettiche o deflazioniste, la ricerca assume che le principali tradizioni colgano tutte aspetti parzialmente condivisibili del fenomeno della conoscenza e della comunicazione umana e della relazionalità tra cose, così come del fenomeno giuridico, tant’è che, ad esempio, questo è qui così descritto: Qual. [il diritto è una famiglia di insiemi retta dal perenne mutevole combinamento di differenti tipi di verità e di falsità o di assenze di verità-mv]
Più in generale, la vista di queste tabelle dovrebbe trasmettere da sé almeno il senso della funzione del codice Versiglioni 2.0 (che risale al 2020).
Tuttavia, per agevolare la comunicazione, fornirò una qualificazione del codice-mv che descrive il suo ambito di esistenza e di applicazione affinché si possa meglio intuire che tale codice verte soltanto sul metodo-mv della prova-mv e della motivazione-mv.
Qual. {il codice Versiglioni è un meta-codice del metodo del pensare, del comunicare e del vivere dell’essere umano (umanità) o dell’umanoide (umanoidità) che consente di affrontare il «Problema della verità» di qualunque cosa (cosicità,, dirittocità, provabilità, motivazionalità..) attraverso un algoritmo (rectius: una norma d’uso di sé) di natura logico-matematica}-mv.
In concreto il codice-mv funziona e produce un proprio output codificato-mv di natura legistica (ad es., una legge con verità-mv)[7] o di natura attuativa (ad es., una sentenza con verità-mv )[8].
Dunque, un meta-codice che, a differenza dell’Intelligenza artificiale, non si pone l’illusione di produrre ogni volta “la” soluzione di merito. Un meta-codice, perciò particolarmente utile alla prova-mv o alla motivazione-mv perché in grado di codificare-mv, ogni volta, il metodomatematicamente corretto-mv o la direzione geometricamente corretta-mv per trovare la soluzione di merito (a prescindere dal se, poi, la si trovi o meno, a prescindere, cioè, dal fatto che la soluzione trovata sia vera-mv o falsa-mv).
In effetti, in sintesi estrema, nient’altro che il codice-mv che:
Def. [dà al dado la sua chiave, alla vite il suo cacciavite, alla non controvertibilità la sua razionalità, alla controvertibilità la sua ragionevolezza]-mv.
5. Il codice Versiglioni 3.0 (anticipazione)
Come si è potuto notare, il codice Versiglioni 2.0, pur trovando premessa di sé nella distinzione tra diritti con verità-mv e diritti senza verità-mv, è tuttavia, almeno positivamente, dedicato ai diritti con verità-mv. In realtà, Qual.: {un codice che intendesse comprendere e spiegare tutto ciò che chiamiamo sinteticamente diritto dovrebbe essere astrattamente idoneo a raccogliere in sé e a spiegare da sé quel ‘tutto’, così come quel ‘punto’, che è necessario a un codice che implichi unità e pluralità[9]}-mv. Dunque, dovrebbe poter funzionare efficacemente sia se la cosa fosse senza verità-mv, sia se la cosa fosse con verità-mv.
Proprio alla luce di questa esigenza, posta prima di tutto dal vero Metodo scientifico, ho recentemente completato la versione 3.0 del codice Versiglioni. Si tratta di un sistema chiuso e universale (immaginabile geometricamente come un cerchio o una sfera) in grado di comprendere e spiegare l’orientamento o il disorientamento, l’attrazione o la repulsione, l’appartenenza o la non appartenenza etc.: in sintesi, Qual. [un codice di computazione quantistica, logica o illogica, a base qualitativa]-mv.
Più in dettaglio, un codice capace di sistemare e spiegare anche cose senza verità-mv quali sono le cose frutto di arbitrio o di libero arbitrio (ad esempio le funzioni ordinanti o imperative) o le cose casuali (ad esempio, l’imperscrutabile correlazione che normalmente si trova tra un altissimo numero di elementi tra loro eterogenei, che è carattere fondativo dell’intelligenza artificiale).
Dell’immagine di questa nuova versione 3.0 del Codice Versiglioni (che forma oggetto di una monografia di prossima pubblicazione), fornisco qui l’anteprima.
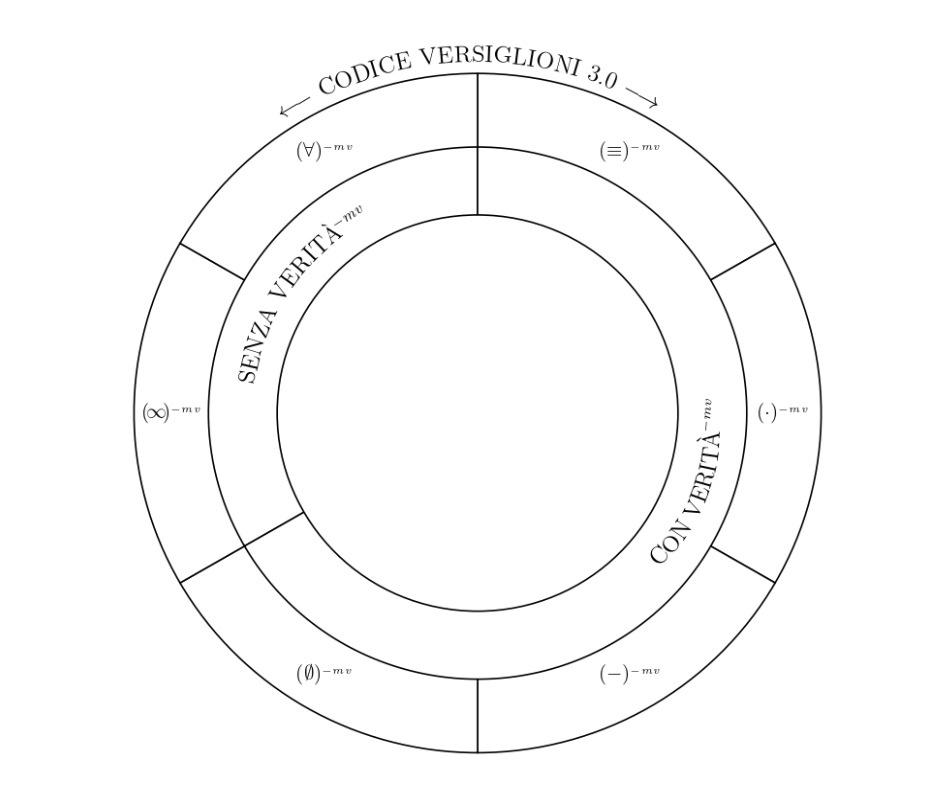
Per ciò che concerne il diritto-mv, questa versione del codice Versiglioni produce sempre un output di validità/invalidità metodologica-mv, sia che lo si usi per creare il diritto-mv, sia che lo si usi per applicare il diritto (dunque per provare e motivare), sia esso un diritto-mv a forma costituzionalizzata e multilivello (con verità-mv), sia esso un diritto a forma autoritaria e mono livello (senza verità-mv). Il codice Versiglioni 3.0 è un meta-codice-mv degli indici e dei codici di verità-mv che offre alla scelta di metodo una piattaforma, meta-logica o meta-normativa, di natura essenzialmente pratica.
Questa piattaforma è capace di integrare (senza confonderle) e gestire (con metodo matematico-mv) le tradizionali dimensioni formali, assiologiche e/o epistemiche che concorrono alla produzione di qualunque discorso o ragionamento umano, compreso quello giuridico, cosìcome di qualsiasi relazione tra cose ovvero tra esseri umani, umanoidi e cose.
6. Conclusione
Il Linguaggio a verità aumentata-mv è il linguaggio che incorpora contenuti e veicoli che sono indispensabili alla prova-mv e alla motivazione-mv (intese, entrambe, come cose-mv non coincidenti, rispettivamente, con la prova e la motivazione espresse con linguaggio naturale). Tale linguaggio-mv è il prodotto di un algoritmo ossia di un codice denominato codice Versiglioni.
Il codice Versiglioni non coltiva il mito tradizionale fatto di classifiche metodologiche, di regole di priorità o di standard di giustificazione che stabiliscano quando e come un codice di verità prevalga sugli altri, e quali oneri argomentativi gravino sull’interprete che intenda discostarsene, addirittura soppesando probabilisticamente le capacità aletiche attribuite ai vari codici in modo almeno deterministico. Via, questa, che è stata tentata fin dagli albori dell’esperienza umana, ivi inclusa quella giuridica, ma che a questa lunga ricerca è sempre apparsa e continua ad apparire illusoria, anche alla luce dei tratti che caratterizzano i linguaggi informatici odierni, in specie se prodotti dall’intelligenza artificiale.
A differenza di quanto sovente accaduto in passato, la novità del modello-mv che qui si propone non sta tanto in una nuova, ennesima, ipotesi sul concetto unitario di verità (e dunque di prova o di motivazione) ritenuta soggettivamente preferibile o logicamente più efficiente rispetto alle precedenti. La novità del modello-mv sta invece nel proporre una grammatica di reciproca e condivisa sostituzione e, al tempo stesso, di convivenza tra linguaggi di verità differenti ma iso-ordinati e funzionalmente equivalenti o equipollenti sia sul piano aletico, sia sul piano probatorio o motivazionale.
Una matrice pratica di priorità metodologica, che impedisce sia il formalismo esasperato, sia il valorialismo senza vincoli, che ricorda all’homo di possedere in sé (e dunque usare) un algoritmo-mv che, come una bussola-mv, segna la direzione metodologica del pensiero o della comunicazione, dell’esperimento o dell’argomento ovvero, persino, del sofismo meramente persuasivo.
Un algoritmo che rende possibile alle cose-mv di relazionarsi in modo innato con tutto ciò che le circonda o che ognuna di esse circonda.
Il codice Versiglioni, in tal senso, non è un nuovo codice di verità che soppianta gli altri, ma un codice dei codici-mv, perciò, un meta-codice-mv, cioè una scienza-mv e/o un’etica-mv regolativa che, attraverso il suo algoritmo (la norma d’uso di sé-mv) governa l’uso dei codici già in campo, anche se diversamente formalizzati e sistemati. In definitiva, l’ipotesi che propongo è che, nel futuro tecnologico (digitale o quantistico) che è probabile attendersi, l’essere umano, se volesse ovunque votarsi alla convivenza e alla pace, dovrebbe scoprire e usare il codice delle verità-mv che è già presente in lui, ma che lui non sa ancora di possedere, codice-mv che è idoneo da sé a consentire, a tutti, di dialogare attivamente a verità aumentata-mv.
Tutto ciò servirebbe a comprendere il linguaggio a verità aumentata-mv di cui dovrebbe essere dotato un nuovo tipo di umanoide (l’umanoide-mv). Sia laddove, ossia nei discorsi con verità-mv, necessita un impegno soggettivo alla verità-mv, sia laddove, ossia nei discorsi senza verità-mv, un tale impegno non necessita.
In conclusione, tornando all’antico da cui ero partito, risalendo cioè al piano etimologico, il codice Versiglioni si propone quale codice delle verità-mv idoneo a decodificare finalmente il legame, altrimenti incerto, tra la concezione della verità come esperienza ontologica relativa a leggi che regolano la natura e la morale, così come tramandata dalla cultura greca (ἀλήθεια) e la concezione della verità come criterio epistemico di giudizio (di conformità o di riguardo) tramandata dalla cultura romana (veritas).
Tutto ciò, lasciando convivere verità e verità-mv, dando a ciascun lemma il suo e ricevendo da ciascun lemma il suo-mv, vicendevolmente, con moto perpetuo. Così che si attuino in modo pacifico e contestualizzato la tradizione e l’evoluzione: dal passato di ἀλήθεια e di veritas, al presente di verità e al futuro, sperato, di verità-mv [la cui perpetua, ma ordinata, mutevolezza pare forse il punto, come il tutto, nel quale si svela la congiunzione tra l’assoluto e il relativo di sé].
[1] Il testo del presente articolo corrisponde al testo della relazione svolta nel corso del Convegno “Prova e motivazione” tenutosi nell’Università di Perugia in data 21 novembre 2025.
[2] Per eventuali approfondimenti, v. M. Versiglioni, Codice Versiglioni e verità aumentata-mv. Una teoria generale del diritto che c’è (e che forse sarà), in Giocare con altri dadi. Giustizia e predittività dell’algoritmo, Torino, 2024, 291 ss. Id., M. Versiglioni, Codice Versiglioni. Dal linguaggio naturale al linguaggio matematico-mv in Il Pensare - Rivista di filosofia, 2023, 393 ss.
[3] In generale, l'apice -mv lavora come un modello architetturale nel software per computer che facilita la separazione dello sviluppo dell'interfaccia utente grafica (GUI), sia tramite un linguaggio di markup che un codice GUI, dallo sviluppo della logica di back-end (il modello), in modo tale che la vista (che comunica con il linguaggio naturale) non dipenda da alcuna piattaforma specifica del modello, anche se è, in realtà, derivazione, applicazione o comunque parte del modello (che invece comunica con linguaggio informatico). Più precisamente, l'apice -mv funge da intermediario tra il lemma, il termine, la frase, l'espressione, il concetto (naturalmente visibile) ecc. e il modello linguistico (non naturalmente visibile), che, nel nostro caso, cioè in ambito giuridico, è costituito da un insieme linguistico matematico chiamato diritto-mv o diritto matematico-mv, i cui singoli elementi sono definiti o qualificati dal codice Versiglioni. D'altra parte, l'apice -mv inverte la modalità d'uso classica (che avrebbe dovuto portare al diverso apice -vm); ma fortuna vuole che si possa creare un unicum che, anche per evitare confusione, identifichi l'invenzione con le rispettive lettere iniziali del nome e cognome dell'autore (appunto, M e V).
[4] Per evitare l’insorgere di eccessive ridondanze, l’apice (-mv) è usato quando necessario od opportuno e, comunque, nelle [definizioni] e nelle {qualificazioni} viene collocato solo sulla parentesi chiusa, anche quando la frase tra parentesi contiene termini o espressioni, concetti o strumenti, che, se usati singolarmente, sarebbero stati taggati con l’apice-mv.
[5] Per eventuali approfondimenti relativamente a questa ipotesi ricostruttiva di ciò che comunemente chiamiamo diritto, si propone il rinvio a M. Versiglioni,Diritto matematico-mv. Diritto Con verità-mv e Diritto Senza Verità-mv, Pisa, 2020, passim
[6] Esigenza manifestata inizialmente nella ricerca dedicata alla nozione tipologica dell’interpretazione, ossia M. Versiglioni, L’interpello nel diritto tributario, Perugia, 2005 e poi proseguita nella ricerca dedicata alla nozione tipologica della prova, Id., Prova e studi di settore, Milano, 2007. Fonti, queste, oggi liberamente consultabili nel sito https://marcoversiglioni.it.
[7] Come esempio di applicazione pratica del Codice Versiglioni in sede legistica può eventualmente vedersi M. Versiglioni, Appunti sul processo matematico-mv: l’accordo giudiziale-mv in giusmatematichese-mv, in Riv. tel. dir. trib., 2020; Id., Accordo matematico e sentenza matematica tra complementarità, equivalenza e alternatività, in Unità e pluralità del sapere giuridico, 2022, 109.
[8] Come esempio di applicazione pratica del Codice Versiglioni in sede giudiziale (o applicativa del diritto) può eventualmente vedersi M. Versiglioni, Abuso del diritto. Logica e Costituzione, Pisa, 2016 o, tra gli altri esempi reperibili nel sito www.dirittomatematico.it, M. Versiglioni, Dirittomatematico.it. L’algoritmo del dovere di contraddittorio preventivo, in Riv. tel. dir. trib., 2019.
[9] Per la dimostrazione pratica di questa attitudine, con riferimento alla legislazione sugli accordi complementari di cui alla recente riforma Cartabia, ossia per un’applicazione del criterio scientifico che passa per l’unione dell’affermazione e della negazione, v. Versiglioni, Accordo matematico e sentenza matematica, cit., p. 114 ss.
Immagine: particolare da René Magritte, La firma in bianco, 1965.
Il rapporto tra ricorso al mercato e affidamento in house: un’interpretazione degli artt. 14 e 17 del Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali, decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (nota a sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, sez. I, sentenza n. 230 del 2025)
di Lorenzo Ferretti
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Servizi pubblici locali e in house providing: il TAR Marche ribadisce la preferenza per il ricorso al mercato – 3. Gerarchia tra i modelli di gestione: la rigorosa posizione dell’AGCM. – 4. Conclusioni
1. Introduzione
L’evoluzione della disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali continua a sollevare questioni non solo tecniche, ma anche di organicità del diritto positivo, specialmente con riferimento al modello dell’in house providing, oggetto della pronuncia del TAR Marche in commento. Il caso affrontato – l’annullamento della delibera con cui l’ATA ATO 2 di Ancona aveva optato per l’affidamento diretto del servizio di gestione dei rifiuti – si colloca in un contesto di persistente tensione tra autonomia organizzativa degli enti locali, principi concorrenziali e vincoli procedurali[1].
All’interno di tale quadro, merita attenzione l’art. 17 del TUSPL[2], che introduce un onere motivazionale rafforzato con riguardo ai soli affidamenti in house sopra soglia. La scelta legislativa ha suscitato riflessioni in dottrina[3], nella misura in cui sembra presupporre che l’esigenza di un controllo più penetrante sulla deroga al mercato si manifesti unicamente oltre determinate soglie economiche, mentre il principio generale di tutela della concorrenza sembrerebbe suggerire una più ampia considerazione delle motivazioni che giustificano l’affidamento diretto del servizio. L’individuazione di una possibile ratio di tale delimitazione normativa appare, pertanto, un terreno particolarmente interessante per la riflessione esegetica.
La sentenza in commento contribuisce ad arricchire il dibattito, poiché valorizza il ruolo centrale della fase preliminare del procedimento di affidamento, disciplinata dall’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 (TUSPL). È in questo momento che si colloca la scelta del modello di gestione, in cui la relazione istruttoria è chiamata a verificare in termini concreti la rispondenza della soluzione organizzativa all’interesse generale. L’obbligo motivazionale sancito dall’art. 14 assume così una funzione essenziale, ponendosi quale snodo logico attraverso cui valutare la coerenza e la trasparenza dell’azione amministrativa.
La pronuncia offre quindi l’occasione per interrogarsi sul rapporto tra gli oneri motivazionali di cui all’art. 14 e quello ulteriore previsto dall’art. 17, consentendo di ipotizzare un’interpretazione sistematica degli articoli appena menzionati. In quest’ottica, la valutazione comparativa imposta dall’art. 14 potrebbe contribuire a rendere meno netta la distinzione tra affidamenti sopra e sotto soglia, suggerendo la potenziale estensione della giustificazione del mancato ricorso al mercato anche agli affidamenti in house di minore valore economico. La riflessione avviata dalla decisione del TAR Marche sembra dunque porsi in linea con tale possibile ricomposizione sistematica.
In tale prospettiva, l’analisi dell’interpretazione coordinata che deriva dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 sembra suggerire una possibile configurazione del modello in house, indipendentemente dalla consistenza economica, come soluzione caratterizzata da un controllo motivazionale di maggiore intensità rispetto ad altre forme di gestione del servizio pubblico locale. L’esame della normativa vigente e delle più recenti tendenze giurisprudenziali, unitamente al ruolo attivo dell’AGCM[4], mostra come l’attenzione nei confronti della giustificazione della scelta in house si stia progressivamente consolidando, lasciando emergere un orientamento che merita di essere ulteriormente approfondito anche alla luce della decisione del TAR Marche.
L’analisi consente, inoltre, di valorizzare il rilievo che assume il principio di concorrenza nell’assetto attuale dei servizi pubblici locali[5]: viene riaffermata la necessità di una istruttoria comparativa effettiva, concreta e trasparente, idonea a dimostrare la rispondenza della scelta all’interesse pubblico e a prevenire approcci motivazionali puramente formali o stereotipati. Nel solco di queste direttrici, la presente nota si propone di offrire una lettura critica della pronuncia, al fine di mettere in luce le principali implicazioni sistemiche e applicative che essa può determinare per il diritto amministrativo dei servizi pubblici locali.
2. Servizi pubblici locali e in house providing: il TAR Marche e il rapporto tra art. 14 e art. 17 TUSPL
Con la sentenza in commento, il TAR Marche ha annullato la delibera n. 16/2024 con cui l’ATA ATO 2 – Ancona aveva disposto l’affidamento in house del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto da una società mista operante nei settori idrico, ambientale e della distribuzione del gas, che aveva interesse a prendere parte a una eventuale procedura di gara. La doglianza, pur formalmente riferita alla violazione dell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, è stata riqualificata dal giudice alla luce dell’art. 14, comma 3, che disciplina la fase preliminare di individuazione della forma gestionale del servizio[6]. Tale disposizione prevede la stesura, da parte dell’ente competente, di una relazione istruttoria preventiva, completa e comparativa tra le diverse modalità astrattamente percorribili (gara, società mista, in house), dalla quale devono emergere in concreto le ragioni della scelta effettuata.
Nel caso di specie, il TAR ha rilevato l’assenza di una valutazione effettiva delle alternative, osservando come la relazione si limitasse a valorizzare l’esperienza dell’attuale gestore (società in house) senza un confronto sostanziale con modelli differenti[7]. In quest’ottica, sono state ritenute non sufficienti anche le argomentazioni legate a sinergie operative o effetti occupazionali, in quanto prive di un supporto analitico e documentale[8]. È stato inoltre ribadito che l’utilizzo di format standard predisposti da ANAC non può sostituire l’obbligo motivazionale imposto dal legislatore[9].
Nel complesso, la pronuncia riafferma la centralità della fase preliminare di individuazione del modello gestionale, evidenziando come, indipendentemente dal modello poi prescelto, l’amministrazione sia vincolata a un’istruttoria reale e comparativa, condizione indefettibile di legittimità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 14 TUSPL.
La decisione fonda, dunque, il proprio dictum sulla violazione dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022, che regola la fase di individuazione della forma di gestione del servizio, e non sull’art. 17, comma 2, relativo alla fase dell’affidamento in house sopra soglia. Tale lettura consente di approfondire il presunto carattere duale dell’onere motivazionale delineato dal TUSPL, articolato su due livelli: il primo, comune a tutte le modalità di gestione, centrato sulla relazione comparativa ex art. 14[10]; il secondo, specifico per gli affidamenti in housesopra soglia, disciplinato dall’art. 17[11].
La sentenza offre così lo spunto per chiarire la portata sistematica dell’art. 14, applicabile a tutte le forme di gestione e idoneo a proiettare anche sugli affidamenti sotto soglia le logiche motivazionali proprie del diritto eurounitario[12]. La norma impone, infatti, un’analisi comparativa fondata su parametri oggettivi e verificabili, includendo l’individuazione degli obblighi di servizio e dei meccanismi di compensazione economica. Un’istruttoria così rigorosa, prevista per tutte le modalità di gestione, potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia voluto collocarle su un piano di effettiva equivalenza. Tale equivalenza, tuttavia, è solo apparente[13]: proprio l’estensione della verifica comparativa ex art. 14 a tutte le soluzioni organizzative determina un innalzamento generalizzato del livello di motivazione richiesto, che finisce per incidere in modo più marcato sull’in house.
La scelta di fondare l’annullamento sull’art. 14 e non sull’art. 17 segna, quindi, il punto interpretativo decisivo. Così facendo, il giudice non neutralizza l’onere motivazionale rafforzato previsto per l’in house[14], ma lo anticipa nella fase di scelta del modello gestionale, rendendolo di fatto applicabile anche agli affidamenti sotto soglia. Ne risulta che quella che appare come una parificazione tra modelli gestionali si traduce, in realtà, in una dinamica asimmetrica: il peso della giustificazione richiesta – dimostrare la convenienza del mancato ricorso al mercato – grava esclusivamente sull’in house, mentre le forme che ricorrono al mercato ne sono per definizione esentate. In questo modo, l’art. 14 diventa il veicolo attraverso cui l’onere ex art. 17 si espande oltre i suoi confini originari, trasformando la relazione istruttoria in un presidio di controllo penetrante che condiziona la praticabilità del modello e ne rafforza la subordinazione strutturale.
Particolarmente significativa, in questa prospettiva, è la constatazione per cui l’art. 14 diventa il mezzo attraverso cui le prescrizioni specifiche dell’art. 17 si rendono applicabili anche agli affidamenti in house sotto soglia[15], non già in ragione dell’assenza di una disciplina motivazionale ad essi specificamente dedicata, ma perché la struttura stessa dell’art. 14 ricomprende e anticipa le verifiche richieste dall’art. 17 per gli affidamenti sopra soglia. Ne deriva che le logiche di giustificazione proprie del diritto euro-unitario si proiettano fisiologicamente anche sugli affidamenti sotto soglia.
La relazione olistica tra l’art. 14 e l’art. 17 emerge con particolare evidenza se si considera l’orientamento giurisprudenziale che ammette la possibilità di assolvere l’onere motivazionale previsto dall’art. 17 mediante rinvio per relationem alla relazione istruttoria redatta ai sensi dell’art. 14[16]. Tale soluzione interpretativa è possibile solo perché l’art. 14, nella sua struttura e nei suoi contenuti, già ricomprende, in via generale, le verifiche richieste dall’art. 17 per gli affidamenti sopra soglia. Ne costituisce ulteriore conferma anche il piano economico-finanziario, richiesto tanto dall’art. 14, comma 4, quanto dall’art. 17, comma 4, quale strumento comune di verifica della sostenibilità economica: un elemento che accentua la convergenza tra i due livelli istruttori e rafforza l’idea di una sostanziale continenza dell’art. 17 nell’art. 14. Quest’ultimo, peraltro, non si limita ad assorbire le verifiche specifiche del 17: include contenuti ulteriori – come l’individuazione degli obblighi di servizio pubblico e dei criteri di compensazione economica – che lo qualificano come fulcro istruttorio dell’intero procedimento[17]. In questo quadro, la clausola di standstill prevista dall’art. 17, comma 3 – applicabile soltanto agli affidamenti sopra soglia – appare scarsamente giustificata[18], soprattutto considerando che anche la relazione ex art. 14 deve essere pubblicata ed è suscettibile di controllo da parte di ANAC, AGCM e operatori economici[19].
In definitiva, la pronuncia evidenzia che nell’attuale assetto normativo, il fulcro motivazionale risiede nella relazione ex art. 14, attorno alla quale ruota l’intero sistema di legittimità dell’azione amministrativa. L’art. 17, pur previsto come ulteriore presidio, rischia di ridursi a un adempimento formale, con una disciplina che, seppur orientata alla trasparenza, finisce per proiettare il proprio contenuto all’interno della relazione ex art. 14, determinando un aggravio procedurale che incide in via quasi esclusiva sul modello in house, anche sotto soglia, e che tende a comprimere in misura sensibile l’autonomia decisionale degli enti locali.
3. Gerarchia tra i modelli di gestione: la rigorosa posizione dell’AGCM
Pur essendo incentrata sulla violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 – norma comune a tutte le modalità di gestione – la sentenza in commento sembra iscriversi, seppur indirettamente, in quella linea giurisprudenziale che riconosce una posizione tendenzialmente subordinata del modello in house rispetto alle alternative di mercato[20]. Questa percezione di subordinazione risulta ora ancor più coerente se letta alla luce della dinamica interpretativa emersa nel paragrafo precedente: l’anticipazione dell’onere motivazionale rafforzato dell’art. 17 all’interno della relazione ex art. 14, e la sua conseguente applicazione anche agli affidamenti sotto soglia, accentuano la pressione istruttoria proprio sul modello in house, anche quando non ricorrono i presupposti formali per l’attivazione dell’art. 17 stesso.
Tale impostazione non è esplicitata in modo diretto dal TAR, ma traspare, innanzitutto, dal richiamo, operato in limine alla motivazione, all’“onere motivazionale rafforzato” che grava sull’amministrazione in caso di affidamento diretto, e che impone un “penetrante controllo della scelta effettuata (...) anzitutto sul piano dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche”[21] e, in secondo luogo, anche dall’inedita portata applicativa dell’interpretazione estensiva dell’onere motivazionale ai sensi dell’art. 14.
In questo contesto, il modello in house, pur formalmente equiparato ad altre forme gestionali, continua a essere percepito come una soluzione derogatoria, soggetta a condizioni più stringenti e a un grado di giustificazione particolarmente elevato[22]. La sentenza in commento non si pone, quindi, in linea di continuità con le più recenti interpretazioni del nuovo Codice dei Contratti pubblici, che valorizzano una lettura meno gravosa dell’affidamento in house sulla base del principio di autorganizzazione amministrativa sancito dall’art. 7 e nel solco dell’abrogazione del contenuto dispositivo dell’art. 192 della disciplina previgente, che imponeva, esplicitamente, di motivare il mancato ricorso al mercato[23]. L’equiparazione solo apparente tra le scelte di gestione trova conferma anche nel ruolo assunto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la cui prassi si è caratterizzata per un’attività di vigilanza particolarmente rigorosa nei confronti degli affidamenti diretti[24].
L’AGCM ha più volte sollevato rilievi critici in relazione all’inadeguatezza delle motivazioni addotte a supporto della scelta in house[25], evidenziando, tra le principali criticità: l’uso di schemi argomentativi standardizzati (come le matrici SWOT[26]), l’assenza di dati attendibili sulla gestione pregressa, la mancata certificazione dei piani economico-finanziari e, soprattutto, la tendenza a fondare la presunta convenienza dell’autoproduzione sul solo presupposto dell’assenza di utile[27].
Da ultimo, in riferimento al caso di specie, l’AGCM, su richiesta dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO 2 di Ancona, ha precisato che la scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale deve essere sorretta da una motivazione analitica, corredata – in caso di affidamenti in house sopra soglia – da piano economico-finanziario asseverato, con puntuale riferimento a qualità, costi, investimenti ed esiti gestionali pregressi, non potendo giustificarsi con il solo richiamo all’equilibrio di bilancio; ha altresì ribadito che le società in house, quali longa manus dell’amministrazione, sono tenute al rispetto del Codice dei contratti pubblici per i sub-affidamenti, con conseguente inammissibilità delle soluzioni prospettate di partenariato pubblico-pubblico o di titoli partecipativi, essendo consentite unicamente gara, gara a doppio oggetto o affidamento diretto in house[28].
Tali osservazioni rivelano come, al di là della formale neutralità dell’articolazione normativa, l’in house resti una modalità di gestione soggetta a un più stringente obbligo di motivazione, il cui mancato rispetto può determinare effetti distorsivi sul piano concorrenziale. La sentenza del TAR Marche, pur non fondando l’annullamento sull’art. 17, conferma l’importanza di un’istruttoria completa e sostanziale quale presupposto necessario di legittimità, lasciando trasparire, tra le righe, una persistente difficoltà del modello in house ad affermarsi come opzione effettivamente paritaria.
4. Conclusioni
La sentenza del TAR Marche rappresenta un momento di svolta nell’interpretazione dei presupposti motivazionali alla base della scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all’affidamento in house providing. Il vero elemento innovativo non risiede tanto nella riaffermazione del carattere eccezionale di tale modello, già pacificamente accolto, come evidenziato dalla giurisprudenza e dalla prassi richiamate nei paragrafi precedenti, quanto nell’enfasi posta sulla relazione ex art. 14, comma 3, del d.lgs. 201/2022, riconosciuta come fulcro logico-giuridico del procedimento decisionale.
Il giudice amministrativo distingue con nettezza la fase della scelta dell’affidamento da quella della sua attuazione, attribuendo alla relazione ex art. 14 un ruolo centrale e sostanziale: non mero adempimento formale, ma strumento funzionale a garantire la razionalità, l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa. Ciò che, tuttavia, merita particolare attenzione è l’effetto pratico derivante da questa impostazione: la traslazione dell’onere motivazionale rafforzato dell’art. 17 nella relazione ex art. 14 comporta la sua applicazione generalizzata anche agli affidamenti sotto soglia, incidendo quasi esclusivamente sul modello in house.
In questo modo, lungi dal creare un piano di parità tra modelli, l’interpretazione adottata rafforza la tradizionale asimmetria, sottoponendo l’in house a un controllo più gravoso e anticipato, che ne condiziona le possibilità di impiego e rischia di limitarne la funzione come strumento legittimo e flessibile di organizzazione dei servizi pubblici locali. La sentenza restituisce così alla motivazione amministrativa la sua funzione più nobile: rendere intellegibile, verificabile e fondata la decisione pubblica, ma al contempo mostra come la scelta del baricentro procedimentale possa produrre effetti sistemici rilevanti, ridefinendo in modo significativo i rapporti di forza tra modelli gestionali e incidendo, forse in maniera non del tutto voluta, sulla libertà di scelta organizzativa degli enti locali.
[1] Per una ricostruzione organica del quadro teorico e normativo, ex pluribus: S. DEL GATTO, Le società pubbliche tra obiettivi di razionalizzazione e prospettive di rilancio, in Giornale di diritto amministrativo, 5, 2024, pp. 584-593; V. BATTISTELLI, L’affidamento "in house": luci ed ombre del nuovo principio di autorganizzazione amministrativa, in Rivista della Corte dei Conti, 6, 2024, pp. 104-113; L. M. FERA, L’in-house providing nel nuovo codice dei contratti pubblici: tra libertà di auto-organizzazione amministrativa e tutela della concorrenza e del mercato, in federalismi.it, 28, 20 novembre 2024, pp. 33-52; B. G. MATTARELLA, Ambiguità e vicende degli affidamenti in house, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 4, 1 dicembre 2023, p. 1283 ss.; R. CAMPONI, Tensioni e contrapposizioni dell’in house providing: fra servizi e contratti pubblici, in italiappalti, 13 febbraio 2023, pp. 1-12; M. LIBERTINI, Le società di autoproduzione in mano pubblica: controllo analogo, destinazione prevalente dell’attività ed autonomia statutaria, in BENAZZO P., CERA M., PATRIARCA S., Il diritto delle società oggi – Innovazioni e persistenze, Torino, Utet, 2011, pp. 471-514; D. SORACE, Pubblico e privato nella gestione dei servizi pubblici locali mediante società per azioni, in F. TRIMARCHI, a cura di, Le società miste per i servizi locali, Milano, Giuffrè, 1999, p 135 ss.; S. CASSESE Partecipazioni pubbliche ed enti di gestione, Milano, Comunità, 1962.
[2] D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", adottato in attuazione dell’art. 8 della legge delega 5 agosto 2022, n. 118. Il decreto ha sostituito integralmente la previgente disciplina di settore, incidendo in modo rilevante su modalità di affidamento, controllo e concorrenza nei servizi pubblici locali.
[3] Ex multis, U. IZZO e P. LONGONI, Per l’in house occorre sempre motivare le ragioni del mancato ricorso al mercato, in Azienditalia, 2020, 1955; L. DI MARTINO, L'onere di motivazione negli affidamenti in house, in Contratti Stato e enti pubbl., 2021, 2, 21 I. GENUESSI, L’onere motivazionale in caso di affidamento in house alla luce della più recente normativa e giurisprudenza, in AmbienteDiritto.it, 2023, n. 1; A. MALTONI, Oneri motivazionali differenziati richiesti per l’affidamento a società in house di attività aventi rilevanza economica e affidamenti in house “convenzionali”, in federalismi.it, 29, 13 dicembre 2023, p. 43 e p. 49; H. BONURA, Il PNRR, il diritto dell’emergenza e l’in house senza controllo analogo: incrociare le rette parallele o intraprendere una retta via ?, in Diritto e Pratica amministrativa, n. 6/2022, spec. 53; D. ANSELMI, F. SMERCHINICH, Affidamento in house ed obbligo di motivazione, tra orientamenti giurisprudenziali, nuove Linee Guida ANAC e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in Associazione avvocati amministrativi liguri “Carlo Raggi”, p. 9 (http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2021/05/Affidamento-in-house-ed- obbligo-di-motivazione-tra-orientamenti-giurisprudenziali-nuove-Linee-Guida-ANAC-e-il-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza.pdf, 13 ottobre 2023).
[4] L’approfondimento che segue analizza il ruolo esercitato dall’AGCM nella verifica dell’effettiva conformità degli affidamenti in house ai requisiti di motivazione previsti dagli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022. In particolare, si evidenziano le principali criticità riscontrate dall’Autorità, tra cui la tendenza delle amministrazioni a ricorrere a motivazioni standardizzate, valutazioni astratte e strumenti analitici inadeguati, come l’uso meccanico della matrice SWOT, privi di un reale confronto tra alternative gestionali. L’azione dell’AGCM si configura, in tale prospettiva, come un presidio sostanziale contro prassi elusive del principio di concorrenza.
[5] Per una puntuale disamina sulla più recente riforma relativa ai servizi pubblici locali si vedano, A. LUCARELLI, Il nuovo Statuto giuridico dei servizi pubblici locali: tra concorrenza e mito del “privato” si consuma l’eccesso di delega. Considerazioni a margine del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell’art. 8 della legge delega del 5 agosto 2022, n. 118, in federalismi.it, 9, 2024, pp. 161-181; E. ZAMPETTI, Concorrenza e sussidiarietà orizzontale nella recente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in Diritto e società, 3, 2024, pp. 511-538; F. MARONE, Servizi pubblici locali e società pubbliche nel quadro della costituzione economica, in P.A. Persona e Amministrazione, 1, 2024, pp. 935-972; S. SILEONI, Dalla teoria alla pratica: i principi della riforma dei servizi pubblici locali e le regole sulle forme di sostegno agli utenti, in Munus 2/2024, pp. 425-459; G. F. PULIZZI, Un convegno sulla riforma dei servizi pubblici locali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1, 2024, pp. 281-282; A. MOLITERNI, La riforma dei servizi pubblici locali, in Giornale di diritto amministrativo, 4, 2023, pp. 478-498; P. MORIGI, La riforma dei servizi pubblici locali: prime valutazioni, in Finanza e tributi locali, 3, 2023, pp. 15-21. Sul tema, v. E. PICOZZA e A. DI GIOVANNI (a cura di), La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, Torino, 2025; N. AICARDI, G. CAIA, M. CALCAGNILE, P. ACRI, La gestione dei servizi pubblici locali dopo il d.lgs. 23 dicembre 2022, N. 201, Napoli, 2024; R. VILLATA (a cura di), La riforma dei servizi pubblici locali. Aggiornato al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, Torino, 2023; L. PERGOLIZZI, I servizi pubblici locali tra tutela della concorrenza e funzione sociale, Napoli, 2024; S. VINCI, Dall'impresa-organo alla società in house: istituzioni, economia e aziende nell'evoluzione dei modelli di organizzazione dei servizi pubblici locali, Torino, 2023.
Per approfondimenti sulla disciplina generale E. SCOTTI, I principi informatori dei servizi pubblici locali, in H. BONURA, M. CASSANO, a cura di, L’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 3-49;F. MERUSI, La tormentata vita della concorrenza nei servizi pubblici locali, in Munus, 2011, pp. 413-426; F. LIGUORI, I servizi pubblici locali, Torino, Giappichelli, 2007; F. LUCARINI, I servizi pubblici locali e il modello di municipalizzazione nel dibattito italiano del primo ‘900, in V. TERMINI, a cura di, Dai municipi all’Europa. La trasformazione dei servizi pubblici locali, Bologna, Mulino 2004, pp. 151 ss.; L. PERFETTI, I servizi pubblici locali. La riforma del settore operata dall’art. 35 della l. 448 del 2001 ed i possibili profili evolutivi, in Dir. Amm., 2002, pp. 575 ss.; L. AMMANATI, Servizi pubblici locali, società per azioni a partecipazione pubblica e concorrenza, in L. AMMANATI, M. A. CABIDDU, P. DE CARLI, a cura di, Servizi. Concorrenza. Diritti, Milano Giuffrè, 2001, pp. 59-97; R. CAVALLO PERIN, La struttura della concessione di servizio pubblico locale, Torino, Giappichelli, 1998; M. CLARICH, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi, in Dir. Pub., 1998, pp. 181-200; G. CAIA, La disciplina dei servizi pubblici, in L. MAZZAROLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA, a cura di, Diritto amministrativo, I, 1993, Monduzzi, Pianoro, 735 ss. (ed. del 2005, II, pp. 131-177); U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, Cedam, 1964; A. DE VALLES, I servizi pubblici, in V.E ORLANDO, a cura di, Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, Vol. VI, I, Milano, Società editrice libraria, 1930.
[6] L’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022 impone che, prima di ogni affidamento, l’ente rediga una relazione comparativa tra le modalità di gestione, fondata su parametri oggettivi (costi, qualità del servizio, investimenti, impatto sulla finanza pubblica). La relazione deve precedere l’avvio della procedura e ha natura vincolante: la sua assenza o carenza determina l’illegittimità dell’affidamento.
[7] Secondo il TAR, il mero richiamo all’esperienza positiva del gestore uscente non soddisfa il requisito comparativo: manca ogni analisi sostanziale dei costi o benefici delle alternative (gara, doppio oggetto), come invece richiesto dall’art. 14. In questo modo, l’amministrazione non dimostra l’effettiva funzionalità della scelta rispetto all’interesse pubblico.
[8] Le sinergie organizzative e gli effetti sull’occupazione possono concorrere alla motivazione, ma solo se supportati da dati verificabili. Nella sentenza si evidenzia come la relazione fosse priva di stime, indicatori o scenari economici concreti, riducendosi a enunciazioni generiche.
[9] Il giudice amministrativo ritiene che l’uso dei modelli e schemi tipo resi disponibili da ANAC, a suffragio di una corretta realizzazione, fra le altre, della relazione ai sensi dell’art. 14 (come le matrici SWOT o i template standard) non sia vietato, ma non possa sostituire l’analisi richiesta dalla legge. L’istruttoria deve essere cucita sul caso concreto, con documentazione puntuale e coerente con la realtà del servizio da affidare. Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) cura la gestione della Piattaforma unica “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”, nella quale rende disponibili strumenti di supporto per l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dagli articoli 14 e 17 del medesimo decreto. In particolare, sono pubblicati: lo “Schema di relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale (art. 14, comma 3)”; lo schema per la motivazione qualificata ex art. 17, comma 2 (affidamenti diretti in house sopra soglia). I predetti format, reperibili sul sito istituzionale ANAC nella sezione Trasparenza SPL (https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-spl), hanno valore meramente orientativo e non sostitutivo dell’istruttoria analitica richiesta dalla normativa. Si evidenzia altresì che anche le autorità di regolazione settoriali possono adottare propri schemi-tipo nei rispettivi ambiti: ad esempio, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con Delibera n. 64/2024, ha approvato lo Schema-tipo di “Relazione di Affidamento – in house” per il trasporto pubblico locale. Tali strumenti, pur non provenendo da ANAC, si collocano nel medesimo quadro di supporto non vincolante all’attività istruttoria e motivazionale delle amministrazioni. In argomento, S. VERNILE, L’affidamento in house, in G.M. CARUSO, D. D'ALESSANDRO e D. PAPPANO (a cura di), Contratti delle pubbliche amministrazioni. Questioni attuali, Torino, 2024, pp. pp. 177-203; L. M. FERA, L’in-house providing nel nuovo codice dei contratti pubblici: tra libertà di auto-organizzazione amministrativa e tutela della concorrenza e del mercato, cit., p. 38.
[10] La relazione ex art. 14 è uno strumento obbligatorio per tutti i modelli di gestione: impone una comparazione ragionata tra opzioni, con indicatori misurabili (costi, qualità, investimenti, obblighi di servizio). È il fulcro logico dell’intera istruttoria amministrativa, anche per gli affidamenti sotto soglia.
[11] L’art. 17 si applica solo agli affidamenti in house sopra soglia UE e impone un onere motivazionale “rafforzato”: una seconda delibera che confermi la scelta come la più efficiente ed efficace. La sua funzione è quella di rafforzare i presidi di trasparenza e giustificazione economica dell’autoproduzione.
[12] Anche se gli affidamenti sotto soglia non ricadono nella disciplina comunitaria vincolante, l’art. 14 impone un’istruttoria comparativa che riflette i criteri euro-unitari (trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento), promuovendone l’applicazione estesa nell’ordinamento interno.
[13] Sull’apparente regime paritario dei modelli gestionali previsti e sull’effettiva subordinazione del modello in house si veda R. CAMPONI, Tensioni e contrapposizioni dell’in house providing: fra servizi e contratti pubblici, cit. p. 2.
[14] La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che gli Stati membri hanno facoltà di subordinare il ricorso a un’operazione interna per la fornitura di servizi “all’impossibilità di indire una gara d’appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione interna”, Corte di Giustizia UE, sez. IX, 6 febbraio 2020, nelle cause riunite C-89/19, C-90/19 e C-91/19, in eur-lex.europa.eu.
[15] In mancanza di disciplina specifica, si è affermato in dottrina e giurisprudenza che anche per affidamenti in house sotto soglia l’art. 14 costituisce parametro di legalità: la scelta gestionale deve comunque risultare motivata in modo trasparente, concreto e documentato. Cfr. L. M. FERA, L’in-house providing nel nuovo codice dei contratti pubblici: tra libertà di auto organizzazione amministrativa e tutela della concorrenza e del mercato, cit.; C. L. APPIO E DAVIDE DE FILIPPIS, L’in house providing nei servizi pubblici di rilevanza economica: la prospettiva del diritto dell’economia a qualche anno dal riordino, in Dirittobancario.it, 14 marzo 2025. La giurisprudenza rilevante: sent. TAR Marche n. 367 del 28 maggio 2019; Corte dei conti, Sez. reg. controllo Lombardia, delib. n. 115/2024/PASP, 27 maggio 2024: afferma che la “qualificata motivazione” dell’art. 17 è prevista per gli affidamenti sopra soglia, ma il principio di motivazione analitica costituisce “canone generale” (rilevante anche sottosoglia) in coerenza con l’art. 5 TUSP, dunque l’ente deve comunque motivare la scelta; TAR Lazio – Roma, Sez. II-bis, 19 marzo 2024, n. 5452, nel sindacare la scelta del modello gestionale (gara/società mista/in house), il TAR richiama il perimetro del TUSPL e la necessità della delibera e relazione motivata ex art. 14 quale base legale della scelta, distinguendola dall’eventuale onere “rafforzato” dell’art. 17 per i casi sopra soglia; Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 luglio 2021, n. 5351 (precedente “di principio”, pre-TUSPL ma spesso richiamato). Afferma l’esigenza di un onere motivazionale incisivo quando si deroga al mercato con l’in house (convenienza, efficienza, qualità): orientamento che la prassi ha riletto come regola generale anche nel sistema TUSPL, a prescindere dalla soglia economica, con gli oneri rafforzati tipizzati solo per gli affidamenti sopra soglia.
[16] La giurisprudenza ha ammesso che la delibera ex art. 17 possa richiamare per relationem la relazione ex art. 14, purché quest’ultima sia esaustiva e verificabile. Questo evita la duplicazione documentale, ma non esonera l’amministrazione dal predisporre un’istruttoria solida a monte. Si veda sul punto, con riferimento all’articolato precedente, Cons. giust. amm., Sicilia, sez. giurisd., 13 dicembre 2022, n. 1258 e Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2021, n. 1596, in giustiziaamministrativa.it.
[17] A differenza dell’art. 17, la relazione ex art. 14 contiene anche elementi economici e giuridici aggiuntivi: obblighi di servizio pubblico, compensazioni, criteri per evitarne la sovracompensazione. Questi elementi sono centrali nella logica dell’equilibrio economico-finanziario dei servizi pubblici locali.
[18] La clausola di standstill (60 giorni prima della stipula del contratto) si applica solo alla delibera ex art. 17, ma non alla relazione ex art. 14. Questa disparità appare incoerente, specie se si considera che anche la relazione ex art. 14 è soggetta a pubblicazione e può avere effetti sostanziali sull’accesso al mercato. Sul punto, v. M. CLARICH, A. MOLITERNI, Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, in R. CHIEPPA, G. BRUZZONE, A. MOLITERNI (a cura di), La riforma dei servizi pubblici locali. Commento al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, e analisi sistematica delle regole vigenti nei singoli settori, Milano, 2023, 244; G. FARES, V. LOPILATO, L’affidamento in house dei servizi pubblici locali, in La riforma dei servizi pubblici locali. Commento al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, e analisi sistematica delle regole vigenti nei singoli settori, ivi, p. 311 ss.
[19] A. MALTONI, Oneri motivazionali differenziati richiesti per l’affidamento a società in house di attività aventi rilevanza economica e affidamenti in house “convenzionali”, in federalismi.it, 29, 13 dicembre 2023, p. 51.
[20] In dottrina e giurisprudenza si è consolidata la tesi per cui il modello in house, pur astrattamente equivalente agli altri, è soggetto a condizioni più restrittive. La sua adozione richiede una motivazione rafforzata e una dimostrazione stringente di efficienza ed economicità, come ribadito dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, n. 702/2021).
[21]La citazione proviene testualmente dalla motivazione del TAR Marche, che richiama l’onere motivazionale “rafforzato” a carico dell’amministrazione. Questa formulazione deriva da orientamenti consolidati che considerano l’in house una “eccezione” da giustificare con particolare attenzione all’efficienza e al buon uso delle risorse pubbliche.
[22]Il vincolo è doppio: da un lato l’ente deve dimostrare la convenienza dell’in house rispetto al mercato; dall’altro, la società affidataria deve rispettare rigorosi requisiti strutturali (assenza di attività di mercato, controllo analogo, struttura proprietaria pubblica). L’inosservanza anche solo di uno di questi elementi determina l’illegittimità dell’affidamento.
[23] Il riferimento è al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, entrato in vigore il 1° luglio 2023, che ha sostituito il previgente d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nella disciplina antecedente alla riforma, l’art. 192, comma 2, prevedeva espressamente un onere motivazionale in caso di affidamento in house, imponendo alle stazioni appaltanti di “dare conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato”, nell’ambito di una più ampia valutazione sulla congruità economica dell’offerta del soggetto in house, nonché sui benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Tale contenuto dispositivo non è stato riprodotto nel nuovo art. 192, con la conseguenza che il Codice del 2023 non contempla più un obbligo esplicito di giustificazione del mancato ricorso al mercato, in coerenza con il principio di autorganizzazione amministrativa sancito dall’art. 7.
[24]L’AGCM ha più volte agito formalmente, anche tramite ricorsi giurisdizionali, per contrastare affidamenti in house carenti di adeguata istruttoria. Le sue valutazioni insistono sul rispetto sostanziale dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di accesso, e sulla necessità di motivazioni fondate su dati concreti.
[25] Sul punto, si vedano, tra i numerosi interventi critici dell’AGCM in materia di affidamenti in house: AGCM, Parere AS2055 del 6 novembre 2024 – Ambito Territoriale Ottimale Avellino – Gestione integrata dei rifiuti urbani, in Bollettino AGCM, n. 5 del 10 febbraio 2025; AGCM, Parere AS1915 del 25 luglio 2023 – Consorzio di Bacino Alessandrino – Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, in Bollettino AGCM, n. 39 del 16 ottobre 2023; AGCM, Parere AS1939 del 23 novembre 2023 – Ambito distrettuale di Caserta – Affidamento del servizio idrico integrato, in Bollettino AGCM, n. 8 del 26 febbraio 2024; AGCM, Parere AS1918 del 14 giugno 2023 – ATO Avellino – Costituzione di una nuova società in house per l’affidamento della gestione dei rifiuti, in Bollettino AGCM, n. 40 del 23 ottobre 2023; AGCM, Parere AS2072 del 27 gennaio 2025 – ATO Avellino – Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in Bollettino AGCM, n. 14 del 14 aprile 2025.
[26] Cfr. Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione 26 settembre 2023, n. 315, ove si precisa che la SWOT Analysis è concepita dal legislatore come strumento di pianificazione strategica, da utilizzare per comparare le diverse opzioni disponibili attraverso l’individuazione di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce.
[27]Tra le criticità ricorrenti segnalate dall’AGCM vi sono l’uso di argomentazioni stereotipate, come i presunti vantaggi economici o sinergie generiche, la mancanza di indicatori economici puntuali (ad esempio, l’assenza o la non validazione del piano economico-finanziario), l’insufficiente comparazione tra le diverse opzioni gestionali e l’utilizzo meccanico di strumenti analitici come la matrice SWOT, impiegati senza alcuna contestualizzazione. L’Autorità ha inoltre evidenziato che l’assunto secondo cui l’internalizzazione del servizio comporterebbe automaticamente un risparmio, per via dell’assenza di utile, è economicamente infondato: anche il capitale pubblico impiegato deve essere adeguatamente remunerato per garantire la sostenibilità dell’intero sistema di gestione.
[28] AGCM, Parere del 29 luglio 2025, in Bollettino AGCM, n. 35 dell’8 settembre 2025, p. 22.
Sommario: 1. Il meccanismo del sorteggio dei membri degli organi collegiali: la sfortunata esperienza della Boulé ateniese - 2. La mancata previsione di uno screening preliminare per il sorteggio dei componenti togati dei nuovi Consigli Superiori - 3. Le minoranze non organizzate secondo Gaetano Mosca - 4. Conclusioni: il rischio attuale della subordinazione.
1. Il meccanismo del sorteggio dei membri degli organi collegiali: la sfortunata esperienza della Boulé ateniese
Il sorteggio, previsto per l’elezione dei componenti dei nuovi Consigli Superiori della Magistratura introdotti dalla riforma costituzionale, è senza dubbio un meccanismo inusuale nella formazione degli organi costituzionali.
Guardando alla storia costituzionale, oltre a inusuale, si potrebbe trovare anche un altro aggettivo per descrivere il meccanismo del sorteggio, e cioè sfortunato.
Se la Storia è ancora magistra vitae, l’esempio principe che addurrei per dimostrare la sfortuna del metodo in commento è quello della Boulé dell’Atene nel V secolo a.C. Si tratta di un organo che – nell’impianto della democrazia riformata da Clistene – era appunto tirato a sorte tra tutti i cittadini ateniesi di pieno diritto.
La sfortuna, in questo caso, è duplice e concerne sia il suo funzionamento che la sua fine.
In effetti, nella sapienza degli antichi, il ruolo di un organo sorteggiato chiamato ad esprimere gli interessi della politeia, diveniva di fatto ancillare; e per la precisione, schiacciato tra due altri poteri: quello dell’ecclesia (cioè l’assemblea di tutti i cittadini) da un lato e – soprattutto – il collegio degli strateghi (questi sì, eletti tra tutti i demi dell’Attica), dall’altro. In sostanza, la Boulé di sorteggiati veniva a trovarsi tra l’incudine e il martello, e di fatto era destinata ad essere estromessa dall’assunzione delle decisioni politiche più significative.
Tuttavia, se dall’organizzazione della Boulé nel quadro costituzionale ateniese si può solo trarre il segno della sua debolezza istituzionale, un segno – tragico – della sua inconsistenza politica (laddove per politica si intende badi, la sua capacità di rispondere alle sollecitazioni storico e costituzionali della politeia) è rappresentato dal modo in cui fu sciolta nel 411 a.C.
Ci racconta Tucidide ateniese come, all’indomani del colpo di stato oligarchico ordito in quell’anno, prima premura dei “golpisti” (se così possono essere chiamati Antifonte e i suoi) fu quella di liquidare l’organo sorteggiato. Ai suoi membri, non senza disprezzo, fu liquidata la paga residua per il loro incarico;[1] un gesto che ai nostri occhi pare evidentemente denigratorio ed espressivo dello spregio con cui doveva essere considerata la Boulé sorteggiata; uno spregio che potrebbe anche derivare dal difetto di legittimazione con cui doveva essere percepito dagli autori della sua dissoluzione.
Le modalità di questo scioglimento avvenuto a distanza di 25 secoli dimostrano come la Boulé – come qualunque organo sorteggiato – fosse un organo essenzialmente debole, passivo, talmente inconsistente da accettare bonariamente la propria liquidazione.[2]
2. La mancata previsione di uno screening preliminare per il sorteggio dei componenti togati dei nuovi Consigli Superiori
Ora, venendo alle dolenti note della quotidianità, a me pare che il rischio che i nuovi costituendi CCSSMM divengano organi inconsistenti non sia fugato dalla riforma. Ma occorre una puntualizzazione: ad essere inconsistente sarà soprattutto (se non esclusivamente) la sua componente togata, e cioè quella che più di tutti dovrebbe esprimere la capacità di autogoverno. La scelta di individuare una maggioranza di componenti a sorte tra tutti i magistrati d’Italia (circa 10.000), renderebbe questa maggioranza sostanzialmente inconsistente. Se questo è il meccanismo di nomina dei togati, per contro, i laici saranno tirati a sorte da una lista predisposta dal Parlamento. A questo quadro si aggiungeranno i tre nominati dal presidente della Repubblica e i membri diritto. Questa impostazione fa ritenere che già oggi nell’architettura dei nuovi CCSSMM sia presente – chiaramente – la possibilità di subordinare la giurisdizione alla politica.
In effetti, occorre riflettere su un problema preliminare che le “democraticissime” istituzioni Ateniesi avevano risolto almeno in parte, cioè quello della selezione dei candidati.
Tramanda Aristotele che già fin dalle leggi di Solone tra alcuni magistrati da tirare a sorte, vi era quello che oggi chiameremmo uno “screening preliminare”, cioè la compilazione di una lista di candidati tra cui sorteggiare.[3]
La riforma del 2025, invece, prevede questa sorta di filtro solo per la componente laica, mentre la componente togata, espressione dei magistrati, verrà nominata senza nessuno screening.[4] Questo significa che - ad oggi - la lista dei papabili tra cui estrarre a sorte sarà composto da tutti i 10.000 magistrati, senza che – alcuno di questo – abbia preventivamente dato prova di sufficienti capacità organizzative, negoziali, relazionali, gestionali e – in ultima istanza – latamente politiche, necessarie per partecipare proficuamente alla vita di un organo costituzionale collegiale, ma non richieste per accedere in Magistratura, né necessarie per essere un buon magistrato.
Il rischio, in altri termini, è quello di avere due bacini diversi da cui pescare: un bacino compatto composto da quel mondo di sottogoverno di cui pullula il mondo politico, da un lato, e dall’altro la totalità dei 10.000 magistrati tra cui - com'è ovvio – si trovano personalità di tutti tipi, alcune delle quali, per forza di cose, non attrezzate per la sfida che li attenderebbe.
Questo sospetto è tanto più radicato se si considera che non risulta ancora disciplinato il modo in cui verranno selezionate le persone da inserire nella lista dei laici. Ciò significa che – in astratto – potrebbero anche essere inserite nella lista esponenti di quel mondo di sottogoverno di un unico colore politico, con l’effetto di polarizzare già da subito politicamente l’operato dell’organo.[5]
Se così dovesse accadere, a maggior ragione una controparte togata nominata nelle modalità anzidette non sarebbe capace di arginare un potere “laico” di questo tipo, proprio in considerazione della sua intrinseca debolezza.
3. Le minoranze non organizzate secondo Gaetano Mosca
Gli approdi della filosofia politica degli ultimi 150 anni, da Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca in poi, passando per Giovanni Sartori, hanno chiaramente evidenziato il ruolo condizionante che nella vita pubblica, e ancor più nel funzionamento degli organi istituzionali, hanno le cosiddette minoranze organizzate. Quella passata alla letteratura come la “legge ferrea dell’oligarchia” ha dimostrato come un’organizzazione politica ben possa essere gestita, condotta e riorganizzata da minoranze omogenee, risolute e compatte.
Scriveva Gaetano Mosca ne La Classe Politica del 1896 che “La forza di qualsiasi minoranza è irresistibile di fronte ad ogni individuo della maggioranza, il quale si trova solo davanti alla totalità della minoranza organizzata; e nello stesso tempo si può dire che questa è organizzata appunto perché è minoranza. Cento, che agiscano sempre di concerto e d’intesa gli uni con gli altri, trionferanno su mille presi ad uno ad uno e che non avranno alcun accordo fra loro; e nello stesso tempo sarà ai primi molto più facile l’agire di concerto e l’avere un’intesa, perché son cento e non mille.” [6]
4. Conclusioni: il rischio attuale della subordinazione.A riprova di questo assunto, porto le elaborazioni del pensiero politico del secolo scorso
Questi elementi ci suggeriscono che già oggi si apre lo spazio, se non per una subordinazione della Magistratura alla politica, quantomeno di una subordinazione della componente togata a quella laica. Si tratta di subordinazione che per il momento vive nei contorni non chiari e ambigui di una riforma adottata in chiara opposizione rispetto agli stakeholders istituzionali (i magistrati, appunto), e che – lo si ribadisce – apre a rischi di condizionamenti non ancora esplorati nella Storia repubblicana.
Accanto a ciò, si pone anche la difficile questione della legittimazione di un organo sorteggiato, che – come dimostra l’esperienza ateniese – oltre ad essere istituzionalmente debole, corre il rischio di presentarsi come un organo non percepito come legittimo, in quanto composto da persone che non hanno alcun titolo per sedervi, se non la buona sorte.
[1] Tucidide, VIII, 69.
[2] “Presentatisi sul posto, si avvicinarono ai consiglieri estratti a sorte che si trovavano nell’aula consiliare e suggerirono loro di accettare l’indennità e filarsela: avevano recato con sé la somma sufficiente a ripagarli per tutto il restante periodo di nomina, e la distribuivano via via che ciascuno dei prescelti si allontanava dalla sede.” Ibid.
[3] Aristotele, Costituzione degli ateniesi, VIII, passo in cui specifica questo elemento per gli arconti
[4] Art. 3 del DDL1353 approvato in prima deliberazione il 16.01.2025: Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori or- dinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge
[5] Anche se è verosimile che – come per le altre nomine – il Parlamento possa orientarsi nel senso di garantire un’equa rappresentatività delle forze politiche che lo compongono.
[6] Mosca, La Classe Politica, Pieffe Edizioni 2018.
Sommario: 1. Introduzione – 2. Il Protocollo Italia-Albania sullo sfondo della crisi del principio delle competenze di attribuzione - 3. La competenza esterna esclusiva implicita dell’Unione europea e l’effetto di preemption: il contributo della Corte di giustizia - 4. Quale esito? - 5. Conclusioni.
1. Introduzione
In data 5 novembre 2025, la Corte d’Appello di Roma, Sezione persona, famiglia, minorenni e protezione internazionale, ha formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia allo scopo di chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti nel contesto di un procedimento di convalida del trattenimento di un cittadino di paese terzo in attuazione del noto Protocollo Italia-Albania, presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gjader[1]. A questo rinvio hanno fatto seguito tre ulteriori ordinanze della medesima Corte e aventi analogo tenore[2].
In prima battuta, i giudici a quibus pongono in dubbio la competenza dell’Italia a stipulare tale trattato, in virtù degli artt. 3, paragrafo 2, e 216, paragrafo 1, TFUE, letti nella prospettiva del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. In particolare, la Corte di giustizia viene interrogata riguardo al possibile radicamento in capo all’Unione, in forza di tali basi giuridiche, di una competenza esterna esclusiva implicita, derivante dal fatto che il regime giuridico ideato dal Protocollo “può incidere su norme comuni o modificarne la portata”[3].
In via subordinata, nell’eventualità di una risposta negativa al primo quesito, i Giudici rimettenti sollecitano la Corte del Lussemburgo a verificare se, in ogni caso, il diritto dell’Unione osti ad una disciplina pattizia come quella di specie, specialmente in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale e di diritto di difesa e diritto alla salute del medesimo.
Le ordinanze segnano una nuova tappa di un sin qui accidentato percorso giuridico e sollevano profili ermeneutici che, pur nella pressante attualità del quadro pattizio in cui sono maturati, promettono un’eco sulle future tappe evolutive del processo di integrazione in materia di immigrazione e asilo. In questa prospettiva, merita particolare attenzione il primo quesito pregiudiziale, che affronta un tema tanto cruciale per l’assetto dei rapporti tra ordinamenti nazionali e diritto dell’Unione quanto ad oggi sottostimato nelle analisi seguite alla stipulazione del Protocollo.
Proprio su questo profilo, pertanto, si focalizza il presente commento, che mira a fornire al lettore e alla lettrice alcune brevi riflessioni nell’immediatezza delle ordinanze di rinvio. In questo spirito, dunque, la trattazione affronta sinteticamente istituti che meriterebbero ben altra ampiezza di analisi e cura del dettaglio, nella consapevolezza che questa vicenda processuale fornirà in futuro, con ogni probabilità, nuove e molteplici occasioni di approfondimento e confronto. Inoltre, il commento non si sofferma sui delicati profili di possibile incompatibilità del Protocollo con il diritto UE. Al riguardo, la dottrina ha già avuto modo di porre in risalto circostanziate perplessità, tanto in relazione ai profili di diritto dell’Unione[4] quanto in rapporto al sistema della CEDU[5]. Sul punto si rimanda dunque a queste analisi, nonché alle ordinanze di rinvio stesse, che ad avviso di chi scrive offrono argomentazioni convincenti e ben articolate.
Ciò posto, l’analisi che segue inquadra anzitutto il contesto nel quale i rinvii si inscrivono. In particolare, nella sezione n. 2, vengono proposte alcune riflessioni sugli elementi di flessibilità che, oggi come in passato, contraddistinguono la messa in opera del principio delle competenze di attribuzione, a fronte di narrazioni politiche di ben altro tenore. Viene inoltre presentato il ‘caso’ della politica di immigrazione e di asilo quale laboratorio elettivo di esperienze sempre più variegate – per forma e sostanza – di proiezione esterna dell’azione dell’Unione e degli Stati membri. Un laboratorio del quale il Protocollo Italia-Albania costituisce un esito esemplare. La sezione n. 3 presenta un quadro della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di parallelismo delle competenze interne ed esterne e, in special modo, di competenza esterna esclusiva implicita nelle ipotesi in cui gli obblighi internazionali contratti da uno Stato membro possano “incidere su norme comuni o modificarne la portata”. Prima di alcune riflessioni conclusive, la trattazione si sofferma su brevi notazioni in ordine al possibile esito dei rinvii pregiudiziali in commento, con il caveat dell’apertura poc’anzi segnalata ad ulteriori e più elaborate analisi venture.
2. Il Protocollo Italia-Albania sullo sfondo della crisi del principio delle competenze di attribuzione
Come noto, l’Unione si fonda sul principio delle competenze di attribuzione e, in un’ottica funzionalista, sulle progressive cessioni di sovranità accordate in suo favore dagli Stati membri, per il tramite del disposto dei Trattati istitutivi, così come evolutisi nel corso dei decenni. Ciò presuppone che i Trattati codifichino espressamente le politiche che ricadono nell’ambito di intervento dell’organizzazione, così come, di regola, i poteri dei quali quest’ultima è dotata allo scopo di condurre efficacemente le azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi comuni. All’esito della riforma di Lisbona, i Trattati evidenziano in più punti la particolare premura dei loro redattori per la centralità del principio di attribuzione[6], quale baluardo posto a confine dell’operato dell’Unione e, di converso, garanzia per gli Stati rispetto a indebite incursioni sovranazionali nelle materie in cui hanno conservato in tutto o in parte la loro sovranità. In effetti, nelle prime reazioni all’entrata in vigore della riforma del 2009, la quantità di clausole in materia ha condotto alcuni commentatori a riscontrare una vera e propria ‘ossessione’[7], talora anche a discapito della linearità e coerenza delle disposizioni di rango primario.
Eppure, proprio il principio di attribuzione appare, a ben vedere, tra i meno ‘monolitici’ nella quotidianità delle politiche dell’Unione. A fronte di elementi di flessibilità viepiù intensi e multiformi, acutamente discussi in dottrina e non di rado alimentati e sostenuti dagli stessi governi nazionali perché necessari a fare fronte a importanti sfide comuni[8], l’esatto posizionamento dei cippi di confine tra il cd. treaty-making power dell’Unione e degli Stati costituisce da decenni un palcoscenico d’elezione per conflitti interpretativi e giurisdizionali.
Il settore della migrazione e dell’asilo costituisce un esempio paradigmatico di questa tendenza. Invero, in questa materia, il trattato di Lisbona ha riconosciuto all'Unione una sola base giuridica esplicita per la conclusione di trattati internazionali con paesi terzi, riguardante la competenza concorrente in materia di accordi di riammissione[9]. Una competenza che, peraltro, nella prassi si confronta con una singolare quanto complessa articolazione di fonti, che spaziano da accordi inter se a trattati bilaterali tra Stati membri e paesi terzi, fino a coinvolgere importanti profili dell’azione esterna dell’Unione[10].
Allo stesso tempo, è ormai consolidata – e ampiamente studiata – una tendenza strutturale verso una crescente proiezione esterna della politica di immigrazione e asilo. Generalmente inquadrati nel concetto di esternalizzazione, vari istituti giuridici e numerose iniziative politiche condotte in parallelo dall’Unione e dagli Stati esplorano modalità di prevenzione o gestione dei flussi migratori verso l’Europa[11]. Sebbene questa non sia la sede per approfondire la trattazione di un tema che richiederebbe ben maggiore sforzo ricostruttivo, è utile ricordare come proprio la stipulazione di accordi, non di rado improntati a spiccata informalità, sia una delle linee direttrici principali di questo fenomeno, in uno con la valorizzazione della frontiera esterna dell’Unione quale perno delle strategie manageriali e deflattive delle politiche migratorie e di asilo.
In questo scenario, ci si trova a fronteggiare due elementi ricorrenti e complementari. Da un lato, si assiste ad una crescente valorizzazione delle basi giuridiche di diritto primario a sostegno del dinamismo dell’azione esterna dell’Unione nella materia in esame. In linea con quanto spesso accaduto nell’evoluzione del processo di integrazione, azioni in materia di immigrazione e asilo permeano gli interstizi di ulteriori politiche, quali la cooperazione allo sviluppo, la politica di vicinato, la politica commerciale. Un crescente ricorso a strumenti di soft law contribuisce a sua volta alla limatura delle rigidità del principio di attribuzione[12]. Dall’altro lato, gli Stati membri sono inclini ad architettare ‘esperimenti giuridici’ che deliberatamente si avvalgono delle zone grigie poste all’ombra dei confini sfrangiati del riparto di competenze. Gli spazi di residuo intervento statale e le incertezze che accompagnano i margini esterni dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione divengono così occasioni propizie per complementare l’operato dell’Unione o condurre iniziative politiche unilaterali.
Ne consegue un panorama di particolare incertezza e complessità, che il rafforzamento della dimensione esterna delle politiche di immigrazione e asilo nel Nuovo Patto pare idoneo ad amplificare ulteriormente. Come i rinvii pregiudiziali che suscitano queste brevi riflessioni evidenziano, la conclusione del Protocollo Italia-Albania costituisce dunque solo l’ultima manifestazione di un problema (per quanto di nostro interesse, giuridico) connaturato al rapporto tra Unione e Stati membri nel quadro di un processo di integrazione in costante evoluzione. Una manifestazione che, al contempo, ben illustra le traiettorie problematiche brevemente accennate.
È noto, infatti, che il sistema normativo inaugurato dal Protocollo costituisce sotto più profili un novum, proprio a cominciare dalla singolare configurazione del legame con il diritto dell’Unione europea. L’accordo, infatti, si avvale della stretta territorialità della disciplina dell’Unione in materia di asilo per (mirare a) sottrarsi dal campo di applicazione del diritto UE. Di converso, però, il Protocollo stesso richiama espressamente la normativa sul sistema europeo comune di asilo (SECA) ed estende unilateralmente ai centri realizzati in Albania l’operatività del diritto italiano di trasposizione. Inoltre, esso manifesta più punti di contatto con molteplici ambiti soggetti al diritto UE. Questa soluzione ibrida è il frutto di una fictio juris, ovverosia la qualificazione dei centri di Shenjin e Gjader quali aree di frontiera italiane, nelle quali, al di fuori del territorio dell’Unione e dunque del formale ambito operativo delle norme sul SECA, l’Italia sceglie di applicare (almeno in parte) queste ultime. Ne deriva una costruzione giuridica del tutto peculiare, che porta ad approdi sino a poco tempo fa inesplorati il grado di “legal creativity and imagination”[13] alla base degli istituti giuridici con cui commentatori ed operatori del diritto si confrontano nel definire i rapporti tra ordinamenti nel sistema europeo.
Inevitabilmente, dunque, come le ordinanze di rinvio pregiudiziale ben pongono in risalto, il Protocollo chiama in causa proprio la titolarità della competenza – dell’Unione o di uno Stato membro – a concludere con un paese terzo norme in materia di conduzione delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. Appare dunque opportuno inquadrare sinteticamente i termini teorici della questione, allo scopo di definire il contesto concettuale dal quale muovono le ordinanze di rinvio e di evidenziarne i principali profili di interesse. La sezione che segue, pertanto, si sofferma sulle basi giuridiche che codificano nel diritto primario i casi di competenza esterna implicita dell’Unione e sulla giurisprudenza di Lussemburgo che, nei decenni, ha contribuito a chiarire la portata di questo particolare frammento del sistema delle competenze dell’Unione.
3. La competenza esterna esclusiva implicita dell’Unione europea e l’effetto di preemption: il contributo della Corte di giustizia
Nel 1971, in occasione della sentenza resa nel caso AETS[14], la Corte di giustizia ha inaugurato il principio del parallelismo delle competenze interne ed esterne. In forza di questo principio, essa ha individuato uno stretto legame tra l’adozione di norme comuni volte a regolare i rapporti giuridici all’interno dell’Unione, o a disciplinare la dimensione intra-europea di determinate politiche, e l’attribuzione all’organizzazione del potere di stipulare trattati internazionali nei medesimi ambiti.
In particolare, secondo la Corte, ogni volta che “(per la realizzazione di una politica comune prevista dal trattato) la Comunità ha adottato delle disposizioni contenenti, sotto qualsivoglia forma, norme comuni, gli Stati membri non hanno più il potere - né individualmente, né collettivamente - di contrarre con gli Stati terzi obbligazioni che incidano su dette norme”[15]. Infatti, la coerente e uniforme attuazione dei Trattati e del diritto UE non consente di “separare il regime dei provvedimenti interni alla Comunità da quello delle relazioni esterne”. In altre parole, l’esercizio della competenza interna genera un effetto di preemption che preclude agli Stati la stipulazione in via unilaterale di accordi con Stati terzi[16].
La cd. ‘dottrina’ o ‘regola AETS’ è oggi codificata nei Trattati. In particolare, per quanto qui di interesse, l’art. 3, paragrafo 2, TFUE stabilisce che l’Unione gode di “competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione […] può incidere su norme comuni o modificarne la portata.” Sebbene con alcune differenze testuali rilevate criticamente in dottrina[17], una disposizione di analogo tenore si rileva all’art. 216, paragrafo 1, TFUE, il quale inaugura il Titolo del Trattato dedicato alle procedure previste in via generale per la conclusione di accordi dell’Unione.
È bene precisare che la scelta di cristallizzare la ‘regola AETS’ nel diritto primario non ha generato modifiche tangibili al quadro teorico e giurisprudenziale di riferimento. In effetti, nonostante parte della dottrina valorizzasse alcuni tratti testuali distintivi degli artt. 3, paragrafo 2, e 216, paragrafo 1, TFUE per sostenere l’esigenza di una revisione dell’approccio ermeneutico al tema delle competenze esterne esclusive ‘implicite’[18], sin dalle prime pronunce seguite al Trattato di Lisbona la Corte ha mostrato chiaramente di voler agire in linea di piena continuità con il passato[19].
Pertanto, il percorso di progressivo affinamento delle statuizioni della Corte ha mantenuto inalterata la propria attualità. Una casistica particolarmente eterogenea ha invero consentito al giudice dell’Unione di testare a più riprese le proprie statuizioni. Al netto dell’inevitabile variabilità derivante dalle circostanze di specie, la giurisprudenza consolidatasi negli anni poggia su alcuni elementi ricorrenti, senz’altro utili per approcciarsi al Protocollo Italia-Albania nel prisma delle basi giuridiche primarie in esame.
Secondo il contributo ermeneutico della Corte di giustizia, l'effetto preclusivo derivante dall’incidenza su norme comuni o dalla modifica della loro portata presuppone due elementi valutativi principali. In primo luogo, la Corte usualmente esamina la misura in cui le norme ‘interne’ dell'UE disciplinano l'oggetto dell'accordo internazionale contestato. Al riguardo, non è sufficiente la sola presenza di norme del Trattato. È anzi richiesto che l'Unione abbia disciplinato “in larga misura” un determinato settore[20], ad esempio nell’ipotesi di una completa armonizzazione[21]. Al contempo, non è ritenuta sufficiente a giustificare il radicamento in capo all’Unione di una competenza esclusiva l’adozione di standard di base, laddove sia l’accordo internazionale che il diritto dell’Unione dispongano misure di armonizzazione minima[22].
In secondo luogo, la Corte esamina se la normativa UE pertinente sia in qualche modo influenzata dagli obblighi internazionali in questione. Questa seconda valutazione appare molto meno lineare e non sempre risponde a premesse argomentative replicabili[23]. Essa infatti poggia sull’oggetto, l’ambito operativo, lo scopo e la natura delle disposizioni pattizie interessate. Ciò implica che la Corte impernia la propria argomentazione su una (spesso molto dettagliata[24]) analisi delle circostanze di specie, con peculiare attenzione per le disposizioni sostanziali dell’accordo, così come per le procedure o i rimedi da questo eventualmente istituiti. Se le disposizioni contestate sono capaci, per il loro contenuto o i loro effetti, di compromettere “l’applicazione uniforme e coerente e il corretto funzionamento” di norme comuni[25], questo criterio di apprezzamento è senz’altro integrato. Allo stesso tempo, non è però necessario rilevare un’incompatibilità con il diritto UE rilevante. La Corte, infatti, considera più generalmente se “senza essere necessariamente in contraddizione con le norme comuni dell’Unione, gli impegni internazionali possono incidere sul significato, sulla portata e sull’efficacia di tali norme”[26]. È interessante rilevare come, in ottica estensiva, la Corte del Kirchberg abbia precisato che anche una semplice o potenziale sovrapposizione con le norme comuni dell'UE può in linea di principio integrare da sé la soglia richiesta dagli articoli 3, paragrafo 2, e 216, paragrafo 1, TFUE e attivare così l'effetto di preemption[27]. In questa prospettiva, il giudice dell’Unione ha ulteriormente rilevato come sia necessario tenere conto non solo dello stato attuale del diritto comunitario nel settore in questione, ma anche del suo sviluppo futuro, nella misura in cui esso sia prevedibile al momento dell'analisi[28].
4. Quale esito?
Benché anticipare l’esito di una futura pronuncia della Corte sia certamente aleatorio, chi scrive condivide il dubbio espresso dalla Corte d’Appello di Roma nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale circa il possibile radicamento in capo all’Unione europea della competenza a concludere il Protocollo, almeno nella sua attuale forma. Le ordinanze, alle quali si rinvia sul punto, dettagliano con puntualità i numerosi elementi di collegamento tra l’accordo e la disciplina del SECA. In termini generali, nonostante il Protocollo tenti di tracciare un sistema parallelo al SECA stesso, la sua attuazione incide su un sostrato normativo oggetto di armonizzazione estesa e intensa, certamente idoneo ad integrare la soglia di capillarità ed esaustività richiesta dalla giurisprudenza. Né d’altra parte appare possibile per l’Italia dare applicazione selettiva agli standard europei, circostanza che peraltro materializzerebbe di per sé, con ogni probabilità, un’ipotesi di incidenza (negativa, in termini di coerenza ed uniformità) sulle norme comuni ai sensi del Trattato.
Ciò vale ancor di più in vista dell'ormai imminente piena entrata in vigore degli atti che compongono il Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo. La direttiva qualifiche e la direttiva procedure saranno infatti sostituite da regolamenti, la cui integrale obbligatorietà renderebbe una loro applicazione incompleta o parzialmente dissonante in nuce idonea a violare l’articolo 288 TFUE. Per la stessa ragione, laddove il Protocollo e la legge italiana di ratifica non fossero aggiornate al mutato contesto normativo, l’articolo 288, paragrafo 2, TFUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di divieto di dissimulazione dell’applicabilità diretta dei regolamenti mediante disciplina interna interposta potrebbero offrire ulteriori argomenti di sistema a supporto dell’idea che le norme pattizie in esame sono suscettibili di incidere sul diritto UE rilevante[29].
Inoltre, l'articolo 54, paragrafo 3, del nuovo regolamento procedure, oltre a circoscrivere maggiormente la discrezionalità delle autorità nazionali nella definizione delle aree di frontiera, obbligherà gli Stati membri a notificare alla Commissione i luoghi in cui saranno eseguite le procedure di frontiera. Ciò genera una situazione di ‘accerchiamento giuridico’ dalla quale l’Italia avrebbe difficoltà a svincolarsi, a meno di un rinnovato ricorso ad un certo grado di inventiva politica e giuridica. Da un lato, la notifica dei centri in territorio albanese confermerebbe che l’attuazione del Protocollo costituisce parte integrante del SECA ed ha implicazioni sulle norme derivate comuni in materia. Dall’altro lato, un’eventuale mancata notificazione sarebbe problematica sotto il profilo del principio di leale cooperazione e riporterebbe in auge il divieto di applicare selettivamente i regolamenti.
In ogni caso, nell’attuale come nel futuro quadro giuridico occorre considerare uno degli argomenti principali sinora addotti a sostegno della natura ‘parallela’ del Protocollo rispetto all’ambito operativo del SECA e della conseguente assenza di punti di contatto di rilievo tra i due regimi normativi: la rigida territorialità del diritto UE d’asilo. Come risaputo, nell’assenza di riferimenti territoriali espressi nel diritto primario – ed in particolare nell’art. 78 TFUE, base giuridica di riferimento – è il diritto derivato a codificare varie clausole che limitano entro i confini del territorio degli Stati membri l’ambito di applicazione dei pilastri del SECA. Nel caso del Protocollo, le principali attività connesse alla conduzione dei centri di Shenjin e Gjader sono soggette alla piena ed esclusiva giurisdizione dell’Italia, circostanza che, tuttavia, come confermato anche dalla Corte costituzionale albanese[30], non implica in alcun modo una cessione territoriale, nemmeno di carattere temporaneo, in favore dell’Italia. La fattispecie in esame, invero, risponde alla diffusa prassi del cd. territorial leasing, in base alla quale uno Stato, usualmente in forza di un accordo internazionale, può consentire a che sul proprio territorio una controparte eserciti attività – finanche di natura coercitiva – sotto la sua giurisdizione e responsabilità[31].
Benché l’obiezione della territorialità integri un dato di realtà che non può essere taciuto, è giocoforza sollevare due contro-argomentazioni. In primo luogo, come puntualmente analizzato nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale, l’attuazione del Protocollo stesso presuppone situazioni in cui il fattore di collegamento ‘territorio’ viene in effetti integrato. Basti pensare al trasferimento in Italia di soggetti vulnerabili, di coloro il cui trattenimento non sia convalidato e dei richiedenti rispetto ai quali la procedura di frontiera non si completi entro il termine di 28 giorni. L’elemento della territorialità appare inoltre pienamente integrato nelle fattispecie oggetto dei rinvii pregiudiziali in esame, che promanano dal nuovo corso funzionale riservato al centro di Gjader, quale centro di Permanenza e Rimpatrio. Nei casi portati all’attenzione della Corte, infatti, la richiesta di protezione internazionale è stata formulata in Albania, ma a seguito di un trasferimento dall’Italia in forza di un provvedimento di rimpatrio. In altre parole, le intersezioni tra due sistemi normativi descritti come paralleli sono numerose e vedono proprio nella territorialità un aspetto cruciale. L’obiezione in esame assume così contorni formalistici, inidonei a resistere ad una valutazione degli aspetti sostanziali della messa in opera del Protocollo.
In secondo luogo, il Protocollo potrebbe costituire l’occasione per una ragionevole mitigazione della territorialità del SECA. Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia[32], questo limite all’applicazione del diritto UE d’asilo risponde all’esigenza strutturale di evitare che il sistema europeo debba affrontare volumi eccessivi di richieste di protezione, a discapito del suo efficace funzionamento. Nel contesto dell’accordo Italia-Albania, questa preoccupazione è in tutta evidenza superata, poiché l’unico modo per accedere ai centri di Shenjin e Gjader è un trasferimento forzoso ad opera delle autorità italiane. Verrebbe dunque meno la ratio stessa della territorialità, con l’ulteriore considerazione che il regime giuridico applicabile muove dalla scelta di qualificare i due centri come aree di frontiera italiane.
Ciò posto, il seguito dei rinvii pregiudiziali – o, per meglio dire, l’incidenza di una futura pronuncia della Corte di giustizia sulla materia in esame – è inevitabilmente esposto al mutevole contesto politico, operativo e normativo. Da una prima prospettiva, il baricentro del Protocollo è già stato oggetto di revisione: mentre le strutture di Shenjin giacciono sostanzialmente inutilizzate, quelle erette a Gjader sono state riconvertite in via elettiva a Centri di Permanenza e Rimpatrio. Peraltro, questa scelta non ha mutato la sostanza di un'iniziativa ad oggi ampiamente deludente, a cominciare dal netto disequilibrio fra costi e risultati. Eppure, data l’estrema volatilità delle scelte di politica migratoria – a fortiori in un periodo di intensi negoziati in sede europea verso la piena entrata in vigore del Nuovo Patto e l’approvazione di ulteriori misure ad esso collegate – è lecito guardare al futuro con prudenza, nella ragionevole attesa di ulteriori elementi di novità.
In questo senso, un secondo elemento di rilievo è l’avanzamento del confronto in seno a Parlamento europeo e Consiglio circa la proposta della Commissione per l’adozione di un nuovo regolamento istitutivo di un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare, destinato ad abrogare e sostituire, tra l’altro, la vigente direttiva 2008/115[33]. Limitatamente a quanto qui di interesse, l’art. 17 della proposta della Commissione prevede la possibilità per gli Stati membri di concludere accordi o intese con paesi terzi, aventi ad oggetto l’istituzione di centri per il rimpatrio al di fuori dell’Unione, la definizione delle procedure applicabili all’iter di trasferimento e al possibile successivo rimpatrio e gli obblighi e le responsabilità del paese terzo coinvolto. Sebbene la proposta non riguardi in alcun modo lo svolgimento di procedure di asilo all’estero, il probabile successo del percorso negoziale è destinato ad aggiungere un nuovo tassello alla configurazione del treaty-making power tra UE e Stati membri[34].
In definitiva, da un lato, lo scenario in rapido cambiamento su più linee direttrici non è idoneo a destituire di fondamento la ricevibilità dei rinvii pregiudiziali, neutralizzando le premesse di rilevanza e necessità dei quesiti interpretativi sorti nel caso di specie. Dall’altro lato, è ragionevole attendersi che gli effetti della pronuncia si inseriscano fra ulteriori nuovi approdi della dinamica proiezione esterna della politica migratoria e di asilo dell’Unione.
5.Conclusioni
Il Protocollo Italia-Albania si contraddistingue per un evidente gioco di ombre, poiché sfrutta e amplifica le ambiguità del complesso sistema di riparto di competenze tra Unione e Stati membri in materia di immigrazione e asilo. Quale che sia il reale scopo di questa scelta di legal design, i margini di incertezza applicativa sono considerevoli e – va detto – inevitabili, anche in virtù della parallela evoluzione del diritto UE rilevante, grazie al pieno ingresso a regime del Nuovo Patto. In questo quadro, dunque, la sottoposizione di quesiti interpretativi alla Corte di giustizia appariva solo questione di tempo. Essa appare in sé una buona notizia e dovrebbe essere auspicio di ogni operatore del diritto che la futura risposta della Corte – di qualunque segno essa sia – venga colta nella sua essenza tecnica, al riparo da facili strumentalizzazioni che rischierebbero di destituirla di autorevolezza.
La conduzione all’estero di procedure di asilo è un tema di particolare delicatezza ed un eventuale riconoscimento della competenza esclusiva dell’Unione in materia porrebbe un freno alle istanze di replicazione del modello Italia-Albania avanzate da altri Stati membri, riconducendo la responsabilità di eventuali iniziative a scelte comuni. In questa ipotesi, d’altra parte, rimarrebbe comunque da verificare la reale fattibilità di esperienze di questo genere, che in ogni caso richiederebbero il dispiegamento di personale e risorse degli Stati membri e, con ogni probabilità, un rafforzamento dei poteri dell’Agenzia europea per l’asilo. Nel caso in cui la Corte riconoscesse che la materia rientra fra le attribuzioni residue degli Stati, tornerebbe in auge il problema del ruolo del diritto dell’Unione, che il modello Italia-Albania ed il funzionamento stesso del SECA chiamano in causa. Laddove la Corte intraprendesse questa strada, si troverebbe con ogni probabilità ad avvalorare il tradizionale assetto in forza del quale l’esercizio delle attribuzioni statali è comunque sottoposto al rispetto dei principi generali dell’ordinamento UE. La Corte sarebbe inoltre tenuta a preservare l’unità e la coerenza delle norme di diritto UE che il Protocollo stesso richiama, confermando la propria giurisdizione in sede interpretativa.
In entrambe le circostanze, la Corte potrebbe comunque cogliere l’occasione per statuire sui profili di possibile incompatibilità materiale tra la disciplina del Protocollo e gli standard fissati dal diritto UE in materia di protezione internazionale. Questa è infatti una criticità connaturata all’essenza stessa del meccanismo realizzato con questo accordo, poiché eventuali discrasie derivano dal mero dato geografico, che è causa inevitabile di sfide operative non superabili. I tempi dei trasferimenti, la difficile valutazione sulla vulnerabilità dei migranti in un contesto di scarsità di personale specializzato, la garanzia di adeguati standard di tutela della salute, la piena esplicazione del diritto alla difesa sono solo alcune delle questioni che l’attuazione del Protocollo pone in via obbligatoria, per il semplice fatto della collocazione all’estero del centro di Gjader. In ultima analisi, pertanto, l’eventuale posizionamento della Corte su questi aspetti equivarrebbe, a seconda dei casi, ad un avallo condizionato a regimi paralleli al SECA o ad una definitiva presa di coscienza della loro materiale impraticabilità, alla luce degli odierni standard che il diritto UE (unitamente, verrebbe da dire, alle garanzie costituzionali) pone.
[1] Causa C-706/25 PPU, Comeri.
[2] Ordinanza del 5 novembre 2025, causa C-707/25 PPU, Sidilli; ordinanza del 17 novembre 2025, causa C-736/25, Peordi; ordinanza del 17 novembre 2025, causa C-737/25, Peordi II.
[3] Cfr. artt. 3, paragrafo 2, e 216, paragrafo 1, TFUE.
[4] Cfr. ad esempio A De Leo e Celoria, The Italy–Albania Protocol: A new model of border-shifting within the EU and its compatibility with Union law, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2024, p, 595. Sia anche permesso rinviare a S Montaldo, Not in my backyard! Outsourcing EU asylum procedures to third countries: A challenge for the Common European Asylum System, in Common Market Law Review, 2025, p. 327.
[5] Inter alia, A Saccucci, Il Protocollo Italia-Albania sui migranti, in Rivista di Diritto Internazionale, 2024, p. 661; A del Guercio, Lasciate ogni speranza, o voi che… sperate di entrare. Osservazioni a margine dell’intesa Italia-Albania, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2024, p. 548.
[6] Si pensi, a titolo esemplificativo, ad alcune formule inserite negli artt. 2, 7, 13 e 14 TFUE, negli artt. 4 e 5 TUE e nell’art. 51 della Carta.
[7] LS Rossi, Does the Lisbon Treaty Provide a Clearer Separation of Competences between EU and Member States?, in A Biondi, P Eeckhout, S. Ripley (a cura di), EU Law after Lisbon, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 85.
[8] M Dougan, EU Competences In An Age Of Complexity And Crisis: Challenges And Tensions In The System Of Attributed Powers, in Common Market Law Review, 2023, p. 93.
[9] V. l’art. 79, comma 3, TFUE.
[10] Sul punto v., ad esempio, E Frasca e E Roman, The informalisation of EU readmission policy: Eclipsing human rights protection under the shadow of informality and unconditionality, in European Papers, 2023, p. 931.
[11] V. la proposta di classificazione delle misure di esternalizzazione proposta da E Xanthopoulou, Mapping externalisation devices through a critical eye, in European Journal of Migration and Law, p. 108.
[12] V. le riflessioni di M. Dawson, Integration through soft law: no competence needed? Juridical and bio-power in the realm of soft law, in S Garben e I Govaere (a cura di), The division of competences between the EU and the member States, Londra, 2017, p. 249
[13] Queste, non a caso, le parole usate dall’allora Presidente della Commissione europea Barroso nel periodo immediatamente precedente alla Brexit, quale possibile via di uscita dal recesso del Regno Unito. Parole poi riprese dalla Premier britannica Theresa May per descrivere l’approccio negoziale all’accordo di recesso: v. https://www.euronews.com/2019/02/19/eu-can-still-compromise-over-brexit-ex-commission-president-says.
[14] Sentenza della Corte del 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione delle Comunità europee contro Consiglio delle Comunità europee (Accordo europeo trasporti su strada).
[15] Ibid., punti 16/19.
[16] A Arena, Il principio della preemption in diritto dell’Unione europea. Esercizio delle competenze e ricognizione delle antinomie tra diritto derivato e diritto nazionale, Napoli, 2013, spec. pp. 103 ss.
[17] V ad es C Kaddous, The EU Competence to Conclude New Generation Free Trade Agreements: Opinion 2/15 (EU-Singapore FTA), in G Butler e R Wessels (a cura di), EU External Relations Law: The Cases in Context, Oxford, 2022, p. 902.
[18] Nelle prime cause post-Lisbona, anche gli Stati membri hanno – infruttuosamente - tentato di argomentare a favore di una lettura più restrittiva delle condizioni per il riconoscimento della competenza esterna esclusiva in capo all’Unione: v ad es. i punti 72 e 73 della sentenza della Corte del 4 settembre 2014, causa C-114/12, Commissione c. Consiglio (convenzione del Consiglio d’Europa relativa ai diritti connessi degli organismi di radiodiffusione).
[19] Sentenza della Corte del 4 settembre 2014, causa C.114/12, Commissione c. Consiglio (convenzione del Consiglio d’Europa relativa ai diritti connessi degli organismi di radiodiffusione); parere 1/13, del 14 ottobre 2014, sulla Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori; sentenza della Corte del 26 novembre 2014, causa C-6/13, Green Network SpA. In dottrina, v. M Chamon, Implied exclusive powers in the ECJ’s post-Lisbon jurisprudence: the continued development of the ETA doctrine, in Common Market Law Review, 2018, p. 1101.
[20] Parere 2/15, del 16 maggio 2017, Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, punti 197 e 206.
[21] Parere 3/15, del 14 febbraio 2017, Conclusione del Trattato di Marrakech, volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, punto 118.
[22] Parere 2/00, del 6 dicembre 2001, Conclusione del Protocollo di Cartagena, punto 46.
[23] Schutze descrive l’approccio della Corte come un “informed chaos in which the Court selects its precedents in a relatively arbitrary way”. Cfr. R Schütze, European Union Law, Oxford, 2021, p. 283.
[24] In dottrina, al riguardo, si è parlato di “painstaking analysis of details”: J Wouters, F Hoffmeister, G De Baere e T Ramopoulos, The Law of EU External Relations, Oxford, 2021, p. 11.
[25] Parere 1/03, del 7 febbraio 2006, Competenza della Comunità a stipulare la nuova Convenzione di Lugano, punto 133.
[26] Sentenza della Corte del 20 novembre 2018, cause riunite C-626/15 e C-659/15, Commissione c Consiglio, punto 114.
[27] Parere 2/15, cit., punti 201 e 229.
[28] Parere 1/91, del 14 dicembre 1991, Progetto di accordo tra la Comunità ed i paesi dell'Associazione europea di libero scambio relativo alla creazione dello Spazio economico europeo, punto 25.
[29] V. ad esempio la sentenza della Corte, del 10 ottobre 1973, causa 34/73, Fratelli Variola Spa v Amministrazione italiana delle finanze.
[30] Corte costituzionale dell’Albania, sentenza V2-24 del 29 gennaio 2024, a comento della quale v ad esempio D Veshi, E Koka e K Haxhia, Comments on the Albanian Constitutional Court V2-24: Is the Italy-Albanian Protocol Regarding Illegal Migration Constitutional?, in Ordine internazionale e diritti umani, 2024, p. 305.
[31] MJ Strauss, Territorial Leasing in Diplomacy and International Law, Leiden, 2015, pp. 70–96.
[32] Sentenza della Corte del 7 marzo 2017, causa C-638/16 PPU, X e X c Belgio, punti 48 e 49. Va inoltre ricordato come questa pronuncia – generalmente portata ad esempio della territorialità ‘stretta’ del diritto UE di asilo, abbia la propria radice fattuale in una richiesta di protezione formulata presso una rappresentanza diplomatica., fattispecie che la direttiva procedure stessa esclude dal proprio ambito di applicazione, senza aggiungere riferimenti ad ulteriori situazioni. In altre parole, la pronuncia in esame sembra in verità avere una portata molto più circoscritta di quella che le è stata spesso riconosciuta.
[33] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio, COM(2025)101 dell’11 marzo 2025
[34] È bene precisare che la proposta della Commissione puntualizza che la conclusione di questi accordi costituirà una ‘attuazione del diritto dell’Unione’ da parte degli Stati membri, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, così risolvendo ab origine ogni dubbio circa la piena applicabilità di questo strumento.
Sommario: Premessa – 1. La delibera CIPESS oggetto del controllo: il “riavvio” delle attività di programmazione e progettazione dell’opera – 2. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in funzione prognostica: evitare pregiudizi nella realizzazione dell’opera – 3. Nel merito: le singole censure di illegittimità e il sindacato “rafforzato” (di legalità finanziaria) rispetto alla cognizione del giudice amministrativo – 3.1. Violazione della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat). Tra politica e tecnica - 3.2. Violazione dell’art. 72 della direttiva n. 2014/24/UE (c.d. direttiva Appalti). “Reviviscenza contrattuale” e necessità di nuova procedura selettiva – 3.3. Esclusione dell’Autorità di regolazione dei Trasporti dalla procedura di approvazione del Piano Economico-Finanziario. La tutela della concorrenza a danno della tutela dell’utenza – 3.4. Le ulteriori osservazioni con finalità conformativa della successiva attività amministrativa – 4. Osservazioni riassuntive sul controllo preventivo di legittimità nel caso di specie – 5. Le conseguenze del diniego di visto – 6. Conclusioni. Tra approvazione del pdl Foti e registrazione con riserva.
Premessa
La ricusazione del visto opposta dalla Corte dei conti all’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo stretto di Messina assume particolare importanza, specie nel momento storico in cui cade.
La pronuncia testimonia l’importanza del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, a tutela della legalità finanziaria e della sostenibilità delle infrastrutture strategiche.
Pare interessante esaminare il possibile seguito governativo della pronuncia, che si affianca sincronicamente all’approvazione del complesso progetto di riforma (pdl Foti), destinato a modificare profondamente le funzioni e l’organizzazione del giudice contabile, incrociando istituti che si sono mostrati decisivi per la pronuncia in esame.
1. La delibera CIPESS oggetto del controllo: il “riavvio” delle attività di programmazione e progettazione dell’opera
Con deliberazione depositata in data 27 novembre 2025 la Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della delibera n. 41/2025 adottata dal CIPESS il 6 agosto 2025[1].
Tale delibera, sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, aveva approvato una serie di atti determinanti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, tra i quali: il progetto definitivo (approvato il 29 luglio 2011 – sic – dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria Stretto di Messina S.p.A.- SdM) e la “Relazione del progettista del 20 gennaio 2024” attestante la rispondenza del progetto stesso al progetto preliminare e alle prescrizioni dettate dalla deliberazione del CIPE n. 66 del 2003; le osservazioni, le richieste e le prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) nonché le prescrizioni formulate, all’esito della valutazione di impatto ambientale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), incluse in specifico “Quadro prescrittivo”, allegato quale parte integrante e sostanziale alla delibera; il Piano economico-finanziario (PEF)[2] sottoscritto dalle parti il 1° agosto 2025, e assentito con decreto del 1° agosto 2025 del MIT, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), sentite la Regione siciliana e la Regione Calabria; la relazione istruttoria del MIT che indica l’integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell’intervento (pari a 13.532 milioni di euro); l’elenco delle opere compensative e sociali; la modifica del soggetto aggiudicatore da Rete ferroviaria italiana (RFI) a SdM relativamente ad una variante e all’assegnazione di 7 milioni di euro già disposta con precedenti delibere CIPE; le varianti al progetto preliminare approvato dal CIPE con delibera n. 66 del 2003 ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; il programma di risoluzione delle interferenze, di cui all’art. 170, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cioè, del Codice dei contratti pubblici allora vigente).
Sul piano finanziario, la medesima deliberazione ha attestato la copertura dei costi di progettazione e realizzazione dell’opera (pari a 13.532 milioni di euro), in considerazione delle risorse statali previste
dalla legge di bilancio 2024, come modificata dalla legge di bilancio 2025), e di quelle di pertinenza di SdM, pari a 370 milioni di euro, acquisite in esito all’operazione di aumento del capitale sociale effettuata dal MEF; ha disposto il finanziamento degli oneri (6 milioni di euro per il periodo 2025-2030) non ricompresi nel quadro economico dell’opera, correlati all’attuazione da parte di SdM di un piano di comunicazione avente ad oggetto iniziative permanenti per l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza sullo stato di avanzamento dell’opera; ha assegnato al MIT le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021- 2027; ha formulato raccomandazione al MIT di “adoperarsi per il conseguimento di un finanziamento europeo, anche in considerazione dell’inclusione dell’opera nella rete TEN-T”.
Alla stessa delibera del CIPESS era apposta condizione sospensiva, che ne subordinava l’efficacia alla registrazione del decreto del MIT, di concerto con il MEF, sentite la Regione siciliana e la Regione Calabria recante, tra l’altro, il nuovo PEF della concessione oggetto di approvazione con il provvedimento all’esame.
Il contenuto complesso della delibera, riferito ad un arco temporale di diversi decenni, rappresenta l’atto conclusivo del procedimento finalizzato al “riavvio delle attività di programmazione e di progettazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”.
La Corte dei conti, Collegio del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ricostruisce in narrativa la “più ampia e complessa operazione” nella quale si iscrive la delibera CIPESS esaminata, che origina ben 57 anni orsono, allorquando la legge 28 marzo 1968, n. 384 aveva indetto un concorso di idee, con la partecipazione di oltre cento concorrenti al bando internazionale e la premiazione di sei ex aequo. Si rinvia interamente alla ricostruzione operata dal Collegio contabile, cui va riconosciuto il merito di aver sistematizzato un procedimento frammentato, ripetutamente interrotto, con i correlati interrogativi sugli effetti giuridici delle operazioni di “riavvio” approvate dal CIPESS.
Basti pensare, solo sul piano progettuale, alle varianti al progetto preliminare e relative prescrizioni del 2003, oggetto di relazione del progettista ben 21 anni dopo e al progetto definitivo approvato nel 2011 e oggetto di verifica 14 anni dopo, peraltro con la sopravvenienza di un sistema normativo profondamente mutato e l’entrata in vigore, nel frattempo, di ben due diversi Codici dei contratti pubblici (addirittura tre, se il riferimento è al progetto preliminare) che hanno radicalmente ridisegnato la materia. L’attualizzazione dei costi risente ovviamente in modo amplificato dell’anomalo trascorrere del tempo, come il Collegio osserva puntualmente, richiamando la disciplina dell’Unione europea da cui deriva quella nazionale.
2. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti in funzione prognostica: evitare pregiudizi nella realizzazione dell’opera
La funzione del controllo preventivo di legittimità intestata alla Corte dei conti ha radici storiche lontane e sollecita interesse de jure condendo, visto il suo prospettato ampliamento ad opera del pdl Foti in corso di approvazione[3].
La Corte dei conti, in base all’art. 100, co. 2, della Costituzione, “esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo”. Tale norma disciplina una funzione di controllo che origina fin dall’istituzione dello stesso giudice contabile: già la legge n. 800 del 1862 (Legge Cavour), “Legge per l’istituzione della Corte dei conti del Regno d’Italia”, attribuiva alla Corte dei conti il controllo di tutti “i decreti reali, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l’obietto”, affinché venisse apposto il visto con conseguente registrazione (art. 13); al contrario, l’eventuale riscontro dell’illegittimità dell’atto, ossia della sua contrarietà al quadro normativo di riferimento, consentiva all’Amministrazione di avvalersi potenzialmente dell’istituto della registrazione con riserva, attraverso il quale veniva rimessa al Consiglio dei Ministri la decisione se dare o meno corso all’atto non vistato dalla Corte dei conti e dunque inefficace[4].
L’art. 100 della Costituzione assegna alla Corte dei conti, quale organo magistratuale terzo e indipendente, il controllo preventivo a tutela dell’interesse generale alla legittimità dell’attività pubblica, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 226 del 1976, c.d. “sentenza Crisafulli”)[5]. Attraverso tale giudizio, la Corte dei conti valuta la conformità al quadro normativo di riferimento degli atti amministrativi ad essa sottoposti, con esclusione di ogni apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico e, quindi, di qualsivoglia comparazione degli interessi coinvolti (Corte cost., sentenze n. 196 del 2018 e n. 18 del 2019).
La disciplina normativa del controllo preventivo, oltre che dal Testo Unico n. 1214 del 1934, è stata oggetto di diverse leggi successivamente intervenute, sino alla completa rivisitazione ad opera della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che oggi costituisce il riferimento generale in materia. Il controllo preventivo di legittimità è volto a verificare la conformità a legge dei provvedimenti sottoposti all’esame della Corte dei conti. L’attività di verifica interviene in una fase antecedente alla produzione degli effetti dell’atto e il cui esito determina, in caso positivo, la registrazione con apposizione del visto e, in caso negativo, la ricusazione del visto. Dal momento dell’apposizione del visto e della registrazione (anche con riserva) l’atto acquista efficacia, inizia quindi a produrre effetti giuridici.
Le tipologie degli atti da sottoporre a controllo preventivo sono tassativamente indicate nell’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e hanno subito ampliamenti e limitazioni negli anni secondo la discrezionalità del legislatore, in relazione alle finalità e alla rilevanza finanziaria che determinati atti possono assumere in un determinato periodo storico[6].
In via generale, occorre ricordare che il controllo preventivo di legittimità è preordinato a tutela del diritto oggettivo, a differenza dei controlli c.d. amministrativi, esercitati all’interno della pubblica amministrazione nell’interesse dello stesso ente conferente, e di altri tipi di controllo disciplinati da leggi speciali.
La disciplina del procedimento di controllo preventivo garantisce il contraddittorio con l’amministrazione interessata e consente alla stessa di adottare processi di autocorrezione e misure di autotutela: così nel caso di richiesta di ritiro da parte delle amministrazioni degli atti assoggettati al controllo di legittimità per un riesame degli stessi, alla quale può seguire la riproposizione degli atti, emendati dei vizi. In tutti questi casi, il procedimento di controllo si conclude nella c.d. fase monocratica, con la proposta del Magistrato istruttore e il visto del Consigliere delegato e conseguente registrazione dell’atto, senza cioè che ne sia data evidenza in deliberazioni. In altri casi la richiesta di ritiro avviene in conseguenza del deferimento dell'atto all'esame collegiale[7].
La Corte dei conti utilizza strumenti quali “note avviso” o “rilievi a vuoto” per indirizzare l’attività delle amministrazioni controllate, provocando il loro spontaneo adeguamento alle indicazioni o di manifestare le ragioni di ammissione a visto, giacché l’avvenuta registrazione dei provvedimenti presuppone il verificarsi di determinate condizioni, affidate all’effettiva verifica da parte dei responsabili dell’amministrazione.
Nel caso qui in esame il Magistrato istruttore, a conclusione dell’attività di competenza, ha analiticamente riportato in apposita relazione i chiarimenti forniti dall’Amministrazione e le proprie corrispondenti osservazioni e, ritenendo non pienamente superati i dubbi emersi, ha prospettato l’opportunità di deferire alla competente sede collegiale la valutazione della delibera CIPESS n. 41/2025 e della sua conformità al quadro normativo di riferimento oltre che ai principi del diritto dell’Unione Europea. Il Consigliere delegato, condividendo le conclusioni del Magistrato istruttore, ha rimesso la questione al Collegio.
È stato garantito il contraddittorio con il DIPE e le amministrazioni interessate, che hanno controdedotto alle osservazioni formulate e condivise dal Consigliere delegato nell’ambito della relazione di deferimento. In sede di adunanza, i rappresentanti delle amministrazioni hanno confermato le considerazioni già svolte nel corso dell’istruttoria e hanno fornito ulteriori chiarimenti.
Prima di analizzare i profili di illegittimità che hanno condotto a ricusare il visto, appare necessario comprendere in via generale quale sia l’ambito di cognizione e di decisione rimesso al Collegio del controllo preventivo in materia di contratti pubblici e di investimenti infrastrutturali, come nel caso di specie.
I più recenti orientamenti della Corte dei conti, con particolare riferimento al perimetro dei contratti pubblici (in specie art. 3, lett. g), legge n. 20 del 1994, cit. sull’approvazione dei contratti d’importo sopra le soglie ivi indicate), rimarcano che il controllo preventivo della Corte si pone a presidio non solo della legalità dell’operato dell’amministrazione, ma anche del corretto impiego delle risorse pubbliche, nonché, in ultima analisi, a tutela della collettività. L’attrazione della materia alla contabilità pubblica ha radici lontane, come puntualmente ricordato dalla recente pronuncia della Sezione regionale campana, fin dal r.d. n. 3074 del 1885, recante “Regolamento per l’applicazione del testo unico della legge sull’amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato”, poi della legge di contabilità generale dello Stato r.d. n. 2440 del 1923, “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e dal regolamento attuativo di cui al r.d. n. 827/1924. Le disposizioni ivi contenute (artt. 3 ss.), ancora applicabili in via residuale rispetto alla disciplina contenuta nell’attuale Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023, orientate a tutelare, seppur attraverso una disciplina significativamente più snella rispetto a quella attuale, l’interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, nonché il sotteso interesse alla economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, rilevando solo in via indiretta l’interesse dei concorrenti alla competizione paritaria[8].
La finalità principale delle menzionate norme è che i contratti si stipulino nel maggior interesse della pubblica finanza, giacché “in nessun altra branca dell’amministrazione quanto in quella finanziaria devesi osservare il principio di economicità, consistente nella suprema legge del minimo mezzo; altro mezzo funzionale a garantire l’erario viene individuato nella promozione della massima concorrenza, che si attua attraverso la pubblicità dell’aggiudicazione dei contratti e attraverso la possibilità per i privati interessati di assumere l’impresa progettata, anche quando non forniti di grandi capitali”[9].
Nel caso in esame, il Collegio ricorda che la funzione del controllo preventivo, nel caso in cui abbia ad oggetto provvedimenti relativi a investimenti pubblici infrastrutturali, è esercitata anche al fine di intervenire preventivamente su aspetti procedurali suscettibili di incidere, negativamente, sulla realizzazione dell’opera, una volta avviata.
In tale contesto si collocano le valutazioni del Collegio che, avuto particolare riguardo all’importanza strategica dell’opera e alle risorse pubbliche alla stessa destinate, ha assegnato prioritario rilievo alle violazioni della normativa del diritto dell’Unione europea nonché alle “illegittimità maggiormente significative”, sulle quali conviene ora distintamente soffermarsi.
3. Nel merito: le singole censure di illegittimità e il sindacato “rafforzato” (di legalità finanziaria) rispetto alla cognizione del giudice amministrativo
3.1. Violazione della direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 (c.d. direttiva Habitat). Tra politica e tecnica
La questione della violazione della Direttiva UE Habitat e della disciplina interna sulla valutazione di incidenza ambientale è correlata alla deliberazione con la quale il Consiglio dei Ministri, pur a fronte di una valutazione “tecnica” di incidenza negativa, ha approvato la c.d. relazione IROPI, cioè ha ritenuto sussistere "Motivi Imperativi di Rilevante Interesse Pubblico" che consentono di procedere senza necessità di ottenere il parere della Commissione europea, essendo sufficiente, ai predetti fini, la mera informativa.
In primo luogo, il Collegio ha dovuto verificare se tale deliberazione governativa fosse assoggettabile a controllo preventivo di legittimità: pur negando la sua riconduzione agli atti previsti dall’art. 3, co. 1, lett. a), della legge n. 20 del 1994, cit. il Collegio la ha ritenuta incidentalmente valutabile in quanto atto endoprocedimentale rispetto all’approvazione del progetto definitivo. La precisazione merita attenzione: seguendo lo schema del giudizio amministrativo di legittimità, è noto che l’atto endoprocedimentale di regola non è idoneo a produrre effetti lesivi e la sua impugnazione deve avvenire congiuntamente al provvedimento conclusivo, tranne nei casi in cui sia in grado di “dimostrare anticipatamente quale sarà la conclusione del procedimento” oppure concluda un subprocedimento dotato di autonomia[10]. Nel caso di specie, il provvedimento conclusivo coincide con l’approvazione del progetto definitivo, i cui vizi discendono dalla relazione IROPI, giacché essa ha condizionato il seguito di un procedimento “composto”, nel quale è previsto l’intervento della Commissione europea[11].
Nessun dubbio riguardo all’esclusione del carattere politico dell’atto[12], laddove è evidente, come rimarcato dal Collegio, che le valutazioni di incidenza ambientale, tra le quali rientra anche la procedura IROPI, sono espressione di esercizio di discrezionalità tecnica, oltre che amministrativa, sindacabile nell’ipotesi in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato[13].
Il ragionamento seguito dal Collegio, assolutamente condivisibile, attiene alla valutazione tecnico discrezionale che riguarda l’istruttoria secondo la direttiva Habitat, da condurre con maggiore rigore proprio quando si invoca l’applicazione di una procedura in deroga (art. 6, comma 4).
La deliberazione del Consiglio dei Ministri (per assurgere a “una scelta politica consapevole”) avrebbe dovuto trovare supporto nella compiuta istruttoria amministrativa, che per contro è mancata nel caso in esame. L’affermazione assume significato particolare ove rapportata all’istituto della c.d. “esimente politica presunta” che verrebbe introdotta in caso di approvazione del pdl Foti (nuovo art. 1, comma 1-ter, legge n. 20 del 1994) che argomenta la buona fede dei titolari degli organi di indirizzo politico quando gli atti da loro assunti siano proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici in assenza di pareri formali di contrario avviso. Tale esimente richiede però che gli atti adottati dai medesimi titolari rientrino “nell’esercizio delle loro competenze”: evenienza che secondo il Collegio non ricorre nel caso di specie[14].
Peraltro non si tratta di vizio meramente procedimentale, posto che all’affermazione secondo cui la relazione è stata predisposta a seguito di un confronto con tutte le Amministrazioni competenti per materia, non è corrisposto altro atto istruttorio, oltre la relazione medesima (peraltro mancante di qualsiasi elemento identificativo quali data e sottoscrizione), da cui potesse desumersi quali amministrazioni, oltre al MIT, siano state coinvolte in dette valutazioni nell’ambito di adeguata attività istruttoria. Il Collegio non si spinge a definire il vizio di legittimità integrato, che indubitabilmente integra l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e l’incompetenza riguardo alla deliberazione conseguentemente assunta dal Consiglio dei Ministri (che viene definita “l’involucro formale” nel quale sono ricomprese anche valutazioni sostanzialmente di natura amministrativa).
Il Collegio nega peraltro che l’esercizio dell’attività discrezionale possa essere riferito all’attività della società concessionaria (peraltro del MIT e non del MASE, al quale sono ascrivibili le competenze in esame): ancorché si tratti di società in house, non può la concessionaria sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio dei poteri istruttori affidati alla titolarità di quest’ultima, sub specie tutela degli interessi ambientali.
La rilevanza diretta della disciplina europea “Habitat” e delle linee guida nazionali per la VlncA[15] sono serventi a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva Habitat. A tal fine individuano quali momenti fondamentali delle valutazioni di competenza dell’Amministrazione, da un lato, l’assenza di soluzioni alternative a progetti che incidono su zone speciali di conservazione e, dall’altro, la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Anche in questo caso il Collegio ricostruisce le fasi essenziali del servente procedimento, che si svolge in maniera progressiva su tre livelli, la verifica dell’assenza di soluzioni alternative costituisce un prerequisito del livello III (misure di compensazione della procedura in deroga ex art. 6.4); a detta verifica si dà corso laddove, nonostante una valutazione negativa, si ritenga di non respingere un piano o progetto, ma di darvi, comunque, esecuzione.
In ogni caso, per quanto detta valutazione possa essere integrata anche nel livello II, quello relativo alla valutazione appropriata o di incidenza ex art. 6.3 – come prospettato dal MASE nella memoria inviata in vista dell’adunanza pubblica – la stessa deve, comunque, rispondere a precisi criteri sostanziali, afferenti ai siti interessati, che, ad avviso del Collegio, non risultano soddisfatti.
Al riguardo le medesime linee guida prevedono che, su ogni soluzione alternativa proposta, debba essere svolta un’analisi basata sui criteri di valutazione appropriata. A tal fine gli unici criteri da prendere in considerazione devono essere quelli ambientali e le varie alternative vanno confrontate alla luce dei loro effetti sugli habitat e sulle specie, presenti in misura significativa nel sito, e sui relativi obiettivi di conservazione, nonché sull'integrità del sito e sulla sua importanza per la coerenza ecologica della Rete Natura 2000. Le incidenze individuate di ogni alternativa devono essere descritte e quantificate in modo completo e preciso, talché “in assenza di una valutazione adeguata di tutte le alternative ragionevoli disponibili, non si può concludere che non vi siano soluzioni alternative”.
È di tutta evidenza la complessità delle verifiche, degli approfondimenti, degli studi e, delle conseguenti valutazioni, che sono demandate alle amministrazioni competenti in coerenza allo speciale valore ambientale che connota i siti della Rete Natura 2000.
Sul punto soccorre la giurisprudenza sovranazionale, particolarmente sensibile sulla conduzione del procedimento amministrativo servente all’autorizzazione e sul previo esperimento della VIncA, nel rispetto del principio di buona fede nell’azione amministrativa. Così: “In virtù dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, un’opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell’approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un’attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all’assenza di tali effetti”[16]. Lo stesso art. 6, par. 3, della direttiva 92/43 istituisce un procedimento di controllo preventivo fondato su un criterio di autorizzazione severo che, contenendo il principio di precauzione, consente di prevenire efficacemente pregiudizi all’integrità dei siti protetti dovute ai piani o ai progetti proposti, dal momento che impone alle autorità nazionali competenti di negare l’autorizzazione di un piano o progetto qualora sussistano incertezze sull’assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l’integrità di tali siti[17].
A completamento delle censure mosse dal Collegio nel caso in esame, si deve ricordare che l’Autorità competente alla valutazione dei documenti prodotti per la VIncA deve essere in possesso delle migliori conoscenze disponibili sul sito Natura 2000, nonché essere in grado di effettuare una analisi rigorosa degli studi e delle informazioni trasmesse da parte del Proponente del piano/progetto/intervento o attività, ed avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva e certa in che modo la proposta possa incidere sul sito Natura 2000 interessato. Le stesse Linee guida qui richiamate ricordano che il Valutatore, ai sensi della legge n. 241 del 1990, è tenuto ad operare sulla base del principio di buona fede nell’azione amministrativa[18].
Nel caso in esame, per contro, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale ha solo riportato la descrizione delle alternative ragionevoli prevista nell’ambito dello studio di fattibilità che il proponente deve presentare unitamente all’istanza di VIA, così come inserita nei formulari predisposti dalla società concessionaria.
Anche la c.d. relazione IROPI risulta immotivata, asserendo in via generica (e assiomatica) “date le motivazioni imperative di sicurezza e di sviluppo economico solo il Ponte sullo stretto, a campata unica, riesce a soddisfare le necessità minimizzando gli impatti ambientali”.
E dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, il MASE non ha offerto supporto motivazionale “tecnico”, limitandosi a valutare le misure di compensazione, recependo le scelte della società concessionaria.
Anche le ragioni di interesse pubblico “connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica” che consentono di prescindere dall’acquisizione di formale parere della Commissione europea e di far ricorso a mera informativa in favore della stessa sono state ritenute sprovviste di adeguata istruttoria svolta dalle strutture tecnico-amministrative dei ministeri competenti.
La relazione si sofferma, di contro, ampiamente sugli effetti economici dell’aumentata accessibilità, che risultano inconferenti ai fini della procedura in deroga, che, ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 6 della direttiva Habitat e, in considerazione delle peculiarità ambientali del sito ascrivibile alla Rete Natura 2000, come già detto, può trovare giustificazione unicamente in ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze di primaria importanza per l’ambiente, richiedendosi, nelle altre ipotesi, tra le quali possono ascriversi quelle economiche, il previo parere della Commissione europea. Si tratterebbe, in altri termini, di un’ipotesi di sviamento dal fine tipico.
Il Collegio evidenzia infine un’incompleta conduzione dell’interlocuzione con la Commissione europea circa la necessità di definire, in modo corretto e completo, sia gli impatti sui siti protetti, sia l’interesse pubblico prevalente, riferendo di aver individuato ambiti su cui sono necessari chiarimenti, nonché ulteriori misure che dovrebbero aiutare le autorità italiane a garantire che eventuali carenze vengano affrontate preventivamente (“prior to granting development consent or initiating works”). Il Collegio non lo richiama, ma pare violare il principio di leale collaborazione opporre, come fatto dal MASE, che la richiesta della Commissione europea risulterebbe generica.
Curiosa, infine, “l’interpretazione minimale del principio di precauzione” sostenuta incautamente dal MIT, secondo cui “lo stesso si applica esclusivamente alle cantierizzazioni che incidono sui siti di interesse prioritario senza precludere la libertà di attività economica”[19].
Conclusivamente il Collegio ritiene che la delibera all’esame debba considerarsi illegittima per violazione dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva europea Habitat, la cui osservanza si impone agli Stati membri e alle loro articolazioni organizzative, tra le quali anche al CIPESS, cui sono attribuiti compiti di tutela dello sviluppo sostenibile nell’ambito delle politiche di investimento pubblico[20]. È appena il caso di ricordare, al riguardo, che il 1° gennaio 2021, il CIPE è stato ribattezzato come Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), segnando un passaggio importante verso un’economia orientata alla transizione ecologica e alla sostenibilità[21]. Il cambiamento riflette la sfida principale del Paese nel promuovere la crescita in modo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e dell’Unione Europea. Il CIPESS ora è chiamato a valutare in modo sostenibile le opere relative agli investimenti pubblici, tenendo conto dei principi del “Do Not Significant Harm” previsti dai vincoli europei[22]. Inoltre, il CIPE approva i singoli progetti delle ex Infrastrutture Strategiche che hanno già avviato la valutazione d’impatto ambientale dal momento dell’approvazione del Codice dei contratti nel 2016, assegnando loro le risorse finanziarie necessarie.
3.2. Violazione dell’art. 72 della direttiva n. 2014/24/UE (c.d. direttiva Appalti). “Reviviscenza contrattuale” e necessità di nuova procedura selettiva
Il secondo profilo di censura riguarda l’approvazione del piano economico e finanziario che, tra l’altro, contiene “il costo complessivo dell’opera e le voci di spesa che lo compongono”.
Il tema è connesso al particolare e affatto peculiare istituto della “ripresa dell’efficacia” di contratti “caducati” nel 2012: lo schema normativo, affidato alla decretazione d’urgenza, prevede che la società concessionaria e il contraente generale nonché gli altri affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati (a loro volta per effetto di un decreto legge del 2012), manifestare la volontà che ciascun contratto “riprenda a produrre i propri effetti” subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una serie di rinunzie e condizioni menzionate dalla stessa norma[23].
L’art. 2 dello stesso decreto-legge, nel disciplinare il rapporto di concessione e i contenuti del relativo piano economico e finanziario, al comma 8-bis regola la rideterminazione del costo complessivo dell’opera includendovi i prezzi dei contratti caducati, aggiornati secondo i criteri ivi previsti in conformità al citato art. 72 della direttiva n. 2014/24/UE (c.d. direttiva appalti).
Il Collegio censura la delibera CIPESS che si sarebbe limitata a prendere atto, sotto l’aspetto finanziario, del costo totale dell’opera, senza svolgere alcuna considerazione in ordine alla procedura di aggiornamento dei costi, con particolare riguardo al rispetto dei presupposti di cui all’art. 72 della direttiva 2014/24/UE.
In tal senso non soccorrono neanche le note congiunte, predisposte in vista delle riunioni del CIPESS, e la relazione istruttoria del MIT, dalle quali non risulta evidenza di una dedicata attività istruttoria.
Ed anche la relazione della Società concessionaria riporta unicamente attestazioni di conformità dei corrispettivi “alla stregua di una teorica disamina dell’articolo 72 della direttiva, asseritamente supportata da un parere legale non allegato in atti, e in assenza di dati finanziari di riferimento”[24].
I riscontri hanno avuto particolare riguardo alla verifica dei presupposti ai quali l’art. 72 della direttiva appalti subordina la possibilità di modificare il contratto senza necessità di nuova procedura concorrenziale, e alla conformità della complessiva operazione, nonché delle modifiche medio tempore intervenute, alla predetta disposizione nella duplice prospettiva della natura sostanziale delle stesse e del contenimento dei rispettivi costi nel limite del 50%.
Il MIT ha fornito al riguardo una “interpretazione minimale” della disposizione europea, ma le finalità di trasparenza delle procedure e di parità di trattamento degli offerenti sottese alla direttiva[25] hanno condotto il Collegio a ritenere integrati i presupposti di cui al combinato disposto del paragrafo 1, lett. e) e del paragrafo 4 dell’art. 72 da cui discende la necessità di un nuovo confronto concorrenziale.
In particolare, risultano verificate “condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero attratto ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione”, essendo intervenute nell’originario programma contrattuale modificazioni, oggettive e soggettive, di favore per i soggetti aggiudicatori, talché l’operazione economica entro cui si collocano i rapporti negoziali differisce, in maniera significativa, da quella originaria.
Al riguardo rilevano le nuove modalità di finanziamento dell’opera, a valere, ex lege, integralmente su risorse pubbliche, del tutto diverse da quelle previste nell’originario contratto del 2006, che all’art. 5.2 prevedeva che “il soggetto aggiudicatore, la SdM, avrebbe dovuto ricorrere alla tecnica della finanza di progetto”[26].
Al riguardo, il Collegio ricorda che nel 2012 la realizzazione dell’opera fu interrotta proprio per l’impossibilità di reperire idonei capitali sul mercato.
È stata inoltre modificata la clausola di indicizzazione, prendendo a riferimento principale il costo di costruzione di un tratto stradale con galleria o con viadotto, corretto per il differenziale tra questo e l’IFOI. Ciò a fronte della previsione dell’originario contratto in forza della quale “il corrispettivo come determinato con l’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, verrà aggiornato tenendo conto della variazione dei prezzi intervenuta tra la data della delibera di approvazione del contratto preliminare, il 1° agosto 2003 e la data di adozione della delibera con cui il CIPE approva il progetto definitivo” sulla base del tasso di inflazione valutato secondo l’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Medesimo carattere innovativo, rispetto all’originario programma negoziale, deve riconoscersi, altresì, alla previsione di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.l. n. 35 del 2023, cit. che, nel prevedere il criterio di aggiornamento del corrispettivo, introduce una ulteriore clausola “di indicizzazione” secondo la qualificazione prospettata dal MIT.
Il Collegio rimarca inoltre la modifica essenziale alle percentuali di prefinanziamento dell’opera[27].
Il MIT ha eccepito l’impossibilità di applicare la direttiva 24/2014/UE alle modifiche precedenti il 2014[28]. Sul punto il Collegio, senza approfondire l’anomalo istituto del contratto che “riprende vita” e la distinzione con la “sola efficacia”, ricorda che l’effetto della reviviscenza non avviene automaticamente ex lege, ma richiede una nuova manifestazione di volontà delle parti contrattuali (atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 35 del 2023, cit.), la cui validità deve essere accertata alla luce dell’attuale quadro normativo di riferimento, europeo e nazionale. Peraltro, le richiamate disposizioni della direttiva 2014/24/UE costituiscano declinazione di principi generali di trasparenza e di concorrenza, già previsti nella precedente direttiva 2004/18/CEE, nella cui vigenza sono stati adottati gli atti in questione.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che le evidenze istruttorie depongano nel senso che risulta integrata la fattispecie di cui al richiamato paragrafo 4 e, in particolare, la sussistenza delle condizioni che, in forza della previsione di cui alla lett. a) del medesimo paragrafo, “avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione”.
Anche il MIT, nel corso dell’adunanza pubblica, ha espressamente ritenuto che l’operazione in esame costituisca una modifica sostanziale del contratto, ritenendo, tuttavia, che se le modifiche sono sostanziali si impone una nuova competizione concorrenziale solo in caso di superamento del limite del 50%. Al riguardo il Collegio eccepisce che la stessa prospettazione non è stata accompagnata dall’enucleazione di alcun elemento di calcolo idoneo a rendere esplicita la relativa operazione e il risultato ottenuto, sul presupposto che si tratti di “elaborazioni endoprocedimentali mai formalizzate in un provvedimento, effettuate ai fini dell’interlocuzione con la Commissione europea”, laddove, per contro, la Direzione generale della Commissione europea (DG Grow) ha posto particolare attenzione all’integrazione dell’art. 72 della Direttiva, cit.[29]
Il Collegio contesta infine l’incerta definizione dei costi dell’opera, in parte meramente stimati e, comunque, non includono alcuni oneri i quali, pur se ricompresi nel quadro economico dell’opera, non sono stati contrattualizzati; tra questi ultimi, rientrano, tra gli altri, i costi dei lavori indicati nella relazione del progettista (per 787 milioni di euro).
Nella stessa prospettiva deve riconnettersi rilievo alla mancata inclusione degli oneri afferenti all’importante quadro prescrittivo allegato, quale parte integrante alla delibera, nella sua dimensione fisica e finanziaria, e la cui quantificazione il Collegio non ha potuto apprezzare in ragione della mancata allegazione delle schede relative alle prescrizioni ritenute assentibili dal MIT, messe a disposizione nella versione non aggiornata.
3.3. Esclusione dell’Autorità di regolazione dei Trasporti dalla procedura di approvazione del Piano Economico-Finanziario. La tutela della concorrenza a danno della tutela dell’utenza
La delibera CIPESS ha escluso la necessità di acquisire il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), nell’ambito della procedura di approvazione del piano economico-finanziario, con specifico riguardo al sistema tariffario, desunto da uno studio di una società privata individuata dalla società concessionaria. L’esclusione è stata motivata asserendo che la Società concessionaria “gestirà in regime di concessione ex lege tratti di rete classificati, tenuto conto delle caratteristiche strutturali, tecniche e funzionali, come strada extraurbana di categoria B”, con conseguente inapplicabilità dell’art. 43 del d.l. n. 201 del 2011, istitutivo dell’Autorità.
Il Collegio correttamente ricorda la più ampia competenza generale nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture, affidata all’ART dall’art. 37 dello stesso decreto, riferita anche alla definizione “dei criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori” (comma 2, lett. b)[30].
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha del resto chiarito che “le attribuzioni dell’ART comprendono, in ampiezza, l’intero settore dei trasporti e dell’accesso alle infrastrutture”[31].
In tal senso depongono, altresì, i principi desumibili dalla direttiva (UE) 2022/362, che, al fine di radicare la competenza delle autorità nazionali di regolazione, valorizza non già la natura e la tipologia della strada, ma la circostanza che sia previsto il pagamento di una tariffa.
La stessa classificazione del tratto di rete oggetto di concessione quale strada extraurbana di categoria B è controversa e il MIT ha invocato l’eccezionalità del ponte e il tentativo di adottare una classificazione “quanto più vicina possibile” ad una delle categorie previste dalla disciplina di settore.
Manca in ogni caso un provvedimento amministrativo di classificazione formale del medesimo collegamento e il Consiglio Superiore dei lavori pubblici nel 1997 aveva qualificato il sistema di attraversamento come “autostrada", secondo una classificazione ripresa nel PEF per quantificare gli importi dei costi per la manutenzione ordinaria.
Ulteriore argomento speso dal MIT per escludere l’ART dal procedimento risiederebbe nella peculiare “natura giuridica del sistema di pedaggiamento in esame, diversa dalla funzione sinallagmatica tipica delle concessioni di costruzione e gestione”. Atteso che l’infrastruttura è finanziata integralmente da fondi pubblici, il PEF non è strutturato per assicurare l’ammortamento del costo complessivo dell’investimento e il pedaggio non avrebbe funzione remunerativa del capitale, essendo configurato esclusivamente quale provvista finanziaria volta ad assicurare la sostenibilità della fase di gestione e come uno strumento di governance pubblica e di attuazione di politiche di coesione territoriale e sociale.
Il Collegio ha ritenuto infondate tali argomentazioni, non contenute nella delibera CIPESS, e non coerenti con la disciplina del PEF, dove i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l’attraversamento del collegamento stabile, pur idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, siano “in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell’opera”[32].
Se dunque la disciplina speciale richiamata non assegna né al PEF né alle tariffe una natura peculiare, o difforme da quella ordinaria, non reggono nemmeno le deduzioni riferite alla provvisorietà del piano tariffario.
Il Collegio censura conclusivamente la lettura parziale, non condivisibile, del d.l. n. 201 del 2011, cit., istitutivo dell’ART, “calibrata esclusivamente sulla tutela della concorrenza”[33], precludendo la partecipazione al procedimento della medesima Autorità, quale soggetto autonomo e indipendente istituzionalmente preposto, altresì, alla tutela dell’utenza.
3.4. Le ulteriori osservazioni con finalità conformativa della successiva attività amministrativa
Il Collegio sottolinea inoltre altri profili rilevanti per conformare la successiva attività amministrativa. Per punti:
- L’istruttoria soffre il mancato apporto delle specifiche competenze del Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), che il dpcm 26 settembre 2023 qualifica come organo consultivo del CIPESS in materia tariffaria;
- la delibera del CIPESS non avrebbe “valenza sostitutiva assoluta” rispetto a ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato ai sensi dell’art. 3, comma 8, del medesimo decreto;
- la permanenza dei requisiti di gara in capo al Contraente generale, al Project Management Consultant e al Monitore ambientale non sono documentate: occorre rispettare il principio generale di continuità in forza del quale il possesso dei requisiti di gara, generali e speciali, deve essere verificato per tutta la durata del contratto e durante l’esecuzione dello stesso senza soluzione di continuità (Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 8/2015, Cons. di Stato, Ad. Plen. n. 7/2024)[34];
- la possibilità di una integrazione postuma della motivazione, espressa dal DIPE in adunanza, deve essere contemperata con l’esigenza di garantire effettività al principio di trasparenza dei processi decisionali e valutativi che caratterizza le grandi opere infrastrutturali e a cui assolve, tra l’altro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici risale al 1997 ed era riferito a un assetto normativo che prevedeva unicamente due livelli di progettazione (quello di massima e quello esecutivo): occorre un secondo parere, in ragione delle varianti al progetto preliminare rese necessarie da richieste di enti terzi e da sopravvenute prescrizioni di legge e dal committente. La precedente valutazione “potrebbe risultare gravemente inficiata sotto l’aspetto della necessaria attualità e concretezza”.
4. Osservazioni riassuntive sul controllo preventivo di legittimità nel caso di specie
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, si può valorizzare l’ambito di cognizione e di decisione del Collegio del controllo preventivo di legittimità, che utilizza lo schema del giudizio amministrativo di legittimità, ma lo rafforza sotto il profilo della legalità finanziaria.
Nel dettaglio si può ravvisare, nella prima e terza censura (Direttiva Habitat e mancato coinvolgimento dell’ART) una attenta ricognizione dei vizi procedimentali capaci di incidere sul contenuto sostanziale del provvedimento assoggettato a controllo, che si uniscono agli ulteriori rilievi contenuti nelle osservazioni con finalità conformativa della successiva attività amministrativa.
Assumono rilevanza, a tal fine, le considerazioni sulla c.d. relazione IROPI come atto endoprocedimentale che vizia l’approvazione del progetto definitivo, la carenza di istruttoria tecnica e la conseguente illegittimità della deliberazione assunta dall’organo politico, gli effetti del mancato coinvolgimento dell’ART nel procedimento di definizione tariffaria e la conseguente indebita violazione dei diritti dell’utenza. Rigorosi sono poi le indicazioni conformative per la successiva attività amministrativa, per le quali si ritiene difficile o comunque complessa un’attività atecnicamente esperibile “in sanatoria”. Il riferimento è alla impossibilità di una integrazione postuma della motivazione, che vanificherebbe il principio di trasparenza dei processi decisionali e valutativi che caratterizza le grandi opere infrastrutturali e alla necessità di nuovo coinvolgimento in via consultiva del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, trascorsi ben 28 anni dall’acquisizione del suo parere. È ben noto che il parere obbligatorio pretermesso non rientra di regola tra i vizi procedimentali sanabili, perdendo la sua acquisizione successiva la sua ontologica natura di “consiglio”.
Quanto alla seconda censura, relativa alla possibilità di modificare il contratto senza necessità di nuova procedura concorrenziale e alla conformità della complessiva operazione, nonché delle modifiche medio tempore intervenute, il Collegio esprime il proprio sindacato negando la sussistenza di entrambi i presupposti ex lege: accerta la natura sostanziale delle modifiche e il superamento del limite del 50% dei rispettivi costi. In disparte la discutibile nozione di “reviviscenza” contrattuale, imposta dal legislatore in via d’urgenza, la valutazione della Corte dei conti a sostegno della ricusazione del visto unisce aspetti di legittimità sostanziale e di legalità finanziaria, proiettati sulla sostenibilità dell’opera e sui rischi gravanti sulla collettività per effetto della sua realizzazione.
5. Le conseguenze del diniego di visto
Alla luce delle considerazioni esposte, per il Collegio del controllo preventivo di legittimità la richiamata delibera n. 41/2025 del CIPESS “non può essere dichiarata conforme a legge”, con conseguente ricusazione del visto e della conseguente registrazione del provvedimento.
L’unica possibilità di cui l’amministrazione dispone per ovviare alle conseguenze di un diniego di visto, consiste nella richiesta di registrazione con riserva, ai sensi degli artt. 24 e 25 del T.U. n. 1214 del 1934, cit. nei casi e con i limiti previsti dalla norma stessa. Il procedimento di “registrazione con riserva” costituisce l’unico strumento predisposto dal legislatore ai fini del discrezionale “superamento”, ad opera dell’Amministrazione, della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, controbilanciato da una specifica assunzione di responsabilità politica.
In caso di diniego, il Consiglio dei ministri può decidere egualmente che l'atto deve aver corso e in tale ipotesi la Corte dei conti è chiamata a deliberare, a Sezioni riunite. In questi casi, si procede alla cosiddetta registrazione con riserva (cioè, più precisamente, all'apposizione del visto con riserva) dandone notizia al Parlamento, che può poi sindacare politicamente il comportamento del Governo.
Una volta richiesto che l’atto abbia corso, l’Amministrazione non può più ritirare l’atto, che è ormai efficace, ma può al più annullarlo in autotutela, secondo i principi generali del diritto amministrativo.
Ciò posto, ritenere che l’Amministrazione, a seguito della ricusazione del visto, possa determinare discrezionalmente l’esito del procedimento di autotutela avviato (avente ad oggetto atti viziati secondo le verifiche dalla Corte dei conti) significherebbe anzitutto contraddire l’esito imperativo-cogente di tale attività di controllo, che affonda le sue radici nel testo costituzionale e nelle norme di rango primario sopra citate.
Tale natura imperativo-cogente è consentanea alla funzione “ausiliaria” del controllo preventivo di legittimità, che si pone spesso per la pubblica amministrazione come occasione per correggere le anomalie riscontrate, mediante ritiro o riforma dell’atto del quale sono stati contestati profili di illegittimità, stimolando nell’amministrazione controllata processi di autocorrezione ed innescando “doverose misure di autotutela, volte a rimuovere le irregolarità e a ripristinare una situazione di legalità, formale e sostanziale”[35].
Non è conseguentemente possibile, né legittimo, ritenere che la rimozione dell’atto ritenuto illegittimo dalla Corte dei conti debba avvenire attraverso il paradigma dell’autotutela facoltativa (di cui all’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990).
Con grande precisione, il giudice contabile ha recentemente ricostruito il seguito della ricusazione del visto, in rapporto con gli istituti di autotutela amministrativa decisoria[36], richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo la quale l’istituto della registrazione con riserva “costituisce l’unico mezzo attraverso il quale può essere data esecuzione agli atti che non abbiano superato il vaglio della Corte dei conti”, non ammettendo “alternative o surrogati giurisdizionali” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 3806/1974).
L’art. 25 cit., nel disciplinare l’attivazione della procedura di registrazione con riserva, prevede che la deliberazione di ricusazione del visto debba essere trasmessa “al ministro cui spetta” e “se esso risolve che l’atto o decreto debba aver corso”, la Corte dei conti può essere chiamata nuovamente a deliberare a Sezioni riunite e ordinerà la registrazione con riserva dell’atto “qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto”. Dunque, la valutazione di difformità dalla norma operata dalla Corte dei conti, sebbene impedisca l’immediata efficacia dell’atto, tuttavia, non vieta al Governo la possibilità di assumersi la responsabilità di rendere parimenti efficace l’atto stesso, a tal fine chiedendo alla Corte di conti di apporre il visto con riserva, che trova la sua ragion d’essere nell’atto di fiducia che lega il Governo e, quindi, l’amministrazione al Parlamento.
In altre parole, il procedimento di registrazione con riserva consente di “superare” il diniego di visto frapposto dalla Corte dei conti, ma sottende una specifica assunzione di responsabilità politica, riservando al Parlamento (al quale la Corte deve trasmettere periodicamente l’elenco dei provvedimenti registrati con tale formula) il giudizio sull’opportunità che la violazione di norme giuridiche sia stata commessa nel prevalente interesse pubblico, sicché il sindacato si trasferisce dal terreno della mera legittimità a quello politico-parlamentare.
È importante ricordare che la registrazione con riserva non attribuisce al provvedimento il crisma della legittimità disconosciuto dalla Sezione di controllo, limitandosi a prendere atto della volontà del Governo di portarlo ad esecuzione. Invero, in tal caso, la registrazione non esclude la gravità della colpa riconosciuta al visto senza riserva dall’art. 1, l. n. 20/1994, a tenore del quale “è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo”.
L’amministrazione si trova dinanzi ad una alternativa secca: a) prendere atto dell’inefficacia dell’atto ritenuto illegittimo dalla Corte dei conti, non potendo esso essere portato ad esecuzione; b) oppure, tenuto conto di tutti gli interessi coinvolti (ivi compreso quello eventualmente riferibile ad un soggetto privato), richiederne la registrazione con riserva attraverso il Governo e mediante l’attivazione del circuito di responsabilità politica sopra indicato.
Ad ulteriore comprova di quanto detto si pone il successivo co. 3 del medesimo art. 25 r.d. n. 1214/1934, a tenore del quale, in alcune ipotesi tassativamente indicate, “il rifiuto di registrazione è assoluto ed annulla il provvedimento”; è eloquente la collocazione di tale disposizione proprio nella medesima norma che disciplina la registrazione con riserva, ad attestazione dell’esistenza di un’alternativa dicotomica tra le ipotesi in cui l’amministrazione può “superare” la ricusazione del visto mediante il procedimento di registrazione con riserva e quelle – eccezionali – in cui neanche tale “via di uscita” risulta praticabile, la ricusazione esitando nella indefettibile caducazione dell’atto illegittimo.
Tali considerazioni sono fondate su una giurisprudenza secolare: già la IV sezione del Consiglio di Stato nel 1903 affermava la non impugnabilità del diniego di visto della Corte dei conti[37]; inaugurando un orientamento giurisprudenziale poi consolidato della giurisprudenza amministrativa[38] e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione[39].
Anche le Sezioni riunite in speciale composizione del giudice contabile hanno negato che, riguardo al controllo preventivo di legittimità su un atto amministrativo soggetto al visto della Corte dei conti, possano sussistere situazioni giuridiche soggettive rilevanti in tale sede, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, innanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, della delibera di ricusazione del visto, da parte del soggetto privato che ritenga lesa la propria sfera giuridica soggettiva, poiché costituente un interesse c.d. di mero fatto, privo di tutela ordinamentale[40]. Ed il Consiglio di Stato, da ultimo, ha rimarcato la “piena autonomia della Corte dei conti, che impedisce di configurare un rapporto di dipendenza della ricusazione del visto con la pronuncia del giudice amministrativo”[41].
Nel sistema costituzionale gli atti di controllo della Corte orientano il Parlamento nell’esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza sull’amministrazione: la valutazione dell’operato dell’amministrazione spetta conseguentemente al Parlamento stesso, attraverso la trasmissione periodica degli atti registrati con riserva, in attuazione dell’ultimo periodo dell’art. 100, co. 2, Cost., secondo cui la Corte “riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito”.
Con l’avviso della Corte, per l’effetto, è chiamato in causa il rapporto di responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento, nel senso che è offerto all’apprezzamento del Parlamento, con l’esito negativo del controllo, un dato conoscitivo su cui innestare un successivo sindacato politico. Le garanzie essenziali per gli interessi dell’amministrazione pubblica risiedono nella assegnazione della seconda deliberazione della Corte dei conti alle Sezioni Riunite e nella periodica presentazione al Parlamento dell’elenco degli atti registrati con riserva.
6. Conclusioni. Tra approvazione del pdl Foti e registrazione con riserva
Come noto, è in corso di approvazione al Senato il pdl Foti, che interviene ridisegnando complessivamente le funzioni e l’organizzazione della Corte dei conti. L’intera riforma è impostata enfatizzando il principio/criterio dell’efficienza, declinato su due piani: l’efficienza della pubblica amministrazione e l’efficienza (rectius, l’“ulteriore incremento” di efficienza, art. 3, co. 1) della Corte dei conti.
L’efficienza della Corte dei conti, tramite la sua riforma prospettata sul piano delle funzioni e dell’organizzazione, dovrebbe quindi essere strumentale al rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.
L’efficienza della pubblica amministrazione asseritamente indotta dalla riforma si fonda su istituti che riguardano sia il controllo sia la giurisdizione del giudice contabile (oltre a una nuova “attività consultiva”) in parte rilevanti anche per il caso qui in esame.
Tra questi la c.d. “esimente politica presunta” (secondo il nuovo art. 1, comma 1-ter, legge n. 20 del 1994: « Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso »). Fermo restando l’ineludibile principio della separazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione amministrativa, mai obliterato dalla giurisprudenza contabile, la disposizione indurrà gli organi di gestione a sollecitare con frequenza il nuovo potere consultivo della Corte dei conti (sub art. 2), con il conseguente aberrante istituto del silenzio-assenso ivi previsto.
L’efficienza, secondo questo disegno, coinciderebbe dunque con una “corsa al parere”, unita al silenzio-assenso del giudice contabile maturato entro 30 giorni dalla richiesta, cui conseguirebbe una sorta di autorizzazione tacita a proseguire lo svolgimento dell’attività amministrativa e, all’organo politico, di adottare formalmente l’atto di sua competenza. È appena il caso di ricordare che l’efficienza è un “criterio” che regola l’esercizio dell’attività amministrativa, assolutamente subordinato al principio di legalità, come ricorda chiaramente l’art. 1 della legge n. 241 del 1990.
Peraltro, tale disposizione richiama la “buona fede” (riferita all’organo politico) e utilizza quindi una clausola generale, in contraddizione con l’esigenza di tipizzare la colpa grave, per contro sollecitata da Corte cost., sentenza n. 132 del 2024[42].
Ove il pdl Foti venisse approvato prima della eventuale registrazione con visto della delibera CIPESS qui esaminata, si tratterebbe di valutare se la delibera del Consiglio dei Ministri conseguentemente assunta e gli eventuali effetti pregiudizievoli per l’erario, indotti da tale approvazione, possano godere di tale esimente. Ipotesi che si ritiene difficilmente invocabile, vista la carenza di istruttoria tecnica segnalata dalla stessa Corte dei conti.
L’altro punto forte, sui controlli, del pdl Foti riguarda la reintroduzione del controllo preventivo di legittimità, sia per gli atti degli enti locali di “particolare rilevanza e complessità” (art. 3, co. 2, lett. s), dove la lata delega al Governo non è accompagnata da principi e criteri direttivi circa la scelta da compiere, sia per i contratti pubblici connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), dove il controllo preventivo di legittimità è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l’aggiudicazione formale. I termini previsti per l’esercizio del controllo hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione della Corte dei conti, l’atto si intende registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità di cui all’art. 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata (nuovo art. 3, co. 1-ter, ma anche co. 1-quater per le regioni e gli enti locali, della legge n. 20 del 1994, cit.).
Il combinato disposto del silenzio-assenso sul controllo preventivo di legittimità e di correlata esimente dalla responsabilità, ove venisse generalizzato, condurrebbe, in un caso come quello qui in esame, a impedire alla Corte dei conti l’esercizio di un serio e approfondito sindacato di legittimità e a escludere da profili di responsabilità amministrativa l’adozione di provvedimenti di approvazione di progettazione e realizzazione di opere pubbliche causativi di danno erariale.
Il pdl Foti introduce inoltre una generale “attività consultiva” della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, addirittura in violazione del divieto di co-amministrazione ove i pareri siano resi su “questioni applicabili a fattispecie concrete” (attuazione del PNRR-PNC), con maturazione del silenzio-assenso entro 30 giorni dalla richiesta (art. 2). Ad avviso d chi scrive, la previsione viola le previsioni costituzionali dedicate alle funzioni della Corte dei conti (artt. 100 e 103). L’attuale funzione consultiva a favore degli enti locali, infatti, pur non prevista nel testo costituzionale, deve limitarsi a questioni in materia di contabilità pubblica che non impingano a scelte amministrative riguardo al caso concreto, come si evince dall’ampio apparato argomentativo del giudice contabile speso per motivare l’ammissibilità dei pareri richiesti e resi. La previsione del pdl in esame, per contro, afferma dichiaratamente il riferimento della funzione consultiva a questioni concrete, dimenticando la terzietà del giudice e rendendolo partecipe delle decisioni amministrative, mediante una commistione di funzioni. La previsione del silenzio-assenso, poi, corrobora questa lettura, giacché è inimmaginabile il suo richiamo all’esercizio di un’attività giurisdizionale.
Ma, soprattutto, l’eventuale approvazione del pdl Foti sortirebbe effetti importanti riferiti al caso di specie, con riguardo agli eventuali profili di responsabilità amministrativa correlati alle attività assoggettate all’eventuale visto con riserva. Lo stesso pdl, infatti, nel tentativo di tipizzare la colpa grave, la riconduce a fatti “incontrastabilmente” affermati/negati di fronte a evidenze contrarie (secondo il prospettato nuovo art. 1, co. 1, legge n. 20 del 1994), nonché all’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta “incontrastabilmente” dagli atti del procedimento. La colpa grave verrebbe esclusa dal rispetto dei pareri delle autorità competenti.
A parte il difficile inquadramento della nozione di “incontrastabilità”, che è diversa rispetto alla “incontrovertibilità” e alla “inoppugnabilità” (riferita agli atti), appare evidente, nel caso di specie, che i fatti acclarati in sede di controllo preventivo dalla Corte dei conti integrano “evidenze” (se non “pareri delle autorità competenti”) che risultano vincolanti e l’eventuale richiesta da parte del Governo della registrazione con riserva amplificherebbe le responsabilità connesse alla deliberazione dell’organo politico, fondate su fatti (appunto “incontrastabilmente”) accertati in fase procedimentale e acclarati dal Collegio del controllo preventivo di legittimità. Si verificherebbe, insomma, una sorta di cortocircuito perché il Governo si esporrebbe a maggiori profili di responsabilità proprio per effetto dell’approvazione della riforma della Corte dei conti che lo stesso esecutivo ha propugnato.
[1] Corte dei conti, Sez. centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, Adunanza del 29 ottobre 2025, Deliberazione n. SCCLEG/19/2025/PREV.
[2] Contenuto nell’allegato F del III Atto aggiuntivo alla convenzione fra il MIT e la SdM.
[3] Ddl n. 1457 (Senato della Repubblica).
[4] Per una interessante ricostruzione storica dell’istituto e della sua applicazione in materia contrattuale, cfr. la recente pronuncia della Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Campania, 28 novembre 2025 (Pres. M. Gagliardi – Relatore A. De Santis), ed ivi una dettagliata analisi sull’effetto conformativo per l’amministrazione e sui rapporti con l’autotutela decisoria, su cui infra.
[5] Corte cost., 18 novembre 1976, n. 226 (Rel. Crisafulli), richiamata per aver riconosciuto la legittimazione di giudice a quo della Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità con l’esigenza sostanziale di ammettere al sindacato di costituzionalità «leggi che (…) più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte», atteso che la funzione di controllo della Corte dei conti «è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa» (punto 3 in diritto). A commento, G. Amato, Il Parlamento e le sue Corti, in Giur. cost., 1976, 1985 ss., S. Pergameno, Funzione di controllo della Corte dei conti e instaurazione del processo di legittimità costituzionale, in Giur. cost., 1976, 2031 ss., che rimarca l’analogia del controllo della Corte dei conti con l’attività giurisdizionale, la posizione neutrale del magistrato addetto al controllo e la garanzia di mera legalità della funzione di controllo della Corte dei conti; F. Pizzetti, Corte dei conti tra Corte costituzionale e Parlamento, in Giur. cost., 1976, 2042.
[6] Per un esame dell’evoluzione normativa, cfr. R. Dainelli, Il controllo preventivo della Corte dei conti sugli atti delle Amministrazioni dello Stato, in Amministrazione in cammino, 19 aprile 2021; A. Luberti, I controlli della Corte dei conti come giurisdizione nell’ottica di razionalità della “Costituzione in senso sostanziale”, in Bilancio, comunità e persona, n. 2/2020, 128 ss.; E. Giardino, I controlli preventivi di legittimità e le questioni irrisolte, in Riv. trim. dir. pub., 2024, 1.
[7] Le diverse ipotesi sono esaminate da R. Dainelli, op. e loc. cit.
[8] In tali termini, puntualmente, la già richiamata pronuncia della Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Campania, 28 novembre 2025 (Pres. M. Gagliardi – Relatore A. De Santis).
[9] Nuovamente il richiamo alla pronuncia di cui alla nota precedente.
[10] C.E. Gallo, Manuale di giustizia amministrativa, XII ed., Torino, 2025, 165.
[11] Sui procedimenti “composti”, cfr. ad esempio, T.a.r. Campania, Napoli, sez. III, 26 luglio 2023, n. 4478, a mente del quale “In caso di procedimenti composti che si concludono con un atto emanato formalmente dalle autorità nazionali, ma in cui il potere decisionale effettivo sia esercitato dagli organi dell’Unione, con atti vincolanti ancorché di natura endo-procedimentale, l’autorità giurisdizionale competente è quella dell’Unione europea e non quella nazionale”. L’oggetto del giudizio riguardava un decreto della Regione Campania emesso in conformità a una relazione vincolante della Commissione europea, da cui discendeva l’obbligo, per l’amministrazione regionale, di provvedere al recupero di alcuni contributi concessi all’impresa ricorrente. Secondo il giudice amministrativo, tale schema procedimentale corrisponde “più alla logica dell’esercizio decentralizzato di tali poteri che non a una ripartizione delle competenze tra la Commissione europea e le autorità nazionali, ove il potere di adottare la decisione finale è riservato alla Commissione europea”, sicché simmetricamente, la competenza esclusiva ad esercitare il sindacato giurisdizionale sull’esercizio di tale potere deve spettare al Tribunale o alla Corte di giustizia UE, ex art. 263 TFUE.
[12] S. Foà, Gli atti e le responsabilità degli organi di governo pubblici, in AA.VV. (a cura di), Studi in onore di Carlo Emanuele Gallo, vol. I, Giappichelli, Torino, 2023, 34 ss.
[13] Cons. Stato, Sez. IV, 1° marzo 2024, n. 2044, richiamata dal Collegio; cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 388, che esige un’adeguata istruttoria tecnico-scientifica “ancor prima di procedere a VINCA vera e propria”.
[14] Sulla attuale portata della esimente politica nel giudizio contabile, cfr. P. Evangelista e D. Vitale, Merito ed esimente politica nel giudizio contabile, in S. Foà (a cura di), Il nuovo merito amministrativo, Torino, 2025, 297 ss.
[15] Linee guida predisposte, su impulso del già Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in raccordo con le regioni e le province, nell’ambito dell’attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità 2011-2020 e per ottemperare agli impegni assunti dall’Italia in relazione al contenzioso comunitario, avviato in data 10 luglio 2014 con l’EU Pilot n. 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell’art. 6, paragrafi 2, 3, 4, della direttiva 92/43/CEE Habitat.
[16] Corte di Giustizia UE in C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50, Causa C-243/15.
[17] Corte di Giustizia UE, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 57 e 58, C-399/14, EU:C:2016:10, punto 48, Causa C-243/15.
[18] Linee guida del Ministero dell’Ambiente sulla VIncA, 2019, punto 1.11 Responsabilità delle Autorità competenti sul rispetto dell’art. 6.3 della Direttiva Habitat.
[19] Per una ricostruzione del principio M. Renna, Il principio di precauzione e la sua attuabilità, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2023, disponibile in www.forumcostituzionale.it.
[20] Cfr. art. 1-bis, decreto-legge 14 ottobre, 2019 n. 111.
[21] V. Galliano, Infrastrutture strategiche e attrazione delle valutazioni ambientali in quelle economiche. La funzione del CIPE con riguardo all’Alta Velocità Torino-Lione, in I. Massa Pinto (a cura di), L’ambiente e la sua cura, Napoli, 2023.
[22] R. Ferrara, La valutazione di impatto ambientale fra principio di precauzione e DNSH (Do not significant harm): spunti di riflessione, in Riv. giur. urb. 2024, 12 ss.
[23] Art. 4, co. 3, d.l. 31 marzo 2023, n. 35, Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 58: “La società concessionaria e il contraente generale nonché gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, manifestare la volontà che ciascun contratto riprenda a produrre i propri effetti subordinatamente alla delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e previa definizione, per il relativo contratto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle seguenti rinunzie e condizioni: (omissis)”.
[24] In tale contesto si inseriscono le verifiche svolte dall’Ufficio di controllo dapprima con il rilievo e, successivamente, visto l’esito infruttuoso dell’interlocuzione istruttoria, con la relazione di deferimento, in risposta alla quale le Amministrazioni interessate hanno svolto considerazioni oggetto di ulteriore approfondimento in occasione della adunanza pubblica.
[25] Corte di giustizia dell’Unione europea, Sez. X, cause C-441/22 e C-443/22, sentenza 7 dicembre 2023, punto 61: l’art. 72 della direttiva 2014/24 mira a garantire il rispetto dei principi di trasparenza delle procedure e di parità di trattamento degli offerenti. Tali principi ostano a che dopo l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario apportino alle disposizioni di tale appalto modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell'appalto iniziale (v., in tal senso, sentenze del 13 aprile 2010, Wall, C-91/08, punto 37, nonché del 3 febbraio 2022, Advania Sverige e Kammarkollegiet, C-461/20, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata). L'osservanza di tali principi si inserisce, a sua volta, nell'obiettivo più generale delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici consistente nell'assicurare la libera circolazione dei servizi e l'apertura dei mercati ad una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri (sentenze del 19 giugno 2008, Pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, punti 31 e 32; del 13 aprile 2010, Wall, C-91/08, punto 37 nonché del 12 maggio 2022, Comune di Lerici, C-719/20, punto 42 e la giurisprudenza citata).
[26] Ciò in coerenza con la delibera CIPE n. 66 del 2003, che, a sua volta, nell’approvare il progetto preliminare, disponeva, altresì, che la copertura del costo complessivo dell’opera fosse assicurata per il 40% dall’aumento di capitale della società Stretto di Messina e per il rimanente 60% con finanziamenti da reperire sui mercati internazionali, senza garanzie da parte dello Stato, nonché in aderenza con il contenuto, pressoché pedissequo, dell’art. 16 della convenzione di concessione del 30 dicembre 2003.
[27] A tal riguardo, si osserva che il bando di gara prevedeva il prefinanziamento, a carico del Contraente generale, per una quota pari almeno al 10%, e non superiore al 20%, assegnando a detto requisito un punteggio pari a 5 punti; il Contraente generale si è aggiudicato il contratto proponendo per tale requisito il 15%. L’accordo integrativo del 2009 lo ha ridotto al 10% e ha assegnato a SdM la possibilità di ridurre ulteriormente la quota fino al limite del 5%.
[28] In via generale, A. Ciatti Càimi, Retroattività e contratto. Disciplina negoziale e successione di norme nel tempo, Napoli, 2007, spec. 131 ss. e 135 ss. circa il c.d. “ordine pubblico intertemporale”.
[29] sin dal “Package Meeting” dell’ 1-2 luglio 2024, cui hanno fatto seguito ulteriori interlocuzioni solo parzialmente documentate all’Ufficio di controllo pur a fronte di richieste istruttorie, in quanto asseritamente inquadrabili nell’ambito di un “dialogo caratterizzato dall’informalità dei rapporti attinenti ad una pluralità di dossier, incluso il Ponte, con contributi non prodotti per le consuete regole di cortesia istituzionale che non consentono di trasmettere documenti di lavoro e scambio di note non protocollate”.
[30] Per un’analisi completa delle competenze dell’ART, cfr. G. Veltri, La natura giuridica dell’Autorità dei trasporti e il suo ruolo nella regolazione di un mercato in via di trasformazione, in Giustizia-amministrativa, 15 marzo 2019.
[31] Cons. Stato, Sez. IV, sent. 4 gennaio 2021, n. 5.
[32] Art. 2, comma 8, lett. c), n. 2, del d.l. n. 35 del 2023, cit.
[33] Contro l’impostazione dell’attuale Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 2023: nella Relazione di accompagnamento si legge: “La concorrenza come mero strumento per il raggiungimento del risultato del “preminente interesse della committenza” (pag. 11): “La codificazione dei principi mira a realizzare, fra gli altri, i seguenti obiettivi: ribadire che la concorrenza è uno strumento il cui fine è realizzare al meglio l’obiettivo di un appalto aggiudicato ed eseguito in funzione del preminente interesse della committenza (e della collettività) (cfr. art. 1, co. 2, d. lgs. n. 36 del 2023, cit.)
[34] Con riferimento alla disciplina del contraente generale, sotto la vigenza del precedente Codice, C.E. Gallo, S. Foà, Affidamento a contraente generale, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2019, Vol. V, 345 ss.
[35] Corte dei conti, SS.RR. in sede consultiva, 30 ottobre 2024, Delibera n. 3/2024/CONS.
[36] Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Campania, 28 novembre 2025 (Pres. M. Gagliardi – Relatore A. De Santis), punto 3.3, dal quale si attingono i puntuali e completi richiami giurisprudenziali nel testo.
[37] Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 1903, ove si discuteva della disciplina applicabile nell’ipotesi di rifiuto opposto dalla Corte dei conti rispetto alla registrazione di un decreto reale di decisione di un ricorso straordinario. Come ricostruisce Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Campania, 28 novembre 2025 (Pres. M. Gagliardi – Relatore A. De Santis), loc. cit., già in tale occasione i giudici amministrativi riconobbero la insindacabilità giurisdizionale del rifiuto del visto della Corte, concludendo nel senso che il ministro interessato fosse tenuto a provocare la deliberazione del Consiglio dei ministri al fine di promuovere la registrazione con riserva di quel decreto reale “od emettere un diverso provvedimento, anche capace di discostarsi dal parere dello stesso Consiglio di Stato”. Tali considerazioni si saldano con quelle contenute nella successiva sentenza del 19 giugno 1903, con cui il Consiglio di Stato afferma la non impugnabilità degli atti costituenti espressione del controllo preventivo di legittimità, osservando che tali atti non sono conoscibili dal giudice in quanto la Corte costituisce nel contempo “emanazione del potere parlamentare, in virtù di delegazione permanente delle Camere” e “magistratura suprema ed autonoma … indipendente dal potere esecutivo”. Appartenendo all’ordine giudiziario, in nessun caso essa rientra “nell’orbita del potere esecutivo e nel novero degli organi amministrativi, non dovendo rispondere dei propri atti ad altra autorità che al parlamento per quanto riguarda l’adempimento del mandato parlamentare, e non avendo sopra di sé che la Corte di cassazione in quanto possano i suoi giudicati esorbitare dai confini della sua giurisdizione speciale”.
[38] Cons. Stato, Ad. Plen. sentenza n. 1 del 1961, Cons. St., nn. 572 e 597 del 1963 e n. 636 del 1996. Di particolare rilievo la sentenza n. 3806/1974 delle Sezioni Unite della Cassazione, con cui veniva annullata senza rinvio l’isolata sentenza del Consiglio di Stato n. 501/1972, che aveva ammesso un sindacato del giudice amministrativo sugli atti di controllo della Corte dei conti. La Cassazione aveva ribadito la sottrazione “a qualsiasi vaglio giurisdizionale” e la “permanente stabilità” delle delibere emesse dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità, stabilità “confermata proprio dall’esistenza dell’istituto della registrazione con riserva … che, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 19 dicembre 1966, n. 121), ‘costituisce deroga al principio della non eseguibilità degli atti del Governo o dell’amministrazione dello Stato ritenuti non legittimi dall’organo preposto al controllo giuridico’, ed ha il suo contrappeso ‘nell’immediato, istituzionale assoggettamento del provvedimento registrato con riserva al controllo politico del Parlamento’”.
[39] Cass. SS.UU., sentenze nn. 2073 del 1953, 1016 del 1964, 1396 del 1965 e 3806 del 1974, tutte richiamate da Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Regione Campania, 28 novembre 2025, cit.
[40] Corte dei conti, Sez. riunite in speciale composizione, sentenza 27 aprile 2020, n. 5/2020/SR.
[41] Cons. Stato, Sez. V, sentenza 3 giugno 2025, n. 4789.
[42] A commento critico, S. Foà, Oltre lo “scudo erariale”: quale futuro per la responsabilità amministrativa?, in questa Rivista, 15 aprile 2025.
Sullo stesso tema su questa Rivista si veda anche Il ponte sullo stretto: la delibera della corte dei conti e le ragioni dell’illegittimità e La Corte dei conti allontana il Ponte sullo stretto. Intervista di Roberto Conti ad Aurora Notarianni
Foto via Wikimedia Commons.

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
