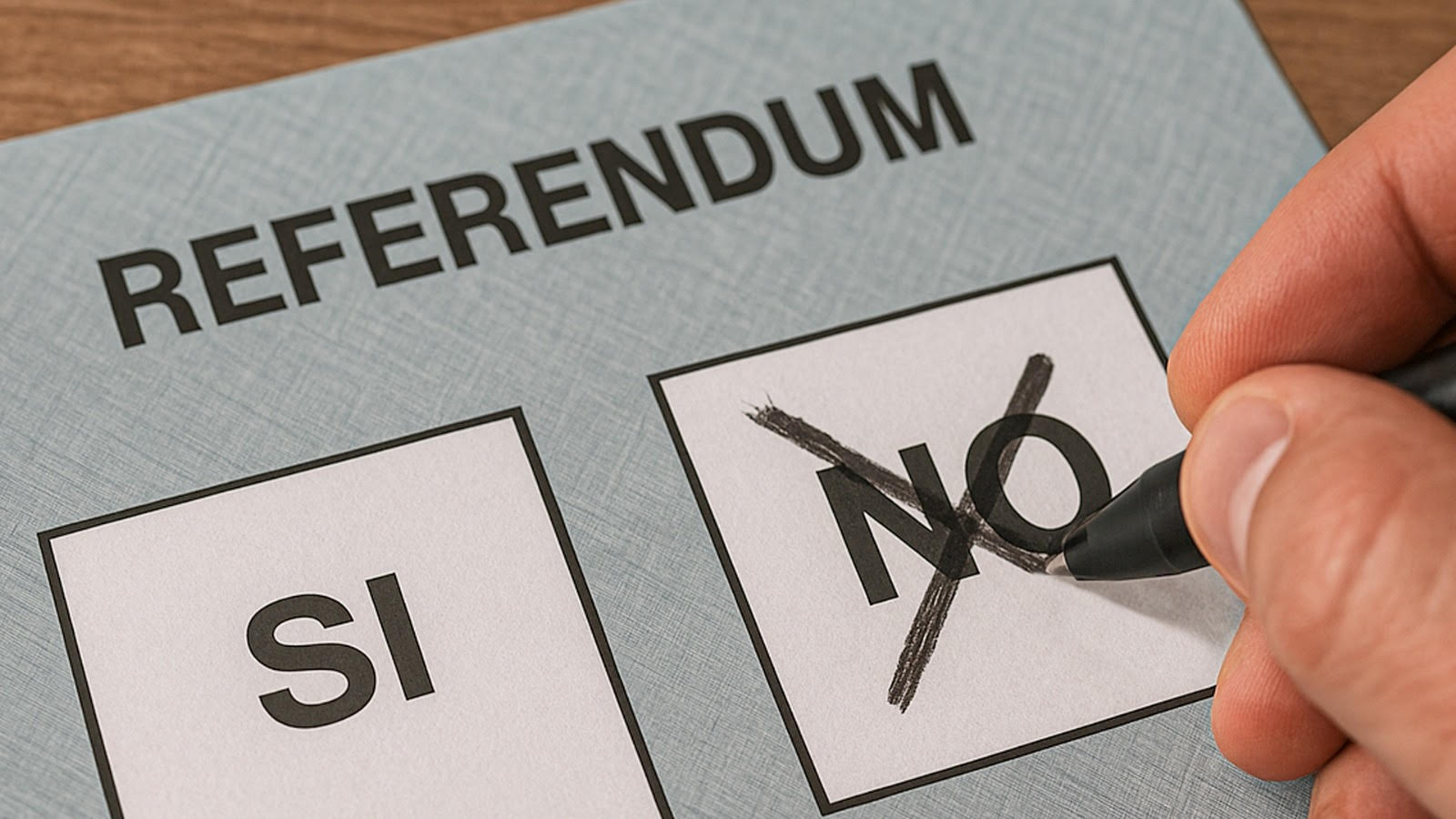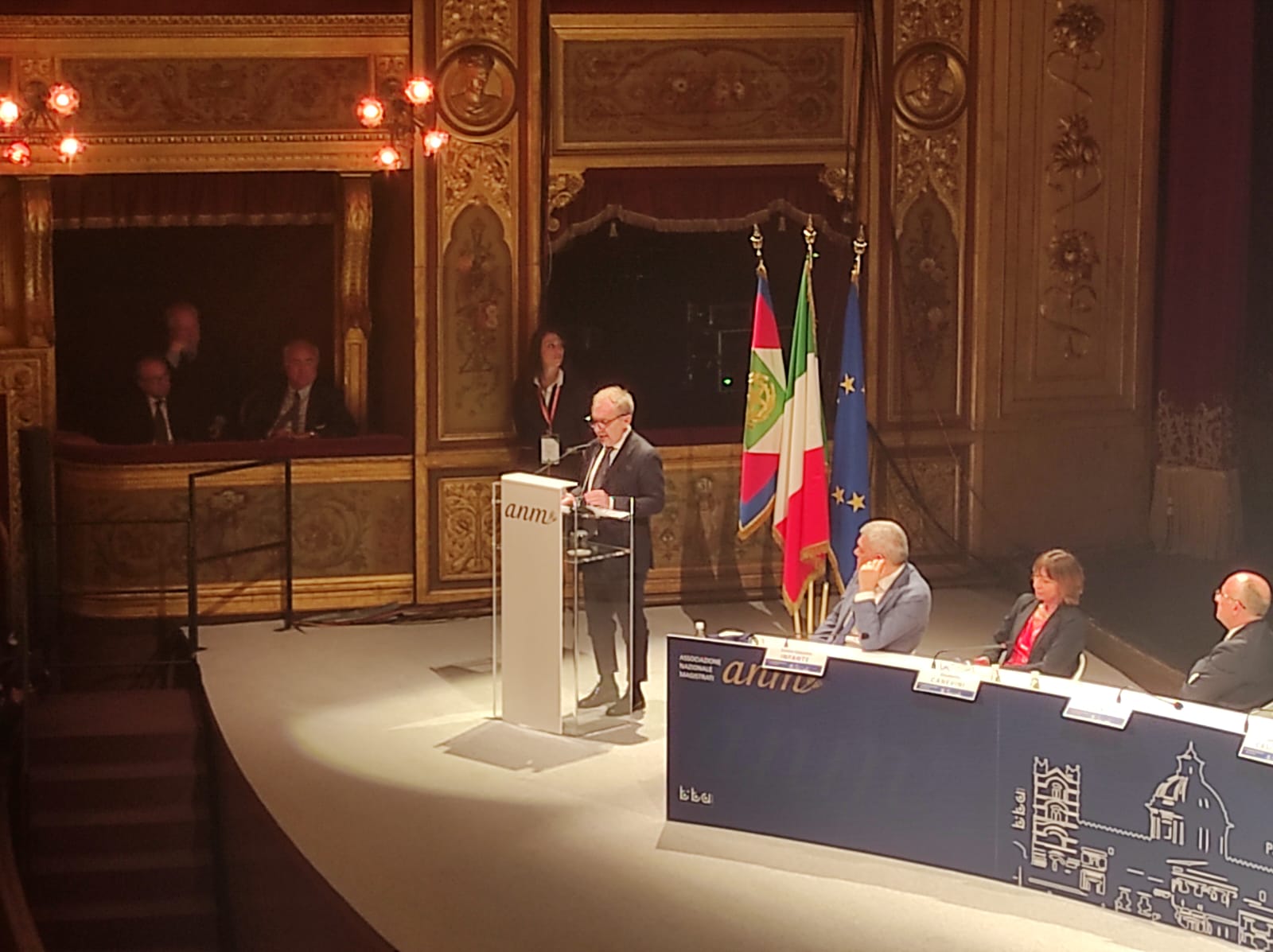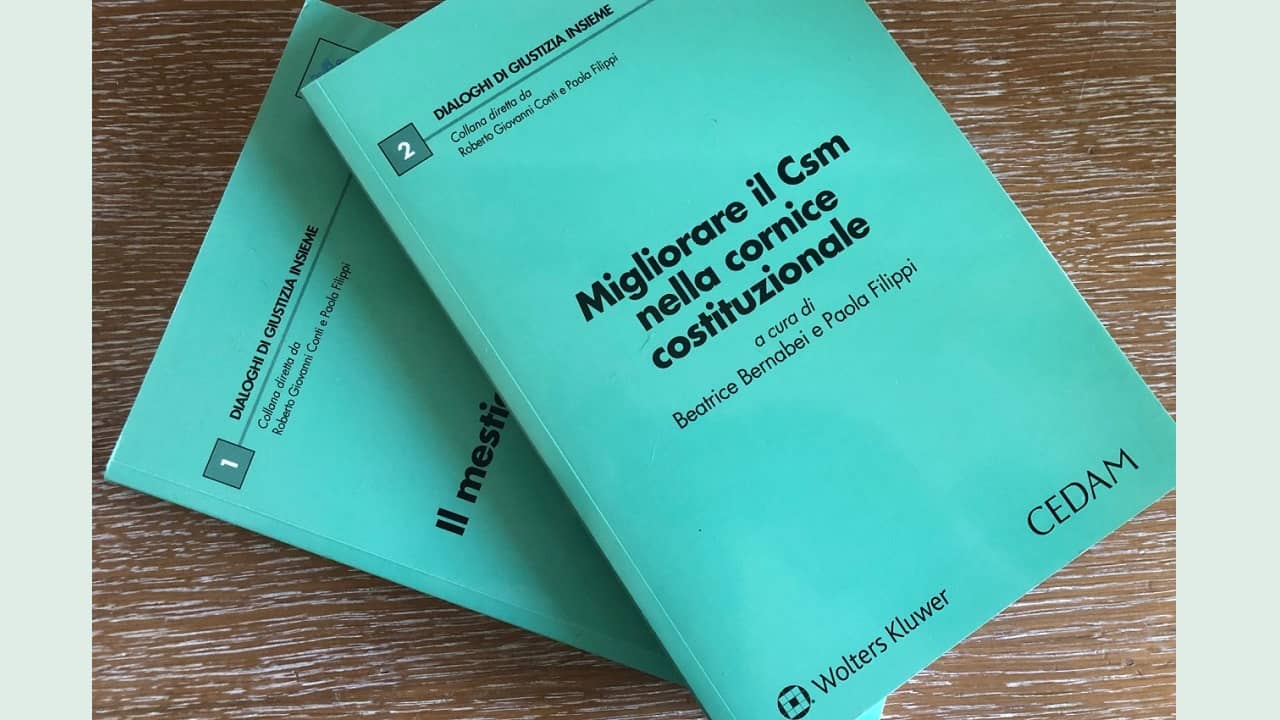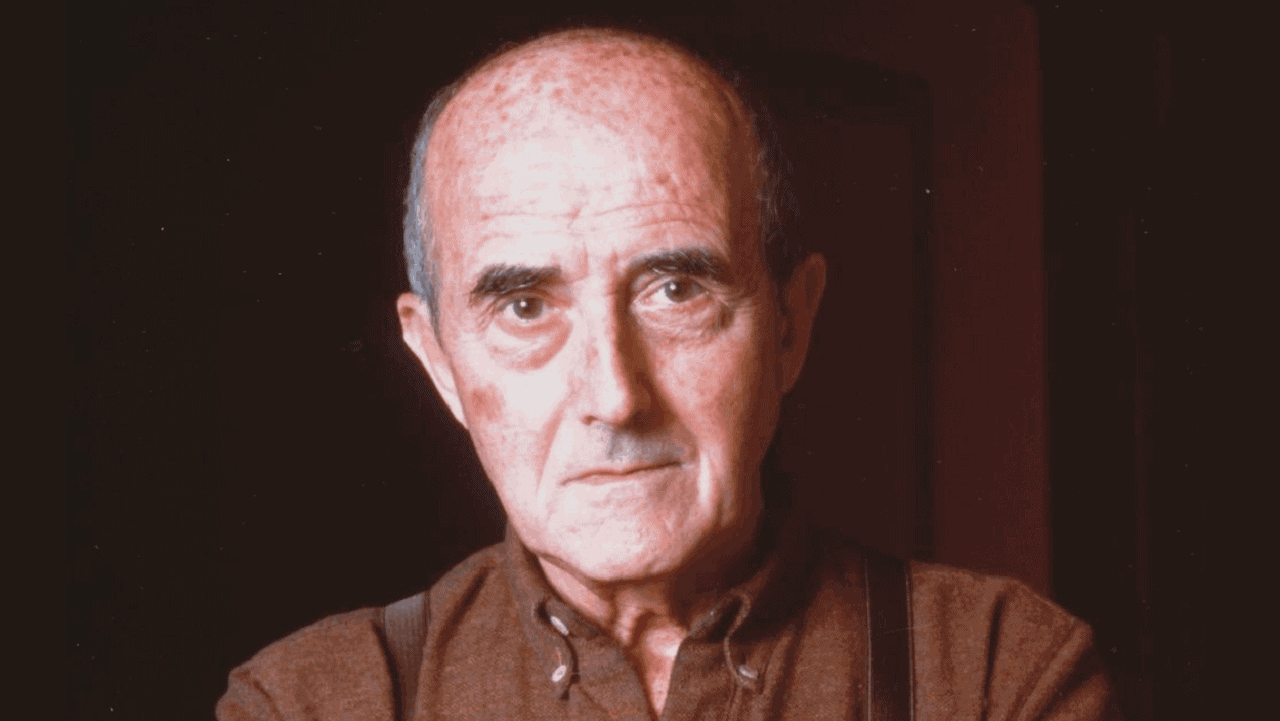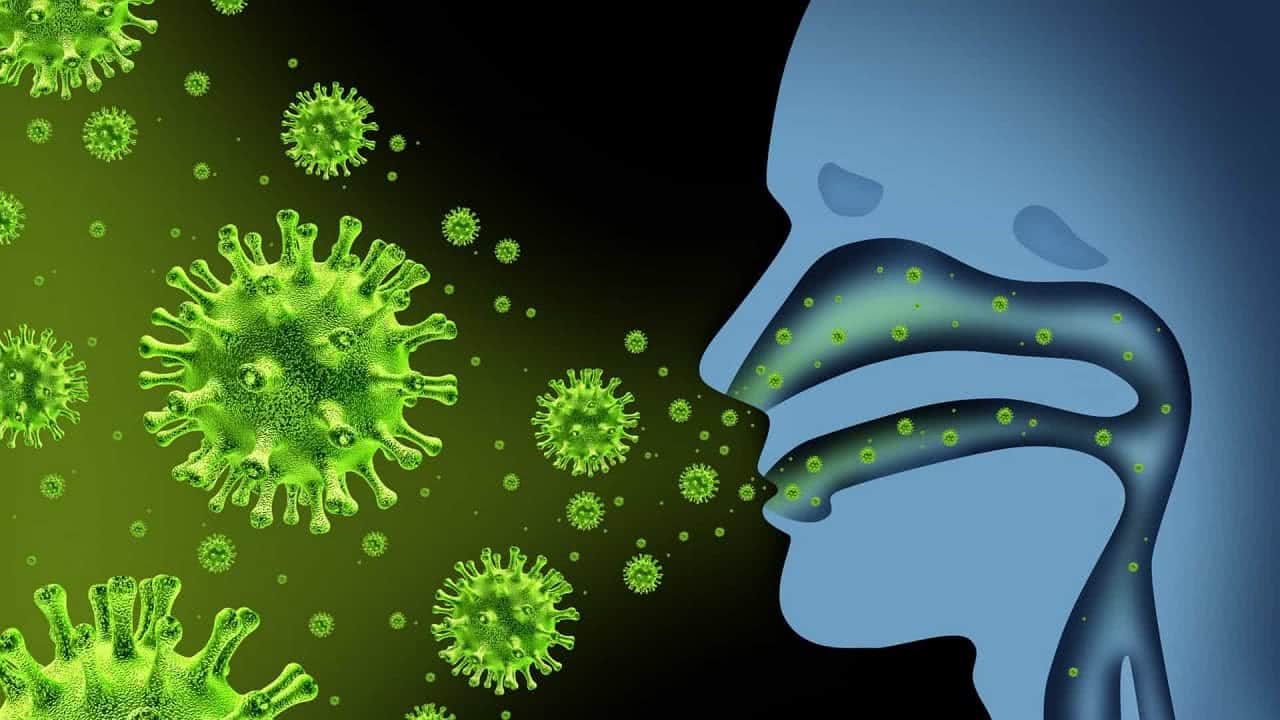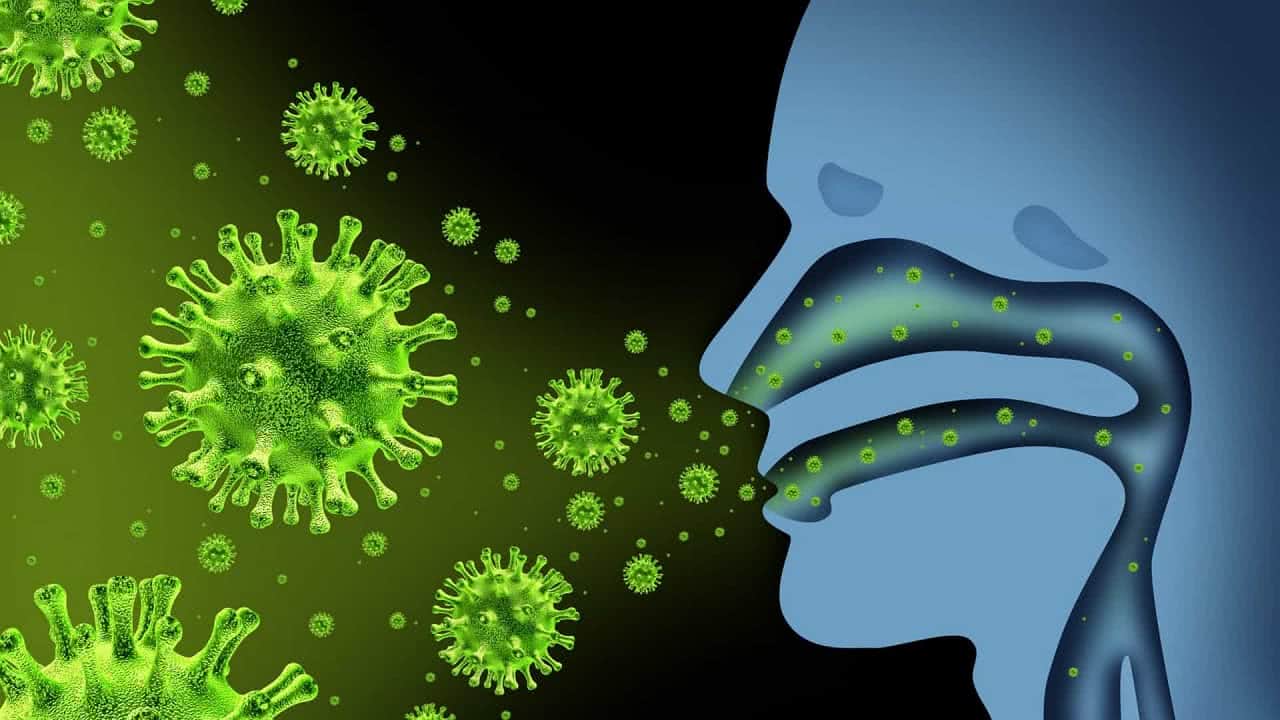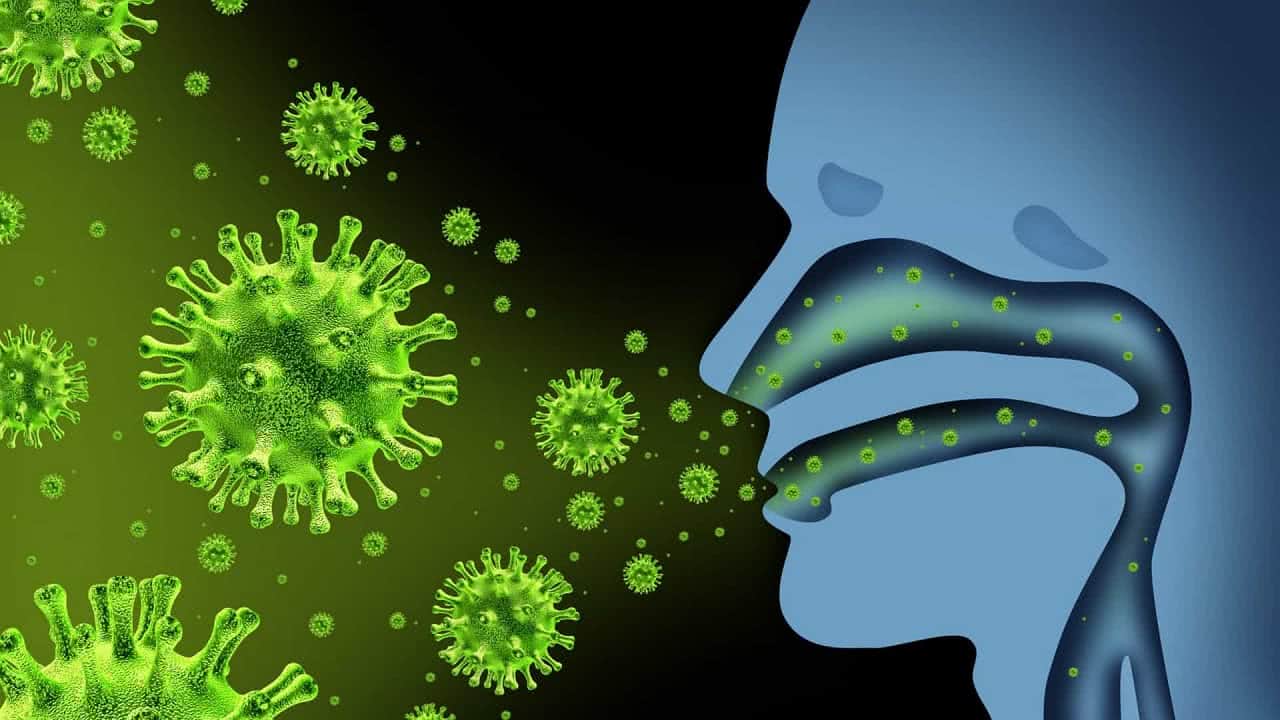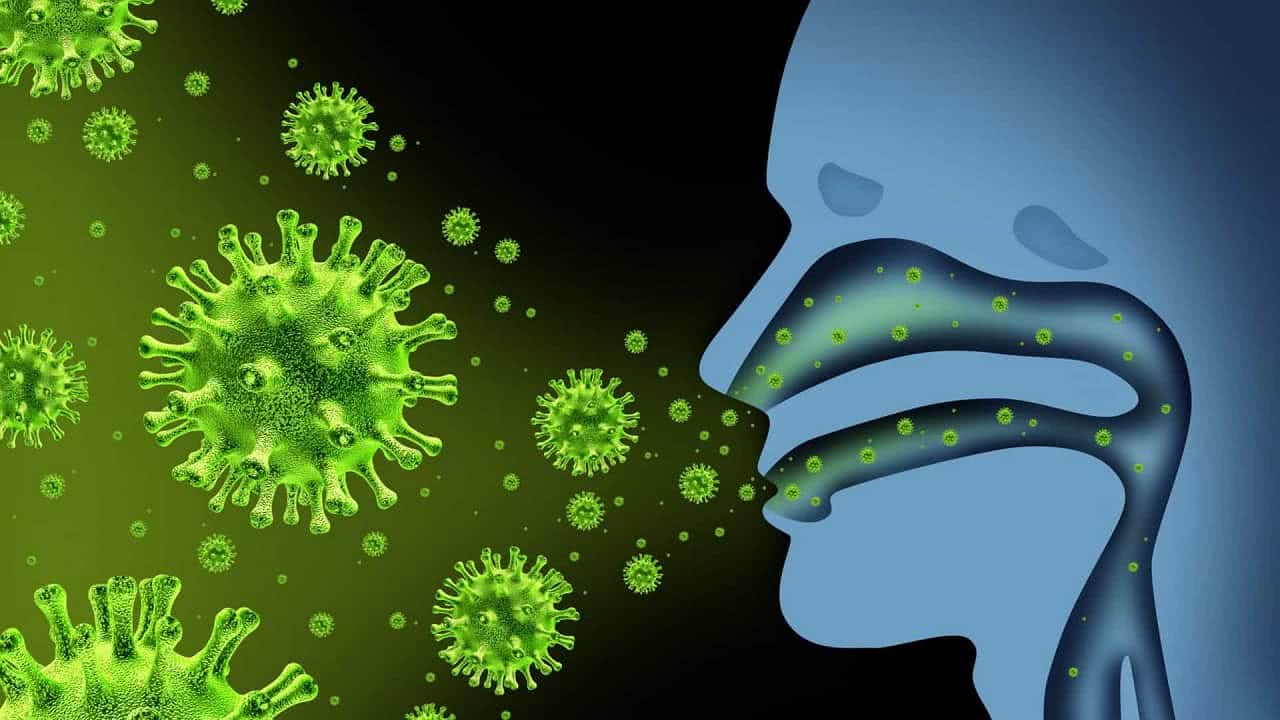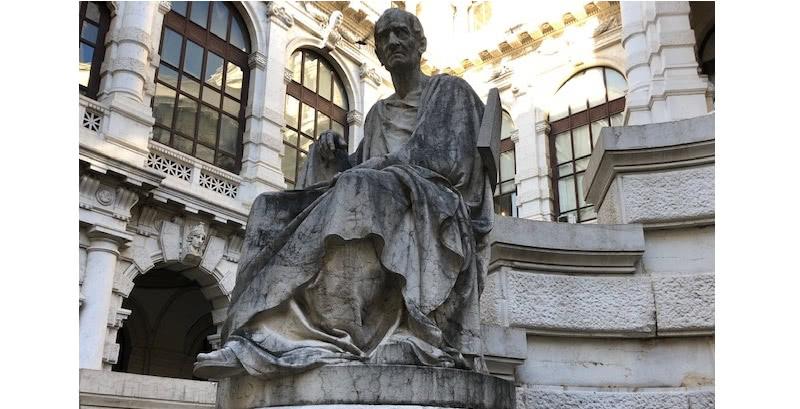Sommario: 1. L’Alta Corte disciplinare: perché? – 2. La diversità da alcune precedenti proposte. – 3. La burocratizzazione della magistratura passa anche per il nuovo sistema disciplinare. – 4. La composizione: la quota di magistrati, elitaria, minoritaria e mista. – 5. Quale sarà la sorte dell’azione disciplinare? – 6. I controlli impugnatori sulle decisioni dell’Alta Corte. – 7. L’incertezza sul futuro della giustizia disciplinare e non solo.
1. L’Alta Corte disciplinare: perché?
La riforma costituzionale della giustizia fa discutere soprattutto per la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri ma si compone di altri due capitoli, forse ancor più dannosi per l’equilibrato assetto del potere giudiziario.
Il disegno di legge che sta per raggiungere il suo finale approdo guarda anche alla giustizia disciplinare della magistratura tutta, giudici e pubblici ministeri, spogliando i due Consigli superiori del futuro di un’attribuzione tipica dei modelli di governo autonomo dell’ordine giudiziario, appunto la disciplina.
Perché lo faccia non è chiaro.
Se l’obiettivo fosse di porre fine alla cd. giustizia domestica, raccontata spesso – con troppa superficialità e mistificazione – come luogo dell’indulgenza corporativa, il prodotto non dovrebbe essere quello di un nuovo organo di giustizia a composizione prevalente di magistrati.
Se il fine fosse quello di spezzare il collegamento fiduciario, e quindi la potenziale negativa incidenza sulla imparzialità dei giudici disciplinari togati – oggi denunciata senza dati oggettivi al solo scopo di svilire l’immagine del Consiglio superiore della magistratura –, non se ne comprenderebbe il senso una volta che i due Consigli superiori che sorgeranno dalle ceneri dell’attuale saranno composti (anche) da magistrati non più eletti ma rigorosamente sorteggiati.
Non è da escludere, nella ricerca di un plausibile senso dell’estensione della riforma alla materia disciplinare – invece ignorata dagli abbinati disegni di legge di iniziativa parlamentare che hanno preceduto l’iniziativa governativa – che si sia voluto introdurre un tema in qualche modo caro al maggior partito dell’attuale opposizione politica, forse per stemperare la prevedibile contrarietà alla riforma nel suo complesso.
2. La diversità da alcune precedenti proposte
Si ricorderà che di un’Alta Corte tratta anche il disegno di legge S-94 della XIX (attuale) Legislatura[1], che la tratteggia come organo di giurisdizione per le controversie riguardanti l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, oltre che per le controversie riguardanti l’impugnazione di ogni altro provvedimento dei suddetti organismi riguardante i magistrati[2].
Questo disegno di legge, dunque, non sostituisce l’Alta Corte al Consiglio superiore della magistratura, e agli altri organi di governo autonomo delle magistrature speciali, che resta e restano giudici disciplinari di primo grado. Esso tenta, peraltro, una parziale unificazione delle giurisdizioni – profilo del tutto ignorato dal disegno di legge governativo che prosegue a tappe forzate la sua corsa verso il referendum confermativo – sì come molti anni prima aveva proposto il testo licenziato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali della XIII Legislatura, istituita con l. n. 1 del 24 gennaio 1997 (c.d. commissione D’Alema). Anche al tempo si ragionava di una Corte di giustizia, a cui affidare le attribuzioni disciplinari nei riguardi sia dei magistrati ordinari, ivi compresi i pubblici ministeri, sia dei magistrati amministrativi, che era in aggiunta organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.
Nulla di tutto questo nell’Alta Corte del disegno Nordio-Meloni.
Questo nuovo giudice speciale, istituito soltanto per la gestione della materia disciplinare nei riguardi delle due magistrature ordinarie, giudici e pubblici ministeri – magistrature divise ma, ciò nonostante, componenti di un unico ordine giudiziario – trova l’unica sua ragion d’essere nella spoliazione di una delle attribuzioni tipiche degli organi di governo autonomo.
I due Consigli superiori, che già risulteranno indeboliti dalla separazione e soprattutto dal meccanismo del sorteggio per la selezione dei loro componenti, subiranno un significativo impoverimento funzionale, inevitabilmente destinato a ridurne l’effettivo tono costituzionale. Previsti dalla Costituzione, ma per disposizione costituzionale i due Consigli superiori patiranno un’amputazione delle competenze[3] e saranno oggetto di una spiccata diffidenza, crudamente espressa nella scelta di recidere ogni legame di rappresentanza con le magistrature “amministrate”.
3. La burocratizzazione della magistratura passa anche per il nuovo sistema disciplinare
L’istituzione dell’Alta Corte, pur priva di un autonomo senso, concorre al ridimensionamento dell’ordine giudiziario. Pensata forse – come appena prima ipotizzato – per attirare qualche consenso tra le fila dell’opposizione parlamentare, è comunque funzionale a rendere più fragile il corpo giudiziario.
Separazione delle magistrature, introduzione del concetto di carriera nel testo costituzionale – nell’art. 102, comma primo, infine si aggiunge che le norme di ordinamento giudiziario disciplinano le distinte carriere –, rafforzamento della leva disciplinare sono i pilastri di una strategia che mira a ridisegnare i confini tra politica e giustizia, nell’illusoria e fuorviante speranza che sia questa la strada da battere per restituire alla Politica il suo primato.
Il tentativo abbastanza scoperto è di sospingere la magistratura – che in questi lunghi anni di storia repubblicana si è nutrita di elaborazioni sul proprio ruolo, sulla propria funzione sociale che hanno direttamente attinto ai principi costituzionali – entro il recinto dell’agire burocratico, per ripiegarla interamente sui propri interessi di carriera, mossa dalla speranza di progressione e promozione e frenata dal timore delle punizioni disciplinari.
Non deve passare inosservato che il testo della riforma non si limita al trasferimento di competenze tra Consigli superiori e nuovo giudice speciale, ma incarica il legislatore ordinario di adeguare le leggi sulla giurisdizione disciplinare alla nuova configurazione. Certo, un adeguamento è nell’ordine naturale delle cose, per il semplice fatto che la sostituzione di un tribunale disciplinare con uno di nuova istituzione, che ingloba anche le funzioni di giudice di secondo grado, reca con sé la necessità di qualche adattamento.
Data l’ampiezza di previsione non può però escludersi che il legislatore ordinario potrà cogliere l’occasione per porre mano ad un aggravamento dell’apparato disciplinare in linea e in conformità con uno dei possibili significati della creazione di un giudice ad hoc, a null’altro votato se non alla repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati.
È affermazione difficilmente contestabile che l’attribuzione della competenza disciplinare all’organo di governo autonomo comporti fisiologicamente una maggiore capacità di individuare, per la gran parte delle fattispecie costituite dagli illeciti funzionali, l’effettiva violazione dei doveri professionali, al di là del riscontro formale della ricorrenza degli indici esteriori della caduta deontologica.
Si può mettere a frutto, ove concorrano in uno stesso organo le funzioni disciplinari e le attribuzioni di cd. amministrazione della giurisdizione, la piena conoscenza del contesto, delle dinamiche che lo connotano, della situazione organizzativa degli uffici giudiziari, per meglio conoscere dell’illecito funzionale in addebito[4].
Se si conoscono le reali condizioni e il modo in cui operano i singoli uffici giudiziari, si può valutare con maggior aderenza alla realtà se un determinato comportamento, che in ipotesi abbia violato i doveri funzionali, meriti o meno di essere sanzionato.
Di contro, con l’attribuzione della materia disciplinare ad un organo estraneo all’organizzazione giudiziaria, privo di quell’utile bagaglio di conoscenze di contesto, è pressoché inevitabile che si giunga ad un’accentuazione del carattere repressivo del sistema disciplinare[5].
Il rischio concreto, con questo mutamento di modello, è che il sistema disciplinare potrà, nei fatti, scolorirsi in un suo tratto costitutivo, che molti anni addietro fu messo in evidenza dalla Corte costituzionale – Corte cost. n. 100 del 1981 – quando ricordò che il fondamento dell’intervento disciplinare va ricercato non già, come avviene per gli impiegati pubblici, “nel rapporto di supremazia speciale della pubblica amministrazione verso i propri dipendenti”, data la soggezione dei magistrati soltanto alla legge e a null’altro, ma nell’esigenza di garantire “il regolare svolgimento della funzione giudiziaria”, che può essere soddisfatta, si aggiunge qui, se non lo si sbilancia in direzione spiccatamente punitiva e se si conforma ogni suo aspetto all’obiettivo, finalisticamente preminente, di irrobustimento di un’adeguata (e sempre più ricca) cultura professionale.
4. La composizione: la quota di magistrati, elitaria, minoritaria e mista
L’Alta Corte sarà composta da magistrati di entrambe le magistrature (nove membri, di cui sei giudici e tre pubblici ministeri), che saranno selezionati per sorteggio, sì come quelli dei Consigli superiori, e da esperti, professori in materie giuridiche ed avvocati, in parte di indicazione parlamentare, sempre attraverso la mediazione del sorteggio, ma del sorteggio cd. temperato (tre membri), ed in parte nominati dal Presidente della Repubblica (tre membri).
Qui, a differenza che per i Consigli superiori, il ricorso al sorteggio è meno criticabile. L’Alta Corte ha infatti funzioni esclusivamente giurisdizionali, non esercita alcuna attribuzione di politica giudiziaria.
Ciò non significa che l’innovazione sia condivisibile.
Alcune ragioni di critica si situano anzitutto, come già detto, a monte, nella scelta di sottrarre la materia disciplinare al Consiglio superiore senza che se ne possa apprezzare una qualsivoglia ragione che non sia quella di deprimere il governo autonomo e inasprire i meccanismi punitivi[6]. Altre attengono, invece, alla restrizione della platea di magistrati tra cui sorteggiare i componenti dell’Alta Corte. Il sorteggio verrà fatto tra gi appartenenti alle due magistrature “con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”.
Traspare chiaramente l’idea di una magistratura verticalmente ordinata, ove chi occupa i posti in alto della piramide orienta e controlla quanti esercitano la giurisdizione “in basso”[7].
Non v’è, infatti, altra ragione nello scegliere i componenti dell’Alta Corte soltanto tra i cassazionisti se non rimarcare un carattere latamente gerarchico, che per il vero da qualche tempo si sta già facendo strada nell’organizzazione giudiziaria. Si è, ad esempio, manifestato con la recente riforma (cd. Cartabia) dell’ordinamento giudiziario, che ha inteso riservare un ruolo nelle valutazioni di professionalità al dato dell’esito degli affari nei successivi gradi di giudizio, come se una riforma o un annullamento intervenuto nei gradi di impugnazione possano dire qualcosa, e qualcosa di utile, sulla professionalità del magistrato che ha adottato e redatto il provvedimento impugnato.
Né può pensarsi che la decisione di sorteggiare soltanto tra i magistrati con funzioni di legittimità possa spiegarsi alla luce dell’attribuzione all’Alta Corte della competenza sulle impugnazioni, con assorbimento quindi del ruolo e delle funzioni oggi esercitate dalla Sezioni unite civili della Corte di cassazione. Sul punto si tornerà a breve, ma pare assai poco discutibile che l’eventuale attribuzione del giudizio di legittimità sulle sentenze disciplinari non possa giustificare la selezione ristretta, che trascura, a questo punto del tutto irragionevolmente, le competenze professionali dei giudici di merito e l’importanza del giudizio sul merito disciplinare.
Non comporranno l’Alta Corte il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione, che invece saranno componenti di diritto, ciascuno del Consiglio superiore di diretto riferimento.
L’assenza dall’Alta Corte delle figure di vertice della Corte di cassazione si spiega ricordando che la materia disciplinare già oggi, seppure attribuita al Consiglio superiore nel suo complesso, è affidata in forza di legge ordinaria alla sezione disciplinare del Consiglio superiore stesso, di cui, come di qualunque altra articolazione interna, non fanno parte né il primo presidente né il procuratore generale.
Eppure, per quanto non fosse da attendersi altro, la mancanza dei due togati rende ancor più evidente un aspetto di struttura della nuova Corte che non si vede come possa esser condotto ad un disegno di sistematica razionalità.
Si può facilmente convenire che le attribuzioni rimesse ai Consigli superiori non siano certo più rilevanti della materia disciplinare sul piano dell’effettività dei principi di autonomia e di indipendenza dei magistrati. Sul terreno della responsabilità disciplinare si sperimenta, come è facilmente comprensibile, la maggiore debolezza del magistrato raggiunto da una incolpazione per scelta ordinariamente del Ministro della giustizia. Se così è, non v’è modo di spiegare perché mai i Consigli superiori conserveranno la maggioranza numerica, nella misura di 2/3, della componente cd. togata, ulteriormente rafforzata dalla presenza del componente di diritto, e l’Alta Corte invece avrà la componente magistratuale in maggioranza sì ma di quota inferiore a 2/3 (9 su 15 componenti è quota di poco inferiore a 2/3).
Resta poi incomprensibile, e questo è il profilo critico di maggior rilievo, la vistosa dissonanza dalla dichiarata ragione di fondo del nuovo assetto costituzionale, di eliminare i luoghi in cui giudici e pubblici ministero possano contaminarsi reciprocamente. La separazione delle magistrature si sostanzia soprattutto nella creazione di due diversi Consigli superiori, per rimediare, secondo quanto reiteratamente dichiarato dai proponenti la riforma e tra questi dal Ministro della giustizia, all’eccentricità che oggi vede pubblici ministeri occuparsi, nell’ambito dell’unico Consiglio superiore, delle carriere dei giudici, e viceversa.
Ebbene, sarebbe stato coerente dividere anche gli organi della giustizia disciplinare, e non consentire la commistione di giudici e pubblici ministeri proprio nell’ambito degli affari disciplinari, ove le temute e sbandierate cointeressenze dovrebbero essere, nella distorta ottica riformatrice, ancora più di nocumento per la vagheggiata terzietà dei giudici.
Insomma, si fa tanto per separare i pubblici ministeri dai giudici, si lacera un ordito costituzionale che ha retto in questi lunghi, e non di rado bui, anni di storia repubblicana, durante i quali l’ordine giudiziario è stato messo a dura prova nel contrasto di gravi fenomeni criminali – terrorismo politico e mafia stragista – e ha svolto al meglio la sua funzione di tutela dell’ordinamento costituzionale e delle libertà di tutti, e si muta radicalmente prospettiva nella costruzione dell’Alta Corte, ove saranno apertamente tradite le aspettative riformatrici di due magistrature per compartimenti stagni.
I pubblici ministeri presenti nell’Alta Corte si occuperanno degli affari disciplinari dei giudici, e viceversa, quindi saranno i dossier più delicati, quelli disciplinari, a continuare ad essere oggetto di condivisione, senza che venga dato conto del perché ciò non dovrebbe mettere in pericolo la terzietà dei giudici, per come è raccontata dai sostenitori della riforma.
Peraltro, se nell’Alta Corte giudici e pubblici ministeri non fossero insieme, non si potrebbe affermare che il nuovo assetto assicurerà la prevalenza numerica della componente togata. Solo grazie al conteggio cumulativo (sei giudici e tre pubblici ministeri) può dirsi che anche l’Alta Corte osserverà il principio della prevalenza dei magistrati, ma il vero è che ciascuna magistratura, se isolatamente considerata come dovrebbe essere in nome della rigida separazione, si vedrà componente minoritaria, senza che sia dato comprendere la diversità di disciplina per la composizione dei due Consigli superiori che, come già detto, si occuperanno di aspetti della carriera dei magistrati di riferimento non certo di maggior rilievo ed importanza.
Infine, se si guarda ai numeri, non è difficile prevedere che nella composizione dei collegi in cui si articolerà l’Alta Corte, secondo la disciplina che verrà dettata dal legislatore ordinario, la rappresentanza dei magistrati giudicanti o requirenti potrà esser sì garantita, come prescrive espressamente il disegno di legge, ma non sempre in piena osservanza del criterio di maggioranza numerica, almeno non se le due magistrature, come pare coerente con l’intera architettura della riforma, verranno isolatamente considerate.
5. Quale sarà la sorte dell’azione disciplinare?
Il testo della riforma ovviamente tace non incidendo sulla previsione dell’art. 107, che assegna al Ministro della giustizia la titolarità dell’azione disciplinare, ma non è affar da poco prefigurarsi quale potrà essere la complessiva sistemazione dell’iniziativa disciplinare che, oggi, è attribuzione anche del procuratore generale della Corte di cassazione in forza della dell’art. 10, comma 1, n. 3 della legge n. 195/1958 (istitutiva del Consiglio superiore della magistratura).
Operata la separazione delle carriere, in modo – si è prima detto – rigido ma incoerente, potrebbe trovare valida giustificazione il mantenimento dell’azione disciplinare in capo al procuratore generale in riferimento alla magistratura requirente, ed anzi potrebbe porsi in linea con una probabile connotazione gerarchica di quegli uffici quale elemento di compensazione dell’assai poco equilibrata accentuazione della figura del pubblico ministero, addirittura rafforzata dalla creazione di un proprio Consiglio superiore in cui quei magistrati avranno, a dispetto di quanto avviene oggi, la prevalenza numerica dei 2/3 sulla componente laica.
Il rafforzamento del modulo gerarchico renderebbe del tutto coerente che il procuratore generale della Corte di cassazione, probabilmente di lì a breve elevato a figura di vertice di una struttura piramidale, abbia il potere di azione sui magistrati che occuperanno i gradi inferiori della gerarchia.
Vi sarebbe però un tratto dissonante.
Il titolare dell’iniziativa disciplinare si troverebbe ad esercitare l’azione di fronte ad una Corte composta anche da magistrati requirenti, e quindi da soggetti che, nello svolgimento delle ordinarie funzioni di pubblico ministero, si porrebbero in posizione a lui gerarchicamente sotto ordinata.
L’incongruità di una situazione di tal fatta, in cui alcuni giudici potrebbero patire una sorta di timore reverenziale per il (co)titolare dell’azione, sarebbe esaltata dalla dichiarata natura giurisdizionale della materia disciplinare e dalla conseguente necessità di predicare la terzietà anche di quel giudice secondo l’enfatizzazione artificiosa che formalmente percorre e dà fisionomia alla riforma nel suo complesso.
In riferimento, poi, alla magistratura giudicante sarebbe sistematicamente insostenibile la conferma dell’iniziativa disciplinare del procuratore generale. Alla luce del contesto delineato dalla riforma, avrebbe il senso e il sapore di una intromissione della magistratura re quirente, nella sua più alta espressione, nella vita della giudicante, che invece si è voluto nettamente separata.
Il leitmotiv dei riformatori, per quanto sgangherato, va preso sul serio, e allora se la separazione serve a porre i giudici al riparo dallo strapotere dei pubblici ministeri che, presenti nel Consiglio superiore, oggi giudicano delle loro carriere, non si potrà accettare che il vertice della magistratura requirente detenga un potere così penetrante, di sindacato sui giudici seppure in termini di richiesta di punizione rivolta all’Alta Corte.
L’attribuzione di competenze in materia disciplinare al procuratore generale, sempre in riguardo alla magistratura giudicante, potrebbe non entrare in frizione con l’architettura di sistema ove la Procura generale della Corte di cassazione dovesse essere avvicinata significativamente al Ministro della giustizia, con una conseguente perdita di autonomia decisoria ed esser ridimensionata in funzione di collaborazione servente, con imputazione al solo Ministro delle scelte di promozione dell’azione. In quest’ottica, la Procura generale sarebbe nulla più che l’esecutrice delle determinazioni ministeriali e non potrebbe aver più la contitolarità dell’azione, addirittura qualificata dall’obbligatorietà di esercizio e dall’attribuzione, in via esclusiva, del potere di indagine e di rappresentanza in giudizio.
Se, di contro, prevarrà la scelta di estromettere il procuratore generale dagli affari disciplinari dei giudici, occorrerà assicurare effettività di esercizio ai poteri di indagine e di azione del Ministro della giustizia: si può ipotizzare il rafforzamento dell’Ispettorato generale del Ministero o la predisposizione di un’apposita un’articolazione amministrativa che possa attuare le determinazioni ministeriali.
In questa eventualità, si apprezzerà comunque una compressione delle garanzie che oggi il sistema assicura. L’azione sarà concretamente esercitata non più da un magistrato in posizione di piena autonomia e di indipendenza ma da un ufficio ministeriale che, per quanto – e chissà per quanto – composto (anche) di magistrati, non potrà che connotarsi per un vincolo stretto di dipendenza, ratione materiae, dall’autorità politica[8].
6. I controlli impugnatori sulle decisioni dell’Alta Corte
Per espressa previsione della riforma, la materia disciplinare ha natura giurisdizionale. L’Alta Corte sarà un organo di giurisdizione in senso stretto e sarà competente, con una regolamentazione sulla formazione dei collegi tale da evitare incompatibilità – affidata ovviamente alla legge ordinaria –, anche per i giudizi di impugnazione contro le sentenze emesse in prima istanza.
L’impugnazione sarà ammessa, si dice testualmente, “anche per motivi di merito”, val quanto dire anche per motivi di legittimità. Di qui il quesito, di non facile soluzione, in ordine alla ricorribilità, o meno, per cassazione.
Si può infatti ragionare valorizzando la natura speciale di questa giurisdizione e quindi concludere che il ricorso per cassazione potrà essere ammesso nei limiti e con i limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione, come oggi avviene per le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (art. 111, comma ottavo, cost.).
In questa direzione potrebbe addursi l’argomento, per il vero strutturalmente assai debole, che fa leva sui criteri di individuazione dei magistrati sorteggiabili in vista della formazione dell’Alta Corte.
Si è già detto che il sorteggio riguarderà soltanto i magistrati, sia dell’una che dell’altra magistratura, che non solo abbiano almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie ma che, in più, “svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”. La ragione della limitazione dei sorteggiabili potrebbe essere rinvenuta proprio nella necessità di assicurare all’Alta Corte, che dovrà occuparsi anche del giudizio di legittimità, professionalità specifiche e sufficientemente formate.
Non sfugge, però, la critica che può muoversi a tale assunto, e cioè che il giudizio disciplinare ha bisogno anzitutto di competenze ed esperienze di giudizi di merito e di conoscenza della realtà organizzativa ed operativa degli uffici in cui esercitano gli incolpati che, per mero dato statistico, sono (e saranno) in numero prevalente magistrati di merito.
Resta, poi il rilievo non facilmente superabile che, per previsione costituzionale, tutte le sentenze sono passibili di ricorso per cassazione e quelle che emanerà l’Alta Corte, definite espressamente “sentenze”, non potranno sottrarsi a questo regime, in assenza di altre disposizioni del medesimo rango che espressamente deroghino a questo assetto.
Dall’inciso sopra ricordato, relativo alla competenza dell’Alta Corte per le impugnazioni delle sentenze di prima istanza “anche per motivi di merito”, non sembra dunque potersi ricavare un principio di deroga.
Esso dice soltanto che con le impugnazioni all’Alta Corte saranno deducibili tutti i vizi possibili, di merito e di legittimità, e non anche che il ricorso per cassazione, garanzia costituzionale di primaria importanza contro tutte le sentenze, resterà assorbito in quell’ampia possibilità di impugnazione.
7. L’incertezza sul futuro della giustizia disciplinare e non solo
La riforma produrrà più incertezze di quanti nodi problematici, veri o presunti, saprà sciogliere. Si imporranno nuovi equilibri che, però, la riforma costituzionale non è in grado di far intravedere sia pure nei contorni essenziali.
Alla legge ordinaria si demanda una revisione ad ampio spettro della materia, come anche della organizzazione e del funzionamento del Consiglio superiore e dell’ordinamento giudiziario nel suo complesso. Si tratta di un compito di grande rilievo, la cui esecuzione non potrà giovarsi di direttrici chiare, dato che le future previsioni costituzionali, come si è visto, non consentiranno letture coerenti[9].
Approvata la riforma, l’attuale normativa di ordinamento giudiziario diverrà provvisoria, assumerà i caratteri della precarietà, come prescritto dall’articolo di chiusura del disegno di legge, ove si assegna al legislatore il termine di un anno per adeguare la disciplina di rango ordinario alla nuova architettura costituzionale.
In quella fase si scaricheranno molte tensioni conseguenti a scelte costituzionali affrettate e assai poco ragionevoli, ma i margini per tentare anche solo parziali correzioni di tiro, e ridurre la distanza da un modello di magistrato a spiccata vocazione professionale, saranno particolarmente risicati.
Non resta che confidare nella maturità democratica del popolo che con ogni probabilità sarà chiamato a dire, con il referendum, la parola decisiva.
[1] Di iniziativa dei sen. Rossomando ed altri, del Partito democratico, componente dell’attuale opposizione parlamentare.
[2] Per A. Rossomando, Forum sull’Istituzione dell’Alta Corte. La rivoluzione dell’assetto giurisdizionale in vista dell’istituzione di una giurisdizione speciale per i giudici, Intervista di Paola Filippi e Roberto Conti, in Questa Rivista, 5 aprile 2022, l’istituzione dell’Alta Corte e l’affidamento ad essa … delle impugnazioni dei provvedimenti del CSM e degli altri organi di autogoverno delle magistrature” avrebbe completato il quadro costituzionale “con il trasferimento ad un più alto livello del controllo su fondamentali decisioni riguardanti lo statuto e la disciplina dei magistrati.”
[3] R. Romboli, La riforma costituzionale della magistratura: la maschera della separazione delle carriere ed il volto della eliminazione del modello Csm voluto dal Costituente, in ordinamentogiudiziario.info, 15 luglio 2025, evidenzia “il depotenziamento… per il Consiglio attraverso la sottrazione di una funzione essenziale per il ruolo ad esso riconosciuto dalla Costituzione, attraverso le indicazioni di un modello di buon giudice da trasmettere all’ordine giudiziario.”
[4] Osserva A. Cosentino, L’Alta Corte. È davvero una buona idea?, in questionegiustizia.it., 25 marzo 2022, che “l’esercizio della potestà sanzionatoria è sinergico con l'esercizio dell'amministrazione attiva e l’una e l’altra concorrono al governo del settore presidiato; e ciò vale con maggior forza nella materia disciplinare, nella quale l'esercizio della potestà disciplinare concorre nella definizione del profilo deontologico dell’operatore del settore”.
[5]S. Bartole, L’assetto degli organi di amministrazione e giustizia disciplinare nel disegno di legge costituzionale n. 1917 sulla separazione delle carriere, in associazionedeicostituzionalisti.it, 10/24 La separazione delle carriere, 18 ottobre 2024, parla di ossessione sanzionatoria osservando che la relazione accompagnatoria, nella parte in cui sottolinea che compito dell’Alta Corte è di garantire nel massimo grado la qualità professionale e deontologica di chi esercita funzioni caratterizzate da un’estrema delicatezza, “fa passare il conseguimento delle finalità formative dei magistrati - con una evidente ossessione sanzionatoria - attraverso lo strumento disciplinare”.
[6] Per N. Zanon, Critiche e speranze intorno ad una riforma che si sarebbe voluta diversa, in ordinamentogiudiziario.info, 17 luglio 2025, l’istituzione di un’Alta Corte distinta dall’organo di governo autonomo si spiega alla luce del “rilievo dei poteri attribuiti al magistrato sulla libertà e i beni dei cittadini”, da cui si trae che “la giustizia disciplinare dei magistrati non deve necessariamente essere, o non deve continuare ad essere, una giustizia disciplinare dei pari.”
[7] N. Rossi, Il sorteggio per i due Csm e per l’Alta Corte disciplinare. Così rinascono corporazione e gerarchia, in Quest. giust., 1-2/2025, p. 114, rileva che “la giustizia disciplinare sarà dunque monopolio dei magistrati di cassazione, ripristinando una primazia – diversa da quella di natura esclusivamente giurisdizionale oggi esercitata – che riecheggia un passato lontano, nel quale gli alti gradi della Cassazione svolgevano un ruolo di vertice dell’organizzazione giudiziaria e di preminenza nel Csm e nella giustizia disciplinare.”
[8] Con riferimento all’attuale sistema E. Cesqui, Il giudizio disciplinare: l’esercizio dell’azione tra poteri, limiti e linee guida. Il ruolo della Procura generale e del Ministro della giustizia, in Il procedimento disciplinare dei magistrati, quaderno n. 8 della Scuola superiore della magistratura, pag. 25 ss., rileva che proprio per mezzo dell’iniziativa del procuratore generale si “riporta all’interno dell’ordine di appartenenza il presidio dei valori deontologici fondamentali” conferendo all’esercizio dell’azione “la piena giurisdizionalizzazione”. L’azione, infatti, spetta anche al Ministro ma egli la promuove, come precisato dall’art. 14, comma secondo, d. lgs. n. 109 del 2016, “mediante richiesta di indagini” al procuratore generale.
[9] R. Romboli, La riforma costituzionale della magistratura: la maschera della separazione delle carriere…, cit., parla della riforma nei termini di una scatola vuota, “tanti sono gli aspetti che vengono rinviati al futuro legislatore ordinario (quindi alla maggioranza parlamentare)”.