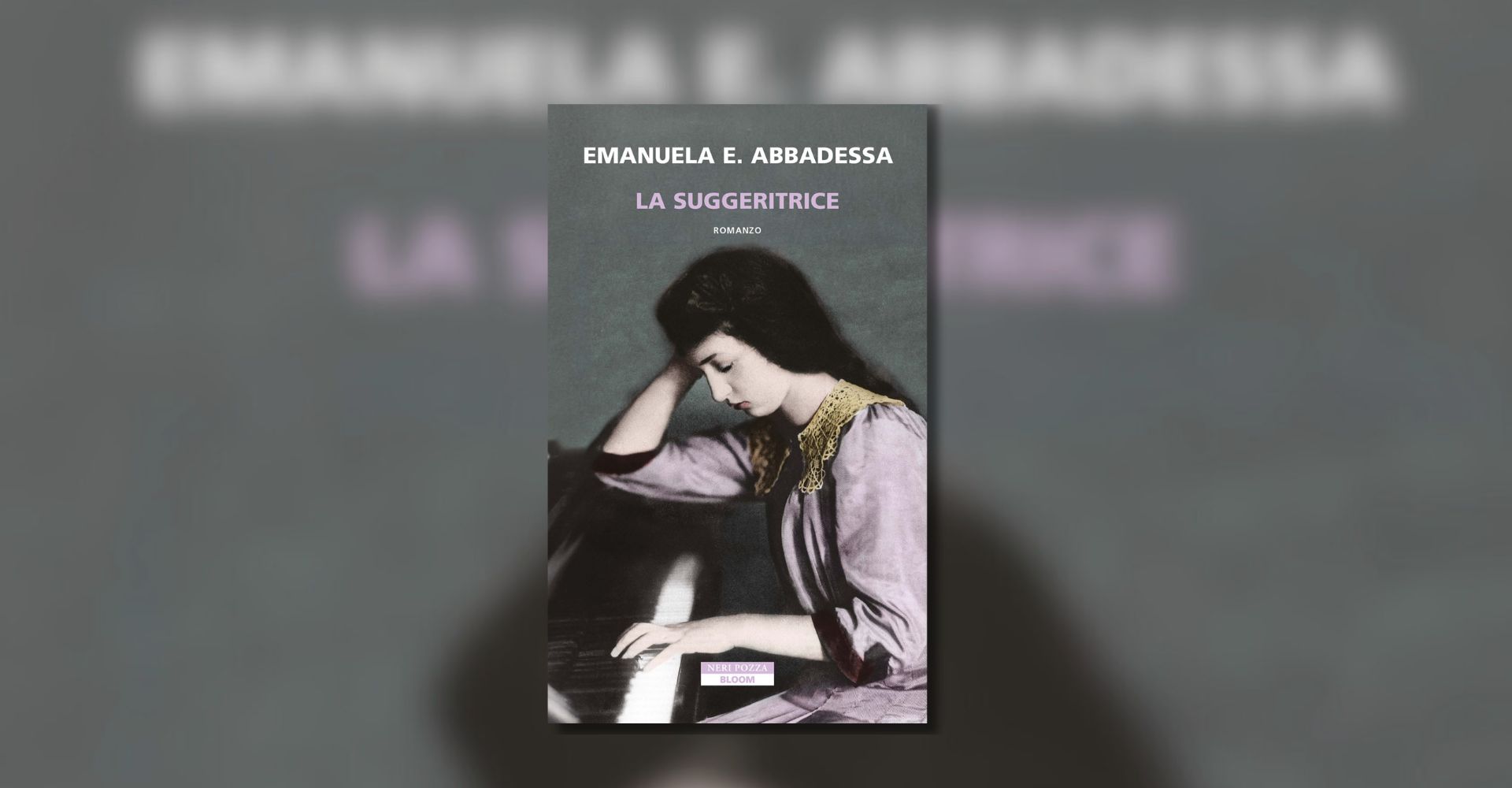Ponti versus muri, o muri e ponti. 8) Il prigioniero coreano, recensione al film di Dino Petralia
[Per conoscere e consultare tutti i contributi sviluppati sul tema, si veda l'Editoriale]
Tra crudezza e rivelazione l’opera di Kim Ki Duk racconta il muro intercoreano nella travagliata vicenda di un povero pescatore del nord, Nam Chul-Woo, rassegnatamente sereno nella sua umilissima vita personale e familiare, trovatosi a valicare involontariamente il confine d’acqua tra le due Coree per un guasto all’elica della sua barca (“È tutto ciò che possiedo”, dirà ad una sentinella del regime, finendo per sconfinare così in un mondo tanto opposto quanto ignoto).
Un muro segnato nell’acqua dunque, tanto più insidioso per il rischio di trasgressione quanto così visibile ai fucili che daranno poi termine alla storia e alla vita dell’onesto pescatore. Onesto si! e null’altro, dato che le colpe di marca ideologica delle quali da una parte e dall’altra sarà fatto bersaglio prescindono dai fatti, fondandosi loro stesse sulla feroce matrice del pregiudizio e del preconcetto ideologico.
Infatti, catturato come spia dai sudcoreani per quell’improvvido sconfinamento Nam viene sottoposto a torture verbali e fisiche nell’intento di guadagnare un’ammissione confessoria da tenere luogo di condotte non provate e del tutto inesistenti; restituito infine al suo Nord, anche lì il pescatore viene trattenuto dalle guardie del regime e costretto a sottoporsi ad un febbrile itinerario inquisitorio nella convinzione di un avvenuto tradimento.
Una doppia prigionia, per opposte ragioni ma con un’unica verità volutamente ignorata da un verdetto unanime in entrambe le sponde, sia nel mezzo che nel fine; una prigionia sospettosa e violenta la sudcoreana, neppure scalfita da quella vibrazione di apparente contraddittorio che a tratti l’esperto regista fa emergere nelle figure del superiore gerarchico e del giovane poliziotto, affidatario del povero pescatore e suo ostinato protettore; una prigionia altrettanto violenta e letale quella nordcoreana, edificata sul bisogno di mantenersi immuni da ogni contaminazione capitalistica, sia pure episodica e casuale.
Il dipinto dei contrasti tra le due realtà bene risalta nell’efficace sintesi comportamentale di Nam e del suo tenace rifiuto di aprire gli occhi al cospetto di una scena urbana – quella del centro di Seul - della quale avrebbe dovuto poi rendere giustificazione al suo regime d’appartenenza non appena di rientro al nord; ed anche nell’incredulo suo disorientamento, una volta aperti gli occhi per necessità di movimento, innanzi ad un mondo troppo eterogeneo e distante dal suo modello esistenziale, così diverso da far rischiare una seduzione di cui in verità sembra consentito cogliere un qualche flebile cenno.
Sullo sfondo tutta l’insensatezza e dissennatezza di un contrasto ideologico armato sul medesimo territorio asiatico, microcosmo filmico del duplice asse capitalistico e totalitario che ancora oggi nel mondo alimenta i suoi seguaci e i suoi muri e che l’abile Kim, tutt’altro che debuttante, proietta con formidabile maestria nella scena finale del doppio orsacchiotto - consunto e sdrucito quello del nord, colorato e semovente quello del sud - ripreso tra le mani della figlioletta di Nam che ad entrambi sorride grata quale prodromo di speranza.