
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Un volo di stato chiude il caso Al Masri
La vicenda dell’arresto e del successivo rilascio di Al Masri, comandante della polizia giudiziaria di Tripoli destinatario di un mandato di arresto internazionale eseguito in Italia lo scorso 19 gennaio, è in queste ore al centro del dibattito soprattutto in ragione della successiva, peculiare decisione del Ministero dell’Interno di disporre il rimpatrio del criminale libico, eseguito prontamente attraverso un volo di stato.
Nelle relazioni tra Italia e Libia da quasi vent’anni si intersecano esigenze di realpolitik ed espedienti tesi a salvare l’apparenza sul piano del diritto internazionale.
Le implicazioni della vicenda sotto il profilo strettamente giuridico sono – e saranno – complesse. Nel tentativo di offrire al dibattito un contributo tecnico, come ci compete, proponiamo di seguito un’analisi della vicenda giudiziaria e del contesto normativo ed istituzionale in cui si colloca.
La Corte di Appello di Roma ordina la scarcerazione di Al Masri: alcune riflessioni sull’esecuzione da parte delle autorità italiane dei mandati d’arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale
di Lavinia Parsi
Lo scorso 19 gennaio, veniva tratto in arresto Njeem Osama, noto come Al Masri (“l’egiziano”), poi rilasciato per ordine della Corte di Appello di Roma il 21 gennaio. L’arresto avveniva sulla base di un mandato emesso dalla Corte Penale Internazionale (CPI) il giorno precedente[1] per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, commessi almeno dal 2015 nel centro di detenzione di Mitiga, il più grande della Libia occidentale.
Più precisamente, Al Masri è indagato da parte della CPI per i crimini di guerra di omicidio, tortura e trattamenti crudeli (ai sensi dell’art. 8(2)(c)(i) dello Statuto di Roma), oltraggio alla dignità personale (art. 8(2)(c)(ii)), stupro, violenza sessuale e schiavitù sessuale (art. 8(2)(e)(vi)) e per i crimini contro l’umanità di omicidio (art. 7(1)(a)), riduzione in schiavitù (art. 7(1)(c)), detenzione illegittima (art. 7(1)(e)), tortura (art. 7(1)(f)), stupro, violenza sessuale e schiavitù sessuale (art. 7(1)(g)), persecuzione (art. 7(1)(h)) ed altri atti disumani (art. 7(1)(k))[2] commessi nei confronti di migranti ed oppositori[3]. Tali crimini, già ampiamente documentati da numerosi avvocati per i diritti umani e dalla Independent Fact Finding Mission on Libya delle Nazioni Unite[4], venivano sistematicamente commessi a Mitiga da parte delle Forze Speciali di Deterrenza (note come “Rada’a”), un’unità islamista radicale formatasi in seno alla polizia militare di Tripoli durante la guerra civile del 2011 e che rappresenta ad oggi una delle maggiori milizie in controllo del Paese. In qualità di direttore del centro di detenzione di Mitiga, e membro di Rada’a, Al Masri avrebbe commesso personalmente, ordinato o partecipato alla commissione delle condotte di cui sopra[5].
Per questi motivi, simultaneamente all’emissione del mandato d’arresto, il 18 gennaio 2025 la CPI inoltrava una richiesta di apposizione di red notice da parte di Interpol, così da allertare le forze dell’ordine competenti nelle giurisdizioni nazionali interessate e richiedere l’arresto dell’indagato[6]. La stessa notte, quindi, la D.i.g.o.s. di Torino arrestava provvisoriamente Al Masri, trasmettendo la relativa nota alla Corte di Appello di Roma (competente in materia ex art. 11 della l. 237/2012, relativa all’adeguamento alle disposizioni dello Statuto della CPI) e al Ministero della Giustizia, in data 19 gennaio 2025. La Corte di Appello, sentito il Procuratore Generale, rilevava l’irritualità dell’arresto ed ordinava l’immediata scarcerazione di Al Masri[7]. Come si legge nel provvedimento, la fonte per l’applicazione della misura cautelare ai fini della consegna alla CPI è correttamente identificata nell’art. 11 della l. 237/2012, il quale dispone che – nei casi in cui sia già stato emesso dalla CPI un mandato d’arresto o una sentenza di condanna a pena detentiva – il Procuratore Generale presso la corte di Appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte l’applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna. La trasmissione degli atti al Procuratore Generale, invece, è affidata al Ministro della Giustizia che, ex art. 2, comma 1 della l. 237/2012, cura in via esclusiva i rapporti con la CPI, ad egli competendo di ricevere le richieste dalla Corte e darvi seguito.
Nel caso di specie, la Corte di Appello rileva che la D.i.g.o.s. di Torino, pur richiamando l’art. 11 della l. 237/2012, non ha atteso la richiesta del Procuratore Generale ai fini dell’applicazione della misura, ma ha agito di propria iniziativa, apparentemente ai sensi dell’art. 716 c.p.p.: tale norma, relativa alle procedure di estradizione, in casi di urgenza, prevede infatti la possibilità di effettuare un arresto su iniziativa della polizia giudiziaria, simultaneamente informando il Ministro della Giustizia e la Corte d’appello competente. A parere dei giudici, l’arresto di Al Masri sarebbe dunque irrituale perché sarebbe avvenuto in applicazione della procedura prevista per l’estradizione, e non invece di quella prevista per l’esecuzione dei mandati d’arresto emessi dalla CPI. A conferma di ciò, la Corte di Appello sottolinea che è prevista dalla stessa l. 237/2012 una norma rubricata “Applicazione provvisoria della misura cautelare” (art. 12), la quale rinvia però alla stessa procedura prevista dall’art. 11, e quindi alla richiesta da parte del Procuratore Generale in seguito a ricezione degli atti da parte del Ministro della Giustizia. Vale la pena notare che, come si apprende dall’informativa della D.i.g.o.s. relativa all’esecuzione dell’arresto, era una nota della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Cooperazione Internazionale, presso il Ministero dell’Interno, a pregare la Questura di Torino di “valutare la sussistenza delle condizioni e l’opportunità di procedere ai sensi degli art 716, in relazione al 715, del c.p.p.”[8].
A parere di chi scrive, vi era spazio almeno per un’interpretazione alternativa da parte della Corte di Appello. Come giustamente rilevato nell’ordinanza, l’art. 3 della l. 237/2012 prevede che, laddove non sia disposto diversamente, in materia di consegna, cooperazione ed esecuzione di pene si osservino le norme contenute nel libro XI, titoli II, III e IV del codice di procedura penale. Nei casi di mandato d’arresto emesso dalla CPI, quindi, se non previsto altrimenti, sono effettivamente applicabili le norme relative all’estradizione. Ebbene, la Corte di Appello di Roma esclude l’applicabilità dell’art. 716 c.p.p. in quanto la procedura per l’applicazione (anche provvisoria) di misure cautelari è prevista dagli artt. 11 e 14 della l. 237/2012: in osservanza del brocardo ubi lex voluit dixit, se il legislatore avesse voluto prevedere una forma di arresto su iniziativa della polizia giudiziaria, avrebbe redatto una norma a ciò dedicata. Tale lettura, tuttavia, è apparentemente contraria alla lettera dell’art. 3, l. 237/2012, che prevede – all’opposto – che le lacune possano e debbano essere colmate alla luce delle disposizioni rilevanti del codice di procedura penale: ciò avviene anche per aspetti essenziali inerenti all’applicazione di misure cautelari, come i termini che, non previsti espressamente dalla l. 237/2012, sarebbero altrimenti da considerarsi assenti tout court.
Anche un’interpretazione teleologicamente orientata delle norme in oggetto sembrerebbe militare a favore dell’applicabilità della procedura prevista dall’art. 716 c.p.p. ai casi di mandati d’arresto emessi dalla CPI. Sarebbe infatti illogico che l’ordinamento italiano prevedesse la possibilità di intervento su iniziativa della polizia giudiziaria per reati comuni e non per i crimini internazionali puniti dallo Statuto di Roma, che sono per definizione connotati da una eccezionale gravità. Inoltre, alla luce degli interessi tendenzialmente collegati alla posizione degli indagati oggetto di mandato d’arresto da parte della CPI, non potere applicare una procedura che assicuri l’arresto in tempi estremamente rapidi significherebbe, nella maggior parte dei casi, frustrare ogni possibilità di azione da parte della Corte[9].
A prescindere dall’adesione o meno all’interpretazione proposta dalla Corte di Appello di Roma, merita attenzione il fatto che sembra esserci stato un inadempimento da parte del Ministro della Giustizia, il quale non avrebbe trasmesso gli atti relativi al mandato d’arresto nei confronti di Al Masri al Procuratore Generale. Il fatto appare ancor più rilevante, poiché oltre ad avere ricevuto la richiesta attraverso i canali previsti per queste comunicazioni con la CPI, il Ministro della Giustizia era stato opportunamente avvisato dalla D.i.g.o.s. di Torino il 19 gennaio e dal Procuratore Generale il 20 gennaio. Come rilevato nell’ordinanza, il 21 gennaio il Ministero non aveva ancora fatto pervenire alcuna richiesta relativamente all’arresto di Al Masri.
La ricostruzione rispecchia quanto rilevato dalla CPI in un comunicato stampa dedicato[10]. Nel comunicato si riporta che, immediatamente dopo l’esecuzione dell’arresto, la Corte, su espressa richiesta delle autorità italiane, si era astenuta dal commentare pubblicamente la notizia; al tempo stesso, essa aveva continuato a impegnarsi con le autorità italiane per garantire l’effettiva esecuzione di tutti i passaggi procedurali richiesti dallo Statuto di Roma. In questo contesto, la Cancelleria della CPI aveva altresì ricordato alle autorità italiane che, nel caso in cui avessero riscontrato problemi capaci di ostacolare o impedire l’esecuzione della richiesta di cooperazione, avrebbero dovuto consultare la Corte senza indugio per risolvere la questione. Le autorità italiane, tuttavia, non rispondevano mai a tali solleciti: il 21 gennaio 2025, senza preavviso o consultazione alcuna, la Corte apprendeva che Al Masri era stato rilasciato e riportato in Libia.
Se, da un lato, l’esitazione si presta a facili interpretazioni, anche alla luce degli esposti presentati alla CPI nei confronti di alcuni Ministri ed ex-Ministri italiani proprio in relazione ai crimini commessi contro i migranti in Libia[11], vale la pena ricordare che, d’altro canto, l’Italia occupa un ruolo di cruciale importanza nell’indagine in oggetto, rappresentando uno dei quattro Paesi componenti la Squadra comune relativa ai crimini commessi contro i migranti in Libia, di cui è parte anche l’Ufficio della procura della stessa CPI[12]. Tale grave inadempimento, oltre ad essere stato oggetto di richieste di spiegazioni da parte di alcuni parlamentari[13] e di una denuncia per artt. 378 e 314 c.p.[14], è attualmente oggetto di verifica da parte della CPI. In effetti, agli articoli della l. 237/2012 sin qui menzionati, pare opportuno (se non necessario) aggiungere un riferimento all’art. 1, che sancisce un “obbligo di cooperazione” dello Stato italiano con la CPI: nonostante nelle ultime settimane vari membri del Governo abbiano rilasciato dichiarazioni di segno opposto[15], eseguire i mandati d’arresto della Corte rappresenta a tutti gli effetti un obbligo per gli Stati Parte, che si sono in tal senso impegnati tramite la firma e la ratifica dello Statuto di Roma[16]. Pertanto, come già rilevato da alcuni avvocati ed organizzazioni per i diritti umani[17], la condotta dell’Italia rappresenta altresì una violazione dell’art. 89 dello Statuto di Roma, il quale prevede che: “Gli Stati contraenti, in conformità alle disposizioni della presente Parte e alla procedura prevista dal loro diritto nazionale, ottemperano alle richieste di arresto e consegna.”
[1] CPI, Camera Preliminare I, Situazione in Libia, “Warrant of Arrest for Mr Osama Elmasry / Almasri Njeem”, ICC-01/11-149-US-Exp (18 gennaio 2025).
[2] ICC-01/11-149-US-Exp, para. 17-90.
[3] Come emerge dal mandato d’arresto nonché, da anni, dalle testimonianze raccolte da organizzazioni della società civile e dai rapporti pubblicati dalle Nazioni Unite, le vittime comprendono tuttavia anche avvocati, attivisti per i diritti umani e soggetti discriminati a causa del loro orientamento religioso o sessuale.
[4] UNGA, Human Rights Council, “Report of the Independent Fact Finding Mission on Libya”, A/HRC/52/83 (20 marzo 2023), para. 57-58, 61-66, 84, 97; UNGA, Human Rights Council, “Report of the Independent Fact Finding Mission on Libya”, A/HRC/50/63 (22 giugno 2022), para. 36-39, 65-66, 92-93.
[5] Come riportato nel mandato d’arresto, Al Masri dirigeva il carcere di Mitiga ed in particolare “era responsabile della gestione delle guardie, come dimostra il fatto che organizzava i loro turni e dava loro istruzioni e ordini. Assistendo il trattamento dei detenuti, decidendo l’assegnazione e la riassegnazione dei detenuti a fini organizzativi, al fine di punire i detenuti o per impedire qualsiasi forma di comportamento contrario, sembra che [Al Masri] abbia anche esercitato un controllo amministrativo sulle persone detenute nel carcere di Mitiga. Picchiare i detenuti era una pratica comune tra le guardie carcerarie e i comandanti, i quali riferivano al signor [Al Masri]. In alcune occasioni il signor [Al Masri] era presente mentre le guardie percuotevano i detenuti o sparavano contro di loro. [Al Masri] avrebbe ordinato alle guardie di picchiare i detenuti in modo che le ferite non fossero visibili. Inoltre, avrebbe punito le guardie che aiutavano i detenuti ad avere contatti con le loro famiglie o a procurarsi cibo migliore.”
[6] Come è noto, sebbene le red notice non rappresentino per se un mandato d’arresto, esse rappresentano una richiesta su scala globale di arrestare provvisoriamente i soggetti indicati, in quanto ricercati da Stati terzi o da tribunali internazionali.
[7] Corte di Appello di Roma, Sez. IV Penale, R.G. 11/2025, Ordinanza in materia di consegna ex lege 237/2012 Corte Penale Internazionale (21 gennaio 2025).
[8] Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Cooperazione Internazionale, Prot. MI-123-U-B-1-2-FD-2025-51, 19 gennaio 2025.
[9] Come noto, la CPI non prevede la possibilità di procedere nei confronti di imputati in absentia. Solo in casi assolutamente eccezionali, la Corte ha recentemente determinato che è possibile svolgere l’udienza di conferma delle accuse (equiparabile all’udienza preliminare prevista dal nostro ordinamento) in assenza dell’indagato. Si veda: CPI, Camera Preliminare III, Situazione in Uganda, Procuratore c. Joseph Kony, “Decision on the criteria for holding confirmation of charges proceedings in absentia”, ICC-02/04-01/05-532 (29 ottobre 2024).
[10] CPI, Comunicato stampa: “Situation in Libya: ICC arrest warrant against Osama Elmasry Njeem for alleged crimes against humanity and war crimes” (22 gennaio 2025).
[11] Per una ricostruzione compiuta degli esposti presentati alla Corte Penale Internazionale sia consentito il rinvio a: Lavinia Parsi, Francesca Vitarelli, “Attuazione delle politiche anti-migratorie e crimini contro l’umanità: emergenti parallelismi ed esigenze di coordinamento tra giustizia penale nazionale e internazionale”, Sistema Penale 9/2023.
[12] CPI, Comunicato stampa: “Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC: Office of the Prosecutor joins national authorities in Joint Team on crimes against migrants in Libya” (7 settembre 2022).
[13] Ansa, Le opposizioni all'attacco contro la scarcerazione del comandante libico Almasri” (22 gennaio 2025).
[14] Come riportato da fonti giornalistiche, la denuncia è stata presentata presso la Procura di Roma nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ed il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, titolare della delega ai servizi segreti, su iniziativa dell’ex-sottosegretario alla Giustizia Luigi Li Gotti. Si veda: Ansa, “Avvocato denuncia Meloni e Piantedosi su caso Almasri” (23 gennaio 2025).
[15] Da ultimo, il Ministro degli Esteri Tajani avrebbe commentato il caso affermando che “L'Aia non è la bocca della verità, si possono anche avere visioni diverse. Noi siamo un Paese sovrano e facciamo la nostra politica”, Euronews, “Il ministro dell'Interno Piantedosi: ‘Al Masri pericoloso, espulso per la sicurezza dello Stato’” (23 gennaio 2025).
[16] Si veda da ultimo: CPI, Camera Preliminare II, Situazione in Ucraina, “Finding under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by Mongolia with the request by the Court to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and referral to the Assembly of States Parties”, ICC-01/22-90 (24 ottobre 2024).
[17] Fédération Internationale pour le Droits Humains, “Italy’s failure to surrender Libyan suspect to the International Criminal Court is a breach of its Rome Statute obligation” (23 gennaio 2025).
Il mandato di arresto a carico di Almasri è pubblicato sul sito della Corte penale internazionale.
Giudizio di ottemperanza nei confronti di comune in stato di dissesto (nota a T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 novembre 2024, n. 3777)
di Vinicio Brigante
Sommario: 1. Il dissesto degli enti locali. Un osservatorio privilegiato di studio. - 2. Il caso di studio. Poste debitorie degli enti locali e giudizio di ottemperanza. - 3. Cause ed effetti del dissesto degli enti locali. Effettività dei diritti e risanamento dell’ente locale. - 3.1 I costi della gestione del governo del territorio per le casse degli enti locali. L’incidenza dei procedimenti espropriativi. - 3.2 Profili di ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un ente locale in dissesto. - 4. Riflessioni conclusive. Autonomia, diritti e territori
1. Il dissesto degli enti locali. Un osservatorio privilegiato di studio
Il tema del dissesto degli enti locali e delle innumerevoli questioni allo stesso collegate rappresentano un osservatorio ideale per lo studio delle questioni che interessano la pubblica amministrazione e la tenuta dei diversi istituti[1]. Si tratta di un ambito regolatorio oggetto, solo negli ultimi mesi, di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[2]e di una questione di legittimità costituzionale pendente, sollevata da un tribunale amministrativo regionale[3], per sottolineare la centralità e la carica problematica che lo stesso ricopre nel contesto delle dinamiche istituzionali contemporanee.
L’intero impianto normativo in materia di procedure di risanamento e, più in generale, la disciplina che riguarda gli enti deficitari o dissestati, è contenuto nel titolo VIII del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il «Testo Unico degli Enti Locali» (TUEL), testo adottato per un proposito e un’esigenza, generalmente avvertita, di conferire e assicurare organicità e certezza all’organizzazione delle amministrazioni comunali, anche nelle ipotesi in cui le stesse si trovino in una condizione di sofferenza finanziaria; obiettivi che le successive riforme, non hanno sempre garantito, e che talvolta hanno palesemente tradito.
Si tratta di un sistema che si basa su una progressione graduale e crescente del livello di criticità finanziaria.
La natura polisemica del concetto stesso di crisi finanziaria, declinata in stato deficitario o di dissesto dal legislatore qualora la stessa sia riferita agli enti locali, consente di confrontare risultati teorici ed empirici, canoni interpretativi e una serie eterogenea di questioni connesse che possono assurgere a campo di osservazione ideale per la verifica della tenuta delle soluzioni interpretative seguite.
Il dissesto, che si configura ex art. 244 del TUEL nell’ipotesi in cui l’ente non sia in grado di assolvere alle funzioni e di erogare i servizi indispensabili[4] - il c.d. dissesto funzionale - rappresenta, come noto, la forma più grave in cui può manifestarsi la crisi finanziaria di un’amministrazione[5].
Si tratta di una condizione nella quale l’ente locale riesce a “mala pena a gestire l’ordinario e lo fa solo mediante l’ausilio delle anticipazioni di liquidità e proprio il ricorso sistematico a tale strumento porta a considerare la perdurante sofferenza di liquidità non più come frutto di un mero disallineamento temporale tra incassi e pagamenti quanto, piuttosto, come la patologica manifestazione finanziaria di reiterati ed evidenti squilibri[6]”.
La dichiarazione di dissesto - che non rappresenta, almeno tendenzialmente, una scelta discrezionale dell’ente ma è una determinazione vincolata e ineludibile[7] - equivale a una dichiarazione di insolvenza che pone l’ente stesso in una condizione di limitata capacità di agire e conduce a una, seppur parziale, delegittimazione degli organi[8], poiché l’attività dell’amministrazione è, in parte, affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali ordinari[9].
Il legislatore - sin dal d.l. 25 febbraio 1995, n. 77 - ha preso atto della necessità di regolare la vicenda peculiare della crisi finanziaria dell’ente locale attraverso la previsione della presenza di altri soggetti e di (ri)attribuire, in seguito alla dichiarazione di dissesto, il potere in un’ottica funzionale al risanamento, con una scelta che incide sensibilmente sulla capacità di agire della persona giuridica pubblica, intesa come amministrazione ordinaria[10].
In quest’ottica, l’organo straordinario di liquidazione deve provvedere al risanamento dell’indebitamento pregresso, una precisa scelta, che vincola l’attribuzione del potere - o, se si vuole, comporta la privazione dello stesso in capo all’amministrazione ordinaria - al profilo temporale, poiché l’ambito oggettivo sul quale insiste il potere è rappresentato da tutte le conseguenze derivanti dalle operazioni di gestione che hanno dato origine e hanno determinato l’ammontare dei debiti che hanno condotto al dissesto[11].
Lo stato di dissesto comporta, tra gli altri, il divieto di spesa per l’ente e, di conseguenza, da ciò dovrebbe desumersi il divieto di agire in ottemperanza in ordine a obblighi specifici di dare o di fare.
Già nella vigenza della previgente normativa in tema di dissesto degli enti locali - il d.l. 2 marzo 1989, n. 66 - la deliberazione di dissesto comportava la sospensione delle azioni esecutive dei creditori nei confronti dell’ente, anche se la tendenza della giurisprudenza amministrativa dell’epoca si dirigeva nel senso di accogliere, in ogni caso, proprio il ricorso per ottemperanza in danno del comune in stato di dissesto; l’approvazione del piano di risanamento finanziario comportava la sospensione delle sole azioni esecutive promosse solo secondo le norme del codice di procedura civile[12], fino alla riforma del 1993[13], che prevedeva espressamente che vi fosse inammissibilità dell’azione anche in occasione di un giudizio di ottemperanza[14].
Si tratta di un profilo delicato, nel quale i principi e gli interessi che si confrontano sono diversi e gli inevitabili conflitti tra posizioni antagoniste impongono da rifuggire da soluzioni rigide, poiché si tratta della garanzia dei diritti dei cittadini e dei vincoli economici che sugli stessi, a vario titolo, gravano.
Potrebbe qualificarsi la vicenda a partire da una ridefinizione dello stesso concetto di territorio, vincolato ai confini dell’ente locale, che è condizionato da pesi economici e debiti, poiché lo stesso non sembra, almeno per il tema in esame, idoneo a qualificare gli interessi economici legittimati ad entrarvi in rapporto[15].
2. Il caso di studio. Poste debitorie degli enti locali e giudizio di ottemperanza
Giova, al fine di apprezzare le asperità del tema e individuare gli incerti confini dell’attività di fare che comportano, anche indirettamente, un costo per l’amministrazione in stato di difficoltà finanziaria, ricostruire la vicenda in esame che ha interessato il comune di Taormina.
Il ricorrente chiedeva al giudice amministrativo di accertare l’illegittimità, invalidità o inefficacia, nonché per l’eventuale disapplicazione, degli atti amministrativi sulla base dei quali l’amministrazione aveva occupato e realizzato un’opera sul fondo di proprietà dello stesso privato ricorrente.
Il tribunale amministrativo regionale accoglieva il ricorso, disponendo, contestualmente, che l’ente intimato provvedesse alla restituzione o all’acquisizione dell’immobile del ricorrente, con le determinazioni conseguenti, con conseguente condanna in capo all’amministrazione locale del pagamento delle spese di giudizio, circostanza che avrebbe, peraltro, comportato un peggioramento della situazione finanziaria dell’ente.
L’amministrazione, nonostante il decorso del termine, non provvedeva all’esecuzione del dictum della sentenza di prime cure, e, persistendo nell’inadempimento, induceva la ricorrente a proporre ricorso per ottenere l’ottemperanza.
Si desumevano, però, possibili profili di parziale inammissibilità del ricorso, limitatamente alla statuizione sul capo della sentenza proprio relativo al peso economico che sarebbe gravato sull’amministrazione condannata, in considerazione dello stato di dissesto.
Si intimava al comune di restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, con la previsione del risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima o provvedere, in alternativa, all’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto.
Si osservava che la procedura espropriativa non era portata a termine proprio per mancanza di copertura finanziaria, ulteriore circostanza che aveva indotto l’ente comunale a dichiarare lo stato di dissesto. Il ricorso disinvolto alle procedure espropriative, anche oltre le reali esigenze, con un peggioramento delle condizioni dell’amministrazione, ha rappresentato, per anni, una prassi diffusa.
Il ricorso per l’ottemperanza era dichiarato, almeno in parte inammissibile, e doveva essere accolto per la restante parte nel rispetto di alcuni limiti.
Come affermato da diversi arresti pretori, il ricorso per ottemperanza è generalmente ammissibile, anche qualora l’ente versi in stato di dissesto, nelle ipotesi in cui l’amministrazione debba, in forza di una sentenza, esercitare un “potere di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale derivanti o meno da titolo giudiziario[16]”.
Per contro, ove sia in contestazione l’obbligo di emanazione dell’atto amministrativo - in questa ipotesi, peraltro ricorrente, nelle ipotesi di squilibrio finanziario dell’ente locale, si tratta del decreto di esproprio[17] - che contempli il titolo di spesa, la competenza amministrativa e contabile resterebbe saldamente ancorata in capo all’organo straordinario per il divieto generale di esecuzione individuale e in forza del principio della par condicio creditorum.
La conclusione non si pone in termini contrari rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la Adunanza Plenaria, con la sentenza 5 agosto 2020, n. 15, la quale stabilisce che il provvedimento di acquisizione sanante, genetico dell’obbligazione e, quindi, del debito è attratto necessariamente nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, qualora lo stesso sia adottato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria.
La vicenda indagata ha ad oggetto un giudizio di ottemperanza che insiste su determinati effetti patrimoniali, di competenza dell’organismo di liquidazione stante lo stato di dissesto, che sarebbero solo conseguenziali alle scelte, non ancora compiute, ma residue in capo all’ente locale, nella sua composizione ordinaria.
La tesi sostenuta va nella direzione di ritenere che il giudizio di ottemperanza, finanche nei confronti di un ente in dissesto, nei confronti del quale sarebbero precluse azioni creditorie a carattere esecutivo, è ammissibile nei limiti della coercizione di obblighi derivanti dal giudicato, che impongano però l’esercizio di attività amministrativa, non riducibile alla mera liquidazione di un credito di natura pecuniaria o, come nel caso di specie, che impongano principalmente obblighi di fare, come l’obbligo di restituzione o, in alternativa, l’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42 bis del Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità[18].
Dalla sentenza ottemperanda non discende un dovere, in termini di attività vincolata, di emanazione dell’atto di acquisizione sanante, con ciò che ne consegue in termini di situazione debitoria, poiché in capo all’amministrazione residua un potere discrezionale di scelta tra la restituzione e l’acquisizione del suolo appreso illegittimamente, peraltro proprio in ragione della deficitaria situazione finanziaria che aveva impedito di completare il procedimento ablatorio reale; da tale scelta sarebbero dipese conseguenze diverse per le casse dell’ente locale.
L’organo straordinario di liquidazione è competente solo in seguito alla decisione discrezionale[19] - che, nel caso di specie è rappresentata dalla scelta tra restituzione e acquisizione - cui l’amministrazione non aveva ancora provveduto e dalla quale sarebbero dipese la natura e l’entità delle obbligazioni, di facere e di dare, rimesse alla competenza dell’organo straordinario.
D’altronde, anche in base a una lettura sistemica delle scelte legislative in tema di regolazione dello stato di dissesto degli enti locali, l’organo straordinario di liquidazione, per sua natura, non può esprimere valutazioni caratterizzate da discrezionalità, ma scelte di natura tecnico-contabile[20] ispirate all’obiettivo del rientro dal debito.
L’amministrazione, non avendo ancora svolto l’attività imposta dal giudicato, era da ritenersi inottemperante.
Per altro verso, il Collegio ritiene insussistenti i presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) del codice del processo amministrativo per l’accoglimento dell’istanza di fissazione della penalità di mora, posto che la sopra richiamata disposizione esclude l’applicazione della c.d. astreinte[21] nel caso in cui la stessa debba ritenersi “manifestamente” iniqua ovvero sussistano ulteriori “ragioni ostative”, coincidenti in questo caso con la non risalente formazione del titolo in epigrafe e, per quanto di interesse, con la peculiare condizione di dissesto del Comune intimato.
Da ultimo, sempre nella prospettiva dello stato di decozione finanziaria dell’ente, il ricorso è da ritenersi inammissibile nella parte in cui si chiede l’esecuzione del dictum per la condanna dell’ente al pagamento delle spese di lite, poiché, per interpretazione pressoché unanime, rispetto alla suddivisione di competenze tra amministrazione ordinarie e organo straordinario, rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto” e, nel caso di specie, la condanna al pagamento delle spese di lite rappresenta un’obbligazione che, per se stricto jure sorta in seguito, proprio con la sentenza, rinviene la genesi in un fatto - si potrebbe discorrere, più compiutamente, di comportamento[22] - precedente, cioè l’occupazione illegittima del terreno.
3. Cause ed effetti del dissesto degli enti locali. Effettività dei diritti e risanamento dell’ente locale
Dalla pronuncia in esame emergono principalmente due questioni, che si impongono all’attenzione dell’interprete e che riguardano da un lato le cause e dall’altro le conseguenze della situazione di deficit finanziario in cui può trovarsi un ente locale.
La prima, collegata alle cause che hanno concorso all’aggravarsi della situazione debitoria, riguarda il governo del territorio da parte delle amministrazioni comunali e, nello specifico, il ricorso, spesso indiscriminato e oltre le reali esigenze, a procedimenti espropriativi cui non si riesce a far fronte da un punto di vista economico.
La seconda, riferibile all’ammissibilità di esperire azioni esecutive nei confronti dell’amministrazione che si trovi nella condizione di cui all’art. 244 del TUEL, impone di volgere uno sguardo alle conseguenze, nella prospettiva della tutela che deve essere, in ogni caso, garantita nei confronti dei cittadini e dei creditori.
In termini generali, la condizione di deficit finanziario della pubblica amministrazione, specie se locale, rappresenta un tema che deve essere analizzato come problema complesso, con componenti economiche, giuridiche e sociali che devono essere isolate, ma senza smarrire e tenendo in debita considerazione le interconnessioni, le interdipendenze, le compatibilità con altri problemi[23].
Non ci si può, in altri termini, limitare alle previsioni del TUEL e alle relative interpretazioni[24], per evitare di analizzare le questioni da un punto di vista angusto, che non restituisca l’importanza di un tema che rappresenta, a ben vedere, uno dei punti di tenuta e di equilibrio della democrazia locale.
Cause ed effetti devono essere letti in modo congiunto e si devono comporre, per pervenire a soluzioni efficaci, in un quadro di attribuzioni e di competenze che sembrano, in realtà, seguire dinamiche che ricalcano lo schema e il regime del fallimento previsto per i soggetti privati, determinato e orientato da altre necessità.
Si devono indagare i limiti interni delle soluzioni predisposte dal TUEL, per verificare, proprio da tale punto di partenza, la disponibilità degli interessi economici ad entrare in contatto con i territori e con le relative problematiche.
3.1 I costi della gestione del governo del territorio per le casse degli enti locali. L’incidenza dei procedimenti espropriativi
Il tema del governo del territorio e, nello specifico, i profili debitori che sono legati ai procedimenti espropriativi rappresentano probabilmente la sede elettiva per analizzare la tenuta delle cause che hanno concorso a generare e aggravare il dissesto degli enti locali, una sorta di filo rosso che attraversa e caratterizza la natura del debito dell’amministrazione.
Le ragioni sono intuibili e sono legate all’esposizione finanziaria che, a vario titolo, può generare da un procedimento di espropriazione per pubblica utilità[25].
Il problema di fondo, giuridico, ma ovviamente prima ancora socioeconomico, in cui si imbatte chiunque voglia occuparsi di urbanistica e di enti in dissesto è quello del concorso e quindi della contrapposizione tra poteri e diritti[26], cioè dell’aspettativa di soddisfazione dell’interesse individuale del privato e del composito e contestuale interesse dell’amministrazione, all’acquisizione del bene e al risanamento.
Il territorio è percepito non solo come confine-limite, idoneo a qualificare, quasi ad esserne condizione o requisito, gli interessi economici destinati a entrarvi in rapporto, ma come spazio o potenzialità, al quale però si collega un rischio, assunto in maniera non sempre consapevole e che potrebbe, però, minare l’equilibrio finanziario dell’ente stesso.
Sarebbe finanche banale ritenere che la risposta potrebbe rinvenirsi in politiche maggiormente aperte alle interazioni con soggetti privati, anche in fase di programmazione, economica e territoriale, perché il valore dei risultati potrebbe imporre una riqualificazione, non sempre adeguata, del ruolo dei poteri pubblici.
Si deve volgere, invece, con attenzione lo sguardo agli obiettivi generali di governo del territorio a monte, che dovrebbero apparire omogenei per garantire una gestione razionale di un sistema complesso, anche se spesso le modifiche territoriali sono state rimesse alla episodicità dei singoli interventi, con le evidenti pericolose conseguenze in tema di pesi, non programmati, che hanno gravato sulla finanza dell’ente solo in un momento successivo, senza l’apposita copertura programmatoria.
Rispetto a un tema così delicato per la natura degli interessi coinvolti, ci si dovrebbe avvantaggiare di chiare individuazioni di funzioni e responsabilità, per evitare di esporre la finanza locale a un passivo che spesso diviene insostenibile. Al di là di altri possibili riferimenti a misure e a soluzioni specifiche, rimane evidente la necessità, per gli enti locali, di adottare politiche che esprimano una concezione del territorio non soltanto finanziariamente condizionata, ma sostenibile nella sua accezione ampia[27].
3.2 Profili di ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un ente locale in dissesto
Per altro verso ci si deve interrogare, sul versante delle conseguenze, sull’ammissibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione[28] che versi in una condizione di difficoltà finanziaria.
Le conseguenze immediate della dichiarazione di dissesto sono rappresentate dalla preclusione assoluta, in capo ai creditori, di intraprendere azioni esecutive[29] nei confronti dell’ente e l’interruzione della maturazione degli interessi e degli effetti della rivalutazione monetaria per i debiti insoluti.
Si deve però, sin da ora, precisare che si tratta di un’inesigibilità temporanea di interessi e rivalutazione, collegata al dissesto, che dura fino al rientro in bonis dell’ente[30], che avviene con l’approvazione del rendiconto della gestione dell’organo straordinario di liquidazione.
Il tema si è posto all’attenzione dell’interprete di recente, in ipotesi di occupazione illecita, alla quale ha fatto seguito la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale, l’istituto che dovrebbe consentire all’amministrazione di evitare lo stato di dissesto, ma le conclusioni sono pienamente valide per il caso indagato.
L’azione di ottemperanza dovrebbe essere preclusa sino all’approvazione del piano di riequilibrio, poiché la stessa è equiparata, come noto, a una procedura esecutiva. Il ricorso è inammissibile, sul piano logico prima che giuridico, poiché non avrebbe senso consentire un giudizio esecutivo destinato ex lege alla sospensione fino alla definizione, in termini positivi o negativi, della relativa situazione temporanea di squilibrio finanziario[31]. Non sarebbe, infatti, assicurata la pretesa creditoria oggetto della stessa azione proposta in giudizio.
Le situazioni debitorie degli enti locali, regolate dal titolo VIII del TUEL, non dovrebbero inibire in radice il giudizio di ottemperanza, che può proseguire fino all’adempimento di obblighi di fare, per poi paralizzarsi quanto agli obblighi di dare. L’obbligo di fare però - che nell’ipotesi indagata potrebbe riguardare la restituzione di suoli oggetto di occupazione illegittima, previo ripristino originario stato - a ben vedere potrebbe comportare, in ogni caso, un aggravio finanziario, un’ulteriore spesa per l’amministrazione.
Nel caso in cui l’ente locale abbia avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbia domandato la sospensione del giudizio di ottemperanza è ammissibile e procedibile il ricorso nei limiti della domanda volta a ottenere, mediante la scelta discrezionalmente rimessa all’amministrazione (o, in sua sostituzione, in fase di esecuzione del giudicato, al Commissario ad acta), l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ovvero di restituzione del fondo con quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento e indennizzo secondo i criteri indicati nella sentenza definitiva, al fine precipuo dell'inserimento del debito così liquidato nel piano di risanamento secondo il sistema e le procedure di cui agli artt. 243 bis o, in caso di dissesto finanziario, nel piano di rilevazione della massa passiva.
L’interpretazione elaborata in questi termini appare convincente, poiché la sospensione del giudizio di ottemperanza deve riguardare le azioni esecutive aventi per oggetto immediato e diretto il pagamento di somme di denaro, ma tale effetto sospensivo non può predicarsi, in maniera equivalente, in relazione agli obblighi di fare, poiché non viene in rilievo l’interesse ad un ordinato assetto delle esigenze di bilancio, ma l’interesse ad ottenere l’adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, per come identificata nella decisione da ottemperare.
Si tratta di un pur complesso punto di equilibrio tra interessi confliggenti, quelli dell’ente, quelli dei cittadini, quelli dei creditori che trovano il proprio terreno di confronto sull’orlo del baratro di una situazione deficitaria[32].
La modulazione dell’ammissibilità di un’azione a carattere esecutivo deve essere condotta in concreto, volgendo lo sguardo allo stato complessivo dello squilibrio, alla probabilità che si verifichi un tempestivo rientro dal debito[33], alla stessa capacità amministrativa dell’ente locale.
4. Riflessioni conclusive. Autonomia, diritti e territori
Una rappresentazione di sintesi, ma interlocutoria e che si proponga di andare oltre la relazione diretta tra ammissibilità del giudizio di ottemperanza e divieti di spesa, ma che sia afferente agli sviluppi tentacolari del tema del dissesto degli enti locali deve rintracciarsi nel filo rosso che lega autonomia, diritti e territori[34], rifuggendo da considerazioni banali, tra le quali quella che induce a sostenere che vi sia un’incapacità del livello di governo locale a rispondere alle domande dei cittadini e alle esigenze degli interessi economici, almeno di quelli che devono essere mediati del potere stesso.
Diritti e interessi economici vivono e spesso si confrontano sullo stesso terreno, caratterizzato, come nelle ipotesi poste sotto indagine, da risorse economiche limitate, condizione dalla quale derivano diversi divieti di spesa e quindi inammissibilità di ricorrere alle poste disponibili, anche se oggetto di statuizioni giurisdizionali.
Non si possono, però, sacrificare né i diritti dei cittadini residenti in un comune in dissesto, già vittime di misure di risanamento spesso improntate all’aumento delle aliquote delle imposte e alla riduzione dei servizi, né gli interessi economici che possono rappresentare la leva per consentire un rientro più celere della condizione finanziaria deficitaria.
Le soluzioni che il legislatore ha predisposto per garantire la soddisfazione del credito nei confronti di un ente che, in partenza, è in condizione di non garantire le funzioni ordinarie sono state modulate, nel corso del tempo, in base a determinati fattori, esogeni e pertanto non disponibili, ma anche endogeni alla stessa amministrazione interessata, come le carenze organizzative che hanno contribuito al debito.
Il riferimento e al contempo l’obiettivo di medio termine che deve essere perseguito è il rientro definitivo dalla posizione debitoria, il risanamento in termini di risultato autonomo, che però si garantisce e si raggiunge in un tempo nel quale devono, contestualmente, essere garantite funzioni essenziali attribuite per legge.
Il punto di partenza, la situazione debitoria, impone di leggere la stessa funzione amministrativa comunale in una dimensione più ampia, complessiva, in termini di rinnovati equilibri e rinnovata sostenibilità.
L’esercizio della funzione e il risanamento sono potenzialmente in antitesi ma si tratta di un conflitto apparente, poiché si tratta di porre rimedio a un danno arrecato dagli amministratori locali cui deve far seguito una logica programmatoria che persegua l’obiettivo della coesione economica e sociale a livello locale.
Il contesto della dimensione locale, anche qualora sia studiato a partire da una situazione di insolvenza, deve restituire una dialettica che tenga in considerazione l’organizzazione e la funzione, nell’ottica finale dell’autonomia dalla quale può desumersi la capacità che il territorio stesso può esprimere, proprio perché sede elettiva nella quale i diritti sono garantiti e tutelati.
[1] Tra gli studi più pregevoli si devono segnalare gli scritti di G. Verde, Le leggi sul dissesto degli enti locali dopo gli interventi della Corte costituzionale, in Dir. proc. amm., 1995, 2, 234 ss. e di M. Sandulli, Il “completo risanamento” dei debiti degli enti locali in dissesto, in Riv. dir. proc., 1996, 1, 7 ss.
[2] Cass., sez. un., 14 maggio 2024, n. 13205, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie che vertono sulle sanzioni interdittive comminate agli amministratori locali responsabili del dissesto.
[3] T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20 settembre 2024, n. 5039, sent. non def. n. 5039, la dichiarazione del dissesto è un atto di competenza dell'organo consiliare rigidamente vincolato, la cui adozione è doverosa e sufficientemente motivata dalla mera ricognizione dell'incapacità dell’ente di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero di assicurare il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili di terzi con gli strumenti forniti dalle norme di contabilità. Il sindacato giurisdizionale sull’atto de quo è necessariamente incentrato sulla verifica del corretto esercizio del potere di azione in ordine all’accertamento dei presupposti di fatto previsti dalla legge, non potendo consentirsi al giudice amministrativo alcuna valutazione delle scelte operate. (Nella fattispecie in esame, la sezione reputa legittima l’adozione della deliberazione finale di dissesto finanziario, preceduta dall’approvazione del rendiconto della gestione nonché dalla presa d’atto dell’impossibilità di ripiano. Assume che gli incontestabili dati di bilancio militano nel senso di ritenere realizzato il presupposto della dichiarazione di dissesto, sulla scorta di un accertamento dell’evidenza dei dati medesimi, a nulla rilevando le ipotetiche soluzioni prospettate dai revisori dei conti, quanto all’alienazione degli immobili di proprietà comunale ovvero ad altre forme di anticipazione finanziaria).
[4] Si v. lo studio pubblicato con cadenza annuale, M. Degni (a cura di), VII Rapporto Ca’ Foscari sui comuni. I comuni nella nuova governance europea della finanza pubblica, Roma, Castelvecchi, 2024.
[5] Sul tema, nell’ottica della tutela dei creditori, cfr. C. Bergonzini, Quando il dissesto si nasconde nei dettagli. Criticità finanziarie del Comuni e tutela dei creditori: un bilanciamento da rivalutare, in Federalismi, 2023, 15, 5 ss.; tra i lavori monografici, per una lettura di taglio economico del tema, si v. R. Civitillo, Il dissesto finanziario degli enti locali, Milano, Franco Angeli, 2022.
[6] Si tratta di un passaggio, particolarmente significativo, della delibera con la quale il comune di Frignano ha dichiarato il dissesto, 29 luglio 2022, del. n. 24; si v., per apprezzare la multifattorialità del dissesto, anche la delibera con la quale il comune di Paolisi ha dichiarato il dissesto, 28 dicembre 2022, del. n. 43, dalla quale si evince che “al di là dei fattori contabili, ha inciso la risalente inadeguatezza della macchina comunale, che avrebbe bisogno dell’innesto di buone pratiche e di robusta assistenza tecnica, con l’inserimento di adeguate figure professionali, tra le quali rileva l’assenza di un responsabile del servizio finanziario”.
[7] Come osserva G. Rivosecchi, I controlli sulla finanza pubblica tra i diversi livelli territoriali di governo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 3, 760, si tratta dell’accertamento della corrispondenza tra determinati fatti giuridico-contabili ai parametri normativi.
[8] Emblematica è l’espressione utilizzata da F. Pica, La crisi finanziaria del Comune di Napoli: lezioni da una esperienza, in Riv. econ. Mezz., 2014, 1-2, con il dissesto si prende atto del fatto che l’ente è morto, in quanto ha fallito senza rimedio alla sua effettiva missione.
[9] Si deve osservare, infatti - come fatto di recente da T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 2 novembre 2023, n. 5936, in Foro amm., 2023, 11, II, 1538 - che l’incarico di componente dell’organo straordinario di liquidazione di un comune non costituisce un rapporto di pubblico impiego, infatti, la revoca di tale incarico non è annoverabile tra gli atti di gestione del rapporto di pubblico impiego.
[10] Sul profilo inerente la tenuta degli equilibri dinamici di perfomance in un regime separato, si v. V. Manzetti, Quale “performance” amministrativa negli enti locali in situazione di grave squilibrio di bilancio?, in Federalismi, 2019, 17, 10 ss.
[11] Cfr. Cons. St., sez. V, 9 maggio 2003, n. 2455, in Foro amm. CdS, 2003, 1612.
[12] Così T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 luglio 1994, n. 335, in Foro it., 1995, III, 352; ex multis, rispetto all’equiparazione del giudizio di ottemperanza alle azioni esecutive, si v. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 29 maggio 2012, n. 2514, in Foro amm. TAR, 2012, 5, 1695, “quando una norma - come l’art. 21 comma 3, d.l. n. 8 del 1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 68 del 1993 - non consente al creditore dell’amministrazione di agire in sede giurisdizionale con le azioni esecutive (in quanto la soddisfazione deve aver luogo nell’ambito di una procedura amministrativa concorsuale), non si può ritenere ammissibile il giudizio di ottemperanza”.
[13] Si v. M. Nunziata, In tema di “dissesto finanziario” degli enti locali, in Amm. cont. St. en. Pubbl., 1994, 1-6, 74 ss.; Cons. St., ad. plen., 24 giugno 1998, n. 4, in Giur. It., 1998, 597, “l’art. 21 comma 3 d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, conv. con modificazioni dalla l. 19 marzo 1993 n. 68 - con il quale è stata disposta l’estinzione delle procedure esecutive pendenti (previo pagamento dell’importo dovuto) e la non proponibilità di nuove azioni esecutive nei confronti degli enti locali dissestati - è applicabile sia in relazione all’esecuzione forzata dinanzi al giudice ordinario, sia quando il creditore dell’ente locale presenti al giudice amministrativo il giudizio per l’esecuzione del giudicato disciplinato dall’art. 27 n. 4 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054; in questo caso, il giudice dell’ottemperanza non può prendere misure dirette alla soddisfazione dei ricorrenti in violazione del principio della «par condicio creditorum», salve le azioni decisorie (che hanno un sostanziale contenuto di cognizione), di controversie ancora non pendenti”.
[14] Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 544, in Foro amm. CdS, 2003, 503.
[15] Si v. C. Barbati, Territori e interessi economici: le “politiche dei luoghi” per lo sviluppo locale, in Scritti in memoria di Roberto Marrama, I, Napoli, ES, 2012, 31 ss., 36.
[16] Ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 22 maggio 2024, n. 3297; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 24 maggio 2023, n. 687.
[17] Sul tema, anche in ragione degli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, cfr. A. Quarta, Effetti del decreto di esproprio e situazioni possessorie. L’ultima parola della Cassazione, in Giur. it., 2023, 6, 1258 ss.
[18] Sul tema, si v. G. Manfredi, Acquisizione sanante, ottemperanza, indennità, in Giur. it., 2021, 6, 1431 ss.; sul profilo debitorio, E. Barile, In tema di dissesto degli enti locali (Nota a Cons. St., ad. plen., 5 agosto 2020, n. 15), in Foro it., 2020, 12, III, 667 ss.
[19] Cons. St., sez. IV, 17 novembre 2023, n. 9874, l’atto di acquisizione sanante, generatore dell’obbligazione (e, quindi, del debito), è attratto nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, e non rientra quindi nella gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile sia sotto il profilo della competenza ammnistrativa, se detto provvedimento ex art. 42-bis t.u. espropriazione è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
[20] Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 18 marzo 2024, n. 997.
[21] Proprio in tema di azioni esecutive in seguito a procedimenti espropriativi, si v. M.M. Cellini, La penalità di mora nel processo amministrativo tra precarietà della statuizione ed effettività della tutela giurisdizionale, in Riv. dir. proc., 2021, 1, 380 ss.
[22] Secondo la nota ricostruzione di H.A. Simon, Il comportamento amministrativo, Bologna, Il Mulino, 2001 (rist.).
[23] Si tratta dell’impostazione teorica elaborata da G. Marongiu, Complessità sociale, identità politica e formazione, in P.F. Casini (a cura di), Sui banchi della politica, Roma, Ed. Cinquelune, 1990, ora anche in La democrazia come problema, II, Bologna, Il Mulino, 1994, 137.
[24] Cfr. C. Bergonzini, P. Brambilla, La riforma del Titolo VIII: soluzioni per la criticità finanziaria dei Comuni, in M. Degni (a cura di), VI Rapporto Ca’ Foscari sui comuni. I comuni dentro la sfida del PNRR, Roma, Castelvecchi, 2023, 121 ss.
[25] Sui profili finanziari della programmazione urbanistica, cfr. A. Moscarini, Proprietà privata e Costituzione dopo le sentenze della Consulta nn. 348 e 349 del 2007, in Dir. soc., 2008, 4, 669 ss.
[26] Ci si limita a rinviare a P. Stella Richter, Proprietà immobiliare e pianificazione urbanistica, in Studi in memoria di Franco Piga, I, Milano, Giuffrè, 1992, 947 ss., che osserva, in termini generali, che il procedimento espropriativo deve tenere, sin dalla fase di programmazione, in debita considerazione, tutti gli interessi che insistono, anche indirettamente, sulla vicenda; L. Mercati, La buona amministrazione del patrimonio immobiliare pubblico, in Scritti per Maria Luisa Bassi, Napoli, ES, 2022, 193.
[27] Cfr. C. Raffestin, Per una geografia del potere, Milano, Unicopli, 1981, 155, ogni pratica spaziale indotta da un sistema d’azioni o di comportamenti, anche embrionali, si traduce in una produzione territoriale, con effetti finanziari che gravano sui soggetti, pubblici o privati, che si fanno carico dell’esecuzione.
[28] In termini generali, sull’esigibilità dei crediti nei confronti degli enti locali, cfr. R. Mininno, Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo come modalità (alternativa) di recupero forzoso dei crediti verso gli enti locali, in Riv. es. forz., 2023, 4, 974 ss.; si v. anche A. Cascone, L’ottemperanza “civile” in trasformazione, in Dir. econ., 2022, 3, 221 ss.
[29] Sul tema, in una lettura che generi dalla procedura esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, cfr. A. Auletta, L’esecuzione forzata contro la pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 2020.
[30] Cfr. Cass., sez. I, 10 marzo 1999, n. 2049, in Giust. civ. mass., 1999, 532, in tema di procedura esecutiva iniziata nei confronti dell’amministrazione precedentemente alla dichiarazione del relativo stato di dissesto è inammissibile l’intervento anche di altri creditori, per il pagamento di interessi su crediti vantati nei confronti dell’ente, ma scaduti dopo la dichiarazione di dissesto.
[31] T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 501.
[32] Cfr. A. Crismani, Il dissesto finanziario degli enti locali tra tutela dei creditori, “diritto a un tribunale” e tutela della finanza pubblica, in questa Rivista, 2022.
[33] Si tratta di un aspetto che impone di tenere in considerazione gli articolati rapporti tra tessuto economico, società e amministrazione, sui cui profili, ex multis, cfr. G. Montedoro, Economia e società circolare: quali trasformazioni dello Stato e del diritto amministrativo?, in Dir. soc., 2020, 1, 175 ss.
[34] Per riprendere il titolo del celebre studio di S. Sassen, Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all’età globale, Milano, Mondadori, 2008; L. Giani, L’amministrazione tra appropriatezza dell’organizzazione e risultato: spunti per una rilettura del dialogo tra territorio, autorità e diritti, in Scritti per Maria Luisa Bassi, Napoli, ES, 2022, 765 ss.
Considerazioni a prima lettura sulla sentenza costituzionale n. 208 del 2024: un passo avanti nell’espansione dei poteri del giudice dell’esecuzione?
di Claudia Terracina
Sommario: 1. Premessa - 2. Le questioni di legittimità costituzionale - 3. La soluzione della Consulta - 4. Un tema delicato: i poteri del giudice dell’esecuzione - 5. I confini dell’intervento del giudice dell’esecuzione - 6. Il procedimento e l’art. 676, comma 3-bis c.p.p.
1. Premessa
La sentenza costituzionale n. 208 depositata il 19 dicembre 2024, che interviene in senso additivo sugli artt. 442, comma 2-bis e 676, comma 3-bis, c.p.p., per il suo contenuto innovativo e per l’autorevolezza della fonte da cui promana costituisce una tappa fondamentale nel cammino di espansione dei poteri del giudice dell’esecuzione.
Oggetto della pronuncia costituzionale è la possibilità di applicare, in sede esecutiva, la sospensione condizionale della pena a valle della riduzione della pena applicata con giudizio abbreviato di un ulteriore sesto, per mancanza di impugnazione. Il meccanismo di applicazione della diminuente trova disciplina nel nuovo comma 2-bis dell’art. 442 c.p.p., introdotto dall’art. 24, lett. l), D.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia), con evidente scopo deflattivo[1]: “Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione”. Sulla norma, oggetto di numerosi commenti e contrasti applicativi, per motivi di spazio, non è opportuno soffermarsi[2].
La disciplina è completata, sul piano processuale, dal comma 3-bis dell’art. 676 c.p.p.:
“Il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.”
Le due norme, tuttavia, nulla dicono sulla possibilità del giudice – a valle della riduzione di un sesto – di applicare la pena sospesa.
2. Le questioni di legittimità costituzionale.
Dubbi di legittimità costituzionale della norma, posti in relazione al potere del giudice dell’esecuzione di applicare la pena sospesa all’esito della riduzione di un sesto della pena, erano stati dissipati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28917 del 26/03/2024, Espinosa Castro Juan Luis[3]. La Corte aveva escluso profili di irragionevolezza nel mancato riferimento, nell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., al potere del giudice dell’esecuzione di concedere i benefici rispetto alla espressa previsione di questo potere nel terzo comma dell’art. 671 c.p.p. in seguito al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
A sollevare la questione di legittimità costituzionale, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nola, investito, in sede esecutiva, dell’istanza, ex art. 676, comma 3-bis, c.p.p., di un condannato con giudizio abbreviato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione in cui venivano chiesti anche i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, non concessi in fase di cognizione solo in ragione della misura della pena. In esito alla riduzione della pena di un sesto, che l’aveva ricondotta nei limiti dell’art. 163 c.p., in assenza di altri elementi ostativi, in effetti il condannato avrebbe potuto fruire dei benefici.
Nel silenzio del legislatore, il giudice remittente si riteneva tuttavia privo del potere di concederli. Né una tale possibilità, a suo avviso, poteva discendere dalla applicazione analogica dell’art. 671, comma 3, c.p.p. che conferisce al giudice dell’esecuzione il potere di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, in quanto norma eccezionale, in contrasto con il principio dell’intangibilità del giudicato, come espressamente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4687 del 20/12/2005 (dep. 2006), Catanzaro[4].
Il giudice a quo riteneva che il silenzio del legislatore sulla possibilità di concedere i benefici una volta ridotta la pena di un sesto in contrasto con i principi costituzionali sulla pena e sulla ragionevole durata del processo.
«L'impossibilità di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena nel caso di applicazione della diminuente ex art. 442 comma 2-bis c.p.p.», si legge nella ordinanza di remissione, «produce di per sé effetti distonici rispetto agli scopi prefissati dal legislatore e, pertanto, sproporzionati ed irragionevoli». Osservava in primo luogo il giudice a quo, richiamando la natura sostanziale e special-preventiva della sospensione condizionale della pena, come la lacuna normativa creasse un vero e proprio «vuoto giurisdizionale», in quanto il potere di vagliare la sussistenza dei presupposti per la possibile applicazione della sospensione condizionale della pena nei confronti del soggetto in questione non è conferita ad alcuna autorità giurisdizionale: non il giudice della cognizione, in quanto inibito dal quantum di pena (originariamente) inflitto, ma neppure il giudice dell'esecuzione che, a seguito della diminuente ex art. 442 comma 2-bis c.p.p., applica al condannato, autore di un comportamento processuale particolarmente meritevole, una pena infrabiennale.» La conseguenza sono, secondo il giudice a quo, che si finisce per applicare al condannato una pena “potenzialmente sproporzionata” e dunque in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e un ostacolo alla sua funzione rieducativa. Rilevava poi un vulnus rispetto al principio della ragionevole durata del processo in quanto «l'inibizione per il giudice dell’esecuzione di valutare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena nei confronti del soggetto che, ormai condannato in via definitiva, a seguito dell'applicazione della diminuente ex art. 442 comma 2-bis c.p.p., si trovi destinatario di una pena infrabiennale, tramuta quest'ultimo - in esatta antitesi a quanto propugnato dalla Riforma Cartabia, che mirava ad eliminare il fenomeno - in un cd. libero sospeso, il cui trattamento sanzionatorio - con ogni probabilità, extracarcerario stante il quantum di pena - dovrà essere supervisionato e gestito dalla Magistratura di sorveglianza.»
Sollevava quindi questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 27, 111, 117 Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 6 CEDU.
La soluzione della Consulta
La Corte costituzionale – recependo certamente anche istanze della dottrina[5] - riteneva la questione fondata sotto svariati profili[6].
In primo luogo, la funzione rieducativa della pena, nella cui promozione i due istituti premiali, la sospensione condizionale e la non menzione, giocano un “ruolo chiave”. Pensata come «funzionale ad assicurare nel condannato per reati di non particolare gravità un effetto di monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, risparmiandogli tuttavia, in particolare nel caso di prima condanna, l’esperienza del carcere», evitando al condannato le implicazioni criminogene e desocializzanti delle detenzioni brevi, la sospensione condizionale della pena mira, infatti, alla prevenzione della recidiva, anche attraverso la minaccia della revoca del beneficio e la previsione di obblighi restitutori e ripristinatori. Parallelamente, la non menzione evita al condannato di subire uno stigma potenzialmente foriero di difficoltà nel reinserimento sociale, con maggiore rischio di ricadere nel crimine.
Il legislatore, prevedendo un limite edittale per l’applicabilità dei due benefici, ha inserito la valutazione del giudice sulla eseguibilità della pena e sulla pubblicità della condanna nella generale attività di «commisurazione in senso lato» della pena, che, nel sistema della cognizione, si svolge ordinariamente a valle della adesione dell’imputato ad uno dei meccanismi premiali di riduzione di pena. Quello previsto all’art. 442, comma 2-bis c.p.p., è proprio uno di questi meccanismi, che – con effetti deflattivi - consente all’imputato condannato in primo grado con rito abbreviato di beneficiare di una ulteriore riduzione di un sesto della pena, oltre al terzo per la scelta del rito, qualora rinunci alla impugnazione nei termini di legge.
Certo, la situazione prevista nella norma censurata - derivante dall’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza a seguito della rinuncia all’impugnazione - è peculiare perché si colloca in fase esecutiva anziché in quella ordinaria di cognizione, senza però pronunciarsi sul suo potere (o dovere) di applicare i benefici della pena sospesa e della non menzione, ove per l’effetto della riduzione la pena rientri nei limiti di cui all’art. 163 c.p.
Da tale lacuna, il quesito sulla sussistenza di tale potere.
Secondo il giudice delle leggi, dare al quesito una soluzione negativa si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e funzione rieducativa della pena.
In primo luogo, avrebbe un effetto discriminatorio nei confronti di coloro che, dopo aver già rinunciato al dibattimento per ottenere uno sconto di pena, rinuncino anche al diritto alla impugnazione per ottenere un ulteriore sconto, rispetto a coloro che scelgano di avvalersi di altri meccanismi premiali prima del passaggio in giudicato della sentenza.
Inoltre, e soprattutto, una tale soluzione appare distonica rispetto alla regola di sistema vigente nel nostro ordinamento, che pone la valutazione del giudice sulla concedibilità della pena sospesa e non menzione al termine dell’intera operazione di commisurazione della pena, compresa di riduzioni premiali per scelte processuali deflattive dell’imputato. Regola di sistema che, correlata alla scelta del legislatore di « assicurare al condannato per reati non gravi, specie se alla prima condanna, una chance di sottrarsi agli effetti desocializzanti propri delle pene detentive brevi e all’effetto stigmatizzante derivante dall’iscrizione della condanna nel casellario giudiziale» si pone come strumento attuativo delle finalità di rieducazione del condannato perseguite dal legislatore attraverso i due istituti della pena sospesa e della non menzione, predisposti «in adempimento del preciso mandato costituzionale di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.».
Inoltre, la Corte concorda con il giudice a quo nel ritenere che la scelta di impedire l’applicazione dei benefici e di destinare alla esecuzione una pena, pur ricompresa nei limiti di cui all’art. 163 c.p., proprio al momento in cui la pena finale viene determinata nel suo preciso ammontare, contrasti anche con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, che esige ogni sforzo di individualizzazione della sanzione rispetto al singolo fatto di reato e alla situazione del singolo condannato.
Infine, la soluzione di escludere l’applicabilità dei benefici in sede esecutiva nel senso finora indicato «finirebbe per minare gravemente l’effettività dell’incentivo alla rinuncia all’impugnazione, sul quale ha scommesso la riforma del 2022, per chi sia stato condannato a una pena che, grazie alla riduzione di un sesto, potrebbe rientrare entro i limiti di legge per il riconoscimento di entrambi i benefici. In tal caso, infatti, il condannato avrebbe ogni incentivo per proporre appello, mirando a ottenere in quella sede una riduzione della pena, anche grazie al meccanismo del concordato con rinuncia ai motivi di appello di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen. Il che introdurrebbe, come a ragione osserva il rimettente, un elemento di intrinseca irrazionalità rispetto allo stesso scopo legislativo di favorire una più rapida definizione del contenzioso penale: con conseguente ulteriore profilo di frizione rispetto all’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU.»
Per garantire il rispetto dei principi costituzionali in gioco, la Corte dunque ritiene di intervenire “semplicemente” mutuando la disciplina dell’art. 671 comma 3, c.p.p. « nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nel caso in cui ciò non fosse stato possibile in sede di giudizio abbreviato perché la pena determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.» Estendeva infine la dichiarazione di incostituzionalità “conseguente”, ai sensi dell’art. 27 della legge 87/53, anche all’art. 676, comma 3-bis, c.p.p.
Un tema delicato: i poteri del giudice dell’esecuzione.
Nella seconda parte della sentenza, la Corte si interroga se, per ricondurre nell’alveo costituzionale la norma censurata, fosse effettivamente necessario un intervento additivo, espressamente volto a conferire al giudice dell’esecuzione anche il potere di concedere i benefici della pena sospesa e non menzione ovvero se il risultato potesse essere raggiunto anche per via di analogia, legis o juris. La risposta che dà è sorprendente, in quanto – analizzando l’evoluzione subita dalla giurisprudenza di legittimità – giunge alla conclusione che un tale potere sia insito nel sistema, in quanto il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di intervenire sul giudicato contiene in sé, indissolubilmente – a meno che sul punto il giudice della cognizione non si sia pronunciato - quello di adottare i “provvedimenti conseguenti”.
Questo il ragionamento del giudice delle leggi.
Il punto di partenza è proprio la sentenza a Sezioni Unite “Catanzaro” del 2006. Il contrasto giurisprudenziale riguardava la possibilità di applicare in sede esecutiva la sospensione condizionale della pena ad una condanna una volta revocate, con lo strumento previsto all’art. 673 c.p.p., per abolitio criminis altre condanne con essa unite dal vincolo della continuazione. L’impossibilità di unire con il vincolo della continuazione reati e fattispecie punite con sanzione amministrativa escludeva la possibilità di applicare l’art. 671 comma 3 c.p.p.
Le fattispecie interessate erano ricettazione di assegni e spendita di assegni a vuoto, reato depenalizzato. In quella occasione[7] si fronteggiavano due orientamenti, uno, più classico, che escludeva una tale possibilità in quanto il legislatore l’aveva consentita espressamente in un unico caso, quello dell’art. 671, comma 3, c.p.p., norma di stretta interpretazione in quanto «derogatoria al principio generale dell’intangibilità del giudicato» e l’altro, che propugnava una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 673 c.p.p. evidenziando l’irragionevolezza di una soluzione che negasse al condannato di accedere al beneficio in sede esecutiva. La compatibilità ai principi costituzionali (all’epoca indicati negli artt. 2, comma 2 e 3 Cost.) era sentita anche dalla Sezione remittente che, aderendo al primo orientamento, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p., dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 211 del 26.5.2005, in quanto volto a far risolvere un contrasto interpretativo interno alla giurisprudenza di legittimità, attesa la riconosciuta presenza di un orientamento favorevole all'opzione ermeneutica considerata conforme al dettato costituzionale.
Le Sezioni Unite risolveva il contrasto individuando nell’inciso finale dell’art. 673 c.p.p. «e adotta le statuizioni conseguenti» lo strumento normativo per superare l’impasse, restando per il resto ancorata alla convinzione della “eccezionalità” del potere conferito al giudice dell’esecuzione dal terzo comma dell’art. 671 c.p.p., in quanto derogatorio al principio generale dell’intangibilità del giudicato[8].
Una volta trovato lo strumento normativo, la Corte affermava il possesso, in capo al giudice dell’esecuzione, di tutti i poteri valutativi conseguenti, tra cui quello di operare il giudizio prognostico (ove mai in precedenza espresso) presupposto per l’applicazione del beneficio: «evidenti esigenze di ordine logico, coessenziali alla razionalità del sistema, inducono a ritenere che, una volta dimostrato che la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all'esercizio di quella medesima attribuzione: onde è consequenziale inferirne che il riconoscimento della possibilità di eliminare l'effetto ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena comporta necessariamente la titolarità dei poteri necessari al conseguimento di tale risultato.».
È la teoria dei c.d. “poteri impliciti” del giudice dell’esecuzione, che sarà più volte riaffermata in seguito per giustificare interventi sul giudicato e che fonda proprio il ragionamento della Coste costituzionale nella pronuncia n. 208.
Da allora, tanta acqua è passata sotto i ponti, contribuendo a definire in modo sempre più consapevole e specifico i confini del “giudicato” da considerare veramente intangibile e quindi la necessità di una sua revisione per la sopravvenienza di fatti che rendano irragionevole il suo mantenimento.
E ciò per un principio immanente all’ordinamento – come chiarito dalla sentenza costituzionale n. 210/2013 – che reputa «recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato» e che individua nel giudice dell’esecuzione il soggetto dotato del potere dovere di intervenire sul giudicato[9]. Principio ribadito in via generale anche in altre pronunce costituzionali: la n. 2 del 2022, la n. 68 del 2021, che fa anch’essa riferimento agli sviluppi ermeneutici cui è giunta la giurisprudenza di legittimità.
Il grimaldello, anche se utilizzato soprattutto dalla Corte di cassazione con interpretazioni adeguatrici, è sempre quello del principio di eguaglianza e alla funzione rieducativa della pena, che risultano frustrati ogni qualvolta la disuguaglianza con situazioni successive emerga in modo evidente. Ma il riferimento, soprattutto nelle sentenze a Sezioni Unite che – a seguito delle note pronunce di illegittimità costituzionale che hanno interessato soprattutto la pena edittale per i reati concernenti gli stupefacenti[10] – dinanzi a situazioni che rendevano non più” legale” il trattamento sanzionatorio irrogato in sentenza definitiva, hanno affermato il potere - dovere del giudice dell’esecuzione[11] di intervenire, è anche agli artt. 13, comma terzo e 25, comma secondo, Cost.[12]
La più incisiva e rilevante tra le pronunce a Sezioni Unite, per il tema che ci occupa, è la sentenza “Marcon” (Sez. U., n. 37107 del 26/02/2015)[13], che ha risolto in senso positivo un contrasto inerente la possibilità di rideterminare in sede esecutiva la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle droghe leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e, in caso positivo, le modalità di calcolo. Benché non oggetto specifico del quesito, la Corte si preoccupa di affermare che: «Il giudice della esecuzione, nel rideterminare la pena applicata con sentenza irrevocabile ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta illegale a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, può disporre la sospensione condizionale della pena.»
In tale pronuncia, in continuità con le precedenti, la Corte ribadisce il ruolo di “custode della legalità della pena” attribuito al giudice dell’esecuzione, tenuto ad intervenire sul giudicato ove in contrasto con i principi costituzionali della legalità della pena non solo con gli strumenti espressamente previsti, ma anche usando l’analogia e dunque rintracciando nel nucleo normativo, riferibile alla fase esecutiva, la fattispecie che meglio si presta alla risoluzione del caso concreto, nel caso di specie individuata nell’art. 188 disp. att. c.p.p.
Ai nostri fini, la parte più interessante della sentenza è quella in cui si sofferma sui poteri valutativi “impliciti” del giudice dell’esecuzione e sui suoi limiti, affermando che dalla funzione di garanzia della legalità “costituzionale” della pena discende il riconoscimento dei relativi poteri, sia che la sua attività si risolva in un computo algebrico, con una mera sostituzione[14], sia che presupponga un autonomo giudizio, come nel caso del patteggiamento e in quello del computo delle circostanze oggetto della sentenza Gatto[15], anche involgente la concessione della pena sospesa e non menzione.
Quanto ai limiti, la Corte ne individua uno inderogabile[16] nel giudicato “sul fatto”, ritenendolo “costituzionalmente garantito”, a differenza di quello “sulla pena”, che arretra dinanzi alla violazione di principi costituzionali. In questa occasione, il riferimento cardine è al principio di eguaglianza e di funzione rieducativa della pena, dinanzi ai quali il principio di certezza dei rapporti giuridici risulta cedente: «Dal contenuto delle norme richiamate, nonché dalla "flessibilizzazione" del giudicato registrata nella fase esecutiva, sembra emergere una duplice dimensione del giudicato penale: la prima relativa all'accertamento del fatto, realmente intangibile, non essendo consentita, al di fuori delle speciali ipotesi rescissorie, una rivalutazione del fatto oggetto del giudizio, e tendenzialmente posta a garanzia del reo (presunzione di innocenza e divieto di bis in idem); la seconda relativa alla determinazione della pena, che, sprovvista di reale copertura costituzionale (o convenzionale), appare maggiormente permeabile alle "sollecitazioni" provenienti ab extra rispetto alla res iudicata.»
Quanto alla pena sospesa, le Sezioni Unite non solo ritengono possibile applicare la pena sospesa all’esito del nuovo accordo delle parti, ma, richiamando la sentenza “Catanzaro”, affermano che: «Allo stesso modo, deve riconoscersi che anche nelle residuali ipotesi di autonoma rideterminazione della pena il giudice dell'esecuzione possa disporre la sospensione condizionale della pena.». Il fondamento del potere di concedere i benefici non è tuttavia individuato in una norma (come l’art. 673 nella sentenza Catanzaro), ma nei “poteri impliciti” del giudice dell’esecuzione, derivanti da «esigenze di razionalità sistematica».
Le Sezioni Unite vanno quindi ben oltre la sentenza “Catanzaro” nell’individuare la fonte dei poteri del giudice dell’esecuzione, che, svincolandosi dai dati testuali, diviene allora più “fluida”.
D’altra parte, già in precedenza, “appoggiandosi” sulla sentenza “Catanzaro, la prima Sezione, nella sentenza del 2013 “Corlando” (n. 16679 del 01/03/2013 in CED Cass., n. 254570), era andata ben oltre, affermando che: «In caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio.». In questo caso la Corte operava un parallelismo tra la revoca della sentenza per abolitio criminis e l’annullamento senza rinvio nel giudizio di cassazione.
Alla sentenza “Marcon” fa riferimento invece, andando molto oltre nel declinare la fonte dei poteri del giudice dell’esecuzione, la sentenza “Terenzi”, sempre della prima Sezione penale (Sez. 1, n. 51692 del 30/10/2018 in CED Cass., n. 274547), citata dalla Corte costituzionale come ultimo approdo sul tema dei “poteri impliciti”. Così la massima: «Il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 669, comma 8, cod. proc. pen., pronunci ordinanza di revoca del capo di una sentenza di condanna per essersi formato, sullo stesso fatto e contro la stessa persona, un giudicato assolutorio, può, nel rideterminare la pena, disporne la sospensione condizionale, costituendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti a tale decisione esplicazione di un potere coessenziale a quello di porre nel nulla il giudicato.»
Il tema è quello dei poteri del giudice dell’esecuzione nel caso, previsto dall’art. 669 c.p.p., che sul medesimo fatto sia intervenuto un giudicato assolutorio ed uno di condanna, oggetto di revoca. La sentenza, in più punti, come ben evidenziato nella massima ufficiale, ribadisce che una volta riconosciuto dall’ordinamento un potere al giudice dell’esecuzione (in questo caso il potere di revoca ex art. 669 c.p.p.) deve per “coerenza interna di sistema” riconoscersi anche il potere di assumere gli adempimenti conseguenti, tra cui la pena sospesa divenuta possibile una volta revocata la sentenza che ne precludeva la concessione.
Ed è proprio a questa sentenza che la Corte costituzionale espressamente si richiama, per affermare che il potere di applicare la pena sospesa e la non menzione da parte del giudice dell’esecuzione una volta operata la riduzione di un sesto della pena ex artt. 442, comma 2-bis e 676, comma 3-bis, c.p.p. sia già insito nel sistema e trovi un richiamo normativo generale nell’art. 673 c.p.p.: «lungi dal consegnare un’attribuzione in via eccezionale, è indicativo di una situazione di potere necessariamente implicata da quella che consente al giudice dell’esecuzione di rimuovere un giudicato». Direttamente in forza di tale principio, dunque, «e non già per applicazioni analogiche di disposizioni dettate per casi simili, il giudice dell’esecuzione può provvedere sulla sospensione condizionale – su cui in precedenza non si sarebbe potuto pronunciare per l’impedimento derivante dal giudicato di condanna revocato».
Un’interpretazione adeguatrice sarebbe stata dunque, secondo la Corte costituzionale, possibile[17].
Superato, infatti, il problema della natura eccezionale del potere del giudice dell’esecuzione di applicare la sospensione condizionale della pena derivante dall’art. 671 comma 3, c.p.p. in quanto “derogatoria al principio generale della intangibilità del giudicato”, la Consulta – andando anche “oltre” la sentenza Marcon, sembra individuare la fonte del potere di intervento del giudice dell’esecuzione nei suoi “poteri impliciti”, che trovano un richiamo normativo nell’art. 673 c.p.p., ma che sono giustificati dal «principio generale del necessario adeguamento del titolo esecutivo a fatti sopravvenuti al giudicato stesso».
Ma a quali situazioni sono ancorati questi “poteri impliciti”? Si possono ritenere correlati ad ogni disposizione normativa che consente al giudice dell’esecuzione di intervenire nel giudicato?
Nella sentenza n. 208 del 2024, la Corte costituzionale, pur argomentando sulla possibilità di giungere alla medesima conclusione sulla base di una interpretazione adeguatrice della norma censurata, sceglie di intervenire sulla norma (anzi, sulle norme) con una sentenza additiva di accoglimento. ‘Ancora una tale scelta ad esigenze di “certezza del diritto”, conseguenti al progressivo consolidarsi di un orientamento, in seno alla prima Sezione penale, espressamente contrario alla possibilità di far derivare in via interpretativa il potere del giudice dell’esecuzione di concedere i benefici.
Si tratta delle sentenze n. 28917 del 26/03/2024, Espinosa Castro Juan Luis, non massimata sul punto e n. 37899 del 09/07/2024, Focsa Ion, la cui massima ufficiale porta il numero 287012-01: «Il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., facendola rientrare nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., posto che la concessione del beneficio in sede esecutiva non è ammessa in via generalizzata, ma può avvenire nei soli casi previsti dalla legge.» La prima sentenza in ordine temporale ad affermare il medesimo principio con analoga motivazione era stata Sez. 1, n. 8106 del 06/12/2023, dep. 2024, Canova[18], non massimata.
La sentenza “Espinosa Castro Juan Luis”, come già rilevato, ha escluso che la norma presentasse profili di incostituzionalità.
Le argomentazioni della pronuncia “Focsa Ion”[19] sono invero piuttosto convincenti nel rilevare le divergenze tra le situazioni finora oggetto della giurisprudenza “espansiva” sopra citata in materia di poteri del giudice dell’esecuzione e quella descritta dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., divergenze tali da far dubitare che i profili di illegittimità costituzionale della norma possano essere superati in via interpretativa evocando la teoria dei “poteri impliciti”.
Osserva la Cassazione, infatti, che «sia il caso dell'abolitio criminis, sia quello inerente alla declaratoria dell'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice determinano sopravvenienze che incidono sul quadro sanzionatorio, per così dire, genetico, nel senso che, la valutazione prognostica da effettuarsi ai sensi dell'art. 164 cod. pen. - in thesi non compiuta in allora - diviene possibile alla stregua del novum sopravvenuto, idoneo a incidere sull'ammissibilità della valutazione che avrebbe dovuto farsi se esso fosse maturato in sede cognitiva.».
Si tratta, in entrambi i casi citati (abolitio criminis e illegittimità costituzionale), così come nel caso della revoca per giudicato assolutorio sul medesimo fatto e di quello dell’annullamento senza rinvio, di ipotesi in cui la condanna ostativa alla concessione dei benefici presenta un vizio “originario” o perché non doveva essere pronunciata (caso dell’annullamento, dell’illegittimità costituzionale e del giudicato assolutorio) o perché, per motivi di eguaglianza, il venir meno della rilevanza penale di un fatto si riverbera con effetti positivi anche sulle condotte precedenti. E allora l’ordinamento conferisce al giudice dell’esecuzione il potere di assumere le “determinazioni conseguenti” alla eliminazione di elementi ostativi illegali o latu sensu “ingiusti”.
La riduzione di un sesto della pena in esito alla mancata impugnazione dell’imputato, come osserva la prima Sezione, non consegue ad alcuna forma di retroazione, ma – pragmaticamente - conferisce un vantaggio all’imputato che abbia deciso di rinunciare ad un diritto, con effetto positivo sul sistema giustizia. È una situazione sopravvenuta di tipo deflattivo paragonabile piuttosto a quella prodotta dall’indulto, che non inerisce alla genesi della pronuncia ma interviene sulla pena o su parte di essa al solo scopo di ridurre la pressione carceraria.
Ed infatti, in tema di indulto, più volte la giurisprudenza ha sottolineato che il venir meno di una condanna ostativa alla concessione dei benefici della pena sospesa e non menzione per effetto dell’indulto non consente al giudice dell’esecuzione di applicarli “ex post” (Sez. 1, n. 29877 del 24/03/2023, Susino, in CED Cass., n. 284972 - 01; v. anche Sez. 7, ord., n. 31091 del 15/10/2020, Cavataio, in CED Cass., n. 279875 - 01).
Il principio è stato espresso anche, in motivazione, da Sez. 1, n. 8262 del 08/01/2019, Campelli, in CED Cass., n. 275658[20]: «Si tratta di casi in cui sopravviene al giudicato un evento giuridicamente rilevante che determina l'ablazione ex tunc di un reato, di una pena, di una condanna: di conseguenza, è giustificata l'adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, dei "provvedimenti conseguenti" al mutato quadro giuridico, diverso da quello esistente al tempo della pronuncia del giudice della cognizione».
D’altra parte, anche nella sentenza “Terenzi” si fa riferimento al potere del giudice dell’esecuzione di assumere determinazioni per effetto di una situazione che, per effetto del contrasto tra giudicati, demoliva ab origine il giudicato di condanna.
E dunque alla previsione normativa di un potere di intervenire sulla pena in sede esecutiva non sempre corrisponde il “potere implicito” di sospenderne l’esecuzione, ma è limitata al caso in cui sia chiamato ad intervenire su un giudicato viziato ab origine. Per questo, l’assunto della sentenza” Catanzaro” sulla eccezionalità del disposto dell’art. 671 comma 3, c.p.p. resta valido. Forse, allora, non solo esigenze di “certezza processuale”, ma (come rilevato dal giudice remittente) coerenza con i principi di cui agli artt. 27 e 111 Cost. hanno reso preferibile un intervento additivo del giudice delle leggi che introducesse una ulteriore (certamente ragionevole) deroga al principio della intangibilità del giudicato.
I confini dell’intervento del giudice dell’esecuzione
La Corte costituzionale traccia poi, brevemente, richiamando la motivazione della sentenza “Catanzaro”, le modalità di intervento del giudice dell’esecuzione, precisando che «dovrà dunque valutare, secondo quanto già chiarito dalle Sezioni unite nella sentenza n. 4687 del 2006 poc’anzi estesamente richiamata, la sussistenza delle condizioni previste rispettivamente dagli artt. 163 e 164, nonché dall’art. 175 cod. pen.: e segnatamente – quanto alla sospensione condizionale – se sussista un pericolo di commissione di nuovi reati, alla luce degli elementi probatori già esaminati nel giudizio di cognizione, e di quelli ulteriori che dovessero essere nel frattempo emersi».
D’altra parte, i poteri istruttori a lui riconosciuti dall’art. 666, comma 5 c.p.p. gli consentono di acquisire ogni tipo di necessaria informazione utile allo svolgimento del giudizio prognostico di cui al primo comma dell’art. 164 c.p.
Assolutamente preclusa a giudice dell’esecuzione la concessione dei benefici è invece, pena il vulnus del giudicato, che sulla questione si sia espresso, in senso negativo, quello di cognizione[21].
Nel caso che ci occupa, la Corte, nel suo intervento additivo, limita peraltro l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione di concedere i benefici al caso in cui «il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici».
Il riferimento nel dispositivo alla “pena determinata” sembra potersi riferire alla pena concretamente determinata (cioè, irrogata) in sentenza: non solo dunque quando il giudice non abbia “potuto” concedere i benefici per i limiti edittali della pena, ma anche al caso in cui il giudice abbia nel concreto “scelto” di irrogare una pena superiore ai minimi edittali o di negare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero consentito di scendere sotto i limiti dell’art. 163 c.p., senza esprimersi sulla pericolosità sociale e il rischio di recidiva.
Per converso, dalla lettura della motivazione della sentenza n. 208 del 2024, potrebbe invece evincersi che la Corte abbia limitato l’intervento solo al caso in cui i limiti edittali della pena, anche considerata l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, rendevano al giudice impossibile determinare la pena in modo da poter concedere il beneficio e dunque che in alcun modo la mancata applicazione fosse frutto di una scelta. L’ordinanza di remissione faceva sicuramente riferimento a questa ipotesi, richiamando il “vuoto di giurisdizione”. Al punto 3.3. del Considerato in diritto la Corte scrive: «Dall’altro lato, questa peculiarità pone, sul piano esegetico, il quesito se, nel silenzio del legislatore, anche il giudice dell’esecuzione abbia il potere (o il dovere) di valutare se applicare la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna, quando soltanto per effetto della nuova riduzione la pena risulti in concreto rientrare nei limiti di legge che rendono possibile l’applicazione di uno o entrambi i benefici.»
Questo come osservazioni a prima lettura, e certamente in sede applicativa e nei commenti di dottrina si avrà qualche chiarimento.
Anche ove si interpretasse in senso ampio il dispositivo della pronuncia costituzionale è da ritenere in via generale che, come recentemente affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza “Zangari” sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena[22], perché si possa creare una preclusione all’intervento del giudice dell’esecuzione, la valutazione del tema in fase di cognizione deve essere “reale ed effettiva”.
Resta il tema della valutazione “implicita”, particolarmente spinoso. In relazione alle circostanze attenuanti, la Cassazione ha recentemente affermato che: «Le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, in CED Cass., n. 280244 – 05, Sez. 3 , n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, in CED Cass., n. 276041 – 01)[23].
Il tema è molto complesso. Ad una prima lettura, quindi, il riferimento della Corte costituzionale al potere di applicare i benefici quando la “pena allora determinata era superiore ai limiti di legge”, comprende sicuramente l’ipotesi in cui (come nel caso oggetto della ordinanza di remissione) la forbice edittale non consentisse, neppure con la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato, di rientrare nei limiti dell’art. 163 c.p., ma resta il dubbio se il giudice dell’esecuzione potrebbe intervenire ove la pena “allora determinata” non consentisse la concessione del beneficio perché applicata dal giudice oltre i minimi edittali, perché potrebbe in concreto celare una valutazione “implicita” sulla concedibilità della sospensione condizionale.
D’altra parte, per come è costruita la norma, è nella fisiologia del sistema che il medesimo giudice che ha determinato la pena in abbreviato sia immediatamente dopo chiamato, a seguito della rinuncia alla impugnazione, a operare quale giudice dell’esecuzione ed è dunque presumibile che la sua valutazione (salvo elementi intervenuti) non verrà a contraddire quella da lui svolta in precedenza. In ogni caso, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che nega ovvero concede la sospensione condizionale della pena, essendo legata ad una valutazione discrezionale ed incidendo sulla libertà personale, comunque può essere oggetto di ricorso per cassazione.
Il procedimento e l’art. 676, comma 3-bis c.p.p.
In chiusura, qualche cenno sul procedimento.
Come accennato, la Corte, in applicazione dei suoi poteri derivanti dall’art. 27 della l. 87/53, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 676, comma 3-bis c.p.p. «nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nel caso in cui ciò non fosse stato possibile in sede di giudizio abbreviato perché la pena determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.»
L’art. 676 c.p.p. è la norma sulla procedura. Nella prima stesura della riforma del 2022, il riferimento alla riduzione di un sesto era contenuto nel primo comma. In seguito, veniva modificata dal c.d. “correttivo Cartabia” (d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31), che, eliminando il riferimento all’art. 442 c.p.p. nel primo comma, ha inserito un comma 3-bis, in cui si precisa la natura officiosa del potere. L’intervento correttivo – come riportato nella Relazione illustrativa – mira a chiarire la natura doverosa ed officiosa del potere di riduzione di un sesto, superando talune incertezze applicative sorte all’indomani delle modifiche del 2022 circa la necessità dell’istanza di parte per sollecitare l’intervento giudiziale[24].
La norma, come osservato dai commentatori[25], introduce un’espressa deroga al principio generale secondo il quale il giudice dell’esecuzione procede, di norma, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore (art. 666, comma 1, c.p.p.).
La scelta di affidare la riduzione al giudice dell’esecuzione – di regola il medesimo giudice che ha emesso la sentenza con rito abbreviato - discende evidentemente dall’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, a seguito della rinuncia alla impugnazione. Altra sua peculiarità è che si colloca “in limine” alla irrevocabilità e prima della trasmissione dell’estratto esecutivo, dunque prima che l’ufficio del pubblico ministero sia interessato della esecuzione. Il meccanismo, volto a intervenire sulla pena, è stabilito in modo tale da allertare (con la produzione dell’estratto esecutivo) il giudice della necessità dell’intervento riduttivo, e di intervenire prima che la pena (definitiva) venga messa in esecuzione.
Il che genera una ulteriore peculiarità, che interessa la competenza del giudice dell’esecuzione, in questo caso certamente e sicuramente da individuare sempre nel giudice che ha deciso, e non nel giudice competente ex art. 665 c.p.p., cui pure spetta la rideterminazione della pena in sede esecutiva. Pertanto, non opera lo spostamento della competenza nel giudice dell’ultima sentenza irrevocabile nel caso di esecuzione di pena concorrenti, in quanto la pena è ridotta prima che inizi, con la trasmissione dell’estratto esecutivo, la fase esecutiva vera e propria.
E allora, come altri istituti della riforma Cartabia, anche quello in esame si presenta come una novità, mostrando di essere una sorta di “incursione” del giudice della cognizione in fase esecutiva – derivante dall’obbligo di agire - più che una funzione specifica del giudice dell’esecuzione, che rende ancora più doveroso riconoscergli il potere di applicare i benefici della pena sospesa e non menzione.
Questa natura “anfibia” potrebbe peraltro spiegare le peculiarità dell’istituto, prima tra tutte il potere di intervento officioso.
È da ritenersi che – a seguito dell’intervento della Corte costituzionale - anche per l’applicazione della sospensione condizionale e della non menzione, il giudice possa provvedere d’ufficio. In generale, il giudice della cognizione può – coerentemente con la funzione dell’istituto – applicare d’ufficio i benefici, potere eccezionalmente concesso anche al giudice di appello in deroga al principio devolutivo dall’art. 597, comma 5, c.p.p. Coerentemente, l’orientamento della Corte di cassazione è quello di escludere che salvo che il condannato non dimostri un interesse “qualificato” (diverso da quello di volersi “conservare” la pena sospesa per una successiva occasione) non sia consentito impugnare la concessione della sospensione condizionale non richiesta[26].
Non vi sono ragioni, pertanto, ad avviso di chi scrive, per non consentire l’esercizio del potere officioso qualora unico motivo per la mancata applicazione del beneficio prima della riduzione di un sesto della pena fosse legato al limite edittale della pena, compresa la riduzione per le circostanze attenuanti generiche, o anche alla mancata valutazione della questione in sede di cognizione[27].
[1] Così la Commissione Lattanzi: “collegando all’acquiescenza, e al connesso risparmio di tempo e risorse processuali, l’ulteriore trattamento premiale in relazione alla pena inflitta” (così, la relazione illustrativa allo schema di decreto, p. 133), al fine di “ridimensionare l’incidenza di appelli finalizzati a censurare unicamente l’entità della pena...” (cfr: relazione finale dei lavori della Commissione Lattanzi, p. 27).
[2] In questa sede ci si limita a riferire che la Corte di cassazione ha chiarito che la “rinuncia” all’impugnazione già presentata, prima dell’entrata in vigore della novella, non sia equiparabile sua radicale mancanza (così Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023 in CED Cass, n. 285583 – 01 e Sez. 1, n. 49255 del 26/09/2023 in CED Cass., n. 285683 – 01). La ragione è individuata nella natura processuale della norma, sottoposta al principio “tempus regit actum”, ove l’”actum” è l’impugnazione. Sul punto v. la nota di C. Minella a Sez.1, 10/3/2023, n.16054, L'introdotta riduzione di un sesto per il mancato appello avverso sentenza in abbreviato non si applica alla rinuncia all'impugnazione, in Diritto & Giustizia, fasc.71, 2023, pag. 10.
Sulla diminuente, vedi tra gli altri Cavallini, Note a margine di una legge “troppo breve”: la nuova “diminuente esecutiva” tra diritto sostanziale e processo, in Dir. pen. proc., 2023, p. 554 ss.; Cecchi-Salimbeni, Mancata impugnazione della condanna pronunciata in abbreviato e sospensione condizionale della pena, in Penale dir. e proc., 10 gennaio 2024; De Giorgio, La natura della riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., in www.ilpenalista.it, 8 aprile 2024;G. Della Monica, La competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ad applicare la diminuente di cui all'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. tra interpretazioni sistematiche e dubbi di legittimità costituzionale, in Cass. Pen., fasc.10, pag. 3234.; V. Maffeo, Efficienza e deflazione processuale nella riforma dei procedimenti speciali (legge n. 134 del 2021 e d.lg. n. 150 del 2022), in Cass. Pen., fasc.1, gennaio 2023, pag. 32.
La giurisprudenza si è interrogata in modo particolare sulla possibilità di concedere la restituzione in termini per poter chiedere il giudizio abbreviato e così fruire della novellata riduzione premiale. Alcune decisioni di merito, sul presupposto della natura (anche) sostanziale della diminuente e conseguente possibilità di applicazione dell'art. 2, comma 4, c.p., hanno accordato la restituzione in termini per richiedere il rito speciale e fruire del nuovo beneficio premiale (Trib. Perugia, 18 gennaio 2023, Signal, in Sistema penale, 19 gennaio 2023 e 9 febbraio 2023, con nota di Lombardi, Rinuncia all'impugnazione nel giudizio abbreviato e riduzione di un sesto della pena (art. 442 co. 2 bis c.p.p.): il problema della rimessione in termini a giudizio in corso; Trib. Latina, 6 febbraio 2023, in Giurisprudenza Penale Web, 23 febbraio 2023). Questo primo indirizzo fonda la decisione positiva sulla natura sostanziale della norma, che consentirebbe dunque l'applicabilità del principio di retroattività in bonam partem sancito dall'art. 2, comma 4, c.p. e, a livello sovranazionale, dall'art. 7 CEDU. Altre decisioni di merito, per converso, hanno negato la restituzione in termini sul presupposto che altro è la natura sostanziale della diminuente – da applicarsi anche ai fatti pregressi e in corso, là dove sia stato già richiesto il rito speciale – altra è la natura processuale della normativa generale che regola comunque la richiesta e l'ammissione del rito, per cui non è possibile restituire nel termine l'imputato che non aveva comunque optato per tale tipo di giudizio. Sul punto v. Sez. 1, n.16054 del 10/03/2023, in Cass. Pen., fasc.7-8, 2023, pag. 2345, con nota di G. Todaro, che ha risolto il dilemma escludendo la possibilità di rimettere in termini e superato i dubbi di illegittimità costituzionale della norma, seguita da altre sentenze. Contra, v. Sez. 2 , n. 4237 del 17/11/2023, in Cass. Pen., 2024 fasc. 6 p. 1744, con nota di F. D’Alessio, La natura sostanziale della disposizione di cui al comma 2-bis dell’art. 442 c.p.p. e in IUS Penale, fasc., 8 aprile 2024, con nota di M. De Giorgio, La natura della riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. In questa sentenza la Corte ritiene che la disciplina dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. sia astrattamente applicabile anche ai procedimenti penali per i quali era stata già proposta impugnazione al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, «atteso che, incidendo sul trattamento sanzionatorio, in quanto determina una ridefinizione della pena stessa, ha natura sostanziale». Rilevante, in particolare, è il passaggio in cui si afferma che «tutte le norme che non solo qualificano il comportamento come reato, ma che ne stabiliscono la punizione in concreto e, quindi, l'an, il quantum e il quomodo delle conseguenze punitive devono soggiacere alla regola della irretroattività della legge sopravvenuta sfavorevole e della retroattività della legge sopravvenuta favorevole. In tali casi deve, allora, trovare applicazione il principio di retroattività della lex mitior, di cui all'art. 2, comma 4, c.p.»..
[3] La sentenza è pubblicata in Diritto & Giustizia, fasc. 137, 2024, pag. 3, con nota di A. Salerno, L’anticipazione in dispositivo della riduzione di un sesto della pena irrogata a seguito di rito abbreviato è irrituale ma non viola i diritti dell'imputato. Sul punto la sentenza osserva: «La norma recentemente introdotta, come evidenziato in precedenza, ha natura strettamente processuale e, proprio al fine di consentire all'imputato (poi condannato) di poter assumere le proprie determinazioni in anticipo, prevede una riduzione in misura fissa. Il giudice dell'esecuzione, cui è quindi sottratta ogni valutazione circa la congruità o meno della pera e del rapporto tra questa e il reato e la personalità del condannato, non ha alcun potere discrezionale paragonabile a quello che gli è invece riconosciuto nella diversa ipotesi prevista dall'art. 671 cod. proc. pen., allorché gli è attribuito eccezionalmente il compito di rideterminare complessivamente la pena. Tale scelta, d'altro canto, non risulta neanche irragionevole in termini generali di sistema. In questa specifica situazione, infatti, il giudizio in ordine alla quantificazione della pena e circa la concessione o meno dei benefici è coerentemente demandato al giudice della cognizione, cui questo è attribuito in via ordinaria, senza che possa su questo incidere la circostanza, del tutto eventuale, che l'ulteriore riduzione di un sesto comporti l'applicazione di una pena finale inferiore ai due anni.»
[4] Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005 in CED Cass., n. 232610. Questo il passo della motivazione: «Invero, considerato che - conformemente all'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità - l'immodificabilità del giudicato corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento derogabile sono nei casi previsti dalla legge, il divieto dell'applicazione analogica dell'art. 671, comma 3, c.p.p. non può essere eluso in nome dell'interpretazione secundum Constitutionem dell'art. 673, la cui sfera precettiva può essere adeguata dal giudice ai principi della Carta fondamentale soltanto quando la ricostruzione della portata della disposizione risulti possibile con l'impiego degli usuali mezzi dell'ermeneutica giuridica.»
[5] Dubbi di coerenza nel sistema si erano posti taluni autori: v. sul punto Cecchi- Salimbeni, op. cit., p. 5 e G. Della Monica, op. cit., p. 3239.
[6] In punto di ammissibilità della questione, superando l’eccezione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, motivata sull’erronea indicazione della norma possibile oggetto della censura - da individuare più correttamente nell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen. - la Corte costituzionale ha precisato che entrambe le disposizioni hanno ad oggetto il potere del giudice dell’esecuzione di operare la riduzione di un sesto, così da non potere considerare la richiesta del giudice a quo viziata da aberratio ictus.
[7] Questa la motivazione: «Le Sezioni Unite ritengono che il principio dell'interpretazione adeguatrice giustifichi l'adesione all'indirizzo favorevole alla concedibilità della sospensione condizionale della pena nell'ipotesi di revoca di sentenze di condanna, per la ragione che esso risulta maggiormente aderente alle linee strutturali del sistema normativo ed appare come il più coerente risultato di un'indagine ricostruttiva della disciplina di cui all'art. 673 c.p.p., che coinvolge sia profili di diritto processuale riguardanti il principio del giudicato e i limiti dei poteri decisori del giudice dell'esecuzione, sia profili di diritto sostanziale, incidenti sull'ambito di operatività della legge penale nel tempo, inquadrati nel contesto dei valori enunciati dalla Carta costituzionale in riferimento ai principi di pari trattamento e di legalità della pena (artt. 3, 25 e 27 Cost.). Gli itinerari argomentativi delle decisioni che esprimono la posizione interpretativa qui condivisa si snodano lungo due distinti percorsi, dato che in alcune sentenze la possibilità di concedere il beneficio rappresenta il risultato dell'applicazione analogica dell'art. 671, comma 3, c.p.p., volta ad eliminare una lacuna ritenuta presente nella disciplina contenuta nell'art. 673, mentre in altre decisioni la questione dibattuta trova soluzione all'interno della stessa normativa dell'art. 673, della quale vengono sviluppate tutte le potenzialità applicative. Il primo itinerario ermeneutico è precluso dallo sbarramento segnato dall'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, che vieta di applicare le leggi che fanno eccezione a regole generali oltre i casi in esse considerate. Invero, considerato che - conformemente all'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità - l'immodificabilità del giudicato corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento derogabile sono nei casi previsti dalla legge, il divieto dell'applicazione analogica dell'art. 671, comma 3, c.p.p. non può essere eluso in nome dell'interpretazione secundum Constitutionem dell'art. 673, la cui sfera precettiva può essere adeguata dal giudice ai principi della Carta fondamentale soltanto quando la ricostruzione della portata della disposizione risulti possibile con l'impiego degli usuali mezzi dell'ermeneutica giuridica. Oltre che trovare ostacolo nei motivi ora indicati, il metodo ermeneutico dell'analogia deve essere escluso per la ragione che nel tessuto normativo della disciplina contenuta nell'art. 673 c.p.p. sono presenti precisi spunti interpretativi che permettono di ricondurre nell'ambito della stessa previsione normativa la possibilità di concedere la sospensione condizionale nell'ipotesi di revoca di una sentenza di condanna.»
[8] D’altra parte, come osserva B. Nacar, I “nuovi” poteri del giudice dell’esecuzione di rideterminazione della pena illegittima, in Dir. pen. e proc. 2/2016, p. 179, era questa l’intenzione del legislatore del 1988 se, nella Relazione al progetto preliminare, si era preoccupato di sottolineare che l’attribuzione di poteri al giudice dell’esecuzione idonei a rideterminare la pena, ai fini del riconoscimento della continuazione, non significava conferirgli una competenza esclusiva in materia. Cfr. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale: «L'articolo 662 (nuovo 671, n.d.r.) dà attuazione alla direttiva 97 della legge-delega in materia di applicazione, in sede esecutiva, dell'art. 81 c.p. sempre che, ovviamente, la stessa non sia stata esclusa in sede di cognizione. Si è precisato che la pena da irrogare per effetto della continuazione deve essere non superiore a quella risultante dal cumulo materiale e si è espressamente conferito al giudice il potere di concedere i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato penale quando ciò sia conseguenza del riconoscimento della continuazione (il che significa che, ove il giudice della cognizione abbia ritenuto la sussistenza di condizioni ostative rispetto alle quali sia ininfluente l'articolo 81, le suddette condizioni non potranno essere disconosciute in sede esecutiva).
[9] La sentenza costituzionale n. 210 del 2013 ha dichiarato (per contrasto con l’art. 117, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU) l’incostituzionalità dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, in quanto, con il suo effetto retroattivo, ha determinato la condanna all’ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e che in base a questo avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione.
[10] Si tratta, come a tutti noto, delle sentenze a Sezioni Unite, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano e n. 42859 del 29/5/2014, Gatto. Le sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione “Ercolano” e “Gatto” hanno fissato i principi e delineato i parametri entro i quali si è articolata la fondamentale questione della ‚” cedevolezza del giudicato”. «Il tema attiene a tutti i casi in cui la pena è determinata in sede di cognizione sulla base di norme, diverse da quelle incriminatrici, poi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale ed investe le domande di coloro che chiedono ai giudici dell’esecuzione di ricondurre ad una dimensione legittima le rispettive pene. Le Sezioni Unite non hanno disconosciuto il valore del giudicato e la necessità, ad esso sottesa, di stabilità dei rapporti, ma hanno al tempo stesso evidenziato come detta necessità non possa impedire di verificare nella fase esecutiva la legalità sostanziale della pena inflitta. La necessità che la restrizione della libertà personale del condannato trovi il suo fondamento, durante l'intero arco della sua durata, in una legge conforme alla Costituzione (art. 13, comma 2 e art. 25, comma 2), prevale rispetto alla intangibilità del giudicato e impone di intervenire in quelle situazioni che devono essere liberate dallo ‚stigma dell'ingiustizia». (Così. G. Canzio, La giurisdizione e la esecuzione della pena, relazione svolta a Roma il 19 aprile 2016 in occasione dell'evento di chiusura degli "Stati generali dell'esecuzione penale", in DPC, 26 aprile 2016).
[11] Anzi, di tutti i protagonisti del sistema giustizia. La sentenza a sezioni Unite “Gatto” sollecita sul punto il pubblico ministero, garante della legalità della fase esecutiva: «Al pubblico ministero, in ragione delle sue funzioni istituzionali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, spetta il compito di richiedere al giudice dell'esecuzione l'eventuale rideterminazione della pena inflitta anche in applicazione dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo, pur se il trattamento sanzionatorio sia già in corso di attuazione, e fino a quando questo non sia stato interamente eseguito.»
[12] La sentenza “Ercolano” è intervenuta a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000 ed ha così statuito: Non può essere ulteriormente eseguita, ma deve essere sostituita con quella di anni trenta di reclusione, la pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000 all'esito di giudizio abbreviato richiesto dall'interessato nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b), legge n. 479 del 1999 - il quale disponeva, per il caso di accesso al rito speciale, la sostituzione della sanzione detentiva perpetua con quella temporanea nella misura precisata -, anche se la condanna è divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7, par. 1, della Convenzione Edu, laddove riconosce il diritto dell'interessato a beneficiare del trattamento "intermedio" più favorevole, in quanto il divieto di dare esecuzione ad una sanzione penale contemplata da una norma dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi esprime un valore che prevale su quello della intangibilità del giudicato e trova attuazione nell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.» La sostituzione spetta x art. 670 c.p.p. al giudice dell’esecuzione.
[13] Tra i commenti alla sentenza “Marcon”, B. Nacar, op. cit., p. 177 ss.; G. Amato, Il patteggiamento irrevocabile relativo a droghe leggere può essere rideterminato in sede di esecuzione, in Guida al Diritto, 2015, fasc. 41 p. 76 ss.; S. Lo Forte, Gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovananrdi sulla pena applicata su richiesta delle parti nel caso di sentenza irrevocabile, in Il Foro ital., 2016, fasc. 2 pag. 134 ss.
[14] Come nel caso oggetto della sentenza Ercolano. Sul tema anche l’ordinanza di remissione delle sezioni Unite alla Corte costituzionale, n. 34472 del 19/04/2012.
[15] Una delle massime della sentenza Gatto è: «La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61 n. 11-bis cod. pen., ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2010, impedisce che sia eseguita la porzione di pena, irrogata con sentenza irrevocabile, corrispondente all'applicazione della circostanza aggravante prevista da tale norma, spettando al giudice dell'esecuzione individuare la porzione di pena da eliminare». Sul tema vedi anche Sez. 1, n. 26601 del 16/09/2020 in CED Cass. n. 279579, che consegue alla sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 222 del 2018 sulle pene accessorie della bancarotta. Così la massima: «In tema di reati fallimentari, è consentito al giudice dell'esecuzione procedere, secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., alla rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, inflitte con sentenza definitiva in misura pari a dieci anni, quando ne sia richiesto l'adeguamento al nuovo testo della norma, come risultante dalla interpretazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni». Più di recente, Sez. 1, n. 12675 del 13/12/2022 (dep. 2023), Huyer, in CED Cass., n. 284284- 01 ha statuito che è ammissibile l’istanza di rideterminazione in executivis della pena pecuniaria, applicata con decreto penale di condanna in sostituzione di pena detentiva, secondo i nuovi valori minimi giornalieri di conversione conseguenti alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 53, comma 2, legge n. 689 del 1981, resa dalla sentenza della Corte cost. n. 28 del 12/01/2022, nel caso in cui il trattamento sanzionatorio non sia stato ancora interamente eseguito.
[16] Limite fondamentale, come rilevato dalle Sez. U. Gatto, è anche quello delle “situazioni esaurite”, ovvero della detenzione carceraria già subita. Un limite alla rivalutazione è costituito anche dalla necessità di una rivalutazione “complessiva” della pena. Sul punto, v. Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, in CED Cass., n. 265109: «L'illegalità della pena, derivante dall'omessa erronea applicazione da parte del tribunale delle sanzioni previste per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, non è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, giacché la richiesta rimodulazione della pena comporta una valutazione complessiva di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio, del tutto eccentrica rispetto all'ambito di intervento del giudice dell'esecuzione».
[17] Così testualmente la Corte costituzionale: « Ciò non solo in considerazione del silenzio serbato sul punto dal legislatore (e dunque dell’assenza di dati testuali incompatibili con tale interpretazione), ma anche alla luce dei principi gradatamente enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, dai quali emerge che tra i poteri del giudice dell’esecuzione – fondati che siano su espresse disposizioni normative, su applicazioni analogiche di tali disposizioni ovvero su un’analogia iuris che muova dal principio generale del necessario adeguamento del titolo esecutivo a fatti sopravvenuti al giudicato stesso – rientra il potere di effettuare ogni valutazione conseguente alla rideterminazione della pena irrogata nella sentenza irrevocabile, a sua volta imposta dalle disposizioni di legge di volta in volta rilevanti. In simili ipotesi, il giudizio di esecuzione è chiamato a ospitare un «frammento di cognizione» (sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del Considerato in diritto), sulla base del materiale raccolto in precedenza o – eventualmente – delle nuove evidenze necessarie a compiere le valutazioni in parola, sì da adeguare le statuizioni relative alla pena nel loro complesso alla mutata situazione sopravvenuta al giudicato, e alla quale il giudicato stesso deve essere conformato.»
[18] In motivazione la Corte ribadisce che il giudice dell’esecuzione non può disporre la sospensione condizionale al di fuori dei casi espressamente previsti, rappresentati dall’art. 671, comma 3, cod. proc. pen., per l’ipotesi di applicazione in fase esecutiva del concorso formale e della continuazione («il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale»), e dall’art. 673 cod. proc. pen., per l’ipotesi di abolitio criminis di un reato per il quale era stata pronunciata condanna, poi revocata per l’intervenuta depenalizzazione, ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena («il giudice dell’esecuzione (...) adotta i provvedimenti conseguenti»). Vedi sul punto, Rassegna della giurisprudenza di legittimità - Gli orientamenti delle Sezioni Penali 2023, vol. II dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, p. 214, capitolo a cura di A.Gatto.
[19] La sentenza, con riferimento ai temi dei poteri del giudice dell’esecuzione, definito “nervo scoperto” è commentata in IUS Penale, fasc.12, dicembre 2024, da R. Magi, in nota dal titolo Riduzione della pena inflitta in rito abbreviato per mancata proposizione dell’impugnazione.
[20] Si riporta tutto il brano: «In effetti, il potere del giudice dell'esecuzione di incidere sul contenuto della sentenza irrevocabile, modificandolo (come avverrebbe nel caso di specie, mediante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena) non è di carattere generale, ma è normativamente previsto o giurisdizionalmente esteso ad ipotesi in cui il giudice della cognizione non ha potuto provvedere: quindi per il riconoscimento della continuazione (art. 671, comma 3 cod. proc. pen.), che presuppone l'intervenuta irrevocabilità di sentenze di condanna non conosciute in cognizione, nell'abolitio criminis (Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005 - dep. 06/02/2006, Catanzaro, Rv. 232610) o in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015 - dep. 15/09/2015, Marcon, Rv. 264859). Si tratta di casi in cui sopravviene al giudicato un evento giuridicamente rilevante che determina l'ablazione ex tunc di un reato, di una pena, di una condanna: di conseguenza, è giustificata l'adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, dei "provvedimenti conseguenti" al mutato quadro giuridico, diverso da quello esistente al tempo della pronuncia del giudice della cognizione (cfr. art. 673, comma 1, cod. proc. pen.).»
[21] Per il caso dell’art. 673 c.p.p. granitico è il principio secondo cui le autonome valutazioni in sede esecutiva non devono contraddire quelle del giudice della cognizione. Il tema era stato espressamente trattato dalla sentenza “Catanzaro”, in cui il vulnus al giudicato presupponeva che «nel pregresso giudizio l'unico motivo della mancata applicazione del beneficio» fosse «identificabile non nella presenza di una valutazione prognostica della pericolosità dell'imputato, ma nel solo effetto preclusivo della sentenza di condanna successivamente revocata per intervenuta abolizione del reato». In riferimento all’applicazione a seguito di “abolitio criminis”, in un caso in cui il giudice della cognizione aveva negato il riconoscimento del beneficio per i precedenti penali e per la gravità del fatto, la Cassazione ha affermato che una tale valutazione precludeva il successivo giudizio in sede esecutiva (Sez. 1, n. 33817 del 20/06/2014, Lamberti, in CED Cass. n. 261433). In tema di continuazione, il principio è stato espresso da Sez. 1 , n. 46146 del 12/04/2018, W., in CED, Cass. 273986: «ll giudice dell'esecuzione, nell'applicare ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, derogando al principio di intangibilità del giudicato, quando il giudice di cognizione non si è pronunciato sul punto. Quando, viceversa, quest'ultimo ha già escluso espressamente la concessione della sospensione condizionale richiesta, non è consentito, in sede di esecuzione, estendere il beneficio ai fatti precedentemente valutati anche sotto tale aspetto.»
Dai principi generali dell’ordinamento emerge anche che l’espansione dei poteri del giudice dell’esecuzione non può che essere in “bonam partem”. Così espressamente anche in Sez. U. n. 50194 del 23/04/2015, Longo.
[22] Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, in CED Cass. n. 287004.
[23] È vero anche che «Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche.» (Così, Sez. 4 , n. 27107 del 15/09/2020, in CED Cass., n.. 280047 – 02). Tuttavia, una motivazione di diniego delle attenuanti motivata sul pericolo di recidiva difficilmente potrebbe non essere considerata ostativa alla successiva applicazione del beneficio in sede di esecuzione.
[24] Come riportato nella Relazione dell’Ufficio del Massimario, la giurisprudenza di merito aveva in prevalenza ritenuto necessaria una istanza di parte.
[25] Cfr. Relazione dell’Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione n. 15/2024, a cura di A. Natalini.
[26] Il tema si era posto esclusivamente per la sospensione della pena pecuniaria, e tuttora vi è un contrasto in giurisprudenza sul punto. Vedi, da ultimo, Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, in CED Cass. n. 283475.
[27] Non è ostativo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, in quanto espressamente riferito al giudizio di appello in sede di rinvio (Sez. 1, n. 8262 del 08/01/2019, Campelli, in CED Cass., n. 275658): «Qualora a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di uno o più capi della sentenza di condanna la misura della pena venga ricondotta nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen., il giudice dell'esecuzione non può provvedere sull'istanza di sospensione condizionale della pena ove questa non sia stata avanzata anche nel giudizio di cognizione.»
Il doppio limite del potere di mitigazione climatica dell’Italia dopo le sentenze CEDU del 9 aprile 2024
di Maralice Cunha Verciano
Sommario: 1. Premessa: Il riparto di competenza del potere di mitigazione climatica tra Stati e UE – 2. I limiti al potere di mitigazione climatica dopo le sentenze CEDU del 9 aprile 2024 – 3. Il doppio limite del potere di mitigazione climatica dello Stato tra diritto UE e CEDU – 4. La competenza della UE in merito al doppio limite esistente – 5. Conclusione 1: il rispetto dei requisiti CEDU non viola il diritto UE – 6. Conclusione 2: i requisiti CEDU garantiscono anche il neminem laedere.
1. Premessa: Il riparto di competenza del potere di mitigazione climatica tra Stati e UE
Com’è noto, il potere statale di mitigazione climatica trova fondamento nell’art. 2 UNFCCC del 1992, con riguardo all’obiettivo definitivo da conseguire attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra, e nell’art. 2 dell’Accordo di Parigi del 2015, con riguardo alla soglia concordata del pericolo da non superare nell’aumento delle temperature medie globali[i].
Queste due fonti vincolano tutte le parti aderenti ai due accordi.
Di conseguenza, vincolano sia l’Italia e che la UE, in quanto entrambe hanno ratificato l’UNFCCC e l’Accordo di Parigi.
Nella UE, il potere di mitigazione climatica è previsto anche dall’art. 191 TFUE, in un quadro di competenze concorrenti con gli Stati membri, contraddistinto altresì dalla clausola di miglior tutela ambientale e della salute, prevista dall’art. 193 TFUE.
Questo significa che la distribuzione dei contenuti della competenza è retta dal principio di sussidiarietà fra UE e Stati, ma fatta salva comunque la facoltà statale di integrare in melius i contenuti del proprio potere di mitigazione, alla luce appunto dell’art. 193 TFUE.
2. I limiti al potere di mitigazione climatica dopo le sentenze CEDU del 9 aprile 2024
Tuttavia, dopo le due sentenze della Corte europea dei diritti umani del 9 aprile 2024 “Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera” (53600/20) e “Duarte Agostinho et al. vs. Portogallo et al.” (39371/20), la materia del potere statale di mitigazione climatica statale è stata acquisita anche all’interno dell’art. 8 CEDU.
In particolare, la Corte di Strasburgo ha stabilito che tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, indipendentemente se aderenti o meno alla UE, sono tenuti a rispettare una serie di “requisiti necessari” di esercizio del potere di mitigazione climatica, che fungono da limite esterno al loro margine di apprezzamento, in quanto servono a garantire la tutela intertemporale e intergenerazionale dei diritti umani presidiati dall’art. 8 CEDU, ai fini dell’effettivo rispetto degli obiettivi di cui agli artt. 2 UNFCCC e 2 Accordo di Parigi.
Il contenuto di questi “requisiti necessari” è descritto e scandito nei §§ 441-444, 543, 550 e 571 della sentenza “Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera”.
Infatti, nel § 441 si legge che «ogni Stato ha la propria quota di responsabilità nell’adottare misure per affrontare il cambiamento climatico e che l’adozione di tali misure è determinata dalle capacità dello Stato stesso piuttosto che da un’azione (o omissione) specifica di un altro Stato», mentre, nel § 444, si specifica che il «test rilevante» [della capacità dello Stato nella sua mitigazione climatica] è quello di «avere una reale prospettiva di alterare l’esito o di mitigare il danno [del cambiamento climatico antropogenico]». Collegato al § 444 è poi il § 571, dove si riconosce che l’IPCC «ha sottolineato l’importanza dei bilanci del carbonio» (ossia il Carbon Budget residuo), nel quadro del «principio delle responsabilità comuni ma differenziate ai sensi dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi», che «richiede agli Stati di agire sulla base dell’equità e in conformità con le rispettive capacità». Infine, nel § 550 si elencano i cinque “requisiti” necessari affinché quanto indicato nei §§ 441-444 e § 571 sia concretamente realizzato. Eccoli elencati: «[Spetta a ciascuno Stato individuare]
(a) il carbon budget residuo, o un altro metodo equivalente di quantificazione delle future emissioni di gas serra, in linea con l’obiettivo generale degli impegni nazionali e/o globali di mitigazione dei cambiamenti climatici;
(b) [gli] obiettivi e percorsi intermedi di riduzione delle emissioni di gas serra (per settore o altre metodologie pertinenti) che siano ritenuti in grado, in linea di principio, di soddisfare gli obiettivi nazionali complessivi di riduzione dei gas serra entro i tempi stabiliti nelle politiche nazionali;
(c) [le] prove che dimostrino che si stanno debitamente rispettando, o si è in procinto rispettare, gli obiettivi di riduzione dei gas serra pertinenti;
(d) l’aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei gas serra pertinenti con la dovuta diligenza e sulla base delle migliori prove disponibili;
(e) [la descrizione delle azioni per intervenire] tempestivamente, in modo appropriato e coerente nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle misure pertinenti».
Tutto questo, conclude il giudice europeo, limita dall’esterno il “margine di apprezzamento” dello Stato membro, a garanzia appunto dell’effettività intertemporale e intergenerazionale dell’art. 8 CEDU.
La Corte, inoltre, ha specificato che tutte «le autorità nazionali competenti, siano esse a livello legislativo, esecutivo o giudiziario», devono tenere «in debita considerazione» tali “requisiti necessari”, affinché lo Stato operi «entro il suo margine di apprezzamento».
Pertanto, questo compito di accertamento e verifica spetta anche al giudice nazionale, come chiarito pure dalla sentenza “Duarte Agostinho et al. vs. Portogallo et al.”.
La tesi che tale vincolo non sussisterebbe per l’Italia, in nome della separazione dei poteri, risulta priva di fondamento costituzionale[ii].
Al contrario, il potere di mitigazione climatica dello Stato aderente alla CEDU conosce un limite assoluto, riguardante i “requisiti necessari” indicati dalla Corte, finalizzato – tale limite - a garantire nel tempo l’art. 8 CEDU e l’effettivo conseguimento degli obiettivi dell’art. 2 UNFCCC e dell’art. 2 Accordo di Parigi.
In più, questo limite assoluto è pienamente conforme con la Costituzione italiana (nello specifico, con gli artt. 9, 32 e 41 Cost.), come risulta dal quadro di confronto sinottico, elaborato dall’Osservatorio di comparazione interformanti sul contenzioso climatico italiano[iii].
3. Il doppio limite del potere di mitigazione climatica dello Stato tra diritto UE e CEDU
Per gli Stati aderenti alla Consiglio d’Europa (CoE) e alla CEDU, ma contemporaneamente membri della UE, i limiti ai sensi dell’art. 8 CEDU si aggiungono ai limiti di competenza, fissati dagli artt. 191 e 193 TFUE, con la puntualizzazione, però, che, mentre i limiti CEDU sono assoluti perché posti come vincoli esterni al margine di apprezzamento dello Stato, in nome per l’appunto dei diritti umani, quelli della UE sono invece relativi, perché riguardanti non i vincoli esterni bensì i contenuti interni delle competenze concorrenti, una volta esercitate secondo sussidiarietà e integrazione in melius ex art. 193 TFUE.
Il quadro che ne consegue può essere così di seguito rappresentato.
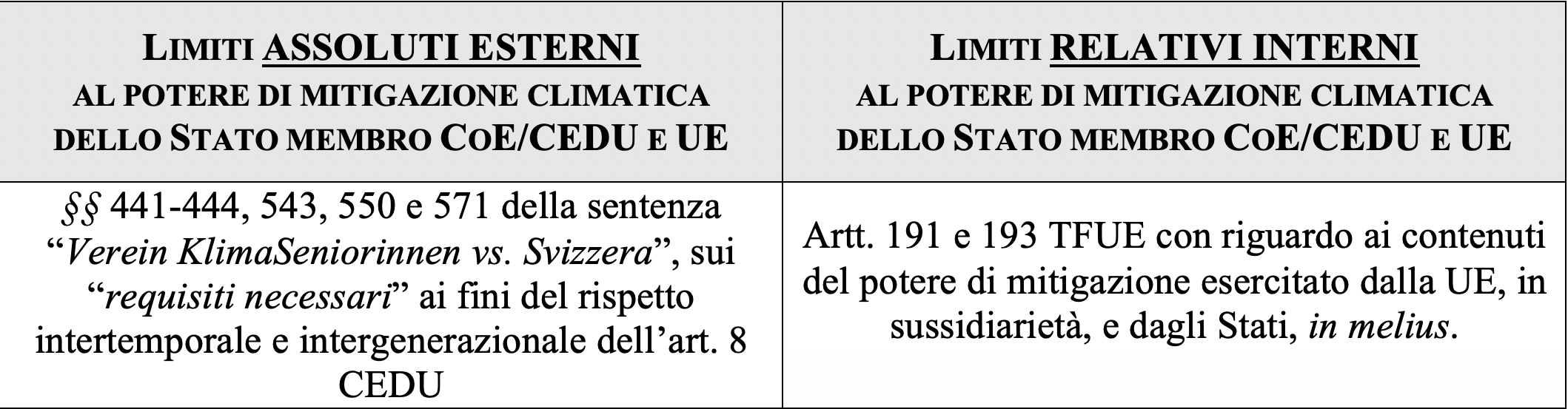
4. La competenza della UE in merito al doppio limite esistente
La coesistenza di questo doppio limite (assoluto esterno e relativo interno) riguarda solo ed esclusivamente gli Stati aderenti al CoE che sono anche membri della UE.
Su siffatta coesistenza, la UE non ha alcun titolo a intervenire, per diverse ragioni:
- perché la UE non è membro della CEDU e dunque non soggiace a “requisiti necessari” sui limiti assoluti del margine di apprezzamento, indicati dalla Corte di Strasburgo;
- perché qualsiasi intervento della UE su tali limiti assoluti CEDU si porrebbe in contrasto con l’art. 4 n. 2 TUE, in merito al rispetto, da parte dalla UE, delle identità nazionali degli Stati e, con esse, dalla loro sovrana sottoposizione ai vincoli di tutela dei diritti, indicati dalla Corte di Strasburgo;
- perché qualsiasi intervento della UE violerebbe anche l’art. 6 n. 2 TUE, attivando una competenza europea non prevista dai Trattati sui poteri statali di mitigazione climatica, per di più in assenza di adesione unionale alla CEDU;
- perché la tutela dei diritti umani (anche se di matrice convenzionale) funge comunque da controlimite a qualsiasi potere UE;
- perché, infine, l’art. 193 TFUE consente allo Stato membro di fare comunque meglio della UE e il rispetto dei limiti assoluti a tutela dell’art. 8 CEDU è indubbiamente un’integrazione in melius del potere statale di mitigazione climatica.
5. Conclusione 1: il rispetto dei requisiti CEDU non viola il diritto UE
Si deve, allora, concludere che l’Italia, in quanto Stato membro sia della UE che del CoE,
- soggiace ai limiti assoluti esterni della CEDU,
- è dunque tenuta a rispettare i “requisiti necessari”, scanditi dalla Corte di Strasburgo nei §§ 441-444, 543, 550 e 571 della sentenza “Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera”,
- indipendentemente dai contenuti delle competenze esercitate dalla UE, che operano, invece, come limiti relativi interni,
- nei cui confronti l’Italia è comunque abilitata a un potere di mitigazione climatica in melius, nei termini dell’art. 193 TFUE,
- sicché il rispetto, da parte dell’Italia, dei “requisiti necessari” CEDU del potere statale di mitigazione climatica non viola il diritto UE.
Del resto, qualsiasi tentativo mirante a ridimensionare i vincoli CEDU, anche in nome del diritto UE e magari al fine di eludere o disapplicare i “requisiti necessari” dei §§ 441-444, 543, 550 e 571 della sentenza “Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera”, dovrebbe comunque passare al vaglio della Corte costituzionale, eccependo ipotesi di violazione di un qualche parametro costituzionale.
Il che, sia detto per inciso, apparirebbe assai improbabile e incomprensibile dopo la riforma degli artt. 9 e 41 Cost. e l’interpretazione “monito”, su di essi fornita dalla Consulta nella sentenza n. 105/2024, dove si parla di nuovi “vincoli” e “limiti” al potere pubblico e privato, in nome dell’interesse delle generazioni future[iv].
6. Conclusione 2: i requisiti CEDU garantiscono anche il neminem laedere
Al contrario, i limiti assoluti esterni al “margine di apprezzamento” degli Stati membri del CoE risultano funzionali alla persistenza del principio del neminem laedere, anch’esso limite esterno a qualsiasi potere pubblico e privato secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana e come richiesto persino dal Green Deal europeo che sul “non nuocere” fonda la propria normativa di mitigazione climatica conforme agli artt. 191 e 193 TFUE[v].
Valgano, in merito, i seguenti riscontri costituzionali italiani.
La Consulta, non da ieri, ha osservato che l’art. 2043 Cod. civ. risulta funzionare da «norma in bianco» che, da un lato, espressamente e chiaramente indica l’obbligazione risarcitoria, conseguente al fatto doloso o colposo, ma, dall’altro, non individua i beni giuridici la cui lesione è vietata, essendo l’illiceità oggettiva del fatto, che condiziona il sorgere della detta obbligazione, indicata unicamente attraverso l’“ingiustizia” del danno prodotto dall’illecito. La disposizione codicistica, di conseguenza, «contiene una norma giuridica secondaria», ha chiarito la Corte (sent. n. 184/1986, rimasta da allora immutata[vi]) la cui applicazione «presuppone l’esistenza di una norma giuridica primaria», da rinvenire nelle disposizioni costituzionali, a partire dall’art. 32 Cost. ma anche, in virtù dell’art. 117 comma 1 Cost., anche nella CEDU e, per il caso specifico della mitigazione climatica, nell’art. 8 CEDU.
Ecco, allora, che i “requisiti necessari”, scanditi dalla Corte di Strasburgo nei §§ 441-444, 543, 550 e 571 della sentenza “Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera”, altro non rappresentano che il catalogo degli elementi di integrazione dell’art. 2043 Cod. civ. in ordine ai beni giuridici (ex art. 8 CEDU) la cui lesione è vietata nelle misure statali di mitigazione climatica.
1 Cfr. M. Cunha Verciano, La discrezionalità del potere nella lotta al cambiamento climatico, in www.federalismi.it, n. 28/2023.
2 Da ultimo, su questa tesi ma ignorando i citati §§ 441-444, 543, 550 e 571 della sentenza “Verein KlimaSeniorinnen vs. Svizzera”, cfr. G. Scarselli, Contenzioso climatico e giurisdizione, in questa Rivista, 26 novembre 2024.
3 Cfr. Comparazione interformanti tra la sentenza del caso "Giudizio Universale", le decisioni "climatiche" CEDU e ITLOS del 2024 e la giurisprudenza costituzionale (Rapporto 1/2024), in https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/osservatorio-e-bibliografia/.
4 Su questo “monito” della sentenza costituzionale n. 105/2024, cfr. i commenti del 25 giugno 2024, nell’ “Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale” (OCA) della rivista DPCE online, rispettivamente di M. Carducci e di G. Giorgini Pignatiello, nonché, da ultimo, G. Vivoli, L’eterna provvisorietà di misure straordinarie è (ed era) incostituzionale, in AmbienteDiritto, 4/2024.
5 Cfr. il Considerando n. 9 del Regolamento UE n. 2021/1119.
6 Cfr. M. Carducci, I sei contenuti di tutela del diritto alla salute e l’inabrogabilità dell’obbligazione riparatoria e della risarcibilità per via giurisdizionale, secondo la Corte costituzionale (2024), in https://www.contenziosoclimaticoitaliano.it/la-dottrina-giuridica/m-z/ (sub voce: Neminem laedere e art. 2043 Cod. civ. (nella giurisprudenza costituzionale).
Questo contributo è frutto del lavoro di sintesi, svolto per Contenzioso climatico italiano, Osservatorio di comparazione interformanti a cura degli Studenti magistrali di Diritto comparato dei cambiamenti climatici dell'Università del Salento, e messo a disposizione alle lettrici e ai lettori di Questa Rivista. Si veda anche Istituzione dell’Osservatorio di comparazione interformanti sul contenzioso climatico italiano.
Foto via Wikimedia Commons.
La separazione delle carriere: repetita iuvant!
di Armando Spataro
Sommario: 1. L’incubo che non scompare - 2. Le balle a sostegno dell’impostura: i giudici appiattiti sulle tesi dei p.m., la “riforma-Falcone”, il giusto processo ex art.111 Cost., il sorteggio dei membri togati dei due CSM e dell’Alta Corte Disciplinare - 3. Paulo Sergio Pinto de Albuquerque, un grande giurista e la sua deludente intervista - 4. La diversità di storia e cultura giuridica dei Paesi europei; 5. Ovunque esiste la separazione delle carriere, il PM dipende dall’Esecutivo (tranne che in Portogallo) - 6. La situazione in Portogallo - 7. Le istituzioni europee guardano al sistema italiano come un modello da realizzare ovunque: le “passerelle” dalla funzione di PM quella dei giudici, e viceversa, fanno crescere le garanzie dei cittadini - 8. Il silenzio colpevole dei “separatisti” - 9. L’impegno contro questa riforma? Testimonianza di dignità e coerenza.
1. L’incubo che non scompare
Il 16 gennaio la Camera dei Deputati ha approvato in prima deliberazione il Disegno di Legge Costituzionale presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Meloni) e dal Ministro della Giustizia Nordio, intitolato “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. La proposta ha per principale oggetto la separazione delle carriere dei magistrati: l’approvazione è avvenuta con 174 voti favorevoli, 92 contrari e 5 astenuti, dunque con una percentuale di adesioni che non supera i due terzi dei 400 componenti elettivi della Camera e che difficilmente potrà mutare nelle prossime altre tre letture e votazioni, anche presso il Senato, composto da 200 componenti elettivi. In sostanza, pur potendosi dare per scontata la approvazione finale della proposta di separazione delle carriere dei magistrati e delle previsioni ad essa connesse, bisognerà sin d’ora prepararsi ad un deciso impegno in sede referendaria, ai sensi dell’art. 138 Costituzione, perché questa orrida proposta finisca su un binario morto.
Dopo la ricordata prima approvazione del 16 gennaio, si sono sprecati i commenti dai toni trionfalistici di Nordio e di altri politici appartenenti alla maggioranza di governo, anche in onore e ricordo di Silvio Berlusconi! Ma chi la pensa in senso opposto non ha risparmiato i doverosi toni allarmistici.
Chi scrive, interviene da anni sul tema della separazione delle carriere per sottolinearne la sua natura di “impostura” anacronistica e irrisoria: in Treccani si spiega che con il termine impostura si intende la tecnica di “inganno e menzogna per trarne profitto”.
Vorrei provare allora ad intervenire su argomenti che i sedicenti giuristi favorevoli alla separazione delle carriere – che d’ora in avanti chiamerò “separatisti” – hanno ignorato (o “ignorano”), evitando anche di rispondere a precisi stimoli di chi la pensa diversamente da loro (gli “unionisti”).
2. Le balle a sostegno dell’impostura: i giudici appiattiti sulle tesi dei p.m., la “riforma-Falcone”, il giusto processo ex art.111 Cost., il sorteggio dei membri togati dei due CSM e dell’Alta Corte Disciplinare.
Non parliamo dunque del fatto che l’appartenenza alla stessa “famiglia” determinerebbe contiguità tra giudici e p.m., condizionando i primi e determinandone l’“appiattimento” sulle tesi dei p.m. e la predisposizione a prestare maggior attenzione alle richieste dell’accusa. Basta ricordare in proposito le parole di Francesco Saverio Borrelli [[1]], secondo cui il sospetto artificioso di “gratuita proclività” del giudice a simpatizzare per le tesi dell’accusatore è da respingere, in quanto fondato su “diffidenze plebee che scorgono ovunque collusioni”.
È anche falso che la separazione delle carriere favorirebbe la maggiore efficacia dell’azione del P.M., tanto che anche Giovanni Falcone avrebbe auspicato una legge in proposito: un noto giornalista è arrivato a proporre che questa legge in fieri sia definita “Riforma Falcone” ed in molti poi, a favore della loro tesi, citano alcuni passaggi di un intervento di Falcone del 1989. Ma è una citazione fuorviante ed un’interpretazione errata di frasi estrapolate da un testo ben più ampio, la cui lettura completa dimostra che Falcone teorizzava la necessità di una più accentuata specializzazione del P.M. nella direzione della polizia giudiziaria, rispetto a quanto richiesto nel regime vigente prima del codice di rito del 1988. Lo hanno confermato la scrittrice giornalista Marcelle Padovani, che con il collega scrisse un libro importante, nonché magistrati come Ayala, Grasso e Natoli che con Falcone avevano a lungo collaborato a Palermo. In ogni caso, la più sicura conferma della sua contrarietà alla separazione delle carriere la diede Falcone stesso chiedendo e ottenendo più volte di passare dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa: da giudice istruttore era anche diventato procuratore della Repubblica aggiunto, funzione che esercitava quando fu chiamato da Martelli al ministero. E analoghi mutamenti di funzione hanno chiesto e ottenuto altre vittime di mafia e terrorismo come Paolo Borsellino e Guido Galli, nonché altri magistrati cui tanto deve il nostro paese come il citato Francesco Saverio Borrelli.
Né potrebbero trarsi argomenti a sostegno della separazione dal testo dell’art. 111 Cost.
La parità delle parti, di cui parla il secondo comma, non si gioca sul piano istituzionale: l’avvocato è un privato professionista vincolato dal solo mandato a difendere, che lo obbliga a ricercare l’assoluzione o, comunque, l’esito più conveniente per il proprio assistito, che lo retribuisce per questo, ed è figura diversa dal P.M., che è un’autorità giudiziaria indipendente, non riducibile al ruolo di “avvocato della polizia” definizione tanto cara al Ministro Nordio. Non a caso il PM è obbligato a svolgere indagini anche a favore dell’imputato: egli, infatti, non agisce sempre in vista della condanna ma dell’accertamento della verità. E questo è un carattere essenziale della sua attività professionale che lo accomunerà comunque al giudice, anche nella malaugurata ipotesi di entrata in vigore della separazione: un carattere che si chiama “cultura giurisdizionale”, definizione ritenuta dai separatisti un mero slogan.
A questo punto, però, non voglio entrare in contraddizione con la dichiarata volontà di approfondire argomenti diversi da quelli quotidianamente oggetto di dispute giornalistiche e di confronti urlati nei talk show serali, come i dati numerici relativi al tramutamento di funzione i quali dimostrano che di fatto non vi è bisogno di mutamenti ulteriori della disciplina o come l’importanza di un’unica formazione dei magistrati e un unico CSM che ne regoli ed amministri le carriere.
Per non parlare della vergogna (non riesco a definirla diversamente) del sorteggio previsto per designare i membri togati dell’altra Corte Disciplinare e dei due CSM, così evitare gli effetti critici della esistenza dell’ANM e delle sue correnti : qualcuno, anzi, vorrebbe sciogliere l’una e le altre per contrastare indicibili accordi, comunque ben diversi – aggiunge chi scrive – da quelli che in questi giorni stanno caratterizzando l’individuazione di quattro giudici da eleggere quali componenti della Corte Costituzionale: ma nessuno ne parla!
3. Paulo Sergio Pinto de Albuquerque, un grande giurista e la sua deludente intervista
Parliamo allora di altro, parliamo della situazione ordinamentale degli altri Stati europei e degli Stati Uniti.
Lo spunto per tornare su questo quasi inesplorato (o mal esplorato) argomento è nato da una intervista rilasciata dal prof. Paulo S. Pinto de Albuquerque, pubblicata l’11 gennaio 2024 su "Il Riformista PQM", di cui è direttore responsabile l'ex presidente della Unione Camere Penali, avv. Gian Domenico Caiazza, uno dei più duri “separatisti” a me noti. Paulo Sergio Pinto de Albuquerque è professore portoghese ordinario di Diritto Penale e Diritti Umani all’Università di Lisbona, con almeno 40 anni di esperienza come giudice nazionale e internazionale, avvocato e attivista per i diritti umani.
È stato esperto del Gruppo di Stati contro la Corruzione (Greco) nel biennio 2009/2010 e giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dal 2011 al 2020. Personalmente ho avuto l'onore di contribuire con un mio intervento ad un volume edito nel 2021, “I diritti Umani in una prospettiva Europea – Opinioni dissenzienti e concorrenti, 2016-2020”, di Paulo Sergio Pinto de Albuquerque, a cura di Andrea Saccucci, con prefazione di Raffaele Sabato e Gilberto Feltri.
Per tutto questo, rimasi profondamente deluso nel leggere l'intervista in cui la proposta di legge Meloni-Nordio sulla separazione delle carriere viene da lui definita "eccellente" con ulteriori e plurimi elogi: «sono un sostenitore della separazione delle carriere, perché essa contribuisce in modo significativo alla piena realizzazione del principio accusatorio, della presunzione di innocenza e del giusto processo. Inoltre, la separazione delle carriere contribuisce anche alla valorizzazione della magistratura del Pubblico Ministero. In Portogallo, prima della separazione delle carriere, la carriera del Pubblico Ministero era una carriera preparatoria per la carriera giudiziaria. Questo comportava, tra l’altro, due conseguenze molto negative. Prima di tutto, la carriera del Pubblico Ministero veniva considerata una carriera di minor valore, il che diminuiva la rilevanza istituzionale e il prestigio sociale della carriera del Pubblico Ministero. In secondo luogo, la carriera preparatoria del magistrato del Ministero Pubblico creava tra i giudici un pregiudizio endemico favorevole all’accusa, il che danneggiava gravemente il principio accusatorio, la presunzione di innocenza e il giusto processo. Queste conseguenze negative sono state definitivamente eliminate dalla separazione delle carriere.»
Alla domanda sul rischio che la riforma italiana, modificando profondamente l’attuale quadro costituzionale e l’equilibrio tra i poteri dello Stato, potrebbe finire con l’incidere sulla indipendenza al potere giudiziario, riducendo le garanzie e i diritti di libertà dei cittadini, Paulo Sergio Pinto de Albuquerque affermava di non condividere queste preoccupazioni: «La separazione delle carriere rafforza l’indipendenza del potere giudiziario e aumenta le garanzie per i cittadini, come ho già spiegato nella risposta precedente. Questa è l’esperienza vissuta quotidianamente nei tribunali portoghesi».
In Portogallo – egli precisava – la separazione delle carriere non ha contribuito a una logica securitaria del Pubblico Ministero e tanto meno al suo allontanamento dalla “cultura della giurisdizione”, perché il Pubblico Ministero, nel quadro costituzionale portoghese, è una magistratura indipendente dal governo. La competenza di rappresentanza dello Stato, in particolare nei tribunali civili e nei tribunali amministrativi e fiscali, è strettamente legata alla difesa della legalità democratica, che è anche attribuita dalla legge al Pubblico Ministero. «Perché, anche in questi casi, il Pubblico Ministero agisce in modo imparziale e indipendente, non comandato da alcun organo specifico dell’apparato statale. Secondo la Costituzione portoghese, il Pubblico Ministero gode di autonomia rispetto agli altri organi del potere centrale, regionale e locale. L’autonomia del Pubblico Ministero si caratterizza per il suo vincolo a criteri di legalità e obiettività e per la soggezione esclusiva dei magistrati del Pubblico Ministero alle direttive, ordini e istruzioni previsti nel loro statuto, nell’ambito della loro gerarchia interna. È importante sottolineare che, nel processo penale, il Pubblico Ministero deve esercitare l’azione penale orientato dal principio di legalità, indagando il caso sia a carico che a discarico».
Tutto ciò perché, a quasi 50 anni dalla riforma che ha istituito la separazione organica tra la carriera dei giudici e quella del Pubblico Ministero, «i magistrati del Pubblico Ministero in Portogallo non si sentono sottoposti al controllo del potere esecutivo, né esprimono pubblicamente alcun disagio a questo proposito. La separazione delle carriere è stata una conquista fondamentale della democrazia portoghese, che ha avuto pieno successo nella pratica. Su questo sono d’accordo i giudici, i magistrati del Pubblico Ministero, gli avvocati e, in generale, la società civile».
Quest’ultimo giudizio, come si dirà appresso, non è affatto condiviso in Portogallo e comunque confesso che quella intervista, nell’ovvio rispetto del pensiero di Paulo Sergio Pinto de Albuquerque, appena letta, mi lasciò davvero senza parole: la giornata era iniziata male, ma fortunatamente scrissi al grande giurista, esponendogli le mie perplessità e determinando il suo apprezzamento per la correttezza del mio approccio.
4. La diversità di storia e cultura giuridica dei Paesi europei
Sono molti gli argomenti di segno opposto a quelli usati da Paulo Sergio Pinto de Albuquerque che si potrebbero qui precisare (e di cui – come ho detto – da molti anni parlo e scrivo), ma francamente preferisco evitare limitandomi a precisare quanto sia errato ritenere che il funzionamento (ammesso che di questo si tratti in Portogallo) di scelte ordinamentali in un Paese ne legittimi l'adozione anche in altri Stati. Non possono trascurarsi, infatti, le diverse storie e differenze di cultura giuridica e degli ordinamenti giudiziari europei nei quali – in caso di pm separato dai giudici – esiste comunque la figura del Giudice Istruttore (titolare indipendente delle indagini), da noi cancellata da vari decenni.
È gratuito affermare, dunque, che la separazione delle carriere si impone anche in Italia poiché si tratta dell’assetto ordinamentale esistente o nettamente prevalente negli ordinamenti degli altri Stati a democrazia avanzata, Stati Uniti inclusi, senza che ciò comporti dipendenza del PM dal potere esecutivo e il condizionamento delle indagini ([2]).
Questa è un’affermazione gratuita che, in modo stupefacente, viene utilizzata anche da autorevoli commentatori e da giuristi favorevoli alla separazione, i quali – tuttavia – non possono non conoscerne la natura di mero slogan, né ignorare quanto essa sia priva totalmente di fondamento. Ma purtroppo, si tratta di una delle tante affermazioni sistematicamente utilizzate “contro” la magistratura che hanno determinato, grazie a martellanti campagne di opinione, convinzioni tanto radicate quanto errate.
Ed aggiungiamo che è un’affermazione anche incoerente e contraddittoria rispetto a quanto si legge nella relazione di accompagnamento al DDL costituzionale Nordio-Meloni: «Sui temi della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, della esistenza e regolamentazione di Consigli Superiori, nonché sulla materia disciplinare, le soluzioni adottate da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea sono variegate e non emergono linee prevalenti. Sono assai varie anche le scelte normative dei diversi Stat, risultando la materia oggetto di disciplina articolata a livello nazionale con interazione di disposizioni costituzionali, ordinamentali e di rito processuale».
È sufficiente, infatti, un’analisi anche superficiale della situazione internazionale o degli ordinamenti degli Stati più evoluti per verificare che la realtà è abbastanza diversa da quella che spesso sentiamo raccontare in Italia. È chiaro, peraltro, che un confronto di questo tipo non è sempre utile se solo si considera che spesso esiste una radicale differenza tra gli ordinamenti presi in considerazione, frutto di tradizioni giuridiche ed evoluzioni storiche peculiari di ciascun paese. Basti pensare al fatto che in Gran Bretagna manca del tutto un pubblico ministero come noi lo intendiamo.
Non si comprende, dunque, come il Ministro Nordio possa avere dichiarato che «nei paesi anglosassoni le carriere sono separate e la magistratura non si sente umiliata» [[3]].
Tra l’altro, il prof. Alessandro Pizzorusso, a proposito di indipendenza del pubblico ministero, affermava l’irrilevanza del dato numerico relativo ai paesi che seguono l’una o l’altra impostazione: «se così non fosse, quando l’Inghilterra era l’unico paese in cui esisteva la democrazia parlamentare, si sarebbe potuto invocare l’argomento comparatistico per dimostrare l’opportunità di instaurare la monarchia assoluta, che era la forma allora assolutamente prevalente». Però possono egualmente trarsi, dalla comparazione ordinamentale, degli spunti generali per la questione che qui interessa, utili a verificare che, nel panorama internazionale, gli ordinamenti che conoscono la separazione delle carriere non costituiscono affatto la maggioranza. Inoltre – ed il dato è molto significativo ai fini che qui interessano – all’estero accade spesso che chi abbia maturato esperienze professionali di pubblico ministero acquisisce una sorta di titolo preferenziale per accedere alla carriera giudicante: dunque, quell’esperienza viene considerata molto positivamente.
5.Ovunque esiste la separazione delle carriere, il PM dipende dall’Esecutivo (tranne che in Portogallo)
Ma, soprattutto, non può non considerarsi che, ove esiste la separazione delle carriere, questa porta con sé la dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo, una conseguenza assolutamente preoccupante, pur se non sgradita ad alcuni accademici come il prof. G. Di Federico [[4]] e persino all’avv. Gian Domenico Caiazza, già presidente della Unione Camere Penali, che nel corso di un confronto con lo scrivente [[5]] ha manifestato la propria indifferenza a tale ipotesi.
Ecco, schematicamente, con inevitabile sommarietà, la realtà di alcuni Stati europei (all’Italia geograficamente più vicini) e degli Stati Uniti, cioè di Stati i cui livelli di democrazia, pur nella diversità ordinamentale, sono sicuramente omogenei rispetto ai nostri:
· in Austria, il PM è organizzato come autorità amministrativa, è gerarchicamente strutturato ed è nominato dal Ministro di Giustizia, da cui dipende. Esiste interscambiabilità dei ruoli;
· in Belgio, il PM è nominato dal Re ed il passaggio da una carriera all’altra può avvenire solo per decisione dell’esecutivo, da cui, comunque, riceve direttive di carattere generale; anche il passaggio da una carriera all’altro può avvenire, per i PM, soltanto per decisione dell’esecutivo;
· in Germania chi esercita la funzione requirente riveste uno status di funzionario statale dipendente, nominato dall’esecutivo ed ha garanzie diminuite rispetto ai giudici; le carriere di giudici e dei pubblici ministeri, inoltre, sono separate, ma l’interscambio è comunque possibile, pur se non è frequente e, per lo più, avviene in un’unica direzione (da PM a Giudice). Lo statuto subordinato del PM ha portato la Corte di Giustizia UE ad affermare che i PM tedeschi, in quanto non totalmente indipendenti perché soggetti al potere di istruzione del ministro, non possono essere qualificati come autorità giudiziaria ai fini della possibilità di emettere Mandati di Arresto Europei (casi riuniti C-508/18 e C-82/19 PPU). Insomma, certe scelte si pagano.
· in Francia, la carriera è unica, è possibile passare da una funzione all’altra, ma il pubblico ministero, pur inserito nell’ordinamento giudiziario, dipende dall’esecutivo, è sottoposto a forme di controllo di tipo gerarchico-burocratico da parte del Ministro della Giustizia, ha un limitato controllo della polizia giudiziaria. Peraltro, i problemi che derivano dalla collocazione del p.m. sono oggi, in quel paese, all’attenzione della pubblica opinione e si è avviata una discussione sulla riforma del P.M., anche alla luce di due durissime condanne della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Moulin c. Francia del 2010 e Vasis c. Francia del 2013). Pur tra resistenze politiche manifestatesi dopo incriminazioni “eccellenti” avvenute anche in un recente passato, si tende a conferire al P.M. maggiore autonomia dall’Esecutivo.
Nel novembre 2013, ad esempio, è stato reso noto il rapporto della Commissione Ministeriale presieduta dal Procuratore Generale Onorario presso la Corte di Cassazione, Jean-Luis Nadal e composta anche da giudici, presidenti di Corte d’Appello e di Tribunale. Orbene, il rapporto, premessa la necessità di garantire l’indipendenza del Pubblico Ministero, ha sottolineato, innanzitutto, proprio la necessaria priorità della unificazione effettiva delle carriere dei giudici e dei P.M. (“Proposta n. 1: Iscrivere nella Costituzione il principio dell’unità della magistratura”), eliminando ogni ambiguità ed affidandone la completa gestione al Consiglio Superiore della Magistratura, senza interferenze dell’esecutivo. Ciò al fine di «garantire ai cittadini una giustizia indipendente, uguale per tutti e liberata da ogni sospetto». Dal luglio 2013, comunque, a seguito di una legge voluta dal Ministro della Giustizia pro tempore Christiane Taubira (poi dimessasi perché contraria alla “costituzionalizzazione dell’emergenza” antiterroristica), è vietato al Ministro della Giustizia di indirizzare ai pubblici ministeri linee guida in relazione a specifici casi concreti (ora, può solo formulare linee generali).È stato intanto presentato un progetto di riforma che prevede di rafforzare i poteri del CSM nella nomina dei procuratori (che allo stato è totalmente nelle mani dell’esecutivo), ma esso langue nel Parlamento francese;
· in Spagna, le carriere sono costituzionalmente separate senza possibilità di interscambio. Esiste una certa dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo;
· in Inghilterra e Galles, come si è già detto, non esiste il pubblico ministero nelle forme da noi tradizionalmente conosciute, ma il Crown Prosecution Service che consiglia la Polizia la quale ha da sempre l’iniziativa penale e può nominare un avvocato da cui far rappresentare le sue ragioni. Non è dunque corretto neppure quanto affermato dall’avv. Francesco Petrelli (Il Dubbio, 30 agosto 2023), secondo cui anche in Gran Bretagna il PM sarebbe separato dal Giudice;
· in Svizzera le carriere sono separate e non vi si accede mediante concorso, ma a seguito di elezione. L’esistenza di un ordinamento federale e di diversi ordinamenti statali e, dunque, di regole molto diverse tra loro, impedisce di approfondire il discorso in questa sede. Non è prevista alcuna forma di passaggio dalla carriera requirente e quella giudicante e viceversa;
· in Olanda, previa frequentazione di corsi di aggiornamento, è possibile passare dalla magistratura giudicante all’ufficio del p.m. (e viceversa), ma il PM è sottoposto alle direttive dell’esecutivo per l’esercizio discrezionale dell’azione penale;
· in Polonia, la riforma della Prokuratura del 2016 ha interrotto e invertito un percorso che era in atto dal 2009 e mirava ad un ufficio indipendente del PM: il ruolo del Ministro della Giustizia è stato riunificato con quello del Procuratore generale, in modo da accentrare nella stessa persona maggiori poteri di indagine ed intervento diretto in casi specifici pendenti presso le giurisdizioni. Una concentrazione di potere che ha comportato l’eliminazione di qualsiasi forma di indipendenza interna per i singoli procuratori. Ne ha parlato Maria Rosaria Guglielmi, in un importante articolo [[6]] in cui sono citate le osservazioni della Commissione di Venezia, le decisioni della Corte Edu e i rapporti della Commissione Europea sulle condizioni di dipendenza dal potere politico dei pubblici ministeri anche in Bulgaria e Romania, in un contesto di enorme pressione sui giudici. In Polonia, peraltro, il 19 gennaio 2024, il governo Tusk ha presentato una proposta legislativa per separare le funzioni del Procuratore Generale da quelle del Ministro della Giustizia, che invece erano state riunite sotto il precedente governo (con effetti evidenti sull'indipendenza): ciò fa parte dello sforzo di rimettere la Polonia sui binari dello Stato di diritto;
· l’ordinamento statunitense, pur se notoriamente molto diverso dal nostro, permette comunque riflessioni interessanti sul tema in esame: si divide in un sistema di giustizia federale, ove predomina la nomina da parte del Presidente degli Stati Uniti, ed un sistema di giustizia statale ove predomina il sistema elettorale. Orbene, pur in questa situazione di radicale differenza rispetto al nostro sistema, è possibile verificare la esistenza di una interscambiabilità tra i ruoli di giudici e pubblici ministeri che coinvolge anche l’avvocatura, dalla quale, come si sa, spesso provengono i pubblici ministeri e i giudici
Dunque, una riflessione può trarsi dall’analisi, pur sommaria, del panorama internazionale: ovunque la carriera del PM sia separata da quella del giudice, non solo il PM stesso dipende dall’esecutivo, ma esiste un giudice istruttore indipendente. Così è in Francia e Spagna ove il ruolo del pubblico ministero italiano è esercitato (non senza qualche occasione di polemica con i pubblici ministeri) dal giudice istruttore, figura da tempo soppressa nel nostro sistema. Evidentemente anche in quegli ordinamenti vi è necessità di un organo investigativo che sia totalmente indipendente dall’esecutivo.
6. La situazione in Portogallo
A questo punto, una situazione particolare che merita qualche precisazione è proprio quella del Portogallo (cui ha fatto riferimento nella citata intervista Paulo Sergio Pinto de Albuquerque) ove, sin dalla “Rivoluzione dei garofani” (1974), vige un sistema di separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti, senza sottoposizione di questi ultimi al potere esecutivo. Orbene, questo sistema ha determinato esattamente, nel corso della sua pluridecennale applicazione, quel progressivo affievolimento della cultura giurisdizionale dei p.m., che è l’oggetto delle preoccupazioni della magistratura italiana. Ne ha parlato spesso, anche in Italia, un esperto magistrato portoghese, Antonio Cluny, dirigente di Medel, il quale ha spiegato che attorno alla fine degli anni ’80 – inizio anni ’90, proprio quando l’ufficio del P.M. ha iniziato a sviluppare un’attività giudiziaria indipendente e capace di mettere in crisi la tradizionale impunità del potere economico e politico, si sono levate “autorevoli” voci a mettere in dubbio la legittimità democratica dell’ufficio del fiscal (il nostro P.M.), la diversa natura di quest’organo rispetto al potere giudiziario, la possibilità dei titolari di dare direttive alla polizia criminale e la stessa possibilità di iniziativa autonoma nel promovimento dell’azione penale. Il dibattito in questione – ha dichiarato il magistrato portoghese – aveva determinato il rischio di dar vita ad un modello di privatizzazione dell’indagine, del processo penale e della giustizia penale, auspicato dalla parte più conservatrice dell’opinione pubblica e da una parte dell’avvocatura. Ma la separazione delle carriere, pur in un regime di indipendenza dall’esecutivo del P.M., ha prodotto in Portogallo una divisione nella cultura professionale dei giudici e dei magistrati del fiscal. I pubblici ministeri hanno sviluppato una tendenza pratica a valorizzare eccessivamente gli obiettivi della sicurezza a detrimento dei valori della giustizia, mentre i giudici hanno sviluppato un’attitudine formalista che li conduce spesso ad assumere una posizione di semplici arbitri, anche quando i casi loro sottoposti esigerebbero un loro diretto intervento ed impegno per il raggiungimento degli obiettivi di giustizia. È stata vanificata, dunque, l’originaria intenzione del legislatore di rafforzare le garanzie dei cittadini di fronte alla legge e si è compromessa l’efficacia del processo penale. Parallelamente, infine, si è sviluppata e si è progressivamente acuita una tendenza al pregiudizio corporativo che ha innescato pericolose tensioni tra giudici, magistrati del fiscal e avvocati.
Ecco dimostrate, dunque, la perversione della specializzazione, la frammentazione dei mestieri, la perdita della visione globale e coordinata della giurisdizione. Ma sono argomenti e sforzi di approfondimento del tutto ignorati dai separatisti che continuiamo a sollecitare.
Del resto, sarebbe sufficiente un’analisi anche superficiale della situazione internazionale o degli ordinamenti degli Stati più evoluti per verificare che la realtà è abbastanza diversa da quella che spesso sentiamo descrivere in Italia.
7. Le istituzioni europee guardano al sistema italiano come un modello da realizzare ovunque: le “passerelle” dalla funzione di PM quella dei giudici, e viceversa, fanno crescere le garanzie dei cittadini
Ma il prof. Paulo Sergio Pinto del Albuquerque, e non solo lui, sembra poi trascurare altri importanti aspetti dei principi sovranazionali affermati in Europa:
· il primo è costituito dalla Raccomandazione REC (2000)19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sul “Ruolo del Pubblico Ministero nell’ordinamento penale”, adottata il 6 ottobre 2000, ove si prevede (al punto 18) che «…se l’ordinamento giuridico lo consente, gli Stati devono prendere provvedimenti concreti al fine di consentire ad una stessa persona di svolgere successivamente le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice, o viceversa. Tali cambiamenti di funzione possono intervenire solo su richiesta formale della persona interessata e nel rispetto delle garanzie».
Si afferma, inoltre, sempre nella Raccomandazione (parte “esposizione dei motivi”), che «La possibilità di “passerelle” tra le funzioni di giudice e quelle di Pubblico Ministero si basa sulla constatazione della complementarità dei mandati degli uni e degli altri, ma anche sulla similitudine delle garanzie che devono essere offerte in termini di qualifica, di competenza, di statuto. Ciò costituisce una garanzia anche per i membri dell’ufficio del pubblico ministero».
· È importante un altro documento, cioè il nuovo parere 9 (2014) del Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei destinato al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, approvato a Roma il 17 dicembre 2014, avente ad oggetto “Norme e principi europei concernenti il Pubblico Ministero”, contenente la cosiddetta “Carta di Roma” ed una nota esplicativa dettagliata dei principi contenuti nella Carta stessa.
In questo importante documento, pur non essendo mai formalmente citate la necessità di unicità delle carriere di pubblici ministeri e giudici e la possibilità del conseguente interscambio di funzioni (implicitamente auspicate), sono con forza ribaditi tutti i principi che in tal senso depongono e che vengono qui illustrati.
· Ma va anche ricordata, in ordine al tema di cui qui si discute, la creazione della Procura Europea (EPPO) che, con sede in Lussemburgo, è entrata in funzione dal 1°giugno 2021, almeno per il momento è competente esclusivamente ad indagare e perseguire gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti e secondo le regole processuali di questi ultimi.
Si tratta di un’importante istituzione sovranazionale, utile per far meglio funzionare la collaborazione internazionale tra gli stati europei, ma anche con Eurojust ed Europol.
Orbene, è significativo che, anche per rendere omogenee le legislazioni europee in tema di giustizia, la normativa che riguarda l’EPPO impegna gli Stati Europei a bandire specifici interpelli ai rispettivi magistrati per diventarne componenti, prevedendo che questi ultimi possono esercitare – negli stati di provenienza – funzioni sia giudicanti che inquirenti: nell’ultimo interpello bandito in Italia, ad esempio., alla luce anche della normativa interna, vi sono stati vari giudici che hanno chiesto di diventare pubblici ministeri nell’EPPO.
8.Il silenzio colpevole dei “separatisti”
Rivolgendomi ora ai “separatisti”, più che a Paulo Sergio Pinto de Albuquerque, viene naturale domandare: “ma le conoscete le prospettive del Consiglio d’Europa, tra i cui scopi vi è quello di promuovere la democrazia ed i diritti umani? E lo sapete come è costituita la Procura Europea e quali sono le sue competenze e quelle di altri organismi sovranazionali?”.
E loro? Rispondono con il silenzio, incapaci di confutare o spiegare.
Ha scritto ancora Maria Rosaria Guglielmi [[7]]: «Nello spazio comune europeo, la garanzia di tutela dei diritti e dello Stato di diritto comporta una riduzione degli spazi di manovra autonomi per interventi strutturali che possano compromettere la capacità dei sistemi giudiziari nazionali di operare nella loro funzione di effettiva garanzia. La prospettiva europea è dunque la cartina di tornasole per valutare l’impatto e le ricadute di tutte le modifiche che incidono sulla qualità ed efficacia della giurisdizione. Ciò che oggi l’Europa ci chiede è valutare ogni riforma istituzionale alla luce dei principi dello Stato di diritto, come insieme dei valori non negoziabili che sono a fondamento dell’Unione: fra questi, l’indipendenza dei sistemi giudiziari e degli attori della giurisdizione, che deve garantire l’effettiva tutela dei diritti e dei singoli contro ogni arbitrio del potere».
E, al di là dell’EPPO, negli ultimi anni sono stati compiuti in Europa altri passi concreti verso la realizzazione di un’effettiva rete di cooperazione giudiziaria nel campo criminale. Sono stati infatti costituiti organismi di polizia, amministrativi e giudiziari di indubbia importanza (Europol, Rete giudiziaria europea e relativi “punti di contatto” tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell’Unione, magistrati di collegamento, Olaf nel settore antifrode, Eurojust, Corte Penale internazionale permanente) ed è noto che si discute della creazione di un vero e proprio Corpus Juris che dovrebbe dar vita ad un diritto penale sostanziale minimo, comune a tutti gli Stati membri.
In questa prospettiva, come ha ricordato Ignazio Juan Patrone, già presidente di Medel, si pone in tutta la sua evidenza, non solo per l’Italia, il problema della garanzia di indipendenza che dovrà essere riconosciuta ai magistrati che, a vario livello, esercitano ed eserciteranno la funzione di P.M. in tutti gli organismi giudiziari sovranazionali ed internazionali che sono stati rapidamente (ed un po’tumultuosamente) creati nel corso del decennio scorso o di cui – in altri casi – ancora si discute.
Orbene, valutando il “senso di marcia” della evoluzione in atto, i poteri di ingerenza nelle funzioni giudiziarie di indagine che inevitabilmente saranno attribuiti agli organismi internazionali, i loro compiti di coordinamento, di impulso ed iniziativa rispetto agli organi inquirenti nazionali ed in settori criminali di indubbio ed oggettivo rilievo, appare evidente che la preservazione del nostro attuale assetto ordinamentale potrà garantire la presenza in quegli organismi di magistrati italiani indipendenti dall’esecutivo ed animati da quella cultura giurisdizionale di cui si è fin qui più volte parlato per dimostrare che non è certo una formula vuota.
9. L’impegno contro questa riforma? Testimonianza di dignità e coerenza
Una cultura e un modello costituzionale ed ordinamentale che, invece, nel nostro Paese viene ciclicamente messo in discussione – quasi mai per buone ragioni – nonostante gli eccezionali risultati conseguiti nel contrasto di terrorismo, mafia, corruzione ed ogni alto tipo di grave reato e che l’Italia, invidiata per questo nel contesto internazionale, dovrebbe invece preoccuparsi di diffondere nel resto di Europa.
Ci sarebbe molto altro di cui parlare a proposito dei rischi derivanti dalla separazione delle carriere: ad esempio, del possibile netto vanificarsi del principio di obbligatorietà dell’azione penale da parte del PM che rischierà di trasformarsi in un organo amministrativo, della bulimia legislativa che determina una pioggia di interventi di Governo e Parlamento in cui anche gli accademici hanno difficoltà ad orientarsi, delle politiche in tema di immigrazione e sicurezza, della discussione in corso sugli “scudi” da creare con legge per le forze dell’ordine alla faccia del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e di tanto altro ancora.
Mi fermo qui, scusandomi per la lunghezza di questo intervento: ma devo anche riprendere a studiare – con approfondimenti – i primi anni della carriera di Bob Dylan, visto che dal 23 gennaio dovremo preoccuparci di vedere nelle sale A complete unknown (parole tratte da una strofa di “Like a rolling stone”).
Perché ho citato Dylan? Per affidarvi un appello in nome della dignità. Eccolo:
Dignity
(versione originale completa in The best of Bob Dylan - Vol. 2 del 2000)
Il grasso la cerca in una lama d’acciaio,
il magro la cerca nel suo ultimo pasto,
un guscio d’uomo la cerca in un campo di cotone,
la dignità.
Il saggio la cerca in un filo d’erba,
il giovane la cerca nelle ombre che passano,
il povero cerca di scorgerla oltre un vetro dipinto,
la dignità.
Ho cercato in lungo, ho cercato in largo,
ho cercato dovunque sapevo,
ho chiesto ai poliziotti dovunque andavo,
avete visto la dignità?
Non ho un posto dove sparire, non possiedo un cappotto,
in mezzo a un fiume burrascoso, su una barca che non sta ferma,
sto cercando di leggere un biglietto lasciato da qualcuno
sulla dignità.
Mi hanno fatto vedere una foto e mi sono messo a ridere,
la dignità non si è mai fatta fotografare.
Ho avuto conti in rosso e conti in pari,
sono stato nella valle dei sogni fatti d’ossa lasciate a disseccare.
Quante strade, quanto in gioco,
quanti vicoli ciechi, io sono in riva al lago,
qualche volte mi chiedo cosa mai ci vuole
per trovare la dignità.
Le parole di Dylan potrebbero riguardare tutti noi: insomma non è più tempo di compromessi e di quietismi. È tempo di testimoniare la propria dignità e coerenza, secondo la propria sensibilità e coscienza!
Sul tema si leggano anche: Audizione di Claudio Castelli in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, L'audizione di Armando Spataro alla Camera dei Deputati del 25 gennaio 2024 sulla separazione delle carriere dei magistrati, Collegialità del giudice della misura cautelare e separazione delle carriere: due tasselli di uno stesso mosaico di Costantino De Robbio, Mozione sul d.d.l. costituzionale in materia di separazione delle carriere, Separazione delle carriere a Costituzione invariata. Problemi applicativi dell’art. 12 della legge n. 71 del 2022 di Pasquale Serrao d’Aquino, La separazione della carriera dei magistrati: la proposta di riforma e il referendum di Paola Filippi, La separazione delle carriere dei magistrati: una proposta di riforma anacronistica ed inutile di Armando Spataro, La separazione delle carriere dei magistrati? una riforma da evitare di Armando Spataro, La mafia si combatte con investimenti tecnologici, non con la separazione delle carriere di Maurizio De Lucia, Separazione delle funzioni dei magistrati vs. celerità dei processi e tutela dei diritti. Intervista di Marta Agostini al prof. David Brunelli; Una riforma che porterà il pm sotto l’esecutivo di Ernesto Carbone, Riforme e assetto costituzionale della magistratura di Giuseppe Santalucia, Separare... cosa? di Marcello Basilico,
[1]. MicroMega n. 1/2003.
[2]. La parte che segue è in buona parte tratta dal libro “Loro dicono, noi diciamo” (Laterza, 2024) di cui sono co-autori i professori Gustavo Zagrebelsky (sul “premierato”), Francesco Pallante (sull’“autonomia regionale”) ed Armando Spataro (sulla “giustizia”).
[3]. Dichiarazioni rese nel corso del Taormina Book Festival (La Stampa, 23.6.2024)
[4]. Intervista pubblicata il 3 luglio 2016 su Il Giornale di Sicilia.
[5]. Roma, 11 settembre 2023 – Confronto organizzato dall’ANM - Sezione Autonoma dei Magistrati a riposo.
[6] Un pubblico ministero “finalmente separato”? Una scelta per poco o per nulla consapevole della posta in gioco. E l’Europa ce lo dimostra (Questione Giustizia, 27/07/2023);
[7]. Art. citato.

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
