
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
La nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari: il nuovo testo unico
di Claudio Castelli
Sommario: 1.Un nuovo testo unico era necessario sia perché imposto dalla legge, sia per superare la eccessiva discrezionalità prima esistente - 2. Il D.Leg. 28.3.2024 n. 44 ha cambiato il quadro normativo ed ha dettato nuove regole su procedura, criteri, fonti di conoscenza e parametri di valutazione - 3. Il fine della scelta dei dirigenti deve essere non soddisfare le esigenze di carriera dei magistrati, ma garantire agli uffici la persona più capace con trasparenza - 4. Le due diverse proposte elaborate dalla Commissione Direttivi recuperavano le migliori esperienze passate sulle nomine: l’adozione di punteggi per merito e attitudini e l’introduzione di fasce di esperienze giudiziarie (non più di anzianità come nel passato). Proposte entrambe differenziate a seconda della tipologia di incarico (direttivo o semidirettivo, giudicante o requirente, di primo, secondo grado o di legittimità) e delle dimensioni dell’ufficio - 5. Elementi comuni alle due proposte era la pubblicità, la trasparenza, la standardizzazione delle domande. Anche se il Consiglio non si è posto il problema della “fuga” dagli incarichi direttivi e semidirettivi che vi è almeno per alcuni incarichi ed alcune zone del Paese - 6. La proposta per fasce di esperienze procede con due differenti modalità di selezione: - una per i posti semidirettivi, i direttivi di piccole e medie dimensioni e gli uffici specializzati che individua una fascia di 6 anni a partire dall’aspirante con maggiore esperienza o comunque avere un’esperienza in uffici omologhi a seconda degli uffici di 12 - 15 - 18 anni (civile, penale o specializzato) con una progressiva selezione sulla base di ulteriori requisiti molto specifici, - l’altra per i Tribunali di medie e grandi dimensioni, per le Corti e le relative Procure sulla base di una valenza decrescente di parametri derivanti dalle esperienze organizzative svolte - 7. La proposta per punteggi individua undici parametri che si rifanno agli elementi citati dal nuovo art. 46 octies (a partire da merito e capacità organizzativa) per poi articolare per ciascuno di essi un punteggio differenziato a seconda del tipo di incarico e di ufficio richiesto - 8. Entrambe le proposte recuperano le esperienze giudiziarie svolte, cosa diversa dalla tradizionale anzianità nel ruolo. Ed entrambi preservano la discrezionalità del Consiglio - 9. I limiti: il sistema per fasce rischia di essere eccessivamente automatico per gli incarichi per posti semidirettivi, direttivi di piccole e medie dimensioni e uffici specializzati e troppo discrezionale per gli altri posti - 10. Il sistema per punteggi è stato mal congegnato e in realtà privilegia eccessivamente l’anzianità e l’avere già svolto incarichi direttivi e semidirettivi oltre che tutte le “medagliette” conseguibili con nomine e incarichi di coordinamento - 11. Ora si tratta di superare critiche spesso preconcette e di far funzionare il sistema, superando gli opposti rischi di eccessivi automatismi o di eccessiva discrezionalità, con la disponibilità e capacità di verificarne e monitorarne la bontà, eventualmente apportando correttivi.
1. Un nuovo Testo Unico era necessario e inevitabile.
Nuove regole per la nomina dei magistrati direttivi e semidirettivi erano necessarie e dovute. Da un lato erano richieste dalla nuova legge[1] che aveva imposto norme più stringenti per le nomine e dall’altro erano imposte dallo scandalo Palamara che aveva evidenziato come di regole troppo lasche e di parametri virtuali si potesse fare agevolmente strame. Del resto il vecchio Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, approvato nel 2016, era nato con scopi nobili, ovvero di limitare ed indirizzare l’inevitabile discrezionalità del Consiglio, ed aveva introdotto e fissato una serie di indicatori generali e specifici oltre che una differenziazione per tipo di incarico e per dimensionamento dell’ufficio in modo da operare una selezione sulla base di parametri oggettivi. La realtà è che l’ampio numero degli indicatori introdotti e l’assenza di una gerarchia tra gli stessi aveva portato a poter giustificare qualsiasi scelta, facendo di volta in volta prevalere il candidato che si voleva. Una modifica era quindi inevitabile, oltre che imposta dalla legge Cartabia che dettava regole stringenti su tutti i profili: la procedura, le fonti da utilizzare e valorizzare, i parametri da adottare.
2. Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 28 marzo 2024 n.44.
La legge delega ed il successivo decreto legislativo n.44/2024 intervenivano su questo tema su diversi fronti. Imponeva una procedura regolata e trasparente, con il criterio cronologico nelle nomine e l’obbligo delle audizioni. Allargava il profilo delle fonti introducendo pareri da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, del dirigente amministrativo, dei magistrati dell’ufficio in caso di conferma) sempre assicurando il contraddittorio. Differenziava la valutazione dei candidati sulla base della natura dell’incarico (semidirettivo o direttivo, di primo, secondo grado o di legittimità o DNA specializzati) e delle dimensioni dell’ufficio da ricoprire (di piccole o medie dimensioni o di grandi dimensioni). Indicava i parametri sulla base dei quali doveva essere svolta la valutazione: merito, attitudini generali e specifiche. Aggiungeva alcune specifiche attività (i risultati avuti, l’analisi statistica, i provvedimenti adottati, la specializzazione, la varietà di esperienze, la conoscenza delle norme ordinamentali, l’aggiornamento professionale e la formazione, le capacità relazionali esterne). Elementi estremamente articolati e completi, forse fin eccessivi dato l’elevato numero di fattori da valutare, ma il cui rilievo veniva correttamente affidato al CSM.
3. Il fine cui tendere: dare dirigenti capaci con trasparenza.
Prima di passare all’esame delle proposte avanzate in Consiglio e delle scelte adottate è opportuno sottolineare che il risultato cui bisogna tendere non è soddisfare le esigenze di carriera dei magistrati aspiranti, ma garantire agli uffici la persona più capace e che dimostra ex ante le migliori attitudini. La trasparenza delle nomine è poi un obiettivo per l’intera società e per le comunità locali e non solo per i magistrati interessati. Proprio per garantire questi obiettivi occorrerebbe assicurare che le valutazioni sulle esperienze pregresse e sulle attività svolte dai singoli aspiranti si basino su di una reale disamina del concreto svolgimento delle stesse e non sul semplice “titolo” formale. Disamina che il Consiglio ha estrema difficoltà a fare, pur in presenza di un’estensione delle fonti di conoscenza, avendo ben pochi strumenti in tal senso ed avendo problemi a procurarseli. Il rischio è che la valutazione si arresti di fronte al dato formale di avere svolto un incarico e non a come è stato svolto e ai risultati effettivamente conseguiti. Sotto questo profilo, almeno per chi ha già svolto incarichi di dirigenza, sarebbe prezioso un esame, con inevitabile contraddittorio, delle performance avute e delle statistiche quali quantitative dell’ufficio.
4. Le vecchie esperienze rivisitate: i parametri per punteggi e le fasce di anzianità.
La Commissione del CSM si trovava ad elaborare la nuova Circolare in tempi estremamente ristretti e, opportunamente, pur non arrivando ad una proposta unitaria, si rifaceva nelle due diverse prospettazioni avanzate alle esperienze concrete più feconde avute nel passato. Da un lato i vecchi parametri per punteggi che fino agli anni 2000 avevano caratterizzato la nomina degli incarichi semidirettivi. Era un’epoca in cui l’anzianità era ancora il carattere dominante e merito e attitudini avevano un rilievo secondario: veniva dato un punto per ogni anno di anzianità nella qualifica richiesta per la nomina, sino a 4 punti per il merito, sino a 2 punti per lo svolgimento di funzioni omologhe e sino a 4 punti per le attitudini. Il pregio di questo sistema, oltre che di consentire una valorizzazione di merito e attitudini in situazioni di scarsa differenza di anzianità, costringeva a solidificare la valutazione in punteggi, con una forte responsabilizzazione. L’altro sistema puntava su fasce di anzianità che portavano a scegliere tra i candidati entro 8 anni di anzianità a partire da quello più anziano. Sistema che portava a valorizzare le esperienze lavorative e a contenere in modo oggettivo il numero dei candidati da valutare. Con il limite di consentire domande strumentali da parte di candidati particolarmente anziani, formulate solo al fine di determinare la fascia.
Sul resto le due proposte si differenziano su punti marginali. Onde evitare discussioni strumentali va chiarito che entrambe le proposte preservano ampiamente la discrezionalità nella scelta da parte del Consiglio. Spacciare o temere che i punteggi portino ad un automatismo nella scelta era del tutto sbagliato perché l’attribuzione dei punteggi era comunque determinante per il risultato. Così l’introdurre fasce di esperienze professionali limita, anche grandemente per larga parte degli uffici, l’ambito della scelta (anche perché non contiene, a differenza del passato, eccezioni per lo “spiccato rilievo”), ma lascia una discrezionalità sia nella valutazione delle esperienze, sia tra gli aspiranti che rientrano nella fascia. Poi per quanto riguarda Tribunali distrettuali, Corti e relative Procure viene lasciata una discrezionalità molto ampia. Il tutto ovviamente deve o dovrebbe avvenire sulla base dei parametri che lo stesso Testo Unico delinea.
5. Gli elementi comuni: pubblicità, trasparenza, standardizzazione, limite al numero delle domande. Il calo delle domande per gli incarichi.
Va valorizzata la tensione verso la pubblicità e la trasparenza che si ha in entrambe le proposte e l’adozione di una standardizzazione sia dell’autorelazione che delle domande proposte. Così pure si cerca di evitare un carrierismo che punta al conseguimento di successivi incarichi sempre di maggiore prestigio con il limite al numero di domande che ogni aspirante può presentare (due per incarichi direttivi e due per incarichi semidirettivi). Anche se in realtà il Consiglio non prende atto della nuova realtà che si sta creando con un calo delle domande almeno per taluni incarichi direttivi e della scarsa appetibilità di almeno alcuni tra di essi (in particolare per posti giudicanti di alcune zone di Italia). Sono andati deserti, almeno in prima battuta, i posti di Presidente della Corte di Appello di Potenza, di Presidente di sezione lavoro a Brescia, di Presidente di sezione del Tribunale di Milano. Disaffezione che deriva in parte dall’impatto fortemente negativo sulla magistratura che ha avuto l’affaire Palamara con una sbagliata identificazione tra presentare domande per incarichi e carrierismo deteriore ed in parte dalla crescente consapevolezza delle difficoltà, complessità ed impegno, diverso dalla normale attività giurisdizionale, che un incarico direttivo e, parzialmente, anche semidirettivo comporta. Purtroppo i tempi sono stati compressi, ma sarebbe stata l’occasione per acquisire una serie di dati di grande interesse che potrebbero aiutare il Consiglio nelle sue politiche: il numero di domande per tipologia di posti, l’età ed il genere dei nominati sia per i posti direttivi che per i semidirettivi, la provenienza geografica rispetto al posto da ricoprire, il tasso di impugnazioni e di conferma. Anni fa il Consiglio aveva condotto una ricerca in questa direzione con risultati per certi aspetti sorprendenti (come l’età dei nominati a posti direttivi ben oltre i 60 anni e il limitato tasso di accoglimento delle impugnazioni). Sarebbe il caso di ripeterla ogni anno, anche per verificare la bontà delle proprie scelte.
6. La proposta per fasce di esperienze giudiziarie.
La proposta 1, poi approvata, riprende la valorizzazione delle fasce, non più di anzianità, (che sarebbe comunque vietata dalla legge), ma per esperienze professionali. Si crea una sorta di scrematura per passaggi successivi ad imbuto, ove sono preferiti per una seconda fase di valutazione unicamente i magistrati che abbiano un’esperienza significativa con funzioni omologhe o in uffici specializzati. Le modalità sono diverse per gli uffici semidirettivi, specializzati e direttivi di piccole e medie dimensioni da un lato e per quelli direttivi degli uffici di grandi dimensioni, distrettuali e di secondo grado e legittimità dall’altro. Per i primi viene effettuata una prima selezione all’interno della fascia di esperienze di sei anni a partire dall’aspirante che può vantare un’esperienza di maggiore durata, o comunque tra candidati che abbiano un’esperienza in uffici omologhi a seconda degli uffici di 12 - 15 - 18 anni, valorizzando il settore di appartenenza (civile, penale o specializzato). Poi in caso di posizioni equivalenti intervengono successive selezioni, sempre più stringenti, una sorta di cerchi concentrici man mano più piccoli, sino ad arrivare al candidato prescelto con una sorta di semi automatismo.
Per i secondi dopo la prima scrematura operata solo sulla base della permanenza nelle funzioni, e quindi scarsamente selettiva, subentrano ulteriori parametri di rilievo decrescente, ma da considerare in un giudizio complessivo ed unitario, lasciando una più ampia discrezionalità.
Onde evitare i “giochetti” che si erano avuti nella passata esperienza relativa alle nomine utilizzando le fasce si è proceduto a cristallizzare la situazione al momento della disamina della Commissione, consentendo eventuali revoche solo sino alla settimana prima la trattazione del posto interessato annunciato con la pubblicazione dell’ordine del giorno della Commissione consiliare.
Il sistema, al di là della difficoltà di esposizione e di lettura, è semplice, in particolare per gli incarichi semidirettivi, direttivi per uffici di piccole e medie dimensioni e specializzati con successive selezioni (ad imbuto come descritto dagli stessi autori della proposta) sulla base di criteri dichiarati ed oggettivizzabili. Per gli altri incarichi, quelli più rilevanti, dopo una prima scrematura che risulterà molto più limitata, resta una ampia discrezionalità, sia pure regolata, stabilendo una valenza decrescente delle ulteriori esperienze organizzative prese in considerazione. Tale valutazione avviene sulla base dei parametri del merito e delle attitudini articolate in criteri principali e criteri secondari.
7. La proposta per punteggi.
La proposta 2, poi soccombente, era molto più articolata, in quanto individuava una serie di parametri, in relazione ai quali vengono attribuiti punteggi. I parametri erano ben undici e si rifacevano agli elementi citati dal nuovo art. 46 octies nelle lettere da a) a n) (salvo la lettera f) ovvero: il merito (lett. a), la capacità organizzativa (lett. b), le pregresse esperienze di direzione, organizzazione e coordinamento (lett. c), la capacità di dare attuazione ai progetti organizzativi e di adeguarli ai mutamenti (lett. d), la capacità di analisi ed elaborazione statistica (lett. e), le specifiche competenze per incarichi specializzati (lett. g), la varietà di esperienze (lett. h), la conoscenza delle norme ordinamentali (lett. i), l’aggiornamento professionale (lett. l), le capacità relazionali (lett. m), la documentazione trasmessa dalla Scuola Superiore della Magistratura (lett. n).
I punteggi sono, con differenze a seconda del tipo di ufficio (di primo, secondo grado o di legittimità, di piccole, medie dimensioni o di grandi dimensioni, oltre alla DNAA) e del tipo di incarico (semidirettivo o direttivo, giudicante o requirente), schematicamente i seguenti:
Qualora infine dall’attribuzione dei punteggi relativi a merito e attitudini risultasse una differenza inferiore o pari al 5 %, verrebbe ad assumere rilievo in via residuale il parametro dell’anzianità dando un ulteriore punteggio di 0,5 punti ogni anno di servizio successivo alla valutazione di professionalità richiesta dalla legge per il conferimento delle funzioni corrispondenti al posto da ricoprire.
La descrizione sommaria dei parametri e dei punteggi adottati può lasciare disorientati per la sua complessità, ma per ognuna delle tipologie dei posti da assegnare (e stiamo parlando di ben nove tipi di incarico, oltre a quelli specializzati come gip, lavoro, minori, sorveglianza) opera una sorta di canalizzazione con uno specifico punteggio da assegnare. Si tratta quindi di partire dal tipo di posto e quindi attribuire gli undici punteggi di cui ai diversi parametri.
8. Prime considerazioni generali.
Una prima considerazione generale che in realtà accomuna entrambe le proposte è il recupero delle esperienze giudiziarie svolte. Non si è voluto, né potuto ridare spazio all’anzianità, ma valorizzare il percorso professionale e la sua durata. Ciò riguarda l’avere svolto per un congruo periodo di tempo funzioni in uffici omologhi e nello stesso settore per una proposta e l’avere superato le varie valutazioni di professionalità per l’altra. Non si tratta di un ricorso all’anzianità sotto mentite spoglie perché in entrambi i casi non si parla di anzianità nel ruolo e non vi è automatismo. Inoltre presuppongono una valutazione positiva dell’attività svolta, riguardando le esperienze professionali positive la prima (come si ricava dai criteri generali di valutazione contenuti nei primi articoli) e le valutazioni di professionalità conseguite la seconda. Il tentativo in entrambi i casi è di valorizzare elementi in larga parte oggettivizzabili.
I sistemi che poi derivano sono in parte diversi da come vengono presentati e che la dialettica consiliare ha dipinto: in realtà non si tratta di un sistema che esalta la discrezionalità (quello per fasce), contro uno semi automatico (quello per punteggi), ma di sistemi complessi in cui il rischio di automatismi semmai vi può essere (in caso manchi qualsiasi valutazione su contenuto e merito delle esperienze) per il sistema per fasce disegnato per gli incarichi semidirettivi e direttivi per uffici piccoli e medi e specializzati (la stragrande maggioranza degli incarichi). Difatti il sistema per punteggi lasciava inevitabilmente un amplissimo spazio di discrezionalità nello stesso range dei punteggi esistenti, dato che vi erano punteggi automatici, punteggi semiautomatici e punteggi totalmente discrezionali.
9. Limiti e criticità del sistema per fasce o a imbuto.
Occorre in primis vedere se si terrà conto dei dati formali, ovvero solo l’avere ricoperto un certo incarico ovvero le effettive modalità con cui è stato svolto e di che strumenti si doterà il consiglio per valutare la positività delle esperienze pregresse oltre che il raggiungimento degli obiettivi.
Quanto al sistema per fasce vanno formulate diverse osservazioni. In primo luogo il sistema delineato pare avere effettuato la scelta di differenziare profondamente tra le modalità di scelta dei dirigenti degli incarichi semidirettivi e direttivi dei piccoli e medi uffici e di quelli specializzati (quasi il 90 % degli incarichi), con modalità molto stringenti e con una forte quota di automatismi e quelle molto più discrezionali degli altri posti apicali (poco più di 100). Una scelta che potrebbe essere condivisibile, in quanto a fronte dell’enorme numero di nomine da effettuare in tempi contenuti con l’obbligo di effettuare audizioni (il che appesantisce ulteriormente la procedura), il Consiglio potrebbe concentrarsi su quelle più significative, ma una tale scelta non è stata esplicitamente dichiarata. I pericoli sono due e curiosamente opposti. Da un lato che per i posti semidirettivi, direttivi di uffici di piccole e medie dimensioni e specializzati il sistema a cerchi concentrici delineato porti ad un automatismo senza valutare quanto meno la positività e complessità delle esperienze pregresse e l’esito delle audizioni, modalità che sarebbe in contrasto con la legge e con lo stesso Testo Unico laddove vengono delineati i parametri ed i criteri di valutazione. Dall’altro che per i posti direttivi dei Tribunali distrettuali, delle Corti e delle relative Procure l’ampia discrezionalità delineata diventi scarsamente verificabile. E’ vero che dovrà prima essere valutata la permanenza in funzioni omologhe e che poi entrano in gioco parametri secondo una chiara gerarchia, ma nel momento in cui si parla della necessità di un giudizio complessivo ed unitario, il rischio è che la discrezionalità diventi eccessiva e priva della necessaria trasparenza.
10. Limiti e criticità del sistema per punteggi.
Quanto al sistema basato sui punteggi emergono moltissimi limiti e criticità, più che per l’idea e per lo strumento, per le concrete modalità con cui è stato congegnato.
Innanzitutto un fortissimo recupero dell’anzianità, articolata come valutazione di professionalità conseguita, che in molti casi verrebbe ad essere determinante sia perché integra realisticamente circa la metà del punteggio complessivo che un candidato può raggiungere, sia per la clausola finale che la fa divenire prevalente in caso di differenza pari o inferiore al 5 %. In secondo luogo per la preferenza che viene data a coloro che hanno già ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi che possono accedere a punteggi di cui invece gli altri magistrati non possono godere. Basti pensare che chi ha già svolto incarichi semidirettivi o direttivi omologhi parte con un vantaggio di almeno 4 punti (un punto per anno) e che in caso di incarico completato arriva ad 8 punti.
In terzo luogo la possibile utilizzazione degli stessi elementi (come la positiva esperienza pregressa in un incarico) per beneficiare di più punteggi (ad esempio per l’efficiente organizzazione del lavoro, le pregresse esperienze semidirettive e direttive, la capacità di dare attuazione ai progetti organizzativi, le capacità relazionali).
Infine la forte valorizzazione autonoma di incarichi istituzionali (di innovazione, formazione, ordinamento) rischia di attribuire loro un eccessivo peso. Se si unisce ciò alla forte valorizzazione degli incarichi di direzione anche di fatto e di coordinamento, attribuiti, sia pure dietro interpello, dal dirigente dell’ufficio, si coglie il rischio di un’ulteriore valorizzazione di tutte quelle posizioni che potrebbero essere ambite a fini carrieristici.
Tutto con una chiara eterogenesi dei fini rispetto a chi, giustamente, rivendica l’idea di una magistratura orizzontale e della sdrammatizzazione delle nomine.
Personalmente ho sempre apprezzato il sistema dei punteggi, come momento di solidificazione di una valutazione e di responsabilità, ma il modo con cui era stato pensato nella proposta 2 portava purtroppo ad un approccio burocratico e a probabili esiti opinabili e negativi. Difatti dalla legge non discendeva alcun obbligo di attribuire un punteggio per ciascuna delle voci richiamate nell’art.46 octies comma 7, ma solo l’obbligo di tenere conto di tutti tali fattori. In realtà, secondo il mio giudizio, è stato un errore sia frammentare i punteggi in ben undici voci, sia di dare loro una ponderazione poco meditata. Personalmente mi sarei limitato a quattro voci: merito, capacità organizzativa, esperienze organizzative pregresse e loro risultati, altre capacità e attitudini (in cui avrei ricompreso tutti gli elementi richiamati dall’art. 46 octies co. 7 dalla lettera g alla lettera n), dando un peso preminente alla capacità organizzativa e limitato e residuale all’ultima voce. Tra l’altro mettere pochi canali avrebbe consentito trasparenza e leggibilità delle decisioni che sarebbe stato invece ben difficile a fronte di un così cospicuo numero di fattori di cui una parte presso che automatica (le valutazioni di professionalità, la documentazione trasmessa dalla SSM) ed una parte ampiamente discrezionale, discrezionalità che viene esaltata dalla pluralità di parametri. Francamente un sistema che poteva essere interessante, ma che è stato mal calibrato. Tra l’altro la discussione consiliare si è soffermata fondamentalmente sulle scelte generali di sistema, con un approccio troppo spesso per slogan, senza andare ad esaminare i dettagli delle proposte, dimenticando che spesso nei dettagli sta il veleno.
11. Lo scenario che si apre.
Va riconosciuto che la Commissione consiliare ha svolto un lavoro estremamente proficuo arrivando a due proposte, con i limiti sopra evidenziali, ma che hanno cercato di superare le deviazioni che il precedente sistema aveva evidenziato. La discussione consiliare, ma anche extra consiliare, non ha aiutato a migliorare le proposte ed a giungere ad una soluzione unitaria, che personalmente avrei cercato di raggiungere combinando i due sistemi partendo dalla prima proposta articolata in fasce di esperienza giudiziaria per gli uffici specializzati e di minori dimensioni, per poi disciplinare con punteggi, relativi a poche voci e ben ponderate, l’inevitabile più ampia discrezionalità da esercitare per i Tribunali distrettuali, le Corti e le relative Procure.
Devo dire che alcune accuse ad entrambe le proposte, ed in particolare alla proposta approvata, sembrano davvero ingenerose e paiono derivare più da ragioni di contrapposizione e propaganda che da una loro seria disamina. Non credo sia corretto delineare il ricorso al sistema dei punteggi come una riduzione del C.S.M. ad una sorta di ufficio del personale con una deriva burocratica. Forse questa è la ragione che ha portato alcuni laici del C.S.M. indicati dall’attuale maggioranza governativa a votarla vedendola in sintonia con la pessima riforma costituzionale in discussione, ma mi sembra un problema mal posto. In discussione non può essere posto il sistema dei punteggi, già adottato in altre amministrazioni di alto livello, ma semmai di come è stato congegnato ed articolato.
Per quanto concerne la proposta approvata contro di essa alcuni hanno avanzato critiche molto severe avanzando la contestazione secondo cui si sarebbe rinunciato ad un cambiamento radicale di metodo al fine di mantenersi le mani libere sulle nomine. Questa osservazione non coglie come per il 90 % delle stesse venga adottato un sistema rigorosamente configurato ben più cogente di quello proposto con i punteggi. Non solo, ma temere che in questo modo si prefiguri una separazione delle carriere irrigidendo ulteriormente i passaggi non tiene conto non solo che inevitabilmente nella valutazione dei candidati occorre valorizzare percorso professionale e funzioni svolte, ma che è presso che inevitabile che i cambiamenti di funzione non avvengano per il passaggio a posti dirigenziali, ma in altre fasi della vita professionale, come del resto già avviene oggi.
Il problema ora pare invero un altro, ovvero come applicare nel modo migliore possibile il nuovo Testo Unico. Il Consiglio si trova di fronte ad una sfida davvero difficilissima: riuscire ad effettuare nomine in tempi ragionevoli (oggi arriviamo ad oltre un anno) e con procedure molto più vincolate e costose come tempi. Il nuovo Testo Unico può essere un buono strumento se riuscirà ad evitare di cadere in anomali automatismi per quanto concerne gli incarichi semidirettivi e direttivi per uffici medio piccoli e specializzati e ad una discrezionalità non regolata per gli altri uffici. Su questo sappiamo che oltre alle norme, contano le prassi ed i precedenti, che vanno costruiti e resi trasparenti.
Saggezza richiede di sperimentare il sistema approvato, verificando il suo funzionamento, ma continuando a monitorare gli esiti e mantenendo la capacità se necessario di adottare correttivi in corsa.
[1] L’art. 5 co. 7 del Decreto Legislativo 28 marzo 2024 n.44 introduce i nuovi artt. 46 bis, 46 ter, 46 quater, 46 quiquies, 46 sexies, 46 septies, 46 octie, 46 nonies, 46 decies, 46 undecies, 46 duodecies, 46 terdecies del Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n.160.
Immagine via Wikimedia Commons.
Una giudice a Catania. Il caso Apostolico e le conseguenze degli attacchi politici alla magistratura
di Cataldo Intrieri
La giudice Iolanda Apostolico che giusto un anno fa precorrendo i tempi e le polemiche, aveva disapplicato uno dei tanti decreti flussi allora denominato Cutro, con motivazioni che avevano precorso quelle adottate oggi dai colleghi di Roma e Bologna con le ben note conseguenze si è improvvisamente dimessa dalla magistratura.
Lo ha fatto senza fornire alcuna spiegazione ufficiale e senza neanche ricorrere alla comoda via d’uscita di una qualche forma di scivolo o prepensionamento.
Il suo collega Stefano Musolino segretario della Corrente di MD cui la magistratura fa parte ha scritto apertamente di «dimissioni che turbano l’intera magistratura» di «senso di isolamento che da individuale tende pericolosamente a diventare collettivo», di «logica intimidatoria» scagliata su» vulnerabilità di cui tutti siamo impastati» che rendono i magistrati meno indipendenti…preoccupati delle loro vite private indifese. Un linguaggio chiaro che getta uno squarcio anche sulla grave situazione politico-istituzionale italiana (e non solo) che in molti fingono di non vedere come se ancora oggi il nocciolo del problema sia la abituale polemica sul garantismo (che ha certo il suo rilievo ed importanza) e non qualcosa di più oscuro e diverso, un grumo nero che corrode la giustizia lentamente ma progressivamente e che dovrebbe scuotere soprattutto i difensori più convinti delle garanzie difensive, tra cui per ciò che può importare milita chi scrive.
Perché se si ritiene normale “isolare un magistrato” o inviare una busta con tre pallottole all’avvocato di un omicida come è avvenuto per il prof. Caruso difensore di Stefano Turetta, ciò significa significa che il problema è generale e connesso in un mondo dove ogni giorno un qualsiasi imbecille politico rovescia insulti su magistrati, imputati, condannati e diritti assortiti delle minoranze.
Apostolico per singolare coincidenza o voluto tempismo, chissà, ha deciso nella stessa giornata in cui il governo ha votato la fiducia all’ultima versione del decreto flussi e la procura generale della Cassazione, supremo organo requirente della giurisdizione italiana, ha chiesto di rinviare alla Corte di giustizia europea la decisione sui ricorsi del governo contro i provvedimenti dei giudici di Roma e Bologna che hanno “sabotato” secondo i cantori Meloniani la "giusta e moderna” politica sull’immigrazione.
Invece i vertici della magistratura requirente hanno ritenuto corretta la decisione già adottata dal giudice Gattuso di Bologna, a sua volta oggetto di violenti attacchi personali sulla sua vita privata: chiedere lumi alla Corte di Lussemburgo al fine di sapere con certezza se la sequela di leggi ossessivamente varate negli ultimi anni dall’attuale esecutivo sull’immigrazione e protezione Internazionale, rispettino i diritti fondamentali di soggetti deboli e soprattutto l’autonomia della giurisdizione, vero nocciolo duro della questione ancorché lo si trascuri come vedremo.
Da circa un anno pende al CSM una richiesta di presa di posizione “a tutela” di Apostolico che non ha avuto seguito.
Il punto non sono le “fragilità personali” e la reazione soggettiva alle polemiche inevitabili.
Ciò che ha contraddistinto le critiche ai magistrati delle varie sezioni sull’immigrazione dei tribunali è stata la deriva verso l’attacco personale come atto costante.
Di Apostolico sono state diffuse in tv riprese durante una manifestazione politica contro provvedimenti del governo sui respingimenti ed addirittura sotto casa in motorino con un familiare.
La prima documentazione proviene da fonti della questura di Catania e nessuno ad oggi ha spiegato chi le abbia fornite alla propaganda filogovernativa.
Del giudice di Bologna sono state riprese dichiarazioni attinenti la sua situazione familiare di padre adottivo.
Accanto a ciò prosegue un’attività di depistaggio informativo che lungi dall’affrontare il merito giuridico dei provvedimenti contestati la butta in caciara sulle idee politiche dei magistrati.
È appena il caso di ricordare che nell’ufficio di sottosegretario alla presidenza del Consiglio siede un eccellente magistrato in aspettativa, Alfredo Mantovano, uno dei registi dell’attuale politica governativa, da lungo tempo parlamentare e militante dei movimenti pro-vita della cui imparzialità mai nessuno ha dubitato anche in ragione va detto della riservatezza da sempre custodita e cui qualche collega potrebbe ispirarsi.
Ebbene, non ci si stancherà dal ripeterlo, anche l’ultimo decreto flussi ripete le medesime criticità che hanno portato alla disapplicazione dei precedenti provvedimenti.
L’elenco dei “paesi sicuri” continua a comprendere paesi “sicuri” che l’UE tali non considera
Contiene parti “riservate” in ordine alle modalità dei trattenimenti e degli appalti che già in precedenza le corti europee anche ai tempi dei governi Renzi, Gentiloni, Minniti hanno ritenuto inaccettabili per violazione del principio di legalità (Cedu Sentenza Italia-Al Khalifa, 2016).
Accanto a ciò il vero tema su cui si sorvola concerne la vera e propria legittimità di una procedura di rimpatri accelerati il cui perno sarebbero i trattenimenti nei costosi resort albanesi dove ad oggi sono entrati e subito usciti in ben 19 (nessuno che sottolinei questo: i centri non hanno mai contenuto moltitudini)
Le precedenti sentenze delle corti europee, tra cui quella della CGUE del 4 ottobre che ha dato fuoco alla miccia, impongono che a decidere sia un giudice e rendono pressoché certa mente irrealizzabile la possibilità di automatismi come i respingimenti basati su elenchi preordinati.
Sullo sfondo come ha fatto Intuire lo stesso Mantovano vi è però di più e cioè la ridiscussione dello stesso ruolo di primazia della giurisdizione europea su quella interna.
Un tema su cui l’Italia in epoca di sovranismo dilaganti potrebbe trovare sponda ma che manderebbe per aria uno dei fondamenti dell’UE. L’Ungheria, dove ciò è stato tentato, per ora senza successo, è vicina.
Questo contributo è già apparso su Linkiesta il 6 dicembre 2024.
Sky ecc, ordine europeo di indagine tra giurisprudenza nostrana e comunitaria
di Francesco Agnino
Sommario: 1. Premessa: il quadro investigativo complesso dinnanzi alle Sezioni Unite - 2. Le diverse soluzioni offerte dalla Corte di cassazione - 3. Interrogativo pregiudiziale: raccolta massiva di dati o “captazione c.d. mirata” - 4. L’estensione della disciplina interna sulla circolazione delle prove fra procedimenti diversi - 5. Nessun controllo giurisdizionale anticipato nello Stato di emissione - 6. Il controllo giurisdizionale non è escluso (anche se postumo) - 7. Il controllo sulle ragioni di merito dell’emissione dell’OEI - 8. Modalità di raccolta delle prove da parte dell’autorità straniera e controllo giurisdizionale - 9. Nessuna critica?
1. Premessa: il quadro investigativo complesso dinnanzi alle Sezioni Unite.
Le sezioni unite con le due sentenze gemelle nn. 23755 e 27356, depositate il 14 giugno 20124, hanno sciolto alcuni dubbi connessi al caso dei c.d. criptofonini Sky ECC.
Gli arresti nomofilattici devono essere letti congiuntamente alla decisione del 30 aprile 2024 con cui la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata in merito all’analoga vicenda dei messaggi criptati scambiati attraverso la piattaforma Encrochat (Corte giust., 30 aprile 2024, M.N., C-670/22). E, comunque, un ulteriore tassello al mosaico verrà aggiunto dalla Corte europa dei diritti dell’uomo, anch’essa chiamata ad esprimersi al riguardo (procedimenti n. 44715/20 e 47930/21).
La diatriba, come è ormai ben noto, concerne la natura e le conseguenti garanzie procedimentali applicabili all’acquisizione delle conversazioni via chat intercorse fra alcuni esponenti di associazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti attraverso piattaforme online di tipo criptato, che avevano loro consentito di comunicare in modo riservato mediante smartphone appositamente modificati.
Nell'esperire le attività istruttorie sui criptofonini, le forze di polizia francesi si sono avvalse di tecniche investigative particolarmente intrusive e articolate, tutt'ora parzialmente coperte da segreto di Stato, che hanno consentito di intercettare, acquisire e decodificare l'intera mole di comunicazioni convogliate su note piattaforme criptate come sky-ecc ed Encrochat (ma anche Ennetcom, PGP Safe, IronChat e ANOM).
Le operazioni hanno coinvolto chat individuali o di gruppo recanti milioni di messaggi riferibili a decine di migliaia di utenti dislocati in tutto il mondo. Per procedere alla captazione, i server e i criptofonini — nel caso sky-ecc basati su quattro diverse chiavi di cifratura — sono stati hackerati dalle autorità di contrasto francesi, operanti in una squadra investigativa congiunta (JIT – Joint Investigation Team) con le forze di polizia olandese e belga.
Gli esiti di tali attività istruttorie sono stati poi trasmessi, ricorrendo all'ordine europeo di indagine, agli organi investigativi degli Stati membri interessati.
La raccolta di dati in così grandi dimensioni ha sollevato complessi interrogativi concernenti la tutela della privacy, la validità delle prove digitali, la compatibilità con le regole del giusto processo sotto il versante della parità delle armi e la necessità di garantire l'inviolabilità del diritto di difesa. Per comprendere la rilevanza della questione, è sufficiente notare come le vicende sui criptofonini abbiano cagionato incidenti di costituzionalità, pronunce dei giudici interni di merito e di legittimità, oltre che l'intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea: dalle corti francesi a quelle italiane, passando per le giurisdizioni belga, olandese, norvegese e tedesca, i tribunali del vecchio continente, di ogni ordine e grado, si sono trovati a dover fronteggiare i dilemmi che le operazioni istruttorie basate sui criptodati hanno originato (ne dà conto la memoria per l'udienza delle sezioni unite penali del 29 febbraio 2024 della procura generale presso la Corte di cassazione, consultabile in , 1° marzo 2024, 83 s.: «il Conseil constitutionnel francese, con la decisione n. 2022-987 QPC dell'8 aprile 2022, ha statuito che la disciplina francese, sulla cui base eÌ stata disposta l'acquisizione delle chat e l'intercettazione delle comunicazioni operate nel presente procedimento, eÌ conforme alla Costituzione francese; il Bundesgerictshof, con la sentenza 5 StR 457/21 del 2 marzo 2022, ha ritenuto che l'intercettazione della piattaforma Encrochat, “violata” dall'autorità giudiziaria francese, fosse legittima ai sensi del diritto processuale penale tedesco; [...] la Corte suprema dei Paesi Bassi (Floge Raad), con la sentenza n. 913 del 13 giugno 2023, ha ritenuto conforme al diritto interno l'acquisizione dei dati informatici presenti sulle piattaforme criptate Encrochat e sky-ecc, acquisite dall'autorità giudiziaria francese”).
Le Sezioni Unite, di conseguenza, si sono dovute confrontare con il tema dell’impiego dell’OEI ai fini della raccolta di prove già in possesso dell’autorità di esecuzione: un’eventualità espressamente prevista sia dalla direttiva sia dal d.lgs. n. 108 del 2017.
Innanzi al giudice della nomofilachia si è posto un problema di tenuta delle garanzie fondamentali e dai non trascurabili risvolti pratici, che, nel caso dell'Italia, si arricchisce anche dei più recenti moniti contenuti nell'ennesima pronuncia dell'affaire Contrada (Corte eur. diritti dell'uomo 23 maggio 2024, Contrada c. Italia (n. 4); sentenza, quest'ultima, che lascia trapelare un problema sistemico nell'ordinamento giuridico italiano: la legge processuale non offre sufficienti garanzie contro gli abusi nelle intercettazioni a carico di soggetti non direttamente coinvolti in un procedimento penale. E, infatti, uno dei rischi che si cela dietro l'acquisizione di un così ragguardevole volume di “corrispondenza” — stando agli ultimi insegnamenti della Corte costituzionale (Corte cost. 27 luglio 2023, n. 170, con cui il giudice delle leggi ha statuito che «il concetto di “corrispondenza” ricomprende ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza”. La tutela accordata dall'art. 15 Cost. “si estende, quindi, ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale» (par. 4.2 del considerato in diritto). Secondo la Memoria per l'udienza delle sezioni unite penali del 29 febbraio 2024 della procura generale presso la Corte di cassazione, cit., 39: “[d]alle statuizioni della Corte costituzionale deriva che le chat acquisite dall'autorità giudiziaria francese debbano essere qualificate come corrispondenza”) — è quello che l'operazione si traduca in una “battuta di pesca” (c.d. fishing expedition) con valenza meramente esplorativa. Esigenze, quelle che si stagliano all'orizzonte, che si mostrano allora tanto più impellenti quando si considerino le notizie che giungono ancora dalla Francia e che riguardano note e ben più in voga app di messaggistica crittografata (è il caso della nota app Telegram; per una ricostruzione v. La svolta di Telegram dopo l'arresto di Durov: consegnerà alle autorità indirizzi e numeri dei presunti criminali, v. La Repubblica, 24 settembre 2024).
2. Le diverse soluzioni offerte dalla Corte di cassazione.
È emerso in giurisprudenza un rilevante contrasto interpretativo, sia in ordine alla individuazione dello strumento processuale “interno” da porre a parametro per l'importazione delle “chat” decrittate e richieste con gli OEI che al tipo e all'ambito del controllo giurisdizionale da svolgere nel nostro ordinamento in merito alla utilizzabilità dei dati probatori i raccolti all'estero. Secondo un orientamento giurisprudenziale, in tali casi non potrebbe farsi riferimento alla disciplina delle intercettazioni, poiché la stessa presuppone l'esistenza di flussi di comunicazioni in atto (in tal senso, Cass., sez. 6, 27 settembre 2023, n. 46482 che ha precisato “trattarsi di registrazioni di conversazioni già avvenute e, quindi, di dati "statici” assimilabili a corrispondenza, e non invece di intercettazioni). La fattispecie processuale potrebbe rientrare nella acquisizione di “corrispondenza informatica” (le “chat”, già disponibili, appunto, nello Stato di esecuzione attraverso il precedente ricorso a mezzi di intercettazione). D'altronde, si aggiunge, l'art. 1, par. 1, della direttiva 2014/41 UE consente il ricorso all'OEI anche per l'acquisizione di prove che già sono in possesso delle competenti Autorità dello Stato di esecuzione e il successivo art. 13 della direttiva disciplina il “trasferimento delle prove” (comprese quelle “già in possesso dello Stato di esecuzione”).
Secondo questa tesi, si tratterebbe, dunque, di atti probatori già nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria francese, che li ha acquisiti con procedura conforme al proprio ordinamento. In questa ottica, si è affermato che, a tal fine, “il pubblico ministero può emettere l'ordine europeo di indagine con cui si richiede il trasferimento di dati documentali, in particolare di corrispondenza già acquisita in un procedimento penale nel paese membro di esecuzione, per il cui sequestro è ‹sufficiente, ai sensi dell'art. 15 Cost. e secondo le disposizioni interne, il provvedimento motivato del pubblico ministero, senza necessità di intervento del giudice per le indagini preliminari” (Cass., sez. 6, 27 settembre 2023, n. 46482, cit.).
Ove si ritenesse fondata tale opzione ermeneutica, la norma di riferimento dovrebbe dunque essere individuata in quella prevista dall'art. 254-bis c.p.p., che consente appunto il sequestro di corrispondenza informatica. Pertanto, ove dovesse ritenersi accoglibile tale ricostruzione normativa, si renderebbe comunque necessaria una valutazione del Giudice cautelare in merito alla sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti di necessaria proporzionalità e adeguatezza nel nostro sistema processuale.
V'è tuttavia da osservare che la richiesta di trascrizione, decodificazione o decrittazione delle comunicazioni intercettate, cui fa riferimento la richiamata disposizione dell'art. 43, comma 4, dovrebbe essere più correttamente interpretata come formulazione di un'istanza collegata ed accessoria a quella, principale, contenuta nell'ordine di indagine richiesto ad altre› Stato membro, al fine di intercettare una delle diverse forme di telecomunicazioni descritte nel primo comma dell'art. 43, come tali non già precedentemente acquisite nell'ordinamento richiesto, ma ancora da espletare e trasmettere, in via immediata (art. 43, comma 3, lett. a) o successiva (art. 43, comma 3, lett. b), in conseguenza della richiesta emessa in fase attiva dalle autorità italiane. Sotto altro, ma connesso profilo, una diversa prospettiva esegetica potrebbe essere più fondatamente seguita valorizzando il contenuto di ulteriori disposizioni del complesso micro-sistema normativo dell'ordine di indagine europeo. Dovrebbe però sempre valutarsi la legittimità della “trasposizione” dei risultati delle intercettazioni “aliene” alla luce della nostra disciplina processuale (ex art. 270 c.p.p. appunto) e, conseguentemente, l'utilizzabilità delle relative comunicazioni (G. Faillaci, Le Sezioni Unite sull’acquisizione e l’utilizzabilità dei dati dei criptofonini importati a seguito di un ordine di indagine europeo. Nota a Corte di cassazione penale, sez. un., 14 giugno 2024, ud. 29 febbraio 2024, n. 23756, in NJus).
In tale ottica, ferma restando la legittimità dell'attività di intercettazione delle comunicazioni svolta all'estero, ci si dovrebbe interrogare circa la possibilità, nel nostro ordinamento, di utilizzare il trojan, non solo per disporre un'intercettazione, ma anche per acquisire — attraverso il sistema sopra descritto - le chiavi di decrittaggio. 'aspetto relativo all'utilizzo del trojan per acquisire le chiavi di decrittaggio non risulta essere stato affrontato dalla giurisprudenza (i precedenti relativi ad intercettazioni effettuate su cellulari “blackberry”, di cui si darà conto infra, differiscono dalla situazione in esame perché per essi la socieietà gestrice forniva, su richiesta della Autorità giudiziaria, le comunicazioni decrittate). La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui le prove “atipiche” acquisite in violazione di un divieto derivante da principi costituzionali sono illecite e quindi inutilizzabili. Peraltro, ove si ritenesse che l'utilizzo del captatore informatico sia consentito, nel nostro ordinamento processuale, per effettuare “l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi” (art. 266 bis c.p.p.), si potrebbe sostenere che l'attività di inoculazione del virus informatico, anche funzionale ad acquisire le chiavi di decrittaggio (trasmesse dai “criptofonini” a ciò indotti dal “malware”), si collochi comunque all'interno di una attività “intercettativa” di un flusso di comunicazioni informatiche. Va peraltro rilevato, al contempo, che tale conclusione non è affatto certa, atteso che l'utilizzo del captatore informatico è, nelle diverse disposizioni processuali previste dal codice di rito (artt. 266, commi 2 e 2-bis, 267, commi 1 e 2-bis, 89 disp. att. c.p.p.), autorizzato soltanto per l'inserimento su un “dispositivo elettronico portatile”. V'è altresì da considerare che, ai fini dell'impiego del captatore informatico, il nostro ordinamento, a seguito della recente interpolazione del testo dell'art. 267, comma 1, c.p.p. (intervenuta per effetto dell'art. 1, comma 2-bis, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 137), impone all'autorità giudiziaria l'assolvimento di un rigoroso onere motivazionale non solo nella indicazione delle specifiche ragioni che ne giustificano l'attivazione, ma anche nella esposizione di una autonoma valutazione della necessità, “in concreto”, del ricorso a tale peculiare modalità tecnica di espletamento del relativo mezzo di ricerca della prova. Una motivazione, dunque, “rafforzata”, attraverso la quale il Giudice è chiamato, nel rispetto del canone di proporzionalità, a spiegare le ragioni poste a fondamento dell'utilizzo di uno strumento di indagine particolarmente invasivo della riservatezza delle persone, dando conto, in concreto, del bilanciamento da lui operato tra i diversi beni di rilievo costituzionale confliggenti nel caso di specie. Ove la tesi sopra indicata — secondo la quale è legittimo l'utilizzo del captatore informatico nel caso di specie - sia ritenuta condivisibile, deve poi rilevarsi come, nella medesima prospettiva, sia stata ritenuta “legittima, ove ricorrono i presupposti di legge per l'autorizzazione, la disposizione di un successivo decreto di intercettazione sul medesimo bersaglio o dispositivo elettronico già colpito da attività investigativa, giustificata dalla necessità di far ricorso, per ragioni d'indagine, allo strumento più pervasivo del "captatore informatico", configurandosi in tal caso un nuovo ed autonomo mezzo di ricerca della prova che non presenta interferenze con le intercettazioni telefoniche e/o ambientali già disposte con i mezzi ordinari di captazione” (Cass., sez. 5, 24 settembre 2020, n. 32426).
I suindicati profili problematici si correlano, infine, anche al tema dell’utilizzabilità a fini probatori degli atti compiuti dall'Autorità estera e importati nel nostro ordinamento a mezzo di OEI. Infatti, l'art. 36 D.L.vo cit. stabilisce al comma 1 che “Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale: a) i documenti acquisiti all'estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), ‹assunti all'estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana”. Un secondo nucleo di profili problematici — avente anch'esso un significativo rilievo e correlato al tema della utilizzabilità delle prove “aliene” acquisite nel nostro ordinamento — concerne in particolare la necessità che la difesa possa disporre, ove Io richieda, dell'algoritmo per la decrittazione delle “chat” (algoritmo che, a quanto consta, nel caso in esame non è stato comunicato all'Autorità giudiziaria italiana che ha ricevuto solo le conversazioni già tradotte "in chiaro”). Sul punto, in riferimento alle intercettazioni effettuate su un dispositivo cellulare "Blackberry" è ravvisabile un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, che è anche "rifluito" in alcune delle pronunce relative alle chat intercorse su "sky ecc". Secondo un orientamento, ove l'attività di messa in chiaro di messaggi criptati scambiati mediante sistema "Blackberry" sia svolta dal fornitore del servizio fuori dal contraddittorio, la difesa ha diritto di ottenere, oltre alla versione originale e criptata dei messaggi, anche le chiavi di sicurezza necessarie alla decriptazione, a pena di nullità ex art. 178, lett. c), c.p.p., sanabile dall'istanza di giudizio di abbreviato; in particolare, sul punto si è rilevato che laddove alla difesa - non solo in sede cautelare, ma anche nel corso del giudizio di merito - fosse precluso di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, nella loro versione originale ed integrale, e fosse ‹conseguentemente impedito l'esercizio di ogni potere di controllo, sussisterebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dalla 'violazione della disciplina diretta ad assicurare l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato in una ipotesi in cui, tuttavia, non è obbligatoria la presenza del suo difensore. In senso contrario, un diverso orientamento ha invece ritenuto che, «in tema di intercettazione di comunicazioni telematiche, l'uso dell'algoritmo per la decriptazione della messaggistica con sistema "Blackberry" esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, in quanto, secondo la scienza informatica, ne consente la fedele riproduzione, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario» (Cass., sez. 3, 21 aprile 2022, n. 30395) e che «il difensore delle parti ha diritto di accesso al dato trasmesso in via digitale costituito dalle sequenze alfanumeriche o simboliche rappresentative della comunicazione oggetto di captazione (c.d. stringhe) e dal risultato della decodificazione intellegibile di tali sequenze, in quanto elementi integranti "informazione" o "registrazione" delle conversazioni o comunicazioni ai sensi dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen.» (Cass., sez. 3, 10 aprile 2019, n. 38009). D'altra parte, poi, per quanto riguarda l'attendibilità della decodificazione, non solo, significativamente, l'operazione di decriptazione per l'autorità giudiziaria è effettuata dalla stessa azienda che garantisce l'ordinario e regolare svolgimento delle comunicazioni, e, quindi, la criptazione e decriptazione delle stesse, tra gli utenti dei dispositivi oggetto di intercettazione.
Va infatti rilevato che, come puntualmente osservato in una recente decisione, “in assenza dell'algoritmo necessario alla decriptazione, risulta - secondo la scienza informatica - impossibile avere a disposizione un testo intellegibile in lingua italiana difforme dal reale, potendosi, al più avere, se del caso, una sequenza alfanumerica o simbolica ("stringa") priva di alcun senso», sicché, salvo l'allegazione di specifici e concreti elementi di segno contrario, deve escludersi l'avvenuta manipolazione delle captazioni” (Cass., sez. 6, 27 novembre 2019, n. 14395).
3. Interrogativo pregiudiziale: raccolta massiva di dati o “captazione c.d. mirata”.
Un problema preliminare che l’interprete è chiamato a risolvere è stabilire se le attività istruttorie avviate in Francia si traducano in operazioni di “bulk interception of data”, cioè di raccolta massiva di dati o se, diversamente opinando, si tratti di una “captazione c.d. mirata”.
La giurisprudenza della Corte Edu, da tempo impegnata a tracciare i confini di tutela del diritto alla vita privata e familiare, al domicilio e alla corrispondenza, ha affrontato in più occasioni la delicata questione della captazione massiva di dati, originariamente circoscritta all'intercettazione collettiva — c.d. “sorveglianza segreta” — di telefoni fissi (Corte eur. diritti dell'uomo 6 settembre 1978, Klass e al. c. Germania, in <hudoc.echr.coe.int>), poi progressivamente estesa ai telefoni cellulari Corte eur. diritti dell'uomo 29 giugno 2006, Weber e Saravia c. Germany, in <hudoc.echr.coe.int>; 1° luglio 2008, Liberty e al. c. Regno unito, ibid.; 4 dicembre 2015, Roman Zakharov c. Russia, ibid.) e più di recente alle intercettazioni indiscriminate effettuate dai servizi di intelligence.
I giudici di Strasburgo sono giunti ad ammetterne la liceità “per indagare su alcuni reati gravi” (Corte eur. diritti dell'uomo, grande camera, 25 maggio 2021, Big Brother Watch e al. c. Regno unito, in <hudoc.echr.coe.int>, § 345; 25 maggio 2021, Centrum för Rättvisa c. Svezia, ibid., § 259.) a condizione, però, che vengano previste efficaci garanzie contro il rischio di abusi e di arbitrii nelle fasi di adozione della misura, della sua esecuzione e del controllo successivo.
Per saggiare se le operazioni sky-ecc ed Encrochat, condotte nell'ambito di diversi procedimenti penali, siano qualificabili come “bulk interception of data” e valutarne l'ammissibilità anzitutto rispetto all'art. 8 Cedu, è possibile prendere a parametro di riferimento le indicazioni che i giudici convenzionali hanno fornito nelle citate Big Brother Watch c. Regno unito e Centrum för Rättvisa c. Svezia; pronunce, queste ultime, nelle quali è stata vagliata la conformità di pratiche di sorveglianza di massa — implicanti la raccolta di dati, metadati e comunicazioni elettroniche — con le garanzie previste dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo.
In tanto un'intercettazione può dirsi “di massa” in quanto presenti le seguenti caratteristiche: i) le comunicazioni riguardino un gran numero di persone, molte delle quali non sono affatto di interesse per le autorità di intelligence; ii) la captazione massiva è generalmente diretta alle comunicazioni internazionali; iii) in molti casi, lo scopo dichiarato dell'intercettazione massiva è quello di monitorare le comunicazioni di persone al di fuori della giurisdizione territoriale dello Stato e, infine; iv) l'intercettazione sembra essere utilizzata ai fini della raccolta di informazioni di intelligence estere.
È opportuno sottolineare che l'intercettazione di massa compiuta dai servizi segreti è operazione diversa rispetto a quella esperita nel contesto di un procedimento penale (come nei casi più recenti di sky-ecc ed Encrochat) con scopi di repressione. Anzitutto, diverge lo scopo della raccolta dei dati: l'intelligence solitamente esegue la captazione indiscriminata con l'intento di raccogliere informazioni di servizi segreti stranieri o di individuare e indagare tempestivamente su attacchi informatici, controspionaggio e atti di terrorismo. Le attività in seno alla piattaforma sky-ecc hanno invece perseguito l'obiettivo di contrastare reati di criminalità organizzata dedita al traffico internazionale di stupefacenti.
In secondo luogo, l'intercettazione collettiva in un contesto di intelligence è generalmente diretta alle comunicazioni di persone o organizzazioni al di fuori della giurisdizione territoriale dello Stato. Nell'operazione sky-ecc, il traffico di rete è stato intercettato attraverso l'utilizzo di uno o più trojan horses inoculati su server specifici utilizzati da sky-ecc Globalpresso un unico fornitore di servizi Internet in Francia. Questa intercettazione è dunque “più mirata”.
E infatti, secondo gli organi giurisdizionali di molti Stati europei, le indagini condotte sui criptofonini nei casi sky-ecc ed Encrochat non costituirebbero un'ipotesi di ”bulk interception of data”. Ad esempio, il Tribunale distrettuale di Amsterdam (Corte distrettuale di Amsterdam 17 marzo 2022), chiamato a pronunciarsi sulla vicenda Encrochat,pur ritenendo che possa sussistere «a (potential) large infringement on privacy» — una (potenziale) grande violazione della privacy — ha statuito che non si tratti affatto di “bulk data”, nel senso di raccolta indifferenziata di dati, essendo le captazioni indirizzate a un target definito di persone — gli utenti Encrochat — additate di un sospetto specifico — che la piattaforma venisse impiegata interamente o prevalentemente da partecipanti alla criminalità organizzata per compiere reati.
Tuttavia, stando anche agli ultimi approdi giurisprudenziali, occorre prestare estrema attenzione all'automatismo in forza del quale, considerate le caratteristiche tecniche degli strumenti di messaggistica, la piattaforma criptata possa essere utilizzata «esclusivamente» da membri dell'organizzazione criminale, senza alcuna considerazione in ordine al ruolo eventualmente rivestito dall'imputato, dato che siffatta presunzione si riverserebbe direttamente sulla fairness processuale, pregiudicando l'art. 6 Cedu sotto il profilo del diritto di difesa (V. Veronica, Criptofonini e indagini digitali transfrontaliere su larga scala: un difficile equilibrio tra privacy, fairness processuale ed esigenze di repressione dei reati, in Foro it., 2024, II, 566).
Ciononostante, la motivazione de qua ricorre anche nelle pronunce di altri tribunali olandesi (Corte distrettuale del North Holland 4 maggio 2022; Corte distrettuale del Zeeland-West-Brabant 10 giugno 2022), tra le motivazioni dei giudici di merito italiani (Trib. Reggio Calabria, ord. 29 agosto 2023: si tratta di apparecchi non intercettabili, progettati per le attività criminali e normalmente utilizzati — tenuto conto anche degli esorbitanti costi e della necessità di conoscere i nickname delle persone con cui si vuole conversare — da strutturate organizzazioni criminali), in alcune sentenze della Corte suprema norvegese (Corte suprema norvegese 30 giugno 2022, HR-2022-1314-A, case no. 22-027874STR-HRET, case no. 22-027879STR-HRET e case no. 22-027883STR-HRET) e della Corte suprema federale tedesca (Bundesgerichtshof tedesco, sent. 5 StR 457/21 del 2 marzo 2022); decisioni, queste, in cui è stata stabilita in modo definitivo la legittimità dell'uso dei dati di Encrochat e sky-ecc nei procedimenti penali (per la Francia, Conseil constitutionnel, decisione n. 2022-987 QPC, dell'8 luglio 2022; per la Germania, Bundesgerichtshof, sent. 5 StR 457/21 del 2 marzo 2022, cit.; per i Paesi Bassi, Hoge Raad, sent. 913 del 13 giugno 2023).
Le operazioni di captazione di grandi quantità di dati, in blocco o meno, si articolano in un iter procedurale ben preciso: a) l'intercettazione e la conservazione iniziale delle comunicazioni e dei dati relativi alle comunicazioni (cioè i dati di traffico appartenenti alle comunicazioni intercettate); b) l'applicazione di “selettori specifici” al materiale raccolto; c) l'analisi per estrarne informazioni rilevanti e, infine, d) la successiva conservazione dei dati e il loro impiego, che include eventualmente anche la condivisione con terzi. I giudici convenzionali ritengono che l'art. 8 Cedu proietti la sua tutela lungo ciascun segmento, sebbene l'interferenza sia progressivamente tanto più marcata quanto più avanzata è la fase in cui stazioni l'operazione.
Tra le garanzie che la Corte Edu ritiene necessarie in operazioni che involgono una grande quantità di dati spicca, senza dubbio, il controllo che un'autorità indipendente è chiamata a esercitare su ciascuna fase, in modo tale che l'ingerenza sui diritti umani possa essere limitata a ciò che è “necessario in una società democratica”.
In particolare, l'organo di controllo dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità dell'azione intrapresa, tenendo debitamente conto del corrispondente livello di intrusione nei diritti tutelati dalla convenzione.
Al riguardo dirimente è la presenza di «garanzie end-to-end»: al fine di ridurre al minimo il rischio di abuso, la corte considera che, a livello nazionale, deve essere effettuata una valutazione in ogni fase del processo circa la necessità e la proporzionalità delle misure adottate; che l'intercettazione di massa debba essere soggetta a autorizzazione indipendente all'inizio, quando vengono definiti l'oggetto e l'ambito dell'operazione; e che l'operazione debba essere soggetta a supervisione e revisione indipendente ex post facto.
Secondo la corte, queste sono salvaguardie fondamentali di qualsiasi regime di intercettazione di massa conforme all'art. 8 Cedu. È altamente probabile che, a prescindere dalla circostanza che si tratti di “bulk data” o meno, analoghe garanzie verranno richieste anche nei casi sky-ecc ed Encrochat.
Nella prima fase — quella che potremmo definire di “raccolta” — le autorità francesi hanno ottenuto un'autorizzazione per intercettare i dati per un periodo di tempo limitato e per trasferirli ad altri Stati al fine di trovare una soluzione per decifrare il traffico di rete. Una tecnica di decriptazione, sviluppata dalle autorità olandesi (c.d. “sistema Hansken”), è stata poi condivisa con la polizia francese. Un giudice d'oltralpe ha quindi successivamente autorizzato l'intercettazione per un periodo di tempo più lungo. In sintesi, un test sulla necessità e la proporzionalità si è svolto nella fase di raccolta dell'operazione sky-ecc.
Le attività compiute in Francia debbono essere considerate legittime sulla base del principio di fiducia reciproca: tra gli Stati membri dell'Unione non sussistono regole uguali per l'assunzione della prova; si suppone, invece, un analogo livello di protezione dei diritti individuali. Quando emette un o.e.i. diretto al trasferimento di prove esistenti, l'autorità di emissione è vincolata al principio del mutuo riconoscimento, che costituisce la “pietra angolare” su cui si fonda la cooperazione in materia penale nell'Unione europea. Poiché i dati di Encrochat e sky-ecc sono stati intercettati dalle autorità francesi nell'ambito di un'indagine condotta sulla base del loro codice di procedura penale, il ricorso al principio della mutual trust implica che gli organi giurisdizionali chiamati a valutare gli esiti delle attività istruttorie condotte in Francia, debbono ritenere affidabili e legittime le intercettazioni dei dati.
La circostanza che la prima delle quattro fasi, quella di raccolta, sia stata assistita dalle garanzie procedurali necessarie assicura la legittimità delle attività istruttorie francesi sul versante dell'art. 8 Cedu. Resta, quindi, da determinare se le operazioni compiute — tanto in Francia, quanto in Italia dopo la trasmigrazione dei dati e ancora coperte da segreto di Stato — siano state condotte in maniera tale da rispettare i diritti sanciti, nell'alveo del giusto processo, dall'art. 6 Cedu. Fatta salva la necessità del relativo bilanciamento con interessi quali la sicurezza nazionale o la segretezza dei metodi di indagine della polizia, infatti, occorre verificare se gli atti istruttori richiesti siano stati acquisiti nel rispetto delle garanzie procedimentali che, anche alla luce del diritto interno (art. 268, commi 6, 7 e 8, c.p.p.), obbligano a mettere la difesa nelle condizioni di conoscere le modalità di acquisizione delle comunicazioni scambiate mediante il sistema sky-ecc, per verificare la corrispondenza dei testi acquisiti in originale e dei testi decodificati, nonché la coincidenza delle utenze dei soggetti identificati come mittenti e destinatari (V. Veronuca, Criptofonini e indagini digitali transfrontaliere su larga scala: un difficile equilibrio tra privacy, fairness processuale ed esigenze di repressione dei reati, cit.).
4. L’estensione della disciplina interna sulla circolazione delle prove fra procedimenti diversi.
Le Sezioni Unite si sono occupate preliminarmente di individuare la natura delle operazioni istruttorie in questione, le quali non consistono in un’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero” ai sensi dell’art. 234 bis c.p.p. (M. Daniele, Ordine europeo di indagine penale e comunicazioni criptate: il caso Sky ECC/Encrochat in attesa delle Sezioni Unite, in sistemapenale.it, 11 dicembre 2023; E. Lorenzetto, L’acquisizione all’estero di comunicazioni digitali criptate nella fucina dell’ordine europeo di indagine penale, in Cass. pen., 2024, p. 182 s.).
Quest’ultima, osserva la Corte di cassazione, è una disciplina “alternativa e incompatibile” rispetto a quella dettata in tema di OEI; essa “prescinde” “da forme di collaborazione con l’autorità giudiziaria di altro Stato”, laddove il Considerando 35 della direttiva qualifica l’OEI come prevalente su tutti gli altri pertinenti strumenti internazionali che dovessero concorrere in materia.
Nel caso dell’OEI operano le garanzie che devono assistere la raccolta delle prove tramite questo strumento. In particolare, il principio di equivalenza, ai sensi di cui l’atto di indagine richiesto nell’OEI dovrebbe poter essere emesso “alle stesse condizioni in un caso interno analogo”; e il principio di proporzionalità, il quale esige che le eventuali compressioni dei diritti fondamentali originate dalle attività istruttorie siano contenute nello stretto necessario, e comunque non intacchino i nuclei essenziali dei medesimi.
Il problema, qui, è comprendere come tali principi operino rispetto a prove che, in quanto autonomamente raccolte dalle autorità straniere, sono già state preformate sulla base della lex loci, a prescindere dalle regole previste dalla lex fori.
Siccome la direttiva e il d.lgs. n. 108 del 2017 si disinteressano della questione, non resta che prendere le mosse dall’art. 78 disp. att. c.p.p., relativo all’acquisizione della “documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera”: una prescrizione concepita in un momento storico in cui l’unico strumento di raccolta transnazionale delle prove era rappresentato dalle rogatorie, ma che può senz’altro essere ritenuta applicabile anche all’OEI. (M. Daniele, Le sentenze gemelle delle Sezioni Unite sui criptofonini, in www.sistemapenale.it).
Vi si prevede, al comma 1, che la documentazione in questione “può essere acquisita” nei procedimenti penali nazionali “a norma dell’articolo 238 del codice”: vale a dire, delle prescrizioni che, in ambito nazionale, regolano la circolazione delle prove da un procedimento penale ad un altro.
Per le Sezioni Unite, venendo in gioco prove già autonomamente raccolte dalle autorità straniere prima dell’emissione dell’OEI, l’equivalenza con in casi interni analoghi va parametrata in rapporto non alla disciplina nazionale della “formazione”, ma a quella della “circolazione” delle prove fra procedimenti diversi.
Da tale premessa, ne discende quale corollario che in questi casi le sole regole probatorie rilevanti ai fini dell’acquisizione in Italia delle prove già raccolte all’estero sono quelle rinvenibili nell’art. 238 c.p.p., a cui l’art. 78 disp. att. rinvia; nonchè, qualora le prove fossero state acquisite con le forme delle intercettazioni di comunicazioni, quelle rinvenibili nell’art. 270 c.p.p., il quale, sebbene non espressamente richiamato, può ritenersi applicabile in virtù della logica sottesa all’art. 78 disp. att.
5. Nessun controllo giurisdizionale anticipato nello Stato di emissione.
Inoltre, per il giudice di legittimità deve escludersi che per l’emissione di un OEI finalizzato all’acquisizione di comunicazioni criptate già autonomamente raccolte all’estero, sia necessaria l’autorizzazione preventiva di un giudice dello Stato di emissione.
Se la circolazione di prove del genere da un procedimento ad un altro avvenisse a livello nazionale, tale autorizzazione preventiva non servirebbe, in quanto non richiesta nè dall’art. 238, nè dall’art. 270 c.p.p.
In applicazione del principio di equivalenza, pertanto, la Corte di cassazione ritiene che pure il corrispondente OEI possa essere emesso direttamente da un pubblico ministero. Ciò, si badi bene, anche quando le prove richieste fossero già state raccolte all’estero attraverso intercettazioni o acquisizione di tabulati: vale a dire, operazioni istruttorie che, a differenza delle perquisizioni e dei sequestri, a livello nazionale non potrebbero essere disposte direttamente dal pubblico ministero, ma necessiterebbero di una preventiva autorizzazione giurisdizionale.
Tale conclusione trova una conferma anche nella più sopra menzionata sentenza della Corte di giustizia relativa al caso Encrochat.
Il pubblico ministero, osservano i giudici di Lussemburgo, figura tra i soggetti che, ai sensi dell’art. 2 lett. c della direttiva, possono costituire un’autorità di emissione dell’OEI. L’unica condizione è che l’organo di accusa sia competente, in un caso interno analogo, “ad ordinare un atto di indagine diretto alla trasmissione di prove già in possesso delle autorità nazionali competenti”.
6. Il controllo giurisdizionale non è escluso (anche se postumo).
Sotto il profilo della garanzia del diritto costituzionale della libertà personale, la Corte di cassazione non esclude che nello Stato emissione sia possibile prescindere da un vaglio giurisdizionale tout court.
Ciò discende dal già ricordato obbligo di rispettare i diritti fondamentali nei limiti del principio di proporzionalità, rispetto a cui il controllo giurisdizionale rappresenta un prerequisito essenziale.
Neppure va trascurata l’esigenza di assicurare che agli atti istruttori richiesti nell’OEI siano applicabili “mezzi d’impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo”, tali da permettere, nell’ambito dello Stato di emissione, di contestare le “ragioni di merito dell’emissione dell’OEI”.
Inoltre, lo Stato di emissione dovrebbe assicurare un mezzo di impugnazione nei confronti dell’OEI perfino quando questo non fosse contemplato in rapporto ad un caso interno analogo: un dovere non statuito dalla direttiva, ma introdotto dalla sentenza Gavanozov II della Corte di giustizia dell’Unione Europea in applicazione del diritto ad un ricorso effettivo previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), al fine di assicurare uno standard di tutela unitario indipendente dalle caratteristiche degli ordinamenti dei singoli Stati (Corte giust., 11 novembre 2021, Gavanozov II, C-852/19).
Il giudice della nomofilachia ritiene di attribuire tale vaglio al giudice nazionale chiamato ad utilizzare le prove autonomamente raccolte all’estero e trasmesse tramite l’OEI: in particolare, al giudice di merito o al giudice chiamato ad applicare una misura cautelare, i quali conservano “integro il potere di valutare se vi siano i presupposti” per “ammettere” ed “utilizzare” tali prove ai fini delle decisioni di loro spettanza”.
A tale soluzione si potrebbe contestare che così non si garantirebbe il diritto al controllo giurisdizionale attraverso un mezzo specifico di impugnazione, postulato dalla sentenza di Gavanozov II della Corte di giustizia a prescindere dalla sua previsione da parte dell’ordinamento dello Stato di emissione in un caso interno analogo, ma è stato efficacemente sottolineato in dottrina che tale diritto, in quella sentenza, non è identificato in modo così netto. Per quanto, infatti, la Corte di giustizia richieda che le persone coinvolte dagli atti istruttori disposti con l’OEI dispongano di “mezzi di impugnazione appropriati”, essa comunque non esclude che si possa equiparare a questi ultimi il vaglio di ammissibilità operato dal giudice dello Stato di emissione chiamato ad utilizzare le prove (M. Daniele, Le sentenze gemelle delle Sezioni Unite sui criptofonini, cit.).
Ne consegue che il controllo giurisdizionale ex post esercitato dal giudice deputato ad utilizzare le prove già autonomamente raccolte all’estero può risultare sufficiente.
Il vero problema, piuttosto, riguarda i limiti di tale controllo.
L’art. 14 § 7 della direttiva si limita a richiedere il rispetto dei “diritti della difesa” e delle “garanzie del giusto processo nel valutare le prove acquisite tramite l’OEI”.
A livello nazionale, non è molto più preciso l’art. 36 del d.lgs. n. 108 del 2017, che ripropone la medesima regola prevista dall’art. 431 comma 1 lett. d c.p.p. per l’utilizzabilità delle prove raccolte tramite le rogatorie: sono ammissibili i “verbali degli atti” “assunti all’estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana”.
La laconicità dei testi normativi comporta il rischio di sfumare i contorni del controllo esercitato dal giudice chiamato ad utilizzare le prove.
Le sentenze in commento precisa che ai fini dell’utilizzabilità nello Stato di emissione di atti acquisiti mediante OEI, “è necessario garantire il rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo”; “ma non anche l’osservanza, da parte dello Stato di esecuzione, di tutte le disposizioni previste dall’ordinamento giuridico italiano in tema di formazione ed acquisizione di tali atti”, considerato che nessuna norma della direttiva e del d.lgs. n. 108 del 2017 “prevedono, ai fini dell’utilizzabilità degli atti formati all’estero, la necessità di una puntuale applicazione di tutte le regole che l’ordinamento giuridico italiano fissa, in via ordinaria, per la formazione degli atti corrispondenti formati sul territorio nazionale”.
Dalla lettura dell’ordito motivazionale sembra che le Sezioni Unite individuano almeno due specifici requisiti di utilizzabilità.
Anzitutto, quando vengano in gioco prove raccolte autonomamente all’estero tramite atti che, come le intercettazioni o l’acquisizione di tabulati, a livello nazionale richiederebbero l’autorizzazione preventiva di un giudice, la Corte di cassazione pare richiedere una condizione ben precisa: il fatto che l’acquisizione delle suddette prove fosse a suo tempo stata autorizzata ex ante da un giudice nello Stato di esecuzione.
Tale presupposto, perlomeno nel caso esaminato dalla sentenza Giorgi, poteva ritenersi integrato, se si considera che le comunicazioni criptate erano state acquisite a seguito di provvedimenti motivati emessi da juges d’instruction francesi.
In secondo luogo, la sentenza Giorgi aggiunge che, qualora le comunicazioni fossero state autonomamente acquisite all’estero con la forma delle intercettazioni, sarebbe necessaria la loro rilevanza per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, così come previsto dall’art. 270, comma 1, c.p.p.
Qualora, poi, tali intercettazioni fossero state eseguite all’estero in rapporto ad indirizzi di comunicazione situati in Italia, opererebbe senz’altro l’obbligo di notifica delle operazioni alle competenti autorità italiane in forza degli artt. 31 della direttiva e 24 del d.lgs. n. 108 del 2017. In questi casi, le intercettazioni diverrebbero inutilizzabili qualora non fossero ammissibili in un caso interno analogo: vale a dire, per quanto concerne l’Italia, se fossero state disposte in rapporto a reati per i quali non sarebbero consentite secondo l’ordinamento interno.
Inoltre, “l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire la violazione di diritti fondamentali grava sulla difesa, quando è questa a dedurre l’inutilizzabilità o l’invalidità di atti istruttori acquisiti dall’autorità giudiziaria italiana mediante OEI”: un principio, quest’ultimo, anch’esso operante nel settore delle rogatorie (Cass., Sez. 2, 18 maggio 2010, n. 24776), e comunque in linea con quanto avviene a livello nazionale, laddove spetta a chi afferma l’esistenza di un’invalidità processuale addurre i fatti che ne sono a fondamento.
Considerazioni non molto diverse sono, del resto, rinvenibili nella sentenza Encrochat della Corte di giustizia, laddove si legge che l’autorità di emissione, quando intenda ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle competenti autorità dello Stato di esecuzione, “non è autorizzata a controllare la regolarità del distinto procedimento con il quale lo Stato membro di esecuzione ha raccolto le prove di cui essa chiede la trasmissione”. Diversamente, si correrebbe il rischio di condurre ad un “sistema più complesso e meno efficace”, in violazione dei principi del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca che connotano il sistema della cooperazione giudiziaria nell’ambito dell’Unione Europea.
7. Il controllo sulle ragioni di merito dell’emissione dell’OEI.
Al contrario, il controllo operato dal giudice nazionale chiamato ad utilizzare le prove, anche se già autonomamente raccolte all’estero, non può prescindere da un vaglio del rispetto dei presupposti di merito di emissione dell’OEI stabiliti dalla lex fori.
Si tratta di un controllo che, specie laddove la lex loci non fosse contraddistinta da adeguati standard di garanzia, costituisce un passaggio indispensabile per assicurare che le attività istruttorie, nel comprimere i diritti fondamentali e, in particolare, la garanzia di riservatezza (artt. 8 CEDU e 7 Carta di Nizza) di cui godono le comunicazioni di cui di discute, rispettino il principio di proporzionalità.
In particolare, laddove le operazioni istruttorie fossero avvenute all’estero con le forme delle intercettazioni o dell’acquisizione di tabulati, tale vaglio, sia pure nel rispetto dell’onere di allegazione a carico di chi proponga eventuali contestazioni, non potrebbe trascurare i requisiti la cui inosservanza, a livello nazionale, determinerebbe l’inutilizzabilità delle prove raccolte: si pensi alla presenza di indizi dei reati elencati dal codice e, per quanto concerne le intercettazioni, all’assoluta indispensabilità.
Qualche accenno in questo senso è, peraltro, rinvenibile nella decisione Encrochat della Corte di giustizia, laddove si afferma che “il carattere necessario e proporzionato” dell’emissione dell’OEI deve essere “valutato unicamente” alla luce del diritto dello Stato di emissione, e si ribadisce la necessità di evitare che l’impiego dell’OEI ai fini della trasmissione di prove già autonomamente raccolte all’estero abbia l’effetto di eludere le condizioni previste dalla lex fori.
“Di conseguenza”, concludono i giudici di Lussemburgo, “se l’acquisizione di prove già in possesso delle autorità competenti di un altro Stato membro dovesse o apparire sproporzionata ai fini dei procedimenti penali avviati a carico dell’interessato nello Stato di emissione, ad esempio in ragione della gravità della violazione dei diritti fondamentali di quest’ultimo, oppure essere stata disposta in violazione del regime giuridico applicabile a un caso interno analogo, l’organo giurisdizionale investito del ricorso contro l’ordine europeo di indagine che dispone tale trasmissione dovrebbe trarne le conseguenze che si impongono in base al diritto nazionale”. Ossia, verrebbe da dire, dovrebbe applicare i divieti probatori che, a parità di condizioni, opererebbero in casi interni analoghi.
8. Modalità di raccolta delle prove da parte dell’autorità straniera e controllo giurisdizionale.
Il controllo operato dal giudice nazionale chiamato ad utilizzare le prove, sempre in osservanza dell’onere di allegazione a carico di chi eccepisca una violazione, deve riguardare anche le modalità con cui esse sono state raccolte all’estero, specie laddove queste fossero tali, in ambito nazionale, da originare un divieto probatorio.
Qui viene in gioco un problema connesso alla peculiare natura delle operazioni istruttorie di cui si discute, le quali consistono in sofisticate attività di acquisizione e di decriptazione da svolgere attraverso idonee tecniche informatiche e specifici algoritmi. Il pericolo, se non vengano compiute in modo corretto, è che diano origine ad esiti falsati, e non siano quindi in grado di rappresentare fedelmente il contenuto delle comunicazioni.
Al fine di scongiurare questo rischio, l’ideale sarebbe che la difesa della persona sotto procedimento potesse venire a conoscenza delle modalità di acquisizione delle comunicazioni e, in particolare, degli algoritmi utilizzati per decriptarle. In questo modo, anche attraverso la nomina di consulenti tecnici di parte, si realizzerebbe un pieno contraddittorio di tipo tecnico, prezioso per la corretta valutazione del peso probatorio delle comunicazioni acquisite (M. Daniele, Le sentenze gemelle delle Sezioni Unite sui criptofonini, in www.sistemapenale.it).
Il problema, tuttavia, è che spesso la trasmissione di tali informazioni da parte delle autorità straniere non avviene: vuoi per esigenze di segretezza dei metodi di indagine impiegati, al fine di non consentire agli esponenti della criminalità di prendere contromisure volte a nascondere le proprie comunicazioni attraverso tecniche informatiche ancora più efficaci; vuoi, addirittura, per esigenze di sicurezza nazionale, magari tali da giustificare l’apposizione del segreto di Stato.
In casi del genere, non ne deriverebbe l’inutilizzabilità delle prove: tale esito non si verificherebbe neppure a livello nazionale, non essendo rinvenibile nel nostro sistema un divieto probatorio volto a sanzionare questo tipo di situazioni. È chiaro, tuttavia, che il contraddittorio ne risulterebbe depotenziato, potendo conseguirne una distorsione dell’accertamento dei fatti.
Ed è essenziale che il giudice chiamato ad utilizzare le prove ne sia ben consapevole, in modo tale da andare alla ricerca di adeguati elementi di riscontro alle prove così ottenute.
Le Sezioni Unite affermano che l’impossibilità per la difesa di conoscere gli algoritmi utilizzati dall’autorità giudiziaria straniera per la decriptazione delle comunicazioni “non determina, almeno in linea di principio, una violazione di diritti fondamentali”. Se è vero, ammette la Corte di cassazione, che la disponibilità di tale algoritmo è “funzionale al controllo di affidabilità del contenuto delle comunicazioni”, deve però osservarsi che “il pericolo di alterazione dei dati non sussiste, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, per cui una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo, anche solo parzialmente”.
9. Nessuna critica?
Le due sentenze delle sezioni unite lasciano aperti molteplici interrogativi in ordine alla mancata conoscenza dei contenuti digitali, alla conseguente impossibilità delle difese di contrastarne gli esiti nonché da ultimo in relazione alla sufficienza del controllo giurisdizionale ex post rispetto ai gravi vulnera arrecati alla difesa.
L'assunzione a parametro “d'importazione” dell'art. 270 c.p.p., stando a quanto stabilito dai commi 2 e 3 della disposizione, dovrebbe garantire anche nella vicenda ad quem l'accesso diretto alla fonte di prova; accesso diretto che è stato reputato dalla Corte costituzionale (Corte cost. 10 ottobre 2008, n. 336) presupposto indefettibile per valutare la genuinità della prova e per verificare l'effettiva valenza dimostrativa degli elementi probatori. Ove il dato grezzo — che dovrebbe essere depositato unitamente a tutti i metadati — sia criptato, sarebbe necessario mettere a disposizione delle parti e del giudice la chiave per decifrarlo. Nella medesima direzione si muove peraltro l'art. 14, par. 7, della direttiva sull'ordine europeo di indagine, che nell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia (Corte giust. 30 aprile 2024, causa C-670/22, M.N., cit.) impone di espungere dal procedimento informazioni ed elementi di prova idonei ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti se l'imputato non sia in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni.
L'approdo dei giudici di Lussemburgo parrebbe andare ben oltre le conseguenze della nullità a regime intermedio argomentabile dalla disciplina dell'intercettazione in caso di violazione delle disposizioni procedurali, per giungere sino ad affermare una vera e propria regola generale di inutilizzabilità patologica.
Secondo il costrutto delle sezioni unite, invece, l'asserita infallibilità dell'algoritmo — cui segue una fideistica presunzione di integrità dei dati trasmessi dall'autorità straniera — renderebbe del tutto superflua ogni garanzia difensiva di accesso, minando in radice il diritto di difesa (V. Veronica, Criptofonini e indagini digitali transfrontaliere su larga scala: un difficile equilibrio tra privacy, fairness processuale ed esigenze di repressione dei reati, cit. che evidenzia che l'impiego crossborder della prova allogena digitale acquisita su larga scala con mezzi tecnologici invasivi e decriptata fuori dal contraddittorio è elemento conoscitivo a tal punto seduttivo da divenire centro di gravità fagocitante le garanzie processuali: presunzioni di legittimità, di integrità, di genuinità e di affidabilità — disinvoltamente affermate dalle sezioni unite — evocano il sospetto, più che giustificato, che difficilmente le soluzioni delle sentenze in rassegna, sotto il versante del diritto di difesa e della parità delle armi, resisterebbero al giudizio incisivo della Corte europea dei diritti dell'uomo).
Pubblichiamo questo contributo in occasione del centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini, nato a Lucca il 22 dicembre 1858 e scomparso a Bruxelles il 29 novembre 1924. La prima parte del contributo, apparsa su Questa Rivista il 30 novembre 2024, si può leggere qui.
All’alba vincerò!
La vittoria di Giacomo Puccini sul tempo. PARTE SECONDA.
di Gerardo Casiello
Sommario: PARTE PRIMA 1. Sei generazioni di musicisti – 2. Trenta chilometri a piedi per Aida – 3. Anni difficili a Milano – 4. Tonio Puccini e la fine di una stirpe di musicisti – 5. Un miracolo a Milano – 6. Le Villi, l’esordio operistico di Puccini – 7. L’influenza di Wagner – 8. Edgar: “la cosa più orribile che sia mai stata scritta” – 9. Anni difficili alla vigilia della gloria – 10. In anticipo sulla musica per il cinema – 11. Puccini e i suoi contemporanei – 12. Bohème: una sfida tra amici – 13. Il gioco e la caccia – 14. Caruso e Puccini: due amici ambasciatori dell’Italia nel mondo – 15. E lucean le stelle – 16. Il grammofono di casa Puccini – 17. Puccini e le “sue donne” – 18. Madama Butterfly – 19. Un fortunatissimo fiasco. PARTE SECONDA 20. Una tragedia in casa Puccini – 21. Il figlio illegittimo – 22. La fanciulla del west – 23. La grande guerra e La rondine – 24. Tre opere in una – 25. Un capolavoro incompiuto – 26. “Qui termina la rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto” – 27. Puccini ascolta Puccini.
20. Una tragedia in casa Puccini.
Giacomo Puccini ha sempre viaggiato molto nonostante preferisse restarsene in disparte nella sua adorata villa di Torre del Lago. Durante i suoi viaggi che il più delle volte coincidevano con allestimenti delle sue opere, il Maestro aveva la possibilità di confrontarsi con altre realtà sociali, di conoscere nuove persone e suggestionarsi per trovare nuove storie sulle quali lavorare.
Fu nel gennaio del 1907, durante un allestimento a New York della terza revisione di Madama Butterfly, che Puccini ebbe l’occasione di assistere al nuovo dramma teatrale di David Belasco intitolato The girl of the golden west rimanendone fortemente impressionato, tanto da chiedere subito all’autore di poterne trarre un’opera lirica. Nell’autunno del 1907 era già al lavoro; essendo Giuseppe Giacosa morto nel 1906, e con Luigi Illica il rapporto non era proprio dei migliori, per il libretto della nuova opera La fanciulla del West, si affidò al poeta Carlo Zangarini e allo scrittore Guelfo Civinini.

[Giacomo Puccini durante l’allestimento di un’opera]
Gli anni tra il 1907 e il 1910 furono molto tumultuosi nella vita privata di Puccini. La Fanciulla del West ha un modello femminile riconducibile alla vita reale del Maestro: Giulia Manfredi, giovane donna che gestiva, insieme al padre, una trattoria sulla terrazza del molo di fronte casa di Puccini a Torre del Lago.
Giacomo era un assiduo frequentatore del posto, soprattutto dopo le sue battute di caccia. La ragazza, dal carattere forte e deciso, affascinò il compositore a tal punto che divennero amanti. La cugina di Giulia, Doria Manfredi, lavorava da alcuni anni come domestica a casa Puccini ed era il tramite tra il musicista e la sua amante, era colei che recapitava le lettere e i messaggi. La giovane Doria ebbe la sventura di cogliere in flagrante adulterio la figliastra di Puccini, Fosca, con il librettista Guelfo Civinini. Fosca, avendo notato la vicinanza di Doria al Maestro, si vendicò instillando in sua madre Elvira il dubbio di una relazione di Giacomo con la ragazza. La moglie del compositore divenne intrattabile e, dopo aver licenziato la ragazza, la ingiuriò per tutto il paese a tal punto che la giovane, non sopportando più il peso delle calunnie, si suicidò avvelenandosi.
Dall’autopsia risultò che Doria era vergine e la famiglia Manfredi denunciò Elvira che fu condannata a cinque mesi di carcere; non scontò mai la pena perché Puccini pagò 12.000 lire ai parenti della ragazza per chiudere il caso.
La figura di Doria la si ritroverà poi con il personaggio di Liù in Turandot.
Dopo questo scandalo Puccini si separò dalla moglie e vissero divisi per un periodo.
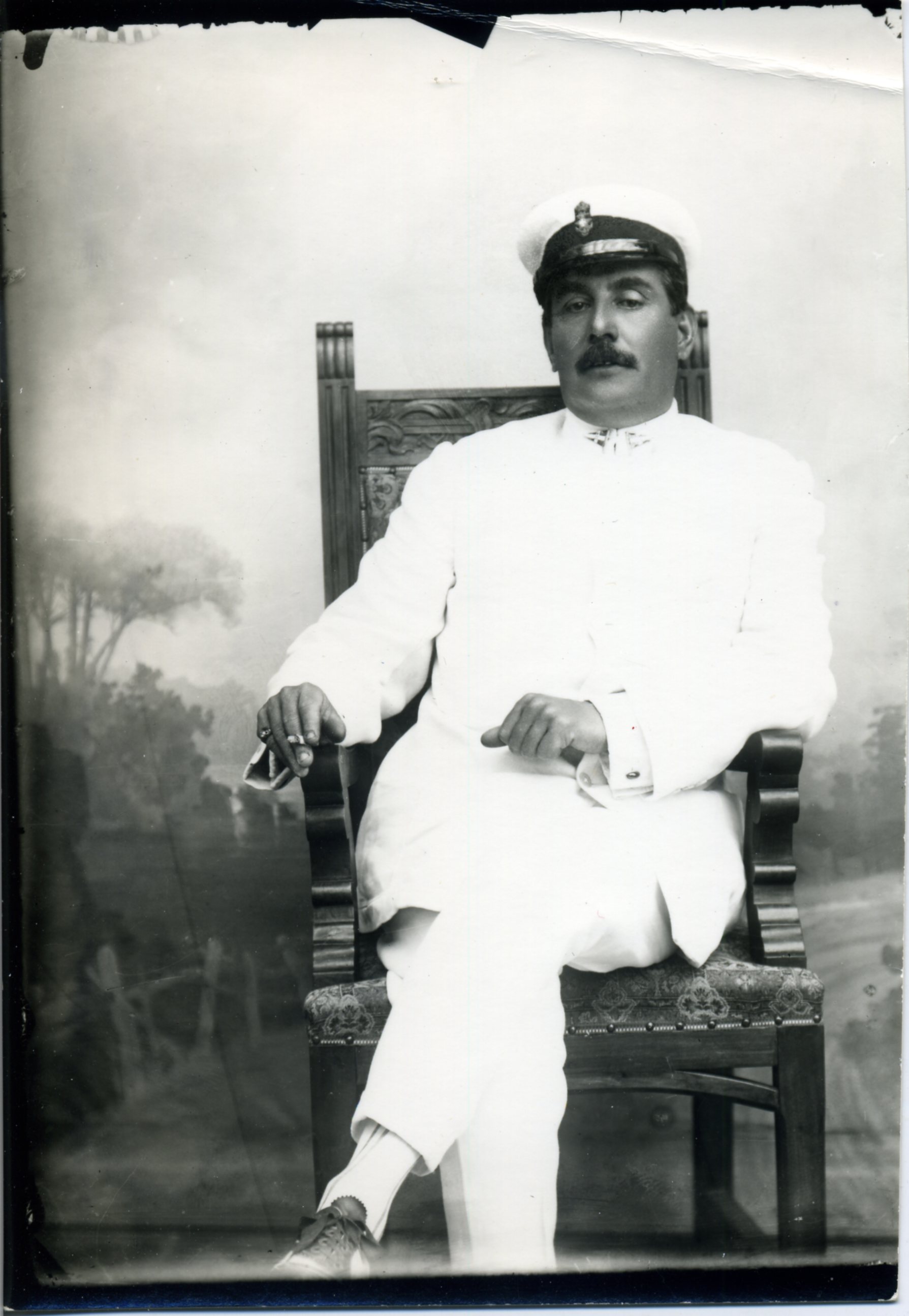
[Giacomo Puccini in uniforme da marinaio]
21. Il figlio illegittimo.
Giulia Manfredi, che fu amante del Maestro per circa 16 anni, nel 1923 si allontanò da Torre del Lago e, nella città di Pisa, diede alla luce un figlio nato dalla relazione con il musicista; il bambino fu chiamato Antonio, come il fratellastro, e portò il cognome della madre. Per più di un anno Puccini mandò regolarmente soldi alla famiglia che cresceva il bambino a Pisa ma poi, dalla morte del compositore avvenuta nel 1924, Giulia dovette provvedere da sola al mantenimento del figlio “segreto”. Ad Antonio fu sempre proibito di andare dalla madre a Torre del Lago.
Nel 1976, alla morte di Giulia, il figlio si recò al paese per prendere tutte le cose ereditate dalla madre, tra cui una valigia rimasta sepolta nella cantina di Manfredi per molti anni. Antonio scomparve nel 1988.
Nel 2008, il regista Paolo Benvenuti, dopo aver fatto interviste a persone molto anziane di Torre del Lago, venne a conoscenza dell’esistenza degli eredi di Giulia Manfredi residenti a Pisa. Benvenuti riuscì a rintracciare Nadia Manfredi nipote di Giulia e, dopo varie interviste che ricostruirono la storia fu recuperata, nella cantina che fu di Antonio, una valigia che conteneva numerosi documenti che riguardavano Giacomo e Giulia, numerosissime lettere e persino un filmino amatoriale risalente al 1915 che ritraeva il Maestro in scene di vita quotidiana nella sua casa.
Grazie a questa scoperta il regista Paolo Benvenuti e la moglie Paola Baroni hanno tratto un soggetto dalla storia e realizzato il film intitolato Puccini e la fanciulla.
22. La fanciulla del west.
Oltre al dramma di Belasco, Puccini fu ispirato anche dalla sua tragedia personale per la composizione de La fanciulla del west.
L’opera è ambientata in California nel contesto della corsa all’oro, un’epoca di grande tumulto e opportunità dove emergono temi di avventura e conflitto. La storia è situata in un saloon e tra i cercatori d’oro, conferendo un’atmosfera western che fu molto innovativa per l’epoca.
La protagonista Minnie è proprio come Giulia Manfredi, una figura forte e autonoma che sa difendersi e prendere decisioni coraggiose.
La donna è disposta a mettere a rischio la sua vita e il suo benessere per difendere il suo amato Dick, facendo emergere sentimenti di amore, sacrificio e giustizia. Puccini incorpora nell’opera scale esatonali, forti dissonanze e passaggi cromatici, mostrando ancora l’influenza di compositori a lui contemporanei come Debussy e Strauss. Questa evoluzione armonica segna una distanza rispetto alle convenzioni melodiche più tradizionali delle sue opere precedenti.
L’uso di accordi di nona e l’impiego di scale per toni interi contribuiscono a creare atmosfere nuove e suggestive.
Puccini utilizza inoltre melodie folkloristiche americane come Dooda dooda day, Ninna-nanna Pellerossa ispirata ai canti indiani, e ritmi di danza americani tipici dell’epoca come il Cakewalk per dare autenticità all’ambientazione western.
Questo approccio non solo arricchisce la partitura ma rende anche omaggio alla cultura statunitense.
A differenza delle opere precedenti di Puccini, i personaggi in La Fanciulla del West non cantano melodie o temi ricorrenti nel modo consueto; piuttosto, il loro stile è più parlato e azione-orientato, riflettendo una nuova direzione nella scrittura operistica.
Altre grandi innovazioni che Puccini inserisce nell’orchestra sono gli effetti sonori che saranno poi ampiamente utilizzati nel cinema: utilizza l’eliofono ossia una macchina che riproduce il suono del vento; si fa costruire apposta uno strumento chiamato Fonica che produce un particolare effetto di vibrato. Specifica inoltre in partitura l’inserimento di fogli di carta tra le corde dell’arpa per imitare il suono del banjo. In quest’opera Puccini porta la sua drammaturgia a un punto molto alto e cerca di fondere insieme tradizione europea e americana.
La fanciulla del west esordì il 10 dicembre del 1910 a New York presso il Metropolitan diretta da Arturo Toscanini con un cast di primordine tra cui Enrico Caruso, Emmy Destinn e Antonio Pini-Corsi.
Fu un clamoroso successo di pubblico ma la stampa specializzata come al solito fu spietata. Alcuni critici, come Sylvester Rawling, contestarono l’autenticità dell’opera, affermando che le melodie all’italiana suonavano fuori luogo nel contesto dei minatori americani. Gustav Kobbé invece sottolineò che l’opera non riusciva a catturare l’atmosfera locale e che i personaggi sembravano solo italiani travestiti da americani.
La storia si svolge nel saloon Polka gestito da Minnie, una giovane donna forte e indipendente. Il locale è frequentato da cercatori d’oro e fuorilegge. Tra i vari personaggi c’è Dick Johnson, un fuorilegge che si innamora di Minnie. Anche se Minnie è affascinata da lui, è insicura riguardo la sua vera identità. I minatori parlano della vita difficile nella miniera e della loro speranza di trovare oro; si fa anche riferimento al fatto che il bandito Jack Rance, il capo dei fuorilegge e sceriffo della zona, ha un interesse per Minnie.
Dick e Minnie approfondiscono il loro legame, lei però scopre che lui è un fuorilegge. Nonostante ciò, i loro sentimenti si intensificano. Nel frattempo, Jack Rance cerca di sedurre Minnie e, scoprendo la presenza di Dick, minaccia di rigorosamente farlo arrestare. La situazione si fa drammatica quando Minnie deve fare una scelta: il suo amore per Dick o la sua lealtà verso la legge.
Dick viene poi braccato dagli uomini di Rance e Minnie, nel tentativo di proteggerlo, affronta le forze dell’ordine e costruisce poi un piano per salvarlo. Con astuzia e coraggio, la donna riesce a salvare Dick dimostrando che il vero amore può superare le avversità. Alla fine Minnie e Dick riusciranno finalmente stare insieme.
23. La grande guerra e La rondine.
Dopo un periodo di separazione, a seguito della tragedia di Doria Manfredi del 1909, Puccini ritornò a vivere con la moglie Elvira; il rapporto però fu sempre conflittuale e il compositore si distraeva immergendosi nella lettura, nella scrittura della sua musica, ricercando sempre materiale per nuovi progetti.
Nel 1913 il Carltheater di Vienna gli commissionò un nuovo lavoro: un’operetta in un solo atto, ma il Maestro fu fortemente insoddisfatto del lavoro dei librettisti Alfred Willner e Heinz Reichert. Il contratto con Vienna fu poi sciolto a causa dello scoppio della prima guerra mondiale e Puccini, liquidati i librettisti affidategli dal teatro di Vienna, ripensò completamente l’assetto drammaturgico e trasformò il progetto iniziale in un’opera in tre atti. Per il libretto contattò il commediografo Giuseppe Adami con il quale intrecciò un rapporto di profonda amicizia e grande intesa professionale.
La Rondine occupa un posto unico nella produzione pucciniana, rappresentando una transizione verso un’opera più moderna e disincantata. È l’unica opera di Puccini priva di dialoghi parlati e può configurarsi come una commedia lirica.
La sua struttura atipica e i numerosi ripensamenti del Maestro mettono in discussione il concetto di capolavoro; l’uso di ritmi di danza riflette le influenze musicali contemporanee, dal valzer al tango, creando un’atmosfera meno drammatica e più giocosa. Mentre molte opere pucciniane esplorano il sacrificio e la tragedia, La Rondine affronta l’amore in modo più leggero e autoironico, con un finale che promuove la consapevolezza e la libertà essendo dunque un esperimento audace nella sua carriera drammaturgica.
Il valzer e il tango non sono utilizzati come elementi di sfondo ma come strumenti narrativi che riflettono le emozioni dei personaggi e la loro evoluzione. Questa scelta contribuisce a rendere l’opera una commedia lirica ibrida, caratterizzata da una varietà musicale che riflette l’influenza viennese, rendendo i momenti coreografici essenziali per la narrazione.
Adami fornì un libretto che permise a Puccini di esplorare temi di amore e libertà in un’atmosfera leggera ma emotivamente complessa. Tuttavia, la scarsa convinzione di Puccini nel progetto e la sua stanchezza creativa comportarono continui ripensamenti durante la gestazione dell’opera, influenzandone il risultato finale.
La storia si svolge a Parigi dove la giovane e bella Magda Civry si intrattiene nel lussuoso salotto della sua casa insieme a un gruppo di amiche, il suo ricco amante Rambaldo, il poeta Prunier e la cameriera Lisette. Magda rievoca con nostalgia il suo amore giovanile per uno studente. Ad un tratto entra nel salotto Ruggero, giovane amico di Rambaldo venuto dalla campagna, Magda resta subito colpita dalla sua serietà e timidezza. Quando Ruggero saluta i presenti per recarsi in un locale a passare la serata, Magda riesce a scoprire la destinazione del ragazzo e, travestendosi, si reca anch’ella al caffè Bullier.
Al locale Ruggero siede da solo a un tavolo non curandosi delle ragazze che gli ronzano intorno; giunta Magda si unisce a lui e iniziano a conversare e poi a danzare.
Intanto arrivano al locale Prunier, Lisette e infine anche Rambaldo che cerca di convincere Magda a tornare a casa con lui ma lei rifiuta dicendogli che si è innamorata di Ruggero.
I due amanti andranno poi a vivere sulla Costa Azzurra e il ragazzo chiede a Magda di sposarlo; Magda gli rivela il suo passato di donna mantenuta dagli uomini e che non avrebbe potuto sposare un uomo così sincero e di sani princìpi. Come una rondine, fa quindi ritorno alla lussuosa vita finta e monotona insieme al suo protettore Rambaldo.
Magda è quindi la bella mantenuta che cerca l’amore autentico. È romantica e nostalgica, ma anche consapevole della sua comoda situazione sociale e delle sue limitazioni; Ruggero è invece un giovanotto provinciale che rappresenta l’innocenza, la ricerca di un amore puro e di una vita semplice e felice.
Rambaldo, ricco banchiere e protettore di Magda, è il simbolo del denaro e dell’amore possessivo. Prunier, poeta cinico e arguto, incarna le nuove e frivole mode amorose parigine; infine Lisette, cameriera di Magda, ragazza concreta e pragmatica, rappresenta il contrasto alle aspirazioni romantiche di Magda.
La prima rappresentazione de La rondine si tenne Grand Théâtre de Monte Carlo il 27 marzo del 1917 e fu accolta da un pubblico caloroso, ma subì una stroncatura dalla critica.
Durante la Prima Guerra Mondiale (1915-1918), Puccini visse un periodo di grande angoscia e preoccupazione; era profondamente turbato dagli orrori del conflitto che definì in una lettera «[…] un’orribile sospensione della vita […]». Grande ansia gli procurò inoltre l’impiego al fronte del figlio Antonio. Il tutto influì pesantemente sulla sua produttività creativa, infatti in una lettera lamentava «[…] ho lavorato poco, questa guerra mi distorna […], che vale? Se non finisce questa guerra, che cosa se ne fa il mondo della musica? […]».
Puccini non si schierò mai politicamente, nel 1915 dichiarò: «[…] Un artista dovrebbe tenersi completamente fuori dalla politica. Almeno, questo è ciò che penso […]». Nonostante tutte le difficoltà continuò a comporre, e riuscì a ultimare un trittico composto dalle opere Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi.
24. Tre opere in una.
Già nei primi anni del Novecento, il compositore aveva avuto l’idea di lavorare a un’opera composta da tre episodi tratti dalla Divina Commedia; per lungo tempo pensò a questo progetto che non si realizzò mai ma di cui se ne ha traccia con l’episodio di Gianni Schicchi per il trittico.
Nel 1812 aveva assistito a Parigi alla rappresentazione del dramma La houppelande di Didier Gold restandone molto colpito e dalla quale pensò di trarre un’opera. Affidò il soggetto al librettista Giuseppe Adami; tra l’estate e l’autunno del 1913 e poi dall’ottobre 1915 al novembre 1916, Puccini lavorò alla composizione de Il tabarro.
Dopo aver messo in scena Le rondini, il compositore pensò di riprendere l’opera in un atto e associarla ad altre due di argomento completamente diverso per avere un’opportunità rappresentativa caleidoscopica sotto il punto di vista musicale, drammaturgico e narrativo. Tra il 1917 e il 1918 compose Suor Angelica e Gianni Schicchi su libretto di Giovacchino Forzano.
Nonostante le sue qualità musicali, Il tabarro è una delle opere meno rappresentate del repertorio pucciniano. La sua narrazione cruda, che affronta il tema del proletariato parigino, l’hanno resa meno popolare rispetto ad altri titoli del compositore. Tuttavia, è considerata un’opera di grande originalità che mostra la capacità di Puccini di inserirsi nelle tendenze musicali europee del suo tempo.
Il Tabarro è caratterizzata da una forte drammaticità e una cupa atmosfera che riflette il tema del tempo che passa simboleggiato dal tramonto e dal lento scorrere della Senna. Puccini utilizza leitmotiv brevi e una struttura musicale basata su grandi blocchi tonali anticipando stilemi tipici dell’espressionismo.
L’opera è ambientata su un barcone da carico ancorato sulla Senna a Parigi, al tramonto. Michele, il proprietario del barcone e marito di Giorgetta, sospetta che la moglie lo tradisca. Giorgetta è innamorata di Luigi, un giovane scaricatore che lavora per Michele. Ogni sera, Luigi raggiunge Giorgetta attratto dal segnale di un fiammifero acceso. Michele, tormentato dalla gelosia e dalla perdita del loro figlio, medita vendetta. Una sera, Michele sorprende Luigi sul barcone, lo costringe a confessare il suo amore per Giorgetta e lo strangola. Nasconde poi il corpo nel suo tabarro. Quando Giorgetta si avvicina a Michele egli le mostra il cadavere di Luigi.
L’opera fu concepita per essere rappresentata insieme a Suor Angelica e Gianni Schicchi, offrendo così un’esperienza teatrale completa e variegata.
Ogni episodio del Trittico esplora temi diversi ma interconnessi.
Il Tabarro si concentra sulla gelosia e la tragedia, rappresentando un mondo cupo e senza speranza che può essere visto come infernale; Suor Angelica tratta l’espiazione e la redenzione, evocando il purgatorio. Infine, Gianni Schicchi offre una visione comica dell’avidità, con un tono più leggero e un finale paradisiaco.
Il Trittico è stato concepito come un percorso dall’oscurità alla luce. Questo viaggio emotivo è reso possibile attraverso la rappresentazione delle diverse sfumature dell’animo umano: passione, redenzione e avidità. L’ordine delle opere è cruciale per mantenere questo equilibrio drammatico.
Le tre opere si distinguono per i loro contrasti stilistici e tematici. Il Tabarro è un dramma realistico ambientato nella Parigi contemporanea a Puccini, mentre Suor Angelica in un convento del XVII secolo seguendo una narrazione lirica e religiosa. Gianni Schicchi è invece una commedia che si svolge nella Firenze medievale.
Suor Angelica è ambientata in un monastero nei pressi di Siena, verso la fine del XVII secolo. La protagonista è una giovane donna di famiglia aristocratica che da sette anni vive nel convento per espiare un peccato d’amore.
Durante questo lungo periodo, Angelica non ha avuto notizie del suo bambino nato da una relazione clandestina e che le era stato strappato subito dopo la nascita. Un giorno riceve la visita inaspettata della zia. Tuttavia, la donna non è venuta per concederle il perdono ma per chiederle di firmare un atto di rinuncia alla sua parte di eredità familiare, necessaria per costituire la dote della sorella minore prossima al matrimonio.
Angelica chiede insistentemente informazioni sul suo bambino e, con fredda crudeltà, la zia le rivela che il bambino è morto da oltre due anni a causa di una grave malattia.
Disperata per la notizia, la ragazza decide di togliersi la vita per ricongiungersi al figlio. Di notte si reca nell’orto del monastero e raccoglie delle erbe velenose con cui prepara una pozione mortale.
Dopo aver bevuto il veleno, Angelica implora il perdono della Vergine Maria e in quel momento avviene il miracolo: la Madonna appare sulla soglia della chiesetta e spinge il bambino tra le braccia della madre morente. Angelica muore riconciliata mentre un coro di angeli la accoglie in cielo.
Gianni Schicchi invece è ambientata a Firenze nel 1299. La storia si svolge attorno alla morte del ricco Buoso Donati e alle macchinazioni dei suoi avidi parenti per assicurarsi l’eredità.
L’opera si apre con i parenti di Donati riuniti intorno al suo letto di morte preoccupati per una voce che circola per cui il ricco avrebbe lasciato tutto il suo patrimonio ai frati. I parenti, ansiosi di conoscere il contenuto del testamento, lo cercano freneticamente e, una volta trovato, le loro paure sono confermate: Buoso ha effettivamente lasciato tutti i suoi beni ai frati.
In preda alla disperazione, il giovane Rinuccio suggerisce di chiamare Gianni Schicchi, uomo noto per la sua astuzia. Schicchi arriva insieme alla figlia Lauretta che è innamorata di Rinuccio.
Dopo aver valutato la situazione, Schicchi escogita un piano audace: si sostituirà al defunto Buoso, fingendosi ancora vivo, per dettare un nuovo testamento al notaio.
Schicchi si mette nel letto di Buoso e, imitandone la voce, detta un nuovo testamento al notaio. Con grande sorpresa e disappunto dei parenti, Schicchi lascia la maggior parte dei beni a se stesso, assicurando così un futuro per sua figlia Lauretta innamorata di Rinuccio.
L’opera si conclude con Schicchi che si rivolge direttamente al pubblico chiedendo l’assoluzione per il suo inganno che ha però permesso ai due giovani innamorati di sposarsi.
Puccini tratta questa vicenda, ispirata a un episodio dell’Inferno di Dante, con grande ironia e leggerezza musicale, trasformando il personaggio di Schicchi da tremendo falsario a simpatico furbetto, in una commedia sull’astuzia e la corruzione nella società italiana.
Il compositore utilizza diversi registri musicali per riflettere le diverse atmosfere delle tre opere. La musica de Il Tabarro è intensa e drammatica, con un’orchestrazione densa e dissonante che crea tensione, senza melodie semplici o facilmente riconoscibili. Suor Angelica presenta toni più lirici e spirituali, l’uso della vocalità femminile è predominante con cori celesti che aggiungono elementi eterei. La musica è raffinata e le sonorità sono vicine al canto gregoriano.
Gianni Schicchi, opera buffa dai toni grotteschi e giocosi che offrono un contrasto netto rispetto alle altre due opere, è caratterizzata da una scrittura brillante e ritmica; le melodie sono accattivanti e sottolineano il tono comico e la satira sociale della trama.
La prima rappresentazione italiana del Trittico, sotto la direzione di Gino Marinuzzi, fu l’undici gennaio 1919 presso il Teatro Costanzi di Roma con successo di pubblico e critica anche se, come già successo a New York, Gianni Schicchi fu l’opera più apprezzata; Suor Angelica fu “riabilitata” rispetto alle critiche ricevute in America mentre Il Tabarro fu aspramente criticata perché troppo cruda e violenta.
Arturo Toscanini espresse il giudizio definendola solo “Grand Guignol” (riferendosi al carattere violento e sensazionalistico).
È interessante notare che ci furono giudizi discordi non solo tra il pubblico ma anche tra gli addetti ai lavori. Mentre Toscanini criticava Il Tabarro, il compositore Ferruccio Busoni lo definì un vero capolavoro.
Il musicologo Fedele D’Amico spiegò queste differenze di giudizio sostenendo che Toscanini valutava l’opera secondo “categorie ottocentesche”, guardando principalmente al nucleo del dramma, mentre Busoni la giudicava secondo “categorie novecentesche”, prestando più attenzione all’elaborazione musicale e al paesaggio sonoro. Puccini, presente alla prima rappresentazione, che si dichiarò soddisfatto. Le reazioni contrastanti portarono presto allo “smembramento” del Trittico, con le tre opere spesso rappresentate separatamente negli anni successivi, contrariamente alle intenzioni originali del compositore.
25. Un capolavoro incompiuto.
Nei primi mesi del 1920 Puccini ricevette, dal critico teatrale e commediografo Renato Simoni, il testo della fiaba teatrale Turandot. Originariamente il dramma fu scritto dal veneto Carlo Gozzi e messo in scena nel 1762; il tedesco Friedrich Schiller ne realizzò poi una versione in tedesco che fu successivamente tradotta in italiano dal poeta Andrea Maffei.
Il compositore quindi non lesse la versione originale di Gozzi ma l’adattamento di Schiller/Maffei e ne fu subito profondamente affascinato.
Nella seconda metà del 1920 Puccini era già a lavoro su Turandot insieme ai librettisti Giuseppe Andami e Renato Simoni.
Turandot è un’opera al contempo semplice e complessa, è caratterizzata da forti contrasti enfatizzati da un costrutto simbolico importante, dove il binomio luce/oscurità è scenografato da un tramonto rosso sangue che si contrappone alla fredda luce lunare; la combinazione caldo/freddo è resa dal calore passionale del protagonista Calaf in contrapposizione alla gelida principessa Turandot. Calaf rappresenta la vita e l’amore mentre la morte è impersonata da Turandot.
Abbiamo quindi nei personaggi degli archetipi contrastanti: Liù, schiava devota, è l’emblema dell’amore sacrificale; Calaf è l’eroe redentore portatore di amore; Turandot è la principessa algida e crudele, simbolo di un femminile distruttivo.
Il nodo centrale dell’opera è la trasformazione psicologica di Turandot da principessa gelida e vendicativa a donna innamorata; fondamentali sono anche l’amore sacrificale di Liù e la passione vitale di Calaf. L’opera è intrisa di tragedia, rappresentata dal suicidio di Liù, di lirismo appassionato dato dalle arie di Calaf; troviamo inoltre momenti ironici e grotteschi con il trio dei ministri Ping, Pang e Pong.
Turandot rappresenta l’apice della sperimentazione musicale di Puccini, combinando elementi tradizionali dell’opera italiana con innovazioni armoniche e timbriche.
L’esotismo è un tratto distintivo della drammaturgia musicale dell’intero lavoro; Puccini incorpora autentiche melodie cinesi come l’inno imperiale e la canzone popolare Mo-li-hua, ascoltata su un carillon durante un soggiorno termale a Bagni di Lucca; utilizza scale pentatoniche per evocare l’atmosfera orientale. La partitura include una vasta sezione di percussioni accordate, gong e altri strumenti della tradizione cinese per ricreare sonorità asiatiche.
Essendo fortemente influenzato dalla musica del primo novecento, Puccini introduce dissonanze, bitonalità e cluster tonali. L’opera si apre infatti con un accordo dissonante che simboleggia il conflitto centrale della storia; l’orchestrazione ricca e variegata si avvale del più grande organico orchestrale mai utilizzato dal compositore.
Il coro ha un ruolo molto più prominente rispetto alle opere precedenti, quasi fosse un personaggio aggiuntivo. Puccini riesce con Turandot a coniugare l’innovazione tecnica e stilistica con la tradizione melodica italiana che trova il suo punto massimo nell’aria Nessun dorma, il cui motivo aleggia in molte parti dell’opera.
La storia si svolge a Pechino in un tempo non specificato; tutto ruota attorno alla principessa Turandot, donna bellissima ma dal cuore di ghiaccio, che ha giurato di non sposarsi mai. Per scoraggiare i pretendenti ha stabilito che chiunque voglia sposarla deve risolvere tre enigmi e coloro che falliscono verranno condannati a morte. La narrazione inizia con l’esecuzione dell’ultimo pretendente fallito, il Principe di Persia.
Tra la folla che assiste all’esecuzione c’è il principe Calaf che, folgorato dalla bellezza di Turandot, decide di tentare la prova degli enigmi nonostante le suppliche del padre Timur e della fedele schiava Liù.
Calaf riesce a risolvere i tre enigmi di Turandot, ma vedendo la principessa disperata, le offre una via d’uscita: se lei riuscirà a scoprire il suo nome prima dell’alba potrà farlo giustiziare. Turandot ordina quindi che nessuno dorma a Pechino finché non verrà scoperto il nome del principe. I ministri della principessa, Ping, Pang e Pong, cercano di corrompere Calaf ma senza successo. Liù e Timur vengono catturati e torturati per rivelare il nome del principe. Liù, per proteggere il segreto di Calaf di cui è segretamente innamorata, si uccide. Calaf, rimasto solo con Turandot, la bacia appassionatamente. Questo gesto scioglie finalmente il cuore della principessa che si innamora di lui.
Puccini purtroppo venne a mancare prima di completare l’opera, la sua scrittura si fermò con la morte di Liù.
La figura di Liù, ragazza devota che si toglie la vita per non tradire la fiducia di Calaf, è un riferimento abbastanza esplicito alla vicenda di Doria Manfredi che Puccini volle riabilitare immortalandola nell’opera.
Incredibile coincidenza che il compositore termini la sua carriera e la sua esistenza proprio in questo punto della composizione.
26. «Qui termina la rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto».
Sin dall’adolescenza, Puccini fu fumatore incallito. Per tutta la vita amò il profumo e il sapore del tabacco, fu grande consumatore di sigarette ma anche di sigari Toscano. Verso l’estate del 1923 iniziò ad avvertire dei fastidi alla gola che, col passare dei mesi, divennero sempre più insistenti fino a quando non si trasformarono in dolori lancinanti. Il Maestro, assistito dal figlio Tonio, fu visitato dai migliori medici specialisti dell’epoca tra i quali Addeo Toti, Camillo Arturo Torrigiani e in fine, suggerito dalla sempre presente fedele amica Sybil Seligman, Giuseppe Gradenigo al tempo il più esperto chirurgo al mondo e pioniere dell’otorinolaringoiatria.
Gli fu diagnosticato un cancro all’epiglottide in stadio avanzato dovuto dal fumo. Puccini non fu mai messo al corrente della gravità del suo male.
Così scriveva all’amico Carlo Clausetti: «[…] Caro Carlo, il mio male è un papilloma, non grave, ma bisogna levarselo e presto; è situato sotto l’epiglottide. Ho telegrafato al professor Gradenigo, dovrò operarmi... col radio, a Firenze o a Parigi: Bella noia! Ma almeno ora so cos’è il mio male che da mesi m’impensierisce e mi tormenta. Ti prego, appena a Milano, di mandarmi una Tosca e una Bohème e inoltre i tre spartiti del Trittico che non ho, divisi. Vorrei sapere se nel Tabarro fu cambiato il monologo finale, e anche vorrei sapere perché queste tre opere rimangono inerti! Speriamo che possa guarire, che Turandot riprenda. Per ora tutta la musica di casa mia un silenzio doloroso! […]».
Al librettista e fedele amico Giuseppe Adami scrisse «[…] Caro Adamino, che volete che vi dica? Sono in un periodo tremendo. Questo mal di gola mi tormenta ma più moralmente che per pena fisica. Andrò a Bruxelles da un celebre specialista. Partirò presto. Aspetto risposta di là e Tonio che ritorni da Milano. Mi opererò? Mi si curerà? Mi si condannerà? Così non posso più andare avanti. E Turandot è lì. […] Vedremo, quando mi rimetterò al lavoro, al ritorno da Bruxelles. Speriamo che io ne esca bene di questa gola! Vi abbraccio[…]».
Il quattro novembre 1924, accompagnato dal figlio Tonio e dall’amico amministratore di Casa Ricordi Clausetti, Puccini partì alla volta di Bruxelles per curarsi presso la clinica del Dottor Ledoux. Giacomo fu raggiunto anche da Sybil Seligman che, avendo compreso la gravità dello stato di salute di Giacomo, sollecitò più volte sia Elvira sia Fosca a raggiungerli, dopo vari contatti solo Fosca si recò a Bruxelles. Le terapie al radio procedettero bene e gli specialisti avevano scongiurato il peggio e, dopo l’intervento chirurgico, diedero a Puccini certezze di guarigione; purtroppo la sera del 28 novembre sopraggiunse un infarto del miocardio che fece collassare la situazione.
Il Maestro si spense alle undici e trenta della mattina del 29 novembre a Bruxelles lontano dal suo amato paese.
Il primo funerale di Puccini a Bruxelles fu un evento solenne che si tenne il primo dicembre 1924.
La cerimonia funebre si svolse nella chiesa di Sainte-Marie e fu celebrata dal Nunzio Apostolico Micara, conferendo all’evento un carattere di grande importanza e rispetto.
Oltre alla cerimonia religiosa, il Teatro reale De La Monnaie rese omaggio al grande compositore con una rappresentazione speciale di Bohème. Durante questa commemorazione fu posta una grande corona di fiori al centro del palcoscenico, simboleggiando il lutto per la perdita del maestro. Prima dell’inizio dell’opera, il direttore del teatro pronunciò un commosso discorso per ricordare la figura artistica del compositore scomparso.
Il due dicembre 1924, alle ore 17, un treno speciale da Bruxelles giunse a Milano trasportando la bara di Puccini avvolta nel tricolore italiano. La salma fu accompagnata dai figli Antonio e Fosca.
La bara fu inizialmente trasferita nella chiesa di San Fedele dove venne allestita una camera ardente. La chiesa era stata addobbata a lutto e la bara fu disposta su un imponente catafalco circondato da 200 ceri accesi. Per tutta la notte, la salma fu vegliata nella chiesa.
Il giorno seguente, tre dicembre, alle 6:30 del mattino, la bara fu trasferita nel Duomo di Milano per la solenne cerimonia funebre. Qui fu collocata su un maestoso catafalco di velluto nero con frange d’oro, gli stessi paramenti utilizzati per il funerale di re Vittorio Emanuele II.
La cerimonia in Duomo fu particolarmente solenne e significativa:
fu celebrata alla presenza eccezionale del cardinale, un onore concesso in precedenza solo per i funerali di Alessandro Manzoni; l’orchestra del Teatro alla Scala, diretta da Arturo Toscanini, eseguì brani musicali, interpretando in chiave mistica la marcia funebre da Edgar; il coro del Duomo accompagnò la cerimonia; la chiesa e la piazza antistante erano gremite di autorità, figure istituzionali e comuni cittadini.
Dopo la cerimonia al Duomo, si formò un lungo corteo funebre che attraversò le strade di Milano; il percorso incluse una sosta significativa davanti al Teatro alla Scala.
Il corteo si concluse al Cimitero Monumentale di Milano. La bara fu portata a spalla nel Famedio dove si tenne un breve rito funebre. Infine, alla presenza dei parenti e degli amici più stretti, la salma di Puccini fu temporaneamente deposta nella cappella della famiglia Toscanini.
La scelta della sepoltura nella tomba di famiglia dell’amico Arturo Toscanini fu una soluzione provvisoria, due anni dopo, nel 1926, i resti del compositore furono trasferiti nel mausoleo appositamente costruito a Torre del Lago, come desiderato dal Maestro.
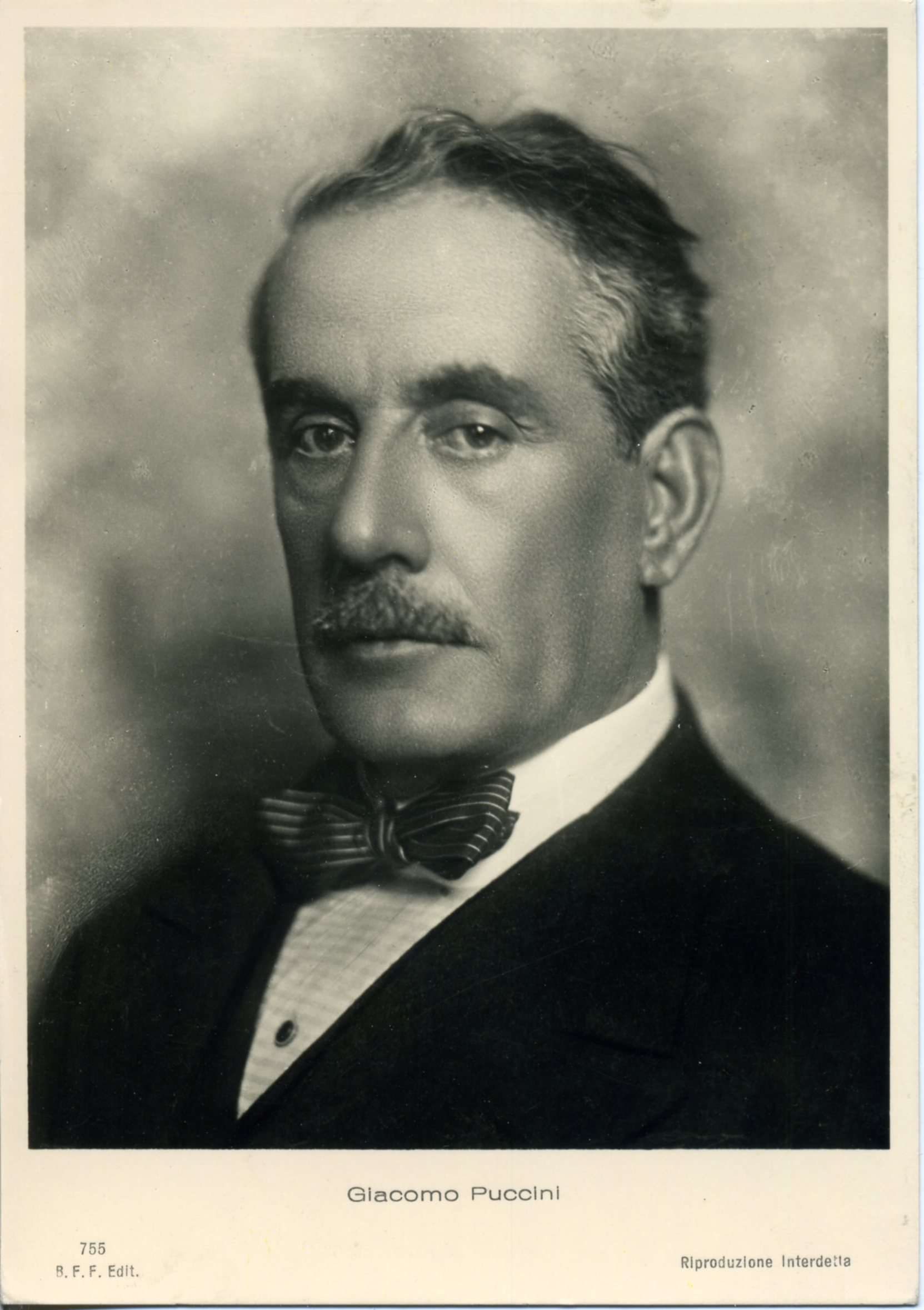
Turandot era rimasta incompiuta. La prima rappresentazione era già in cartellone per il febbraio del 1925 ma fu ovviamente cancellata. Puccini, dopo alti e bassi nel rapporto di amicizia con Arturo Toscanini, nei mesi precedenti alla sua morte, aveva riallacciato i rapporti e lo aveva convinto a occuparsi della nuova opera e dirigerne le prime esecuzioni.
Nei suoi ultimi giorni di vita Giacomo disse al figlio: «… se non finisco Turandot voglio che tu la faccia finire a Zandonai».
Scomparso il Maestro, l’editore Ricordi e Toscanini presero in mano l’opera ma affidarono il completamento a Franco Alfano.
La scelta ricadde su Alfano perché era l’autore de La leggenda di Sakùntala che aveva affinità tematiche e stilistiche con Turandot, entrambe le opere avevano un’ambientazione esotica e caratteristiche musicali simili.
Alfano era considerato uno degli ultimi rappresentanti della scuola verista italiana ed era quindi in linea con lo stile pucciniano; in più anche lui stava evolvendo verso sonorità più moderne. L’opera Risurrezione gli aveva dato fama internazionale dimostrando la sua capacità di comporre opere di successo.
Nonostante queste motivazioni, il compito di completare l’opera si rivelò molto complesso. Alfano dovette lavorare basandosi sui 36 fogli di appunti lasciati da Puccini. Produsse inizialmente una versione del finale molto estesa e troppo personale che poi dovette rivedere e tagliare su richiesta di Ricordi e Toscanini, creando così una versione più breve che è quella che viene generalmente eseguita.
La prima rappresentazione di Turandot ebbe luogo il 25 aprile 1926 presso il Teatro alla Scala di Milano sotto la direzione Arturo Toscanini.
Durante la prima, Toscanini interruppe l’esecuzione a metà del terzo atto subito dopo la morte di Liù, nel punto in cui terminava la partitura completata da Puccini, si rivolse al pubblico e disse: «Qui termina la rappresentazione perché a questo punto il Maestro è morto».
L’impatto emotivo sul pubblico fu enorme. La sera successiva l’opera fu rappresentata nella sua interezza, includendo il finale composto da Alfano.
Turandot ebbe un grande successo di pubblico e critica e fu consacrata come uno dei capolavori di Puccini nonostante fosse rimasta incompiuta.
A cento anni dalla sua scomparsa Giacomo Puccini ha lasciato dunque un’indelebile eredità musicale che ha influenzato, e influenzerà, generazioni di compositori e amanti dell’opera.
27. Puccini ascolta Puccini.
Concludo questo scritto proponendo uno studio che renda omaggio, in modo originale, alla musica del grande Maestro e che ne valorizzi ulteriormente l’importanza: “Puccini ascolta Puccini - 1902/1924: uno studio filologico e comparato delle incisioni discografiche a 78 giri”.
Puccini ascolta Puccini è un ambizioso lavoro di digitalizzazione e restauro dei dischi a 78 giri incisi in Italia dalle società Gramophone-Società Nazionale del “Grammofono” e Fonotipia, dal 1902 al 1924. Questo progetto mira a preservare e diffondere l’opera di Puccini creando una risorsa digitale di inestimabile valore per gli ascoltatori, gli studiosi della musica e gli appassionati del repertorio pucciniano in tutto il mondo.
La parte fondamentale di Puccini ascolta Puccini verte sulla digitalizzazione accurata dei documenti fonografici incisi in Italia dal 1902 al 1924 e sull’individuazione della corretta velocità di rotazione dei dischi con la correzione operata in digitale. Questo processo richiede un attento studio di ciascun documento al fine di garantire che le registrazioni possano essere riprodotte alla veritiera intonazione, cosa che permetterà il fruire dell’interpretazione originale dell’esecuzione.
Poiché la bibliografia esistente relativa alle incisioni italiane del repertorio di Giacomo Puccini si presenta in modo discontinuo e frammentario, l’obiettivo è quello di ricostruire in modo accurato e unitario la discografia italiana del grande compositore, dagli albori della fonoriproduzione sino al 1924, anno della scomparsa dell’illustre Maestro.
Il rilevante ruolo giocato all’interno dell’allora giovane mercato discografico dalle compagnie fonografiche oggetto di studio, la Gramophone-Società Nazionale del “Grammofono” e la Fonotipia, le ha favorite nel porle al centro di questo progetto: è noto infatti il loro fondamentale contributo allo sviluppo e alla diffusione del “nuovo mezzo di comunicazione” in Italia nonché alla veicolazione della musica, sia come intrattenimento che come trasmissione di cultura. Il progetto Puccini ascolta Puccini adotta un approccio filologico rigoroso, enfatizzando l’accuratezza storica e l’integrità delle registrazioni. L’obiettivo è che i documenti sonori digitali siano il più fedeli possibile alle incisioni originali che Puccini e i suoi contemporanei usavano ascoltare con i fonoriproduttori dell’epoca. Questo approccio filologico mira a preservare non solo il suono, ma anche il contesto in cui queste registrazioni furono create. Lo studio dei documenti sonori propone anche la ricostruzione cronologica delle incisioni e la comparazione tecnico-stilistica delle esecuzioni dei vari interpreti; un obiettivo importante di questo lavoro comparativo è la valorizzazione degli esecutori la cui memoria è stata offuscata dallo scorrere del tempo. Grazie a contemporanee tecnologie mirate è dunque possibile fruire delle registrazioni del periodo acustico con un’esperienza di ascolto filologico, fedele il più possibile alle sonorità dell’epoca e che consenta di ipotizzare come Puccini stesso potesse ascoltare le proprie composizioni. Il restauro dei documenti autentici, attingendo a fondi fonografici pubblici e privati, sarà effettuato nel massimo rispetto dell’integrità e della tutela del documento originale, andando a intervenire unicamente sui difetti prodotti dall’usura del tempo, puntando a esaltare il suono originario. Puccini ascolta Puccini mira a ottenere risultati significativi che soddisfino sia il mondo del professionismo musicale e musicologico come quello dei melomani e dei comuni fruitori ed appassionati di musica. La creazione di una collezione digitale di registrazioni “autentiche” delle opere di Puccini consentirà ai fruitori di studiare in dettaglio le interpretazioni del repertorio dell’artista toscano incise da suoi contemporanei. Questo progetto favorirà la conservazione di queste preziose registrazioni preservandone la loro autenticità per le future generazioni. Inoltre permetterà al pubblico di tutto il mondo di accedere a questa eredità musicale unica e di immergersi nelle esecuzioni delle opere di Puccini quando egli era ancora in vita. Puccini ascolta Puccini rappresenta dunque un omaggio straordinario al genio di Giacomo Puccini nel centenario della sua morte. Questa iniziativa, che fonde la ricerca storica e musicologica con l’utilizzo di avanzati sistemi digitali, costituisce un prezioso contributo alla preservazione del patrimonio musicale italiano e alla diffusione della sua bellezza in tutto il mondo. La realizzazione di questo progetto richiede un impegno collettivo, unito dalla passione per la musica e dalla volontà di onorare e celebrare l’eredità di Giacomo Puccini per le generazioni future. La musica di Puccini è destinata a risuonare per sempre nei cuori e nelle orecchie di coloro che si immergono in questo viaggio sonoro.
Immagini tratte dell’Archivio del DMI – Dizionario della Musica in Italia – per gentile concessione del Maestro Claudio Paradiso.
Veicoli sequestrati per violazione del codice della strada. Quadro normativo e prospettive di riforma
di Ludovico Di Benedetto
La gestione pubblica dei veicoli sequestrati per violazione del codice della strada si radica su un quadro normativo complesso e scarsamente coordinato.
Dopo un imprescindibile riferimento al sistema sanzionatorio fissato nel codice, lo studio propone un’analisi dei singoli interventi normativi che si sono affastellati nel corso dei decenni, il cui archetipo - a tutt’oggi in vigore in funzione residuale - risale al dpr 571 del 1982. Tale decreto prevede che la gestione dei veicoli sequestrati sia conferita ad imprese private, autorizzate dal prefetto competente territorialmente, in cambio di un corrispettivo tariffario giornaliero.
Questo primigenio intervento normativo, a causa delle farraginosità procedimentali, ha portato, nel corso degli anni, alla lievitazione del numero dei mezzi depositati presso i soggetti autorizzati, con corrispondente aumento degli oneri custodiali. Pertanto, agli albori del nuovo millennio, il legislatore si è attivato, inaugurando la fase delle rottamazioni straordinarie. In prima battuta, col d.l. 269/2003 (art. 38), è stato infatti previsto che i veicoli depositati, aventi certi requisiti legalmente sanciti, passassero ex lege in proprietà dei custodi, in cambio di un prezzo da compensare coi debiti di custodia. Tuttavia, tale normativa è stata dichiarata incostituzionale (C. cost. 92/2013) per le ragioni che verranno indicate nel corpo, con conseguente riespansione del diritto comune fissato dal citato dpr.
Successivamente, il modello dell’alienazione straordinaria è stato riproposto dal legislatore con la l. 147/2013 (art. 1 commi 444, 445 e 446), con la fondamentale differenza rispetto a quanto previsto nel 2003 di subordinare la cessione al consenso negoziale del custode.
Infine, con l’art. 214 bis del codice della strada (d.lgs. 285/1992), il legislatore ha previsto un nuovo sistema di gestione ordinaria dei veicoli sequestrati, incentrato sulla figura del custode-acquirente, selezionato tramite gara pubblica. Nondimeno, anche questo strumento ha generato delle criticità, particolarmente evidenti nei territori metropolitani ad alto tasso di circolazione veicolare, con un aumento esponenziale dei costi a carico dell’erario. Pertanto, viene qui proposto un armamentario poliedrico che, memore dell’esperienza delle rottamazioni straordinarie, si ipotizza possa comportare un importante sgravio dei costi di deposito.
Sommario: 1 - Cenni sul sistema sanzionatorio di diritto amministrativo. In particolare, le sanzioni reali del codice della strada; 2.1 - Il quadro normativo vigente in tema di gestione dei veicoli sequestrati: il dpr 571/1982; 2.2 - Segue: la stagione delle rottamazioni straordinarie; 2.3 - Segue: il sistema del custode-acquirente; 2.4 - Un parallelismo: la gestione dei beni sequestrati giudiziariamente; 3.1 - Criticità applicative; 3.2 - Proposte di intervento sul piano normativo e negoziale.
1 - Cenni sul sistema sanzionatorio di diritto amministrativo. In particolare, le sanzioni reali del codice della strada
L’amministrazione, come soggetto chiamato alla cura concreta dell’interesse pubblico, è titolare, tra gli altri, di poteri sanzionatori; allorquando, cioè, un consociato abbia integrato gli estremi di un illecito amministrativo[1], violando un dato precetto posto a tutela dell’interesse generale, l’autorità reagisce, punendo questo comportamento. La fondamentale cornice normativa a cui occorre guardare e che funge da autentico diritto comune dell’intera materia è la l. 689/1981, confezionata al duplice scopo di ridimensionare l’area del penalmente rilevante (cosiddetta depenalizzazione)[2] e di fornire un retroterra legislativo generale alla potestà sanzionatoria amministrativa[3]. La citata legge codifica i principi basilari[4], gli istituti sostanziali[5], la sequenza procedimentale[6] e, fino ad un recente passato, pure l’assetto processualistico[7].
Le sanzioni di stampo amministrativo possono essere pecuniarie, personali o reali, a seconda che affliggano le liquidità, le facoltà o le proprietà del singolo; sulle prime due, per ragioni di trattazione, non ci soffermeremo. Per quanto concerne le altre, in breve, le sanzioni reali della l. 689 cit. consistono in provvedimenti duraturi, sfavorevoli, ablatori, come tali soggetti ai principi di tipicità provvedimentale e di legalità procedimentale, all’obbligo di motivazione e alla necessaria conoscibilità (artt. 1 c.1, 3 c. 1 e 21 bis l. 241/90). La legge del 1981 annovera, in particolare, il sequestro e la confisca, atteggiandosi, il primo, come strumento cautelare, strumentale e provvisorio finalizzato allo spossessamento della res a vantaggio della p.a., con cui si assicura ex auctoritate sua l’osservanza dei doveri pubblici gravanti sui consociati[8]; il secondo, consequenziale l’altro, come provvedimento sanzionatorio di acquisizione definitiva in favore dell’amministrazione[9].
Essendo gli obblighi di non fare incoercibili in forma specifica (cfr. art. 2933 c. 1 c.c.), con questo potere cautelare l’ordinamento risolve il conflitto del privato dando temporaneamente prevalenza agli interessi pubblici e sacrificando quelli del cittadino. Il sequestro è dunque funzionale ad impedire che, in attesa dell’accertamento definitivo della illiceità del contegno, una data situazione di fatto si protragga nel tempo e si consolidi a tal punto da essere difficilmente ripristinabile. Per mezzo di tale cautela, l’autorità pubblica riesce a fugare i dubbi circa la conformità all’ordinamento dell’attività del singolo, a bloccare preventivamente le violazioni delle disposizioni legislative e provvedimentali, ad arrestare l’illecito ed i suoi effetti[10].
La l. 689/81, nel regolare l’istituto, rispecchia quest’ultima finalità. L’art. 13 lo declina infatti secondo due sfumature: in generale prevede la misura come facoltativa per quanto riguarda le cose che possono poi essere confiscate (comma 2); nell’evenienza specifica di veicoli (o natanti) non coperti da assicurazione o privi di documenti di circolazione, il sequestro diviene invece obbligatorio e connotato da una smaccata finalità dissuasiva, in sostituzione della precedente pena detentiva (comma 3)[11].
In tema di ablazione definitiva, la legge discerne tra una confisca come sanzione accessoria rispetto ad un’ordinanza ingiunzione che dispone una pena pecuniaria (art. 20 c. 3), la quale, a sua volta, può essere facoltativa, quando ricada sulle cose che furono usate per commettere l’illecito, o obbligatoria, se riguardi i beni che costituirono il prodotto del medesimo[12]; e una misura autonoma e vincolata che affligge i beni la cui fabbricazione, detenzione, alienazione ovvero il cui uso o porto integrino ex se un illecito amministrativo (art. 20 c. 5; si vedano anche le ipotesi puntuali riferite al settore della tutela sul luogo di lavoro del comma 4 del medesimo articolo e della circolazione stradale di cui all’art. 21 commi 1 e 3[13]).
In questi termini, la confisca amministrativa non persegue altro obbiettivo che quello di retribuire l’illecito perpetrato, non certo di reintegrare l’interesse leso, come dimostrato peraltro dalla pacifica confiscabilità persino di beni non intrinsecamente pericolosi. Il suo carattere punitivo la distingue dalle sanzioni risarcitorie e decadenziali civilistiche; sono invece i profili di competenza, di rito e di beni giuridici a differenziarla dalle misure reali di diritto penale.
Il circuito sanzionatorio recato dal codice della strada (d.lgs. 285/1992, d’ora in poi anche cds) - oggetto della presente dissertazione - è parzialmente derogatorio rispetto alla matrice di cui alla legge appena ricordata. A parte alcune specificità rituali e sostanziali di sicuro rilievo ma che qui occorre tralasciare[14], preme rimarcare come il codice preveda per le sue trasgressioni, a fianco della sanzione principale pecuniaria, molteplici misure accessorie, operanti ipso iure, distinte all’art. 210 c. 2 cds in quelle afferenti ad attività (artt. 211 e 212), ai documenti di circolazione (artt. 216 e ss.), al veicolo (artt. 213 e ss.). Tra queste ultime si annoverano la rimozione/blocco (art. 215)[15], il fermo (art. 214)[16] e la confisca[17], intesa, analogamente al disposto della l. 689 cit., come provvedimento sanzionatorio ablatorio che porta all’acquisizione in via autoritativa del bene al patrimonio pubblico. La confisca, praticamente, viene disposta dal prefetto con l’ordinanza con cui ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria o con un distinto provvedimento.
Ora, affinché l’ablazione abbia successo e per evitare altresì che il mezzo rimanga nella materiale disponibilità del trasgressore, in ogni caso in cui il codice prescrive la punizione della confisca, l’organo accertatore provvede a sequestrarlo (art. 213 c. 1 cds). Al sequestro deve comunque seguire, a tutela dell’interessato, la confisca entro 5 anni[18].
In questa veste, lo strumento del sequestro assume dei chiari connotati cautelari (cfr. gli artt. 7 c. 2 e 21 bis, ultimo periodo, l. 241/90), allontanandosi dall’archetipo penalistico (artt. 253 e 321 c.p.p.), in quanto non è proteso a garantire la conservazione delle prove né tantomeno ad evitare che l’illecito sia portato ad ulteriori conseguenze (o ne sia commesso un altro). Semmai, si avvicina al modello del sequestro conservativo di diritto civile (artt. 2905 e 2906 c.c. e art. 671 c.p.c., che trova il suo omologo nell’art. 316 c.p.p.), avente per l’appunto finalità di assicurare la soddisfazione del credito tramite il blocco giuridico di una porzione del patrimonio del debitore, rendendo conseguentemente inopponibili al sequestratario gli eventuali atti dispositivi effettuati medio tempore. Con ciò, si badi, non si vogliono misconoscere le diversità strutturali, rituali e sostanziali. È superfluo rammentare che nei rapporti amministrativi il soggetto pubblico spende un potere unilaterale, scandito da una apposita sequenza procedimentale, laddove invece nei rapporti privatistici, retti da formale eguaglianza, il sequestro è disposto da un’autorità terza (il giudice) all’esito di un processo giurisdizionale in contraddittorio; ma queste differenze non elidono né la corrispondenza degli effetti (inefficacia relativa degli atti reali) né l’affinità funzionale dei due strumenti (lato sensu garanzia del credito).
Ebbene, tutto ciò premesso, è evidente che, per ragioni tanto di tutela degli interessi proprietari del sanzionato quanto delle finalità punitive del soggetto procedente, i veicoli sequestrati vadano amministrati accuratamente fin quando l’iter burocratico non si concluda (id est, non vengano restituiti o assorbiti definitivamente alla mano pubblica); i prossimi paragrafi sono appunto dedicati alla normativa di settore.
2.1 – Il quadro normativo vigente in tema di gestione dei veicoli sequestrati: il dpr 571/1982
La primigenia disciplina normativa dei veicoli sequestrati - a tutt’oggi in vigore - si deve al dpr 571/82, il quale regolamenta in guisa di diritto comune la gestione dei beni mobili sequestrati in via amministrativa. Ciò significa che, in materia di circolazione veicolare, tale risalente testo trova applicazione in ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, non vi sia spazio per la normativa del codice della strada[19].
In particolare, gli artt. 8 e ss. sono dedicati agli autoveicoli sequestrati, quando era ancora vigente la precedente regolamentazione organica di cui al dpr 393/1959 (recante il testo unico delle norme sulla circolazione stradale) che tuttavia non prefigurava una sanzione del genere; il referente normativo del potere cautelare amministrativo andava infatti rinvenuto all’esterno di questa cornice e, precisamente, nei già ricordati commi 2 e 3 dell’art. 13 l. 689/1981.
A fronte della regola generale di cui all’art. 7 c. 1 del dpr n. 571, che prevede la custodia dei beni sequestrati presso l’ufficio cui appartiene l’organo sequestrante, le disposizioni successive, assecondando il principio derogatorio scolpito all’art. 7 c. 3, prescrivono l’individuazione di un soggetto pubblico o privato che assuma le vesti di custode ad hoc (art. 8 c. 1). È compito del prefetto territorialmente competente procedere ad una ricognizione degli operatori che possono ricoprire quest’ultimo incarico, su base annuale (art. 8 c. 2)[20]. Una volta proceduti alla verbalizzazione della consegna del mezzo (art. 8 ult. c.) e alla registrazione in apposito elenco (art. 9), il decreto codifica un potere ispettivo in capo all’amministrazione accertatrice - che può effettuare rilievi fotografici e disporre gli opportuni accertamenti - e al trasgressore (art. 10).
Gli artt. 11 e 12 si occupano, d’altra parte, del delicato profilo attinente alle spese di custodia. Nel dettaglio, questi articoli prescrivono che le somme siano liquidate, previa apposita istanza documentata del custode, dall’amministrazione prefettizia, solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento di confisca oppure che sia disposta la restituzione del bene[21]. Le somme sono calcolate sulla base delle tariffe fissate dal prefetto e degli usi locali; è fatto espressamente salvo il diritto di ripetizione di quanto pagato a danno del trasgressore (art. 11 c. 2).
Agli artt. 13, 14 e 16 si rinviene la disciplina della restituzione delle res[22], mentre all’art. 15 viene sancita la regola secondo cui, divenuto definitivo il provvedimento ablatorio, il bene sequestrato deve essere alienato (o distrutto)[23].
Non è operazione ermeneutica agevole quella di inquadrare giuridicamente la natura del rapporto che si instaura tra prefettura e custode in forza del sopra citato art. 8. Da un lato, troviamo l’ente pubblico che, in base al dato legislativo, “individua” e “riconosce” i soggetti a cui affidare la custodia; dall’altro, i custodi che sono “obbligati” a conservare il mezzo e per la cui attività hanno diritto ad un compenso monetario. Sulla sola scorta del dettato normativo, dunque, parrebbe che la prefettura sia chiamata ad emanare un provvedimento meramente accertativo; eppure, un’interpretazione funzionale e sistematica porta alla diversa conclusione che si tratti di atto costitutivo, di matrice autorizzatoria. Difatti, con la sua attività, la prefettura amplia in senso favorevole la sfera giuridica dei custodi, conferendo loro la possibilità di essere coinvolti nel servizio di conservazione dei veicoli; possibilità che in precedenza non potevano all’evidenza sfruttare, a causa di limiti giuridici[24].
L’autorizzazione, più propriamente, si atteggia a precondizione di un rapporto paritetico tra p.a. e custode, fonte di reciproche obbligazioni di stampo negoziale (art. 1766 e ss. c.c.). Da ciò scaturiscono conseguenze giuridiche di sicuro rilievo. Sul versante del diritto pubblico, per esempio, il rapporto p.a.-custode potrebbe essere formalizzato in un accordo sostitutivo ex art. 11 l. 241/90. Sul fronte civilistico, troveranno applicazione le regole codicistiche sul rapporto contrattuale (in primis, le norme sulla responsabilità - artt. 1218 e ss. c.c.). Non vi è dubbio circa la competenza del giudice ordinario in materia di contenzioso sulla relazione bilaterale; è salva quella dell’autorità giurisdizionale amministrativa in punto di valutazioni imperative della prefettura. Giova infine rammentare che, in C. cost. 92/2013, si parla di rapporto iure privatorum, derivante da un accordo contrattuale[25].
2.2 - Segue: la stagione delle rottamazioni straordinarie
Negli anni, a causa della lentezza delle procedure e della carenza di risorse, il sistema congegnato dal dpr 571/82 ha portato ad un considerevole aumento dei veicoli depositati presso custodi privati, con corrispondente lievitazione degli oneri finanziari. Onde far fronte a questa emergenza e facilitare l’avvio del nuovo sistema del custode-acquirente[26], il legislatore è intervenuto in due momenti, inaugurando la fase delle rottamazioni straordinarie.
Dapprima con l’art. 38, commi 2 e seguenti, del d.l. 269/2003[27] è stata costruita una procedura di alienazione coattiva ope legis dei veicoli sequestrati, in uno con quelli fermati e quelli già confiscati ma non venduti, aventi precise caratteristiche indicate dal testo di legge[28]. Nel dettaglio, il comma 2 delimita l’ambito applicativo oggettivo, prevedendo che la procedura coinvolga esclusivamente i mezzi sequestrati (assieme a quelli soggetti a fermo e a quelli che non siano stati alienati per mancanza di acquirenti) a seguito di violazione del codice della strada, immatricolati da almeno 5 anni e collocati presso i depositi di cui al dpr del 1982 da almeno 2 anni[29], purché sprovvisti di interesse storico o collezionistico. Ebbene, tali mezzi, persino se non sottoposti a confisca e carenti della documentazione sullo stato di conservazione, sono ex lege alienati ai medesimi custodi, anche ai soli fini della rottamazione, secondo elenchi disposti su base provinciale dalle prefetture. L’efficacia traslativa discende dalla notificazione di questi ultimi al depositario.
Il quantum della cessione è calcolato dalle amministrazioni in modo cumulativo, tenuto conto delle condizioni di conservazione, del tipo di veicolo, degli eventuali oneri di rottamazione (comma 4), compensandolo con i costi di custodia che, per espressa eccezione legislativa (comma 6), sono rivisti in deroga (e a ribasso) delle tariffe di cui al dpr 571/82.
Il meccanismo brevemente descritto è stato tuttavia colpito da declaratoria di incostituzionalità, con la sentenza n. 92/2013. In sintesi, il giudice delle leggi radica la pronuncia sul fatto che col decreto-legge richiamato si sia snaturata l’originaria relazione p.a.-custode, imponendo a quest’ultimo - in assenza del suo consenso - di rendersi cessionario dei veicoli, derogando per giunta in peius alle tariffe che quantificano il suo corrispettivo. L’intervento legislativo ha in questo modo frustrato l’aspettativa del privato, aggiungendo oneri non prevedibili ad un rapporto di durata e comportando, peraltro, una sperequazione tra quei rapporti di custodia che, in quanto concernenti veicoli immatricolati o detenuti da più tempo, rimangono assoggettati al regime del 1982 e quegli altri che, seppur esauriti, rientrando nella cornice applicativa delineata, sono regolati dal decreto del 2003.
Sebbene sia dunque pacifico l’assunto che una norma retroattiva in materia extrapenale possa essere costituzionalmente legittima, nella specie difetta quel fondamentale requisito di ragionevolezza (art. 3 Cost.), declinato nei termini di un giusto bilanciamento tra le posizioni in gioco, che avrebbe reso immune da censure la novella.
È risaputo che, a seguito della incostituzionalità di una norma speciale, si riespanda la normativa comune, nel nostro caso rappresentata come visto dal dpr 571/82[30]; in special modo, avrebbero dovuto applicarsi le tariffe custodiali (generalmente più onerose) ratione temporis vigenti di cui all’art. 12, al posto dei criteri di calcolo fissati dal citato art. 38 c. 6[31]. Il legislatore, al fine di evitare un aggravio della finanza pubblica, si è nuovamente attivato, sfruttando lo stesso istituto dell’alienazione straordinaria, ma, memore del dictum della Consulta, vi ha apportato alcuni correttivi di non poco momento.
Con la l. 147/2013, art. 1 commi 444 e seguenti, è stato così confezionato un nuovo procedimento, da concludere entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge[32]; l’ambito di applicazione è quasi sovrapponibile a quello del 2003 (veicoli sequestrati, fermati, confiscati o non alienati per mancanza di acquirenti giacenti in deposito da almeno 2 anni, stavolta anche se di interesse storico-collezionistico), mentre è del tutto identico il meccanismo giuridico (alienazione massiva al custode). Le novità sono rappresentate dal coinvolgimento del proprietario (comma 445) e dal ruolo del custode (comma 446). Infatti, sotto il primo versante, redatto e pubblicato ad opera della prefettura l’elenco dei mezzi nelle condizioni descritte, il titolare del bene ha l’onere di ritirarlo entro 60 giorni dalla pubblicazione del menzionato elenco, pagando contestualmente il compenso al custode. È bene precisare che questa strada è rimasta del tutto priva di riscontro pratico, visto che, nella stragrande maggioranza delle ipotesi, i costi di deposito esorbitano il valore del veicolo.
In riferimento al secondo profilo, decorso inutilmente il termine per il ritiro, la prefettura invia una proposta contrattuale di alienazione cumulativa al custode con valenza transattiva (gli artt. 1965 e ss. c.c. sono espressamente richiamati); con essa, viene fissato il corrispettivo della cessione, considerando il tipo e le condizioni del veicolo e gli oneri di rottamazione, al netto di quanto dovuto al privato per il servizio di custodia (comma 447; cosiddetta rottamazione straordinaria transattiva)[33]. L’offerta negoziale è sottoposta expressis verbis ad un termine di efficacia di 15 giorni dalla notifica.
Pertanto, a differenza del modello del 2003, il legislatore ha dato giusta enfasi alla posizione del custode il quale, se vuole concludere l’alienazione transattiva, deve manifestare la sua volontà negoziale; in caso contrario, in armonia col dictum della Corte costituzionale, nessuna cessione può essergli imposta e continuerà ad applicarsi il regime vigente (a seconda dei casi, il dpr del 1982 o il nuovo codice della strada).
2.3 - Segue: il sistema del custode-acquirente
Le rottamazioni straordinarie summenzionate hanno aggredito il carico residuo di veicoli derivanti dal vecchio sistema del 1982, sull’idea che l’entrata in vigore del nuovo meccanismo incastonato nel codice della strada ed incentrato sulla figura del custode-acquirente avrebbe risolto per l’avvenire tutte le difficoltà riscontrate. Come vedremo più avanti, così non è stato.
Procedendo con ordine, occorre analizzare la novella codicistica che risulta attualmente essere la procedura ordinaria; le disposizioni di nostro interesse si rinvengono negli artt. 213, 214 bis e 215 bis cds, per come riscritti negli anni[34]. Il codice sancisce che, ogniqualvolta sia prevista la sanzione della confisca del veicolo, l’organo accertatore ne dispone il sequestro a fini cautelari (art. 213 c. 1 cds). Le successive norme - che invero non brillano per chiarezza testuale né sistematica - si appuntano sulle modalità gestorie del mezzo, onde garantirne un’adeguata conservazione, preferibilmente, non onerosa per la p.a.. È d’altronde chiaro che in questa sede il canone del buon andamento (art. 97 c. 2 Cost.) non si traduce solamente nell’evitare che il singolo sia esposto sine die all’azione amministrativa (art. 1 c. 2 bis l. 241/90), ma anche nell’economicità dell’operazione (art. 1 c. 1 l. 241 cit.).
La prima evenienza, che funge da regola, ma che nella prassi non è così frequente, è che sia nominato custode il proprietario del bene (o, ove sia assente, il conducente o uno degli obbligati in solido, a dire i soggetti dell’art. 196 c. 1 cds: acquirente con patto di riservato dominio, l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, il locatario). Per prescrizione legislativa, infatti, questi è vincolato a trasportarlo e a detenerlo in luogo non sottoposto a pubblico passaggio (art. 213 c. 2 cds)[35]. In questo ordine di idee, la sequenza viene a concludersi sic et simpliciter con la confisca, a cui segue, decorsi 30 giorni dalla sua definitività, il trasferimento del veicolo nella proprietà del custode-acquirente (art. 213 c. 6 cds)[36].
L’art. 213 c. 5 cds annovera due situazioni che deviano dal meccanismo consegnato dal comma 6. Abbiamo innanzitutto il caso in cui il proprietario del veicolo non possa (in quanto infermo di mente, incapace naturalmente[37] o soggetto a misure di prevenzione personale; si veda il combinato disposto degli artt. 120 e 259 c. 1 c.p.p.) o non voglia assumerne la custodia ovvero non adempia agli obblighi prescritti. Da un lato, quest’ultimo viene colpito da pena pecuniaria e sospensione della patente; dall’altro, allo scopo di tutelare l’effettività della sanzione reale, entra in gioco la figura del custode-acquirente, presso il quale viene depositato il mezzo su ordine dell’autorità pubblica. Dell’avvenuto deposito viene data notizia sul sito della prefettura, in uno con l’avvertimento che, se entro i successivi 5 giorni, l’avente diritto non ne assuma la custodia (contestualmente liquidando gli oneri di conservazione), il bene sarà ceduto in proprietà del custode-acquirente[38].
La seconda casistica contemplata dal menzionato alinea ridonda nella prima, in quanto concerne l’eventualità, assai comune nella pratica, in cui il sequestro venga ordinato in assenza del trasgressore (e non sia stato possibile rintracciare nell’immediatezza il proprietario o l’obbligato in solido) - quindi un altro esempio di trasgressore che non ha possibilità di assumere la diretta custodia della res. Qui a mutare sono le sole regole della comunicazione: ferma la consegna al custode-acquirente[39], l’organo accertatore è gravato di ben due adempimenti, a dire la notificazione ai predetti soggetti del verbale di contestazione e di sequestro e, contestualmente, l’affissione sull’albo pretorio comunale dell’avvenuta consegna al custode. Qualora risulti impossibile procedere al primo onere, esso si dà per avvenuto dopo 30 giorni dall’adempimento del secondo[40].
L’art. 213 cds dà per presupposta la più volte citata figura del custode-acquirente, la cui disciplina normativa risiede tuttavia nel successivo art. 214 bis. Tale è il soggetto che, in esito ad una procedura ristretta ad evidenza pubblica, sulla base del canone dell’offerta economicamente più vantaggiosa, addiviene alla stipula di un contratto misto con la prefettura ed il demanio, ergendosi così ad unico interlocutore per quanto concerne la gestione dei mezzi sequestrati. Tramite questo accordo, mentre la parte privata si obbliga ad assumere la custodia dei veicoli e, allo stesso tempo, a rendersi alienataria dei medesimi secondo gli snodi dell’art. 213 cds; invece, quella pubblica si vincola a cederle quei beni e a corrisponderle un prezzo per la custodia, sulla base di valori prestabiliti bilateralmente. Il valore della res è calcolato in concreto dall’agenzia demaniale, previa istanza prefettizia.
Pertanto, le differenze rispetto al vecchio meccanismo delineato dal dpr 571/1982 sono lampanti: alla valutazione imperativa e discrezionale del prefetto nel selezionare i depositi, si sostituisce una gara competitiva; alla fissazione unilaterale amministrativa delle tariffe, l’accordo negoziale; alla pluralità delle depositerie, l’unicità dell’aggiudicatario. Comunque, va ricordato che, in ogni caso in cui non si raggiunga, nel contesto provinciale, la sottoscrizione del contratto ex art. 214 bis cds o questo per qualsiasi causa risulti inefficace, la disciplina a cui fare riferimento resta quella del dpr.
Da ultimo, del tema della liquidazione delle spese di custodia - beninteso quando un custode terzo sia presente, ossia fuori dai casi ordinari di cui al comma 2 - si occupa l’art. 213 c. 3 cds[41]. La norma vuole che, fintantoché perduri la custodia, di essa si occupino le amministrazioni cui appartengono le forze dell’ordine accertatrici; dunque, il comune per la polizia locale, la prefettura per i corpi statali. A seguito della confisca, d’altra parte, le spese sono liquidate dall’agenzia del demanio, dal momento che il mezzo è divenuto bene di proprietà pubblica.
L’impalcatura architettata dagli artt. 213 e 214 bis cds si incentra peraltro su un software informatico, denominato sistema di gestione dei veicoli sequestrati (SIVES)[42] e gestito integralmente dal demanio. È una banca dati, consultabile in tempo reale, da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento: organi accertatori, prefettura, agenzia del demanio, custode-acquirente. Ciò ha senz’altro agevolato la circolazione delle informazioni e facilitato la tracciabilità dei beni; nondimeno, a causa della scarsa formazione del personale, della obsolescenza e complessità dell’applicativo, esso ha finito per generare più problemi di quelli che ha risolto, non foss’altro perché ogni anello della catena procedimentale è bloccato finché quello precedente non è completo[43].
Al fine di evitare le situazioni che, come visto, hanno dato scaturigine alle liquidazioni straordinarie, il legislatore ha introdotto un interessante strumento all’art. 215 bis cds, la cui portata applicativa è stata però compressa in via amministrativa. Questo articolo onera il prefetto di operare una ricognizione, su base semestrale, dei veicoli giacenti da più di 6 mesi presso le depositerie ex art. 8 dpr 571 cit. perché, a seguito di violazione del codice, sequestrati, fermati, confiscati non definitivamente o dissequestrati ma non ritirati. L’elenco di questi viene pubblicato sul sito della prefettura, con l’avvertimento che il proprietario può, entro i 30 giorni successivi, assumerne la conservazione, pagando gli oneri custodiali al deposito; altrimenti, i mezzi confiscati in via non definitiva sono ex lege confiscati definitivamente, laddove gli altri si danno per abbandonati[44]. Ebbene, nonostante il chiaro tenore testuale, alcune circolari ministeriali[45] hanno letto in modo assai restrittivo la disposizione, estromettendola in ogni caso in cui esista sul territorio locale un custode-acquirente.
2.4 - Un parallelismo: la gestione dei beni sequestrati giudiziariamente
Si è già fatta presente l’affinità istituzionale e funzionale del sequestro amministrativo previsto dal codice della strada col sequestro conservativo di diritto civile[46]. A questo punto, chiarito il quadro normativo nella materia amministrativa, pare utile approfondire questo parallelismo, andando a vedere più nel dettaglio come è regolata la gestione dei beni sequestrati dal giudice comune in sede cautelare.
I sequestri sono accomunati dall’essere provvedimenti giurisdizionali costitutivi in rem; cambiano i diritti protetti, la natura del rapporto con le cose, il pregiudizio da prevenire e la tipologia di cose sequestrabili, ma non possono mai concernere comportamenti umani.
Il sequestro conservativo (artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c.)[47] è uno strumento provvisorio e cautelativo che l’ordinamento dispone a favore del creditore di somme (o cose fungibili), allorquando vi sia il rischio di non veder soddisfatto il suo diritto. Il periculum in mora consiste in questo, che, pendente il giudizio di cognizione, il debitore, realmente o fittiziamente, disperda il suo patrimonio, anche a detrimento della realizzazione dei diritti della parte creditrice[48]. Pertanto, onde evitare complesse iniziative processuali (quali l’azione revocatoria e l’accertamento di simulazione), l’ordinamento concede il diritto di bloccare il patrimonio debitorio (purché sia pignorabile), nella misura necessaria a garantire la effettività del pronunciamento giudiziari e soddisfare le pretese del creditore istante, salvaguardando la cosiddetta garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.)[49].
In concreto, tale tipo di misura si atteggia a vincolo disposto per provvedimento giudiziario sulla res che porta all’inopponibilità al creditore sequestrante degli atti effettuati nel frattempo dal debitore comunque finalizzati a vulnerare la sua idoneità a comporre la garanzia patrimoniale (art. 2906 c. 1 c.c.)[50] e, altresì, allo spossessamento materiale; quest’ultimo aspetto, nell’eventualità che si realizzi, si traduce nell’affidamento del bene ad un custode.
Ai fini della presente trattazione, preme analizzare più nello specifico come si concretizzi la gestione del bene sequestrato. Il suo scopo principale è quello di conservare l’integrità fisica delle cose e facilitarne l’amministrazione.
Il codice di rito, opportunamente, opera un distinguo in base alla tipologia di res sequestrata. Tralasciando i beni immobili che hanno una loro disciplina puntuale e legata all’istituto della trascrizione (cfr. art. 679 c.p.c.), per i beni mobili (e i crediti) le norme di riferimento sono quelle del pignoramento, giusto il rinvio che opera l’art. 678 c. 1 c.p.c.. La regola generale è dunque quella fissata all’art. 520 c.p.c. - che nella sostanza non è poi così diverso da quanto sancisce l’art. 7 del dpr 571/82 - il quale, al primo comma, prevede che alcuni beni mobili (denaro, titoli di credito e cose preziose) siano affidati al cancelliere del tribunale (cioè, in fin dei conti, allo stesso “ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale - in questo caso, il magistrato - che ha eseguito il sequestro” di cui parla l’art. 7 c. 1 cit.); per gli altri beni mobili, invece, il comma 2 prevede tre alternative: su istanza del creditore, affidamento ad un pubblico deposito o ad un terzo o, in caso di urgenza, ad un istituto di vendita giudiziaria (ivg) di cui all’art. 159 disp. att. (proseguendo nell’analogia, cfr. l’art. 7 c. 3 cit.). L’istanza del creditore - salve urgenze - è dunque condizione necessaria perché la custodia non sia conferita al cancelliere; è inoltre vincolante per l’organo procedente.
Ove si decida di dare in custodia il bene a terzi, il successivo art. 521 c.p.c. precisa che non possa essere scelto il debitore (o il suo coniuge) senza il consenso del creditore; l’inverso vale per la nomina del creditore. La regolamentazione circa la scelta è poi completata dal citato art. 159 disp. att. che prevede che gli istituti di vendite all’incanto di cui parla anche art. 520 c. 2 c.p.c., per svolgere le loro attività in materia (custodia compresa), debbano essere autorizzati con provvedimento amministrativo del Ministero della giustizia; nel medesimo atto, vengono disposte le misure di controllo e i corrispettivi[51]: sono evidenti le analogie col decreto prefettizio di cui all’art. 8 dpr 571/82.
Gli ivg sono, quindi, soggetti economici in forma personale o societaria che, con autorizzazione ministeriale di durata quinquennale e tacitamente rinnovabile, sono abilitati a vendere all’incanto i beni nelle procedure giudiziarie esecutive nonché ad assumerne la custodia. Nell’esercizio di tali funzioni sono equiparati ad ausiliari del giudice.
Dei compensi dovuti al custode non proprietario si occupa in via generale il dpr 115/2002, il cui art. 58 c. 2, in corrispondenza con l’art. 12 c. 3 dpr 571/82, rinvia ad un decreto ministeriale e agli usi.
Ulteriormente, in caso di sequestro conservativo su veicoli, l’art. 521 bis c.p.c. specifica che sia lo stesso debitore ad essere nominato custode (comma 2), come vorrebbe d’altra parte l’art. 213 c. 2 cds, e che l’ivg subentri solo in un secondo momento, per la precisione col deposito dell’istanza di vendita (artt. 501 e 529 c.p.c.; identicamente, d’altra parte, vale per il custode-acquirente nell’ipotesi madre dell’art. 213 c. 6 cds). Nondimeno, l’ultimo comma della disposizione, facendo espressamente salve le disposizioni del capo, non esclude la possibilità che si applichi l’art. 520 c. 2 c.p.c., potendosi dunque procedere alla nomina di un custode terzo o direttamente all’affidamento all’istituto.
In sintesi, traendo le conclusioni, l’assunzione della qualità di custode di cose sequestrate in sede civile può avvenire per legge (art. 520 c. 1 c.p.c. per il denaro), per nomina da parte dell’ufficiale giudiziario (art. 520 c. 2 c.p.c.), per nomina del giudice dell’esecuzione (art. 520 c. 1 c.p.c. per titoli di credito e cose preziose); nel contesto del codice della strada, o per legge (art. 213 c. 2 cds) o per nomina autoritativa.
Tanto in sede civile, quanto in sede amministrativa, chiunque sia dotato di capacità d’agire può essere nominato custode, salvi i limiti indicati sopra; per gli ivg e per le depositerie, la qualità segue l’ottenimento del provvedimento amministrativo ampliativo. L’atto di nomina nel contesto civile è sempre condizionato però all’accettazione del terzo, in quanto non esiste obbligo di assumere l’incarico; non è necessaria invece per gli istituti di vendita in quanto, come i custodi amministrativi, l’accettazione è assorbita dall’istanza di ottenimento dell’autorizzazione (per il custode-acquirente il vincolo deriva ovviamente dal contratto stipulato con la p.a.).
Gli obblighi a cui sono astrette le due tipologie di custodia sono essenzialmente i medesimi (salva l’obbligazione di acquisto che grava solo sul custode-acquirente), pur cambiando le fonti (legge per il diritto civile, atto amministrativo o negoziale per il diritto amministrativo): gestione della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, obbligo di non usarla, obbligo di consegnarla al nuovo custode subentrante o di restituirla al debitore nei casi dovuti. Comune è quindi la natura del rapporto autorità-custode: ora longa manus dell’amministrazione, ora del giudice (testualmente ausiliario del giudice in base agli artt. 65 e ss. c.p.c.), ma comunque relazione di stampo pubblicistico[52] (eccezion fatta per il custode-acquirente, il cui rapporto è ovviamente di matrice negoziale).
Infine, non si registrano differenze in punto di legittimazione processuale e di responsabilità. Sotto il primo profilo, i custodi sono abilitati ad agire a tutela del possesso per fatti accaduti successivamente l’incarico; la tutela possessoria per fatti anteriori e quella petitoria spettano al proprietario debitore. Rispetto all’altro tema, il custode è responsabile penalmente (artt. 328, 334, 335, 388 e 388 bis c.p.) e civilmente (inter partes ex artt. 1218 e 1768 c.c.; verso i terzi: artt. 2043 e 2051 c.c. e 67 c. 2 c.p.c.); sanzione amministrativa ad hoc per gli istituti e le depositerie è la decadenza dall’autorizzazione. Solo in diritto civile vale la sanzione punitiva pecuniaria prescritta dall’art. 67 c. 1 c.p.c., mentre esclusivamente per il custode-acquirente si può parlare di rimedi contrattuali per l’inadempimento (artt. 121 e ss. del codice degli appalti; artt. 1453 e ss. c.c.).
3.1 - Criticità applicative
La gestione dei veicoli sequestrati nelle grandi aree metropolitane, per la vastità dell’agglomerato urbano nonché per l’enorme quantitativo di veicoli che quotidianamente vi stazionano, è caratterizzata da evidenti difficoltà, con la grave conseguenza, tra l’altro, di aumentare l’esposizione passiva dell’amministrazione. Lo spunto è occasione per prospettare alcuni interventi di riforma.
Da quando è entrato a pieno regime il meccanismo del custode-acquirente (2010), le prefetture sono state chiamate ad espletare le procedure ad evidenza pubblica e a stipulare i relativi contratti. L’ingente posizione debitoria che si è formata nel corso degli anni presso alcune province deriva eminentemente dalla combinazione tra i cospicui costi tariffari sanciti nei contratti, soprattutto quelli perfezionati all’indomani della riforma, quando la concorrenza era ancora in uno stadio embrionale, e la protratta permanenza presso il custode-acquirente[53].
Sotto quest’ultimo profilo, le problematiche risalgono in maniera precipua a veicoli che:
a) per vari motivi procedurali, quali la mancata valorizzazione del campo della custodia ovvero la presenza di errori di inserimento nell’applicativo informatico, è impossibile allo stato cedere al custode-acquirente con i meccanismi ordinari dell’art. 214 bis cds;
b) pur provvisti dei requisiti di alienabilità - e che quindi potrebbero in tesi seguire la strada dell’art. 214 bis - si stenta a vendere a fronte delle risorse umane disponibili.
Nell’uno come nell’altro caso, sono mezzi che continuano a generare crediti proprio perché rimangono nella custodia della controparte contrattuale. Non secondario, inoltre, appare il tema del rischio ambientale, connesso alla vetustà e lunga giacenza di questi beni.
Considerato dunque che i veicoli, la cui custodia rientra in queste due cornici, sono approssimabili in svariate migliaia[54] e che producono un debito, da ripartire secondo le competenze di ciascuna amministrazione coinvolta, calcolato in decine di milioni di euro l’anno[55], il quale non si riesce a scalfire con le procedure ordinarie, si è arrivati ad ipotizzare un armamentario innovativo per farvi fronte con l’idea di aggredire efficacemente la rilevante massa passiva pregressa, di ridurre per il futuro il rischio di un aggravio dell’esposizione debitoria nonché di scongiurare i rischi ambientali.
Innanzitutto, è imprescindibile avviare un’azione strategica di carattere onnicomprensivo e sistemico.
Sotto il profilo organizzativo e gestionale, è necessaria una proficua attività di reingegnerizzazione e dematerializzazione dei processi lavorativi finalizzati allo smaltimento dei veicoli, con un aumento della media mensile di alienazioni. Cruciale, inoltre, appare il tema della formazione e dell’assunzione di personale.
Sul versante informatico, sono state individuate specifiche vulnerabilità che contaminano la procedura in discorso, inerenti in special modo il corretto e completo inserimento dei dati nel software da parte degli organi accertatori, e che ostacolano la chiusura delle procedure di alienazione. Di questo deve occuparsi il demanio, dominus dell’applicativo.
Ferme dunque queste apprezzabili direttrici, con l’obbiettivo di realizzare pienamente la strategia di intervento elaborata e conferirle compiuta efficacia, soprattutto rispetto alle giacenze presso il custode-acquirente, risulterebbero di somma utilità ulteriori strumenti, stavolta di carattere normativo, amministrativo e/o negoziale, volti a superare le lacune e le disfunzionalità derivanti dalla disciplina attualmente in essere. Ciò è oggetto di excursus nel seguente paragrafo.
3.2 - Proposte di intervento sul piano normativo e negoziale
Il pacchetto che si propone è volto ad abbattere l’esposizione debitoria derivante dagli oneri custodiali sopra descritti, mediante l’avvio di una procedura eccezionale di alienazione massiva delle vetture giacenti presso il custode-acquirente, ai prezzi già sanciti negozialmente.
La sequenza, in sintesi, si articola nei seguenti passaggi:
1. effettuazione, da parte della prefettura, di una ricognizione dei veicoli - vendibili e non - affidati al custode prima del 2022[56] e a tutt’oggi ivi giacenti, tramite l’applicativo SIVES;
2. pubblicazione dell’elenco, per 30 giorni, sul sito istituzionale della prefettura, con valore legale di notifica ai proprietari dei mezzi;
3. facoltà per l’avente diritto di assumere la custodia del veicolo entro i predetti 30 giorni, con pagamento degli oneri maturati per la custodia, il recupero ed il trasporto;
4. spirato il termine, acquisizione ex lege del carattere di vendibilità dei veicoli carenti dei requisiti di alienabilità e cessione ex contractu al custode-acquirente, senza alcun ulteriore atto amministrativo, dei veicoli indicati ma non ritirati, in uno con gli altri già ex ante vendibili, verso il pagamento del corrispettivo previsto da ciascun contratto.
In questo modo si evita il continuo crescere della massa passiva, con immediato e definitivo blocco dei costi di custodia sin dal momento dell’avvenuta pubblicazione. Trattasi inoltre di una procedura completamente informatizzata che non coinvolge l’agenzia del demanio, né per le stime di vendita né per la gestione delle rottamazioni, ciò comportando un enorme risparmio di tempi ed uno snellimento dell’iter amministrativo[57].
Giova sottolineare, poi, che la sequenza si armonizza perfettamente con la figura del custode-acquirente di cui all’art. 214 bis del codice della strada, il quale non vede vulnerata la propria posizione contrattuale; altrimenti opinando, rimanendo inalterata la situazione, il rapporto negoziale si squilibrerebbe - più di quanto non lo sia già - a vantaggio di questi, in totale spregio dei fondamentali canoni regolatori degli accordi contrattuali (su tutti, la buona fede oggettiva nell’esecuzione dell’accordo: art. 2 Cost. e art. 1375 c.c.).
In aggiunta, dal punto di vista finanziario, la presente proposta non comporta nuovi o maggiori oneri. Le poste debitorie così aggredite discendono difatti da rapporti contrattuali già in essere a legislazione vigente. Vista poi la materiale difficoltà del sistema di assorbire una tale mole di rottamazioni, le fatturazioni, così come le liquidazioni, verranno necessariamente diluite nel tempo.
Rispetto all’ambito applicativo oggettivo, restano invero escluse dal discorso le vetture sottoposte a sequestro penale.
Nondimeno, nel rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa (art. 97 c. 2 Cost. e art. 1 c. 1 l. 241/90), la sequenza delineata - allo stato extra ordinem - deve ancorarsi ad una base giuridica.
Visto che il modello di riferimento è la combinazione tra gli artt. 214 bis e 215 bis del codice, sarebbe sufficiente intervenire con una modifica normativa che integri i due sistemi - la ricognizione ex art. 215 bis e l’alienazione al custode-acquirente di cui all’art. 214 bis - generalizzando e mettendo a regime la procedura eccezionale di alienazione qui proposta.
La novella legislativa, che per ragioni sistematiche è opportuno sia inserita nel codice, potrebbe essere così delineata:
“Al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’art. 214-ter è aggiunto il seguente:
Art. 214-quater (Alienazione straordinaria dei veicoli giacenti presso il custode-acquirente)
1. Il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso il custode-acquirente a seguito dell’applicazione di misure di sequestro di cui al presente codice, comunque custoditi antecedentemente al 2022, anche se non confiscati. Dei veicoli giacenti, individuati secondo tipo, modello e numero di targa o di telaio, viene formato un elenco da pubblicare sul sito istituzionale della prefettura competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti dal pubblico registro automobilistico. Tale pubblicazione ha effetto legale di notificazione agli effetti dell’art. 213, comma 5.
2. L’elenco contiene l’avviso che il proprietario o un altro dei soggetti di cui all’articolo 196 del presente codice, entro i successivi trenta giorni, può assumere la custodia del veicolo, pagando le somme spettanti al custode-acquirente, estinguendo contestualmente il debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo.
3. Spirato inutilmente il termine di cui al comma precedente, i veicoli non confiscati divengono di diritto confiscati e sono alienati, assieme agli altri presenti nell’elenco ma non ritirati, al custode-acquirente.
4. Il prezzo dell’alienazione è pari alla quotazione sancita nel contratto col custode-acquirente per i veicoli da cedere ai fini della rottamazione.”.
Inoltre, sarebbe auspicabile ipotizzare, in alternativa o in aggiunta alla via legislativa, una modifica amministrativa tramite una circolare ministeriale che abiliti le prefetture, che si trovino in situazioni analoghe, ad impiegare lo schema tratteggiato, con i correttivi proposti.
Più nello specifico, visto che sull’interpretazione dell’art. 215 bis cit. esistono plurime circolari già citate sopra[58] che espressamente o implicitamente ne vietano l’applicazione ove esista un custode-acquirente[59], sarebbe opportuno intervenire, prioritariamente, in sede amministrativa su questi atti, derogando al divieto e, allo stesso tempo, regolamentando la procedura qui delineata.
A rigor del vero, mentre il decreto n. 152 del 2021, emanato dal Ministero dell’interno, di concerto col demanio, non eccettua testualmente dall’art. 215 bis cds i veicoli inseriti nel circuito SIVES (cfr. a contrario l’elenco di cui all’art. 2 c. 2), la circolare n. 813/19, peraltro, fa espressamente salvo “[…] il ricorso ad altre soluzioni individuate dall’ordinamento vigente che assicurino tempi più rapidi rispetto a quelli stabiliti dalla novella [cioè, l’art. 215 bis]”.
Altro possibile strumento di intervento è la transazione contrattuale (artt. 1965 e ss. c.c.). Da un punto di vista soggettivo, le parti della convenzione devono essere le medesime che hanno stipulato il contratto SIVES, a dire la prefettura, l’agenzia del demanio e il custode-acquirente.
Per quanto concerne l’oggetto e l’efficacia negoziale, occorre riprendere il distinguo tra veicoli confiscati e non:
a) per i primi, che hanno visto concludersi il procedimento amministrativo divenendo proprietà pubblica ex art. 213 c. 6 cds, è possibile procedere con una transazione avente effetti reali, che cioè, in uno con il diffalco del debito, trasferisca la titolarità dei beni al custode-acquirente;
b) per i secondi, invece, in quanto ancora non rientranti nel patrimonio pubblica, non è percorribile una strada del genere, salvo voler forzare il dato testuale dell’art. 213 c. 5 cds[60]. Si ritiene di poter addivenire ad una transazione che riguardi le sole poste creditorie derivanti dai contratti SIVES, ma non il trasferimento delle vetture. Per arrivare a questo risultato, sarebbe utile condizionare l’efficacia della transazione all’adozione in via legislativa della procedura di alienazione sopra indicata.
D’altronde, per una maggiore incisività, i due strumenti, quello normativo e quello negoziale, ben possono combinarsi tra loro, specialmente per quanto riguarda i veicoli non oggetto di ablazione[61].
In conclusione, in esito alla disamina effettuata, sorge un legittimo dubbio sulla ragionevolezza e sostenibilità del meccanismo sequestro-confisca nel suo complesso. Il ripresentarsi ciclicamente dell’esigenza di interventi straordinari per colmare deficit dei vari strumenti che si sono affacciati nei decenni, è sintomatico del fatto che il sistema ordinario non è immune da problematiche e che nel giro di pochi anni entra in fibrillazione; sarebbe forse logico pensare dunque ad azioni trasversali ancor più incisive che vadano a toccare il cuore del tema.
Da un semplice confronto costi-benefici è evidente che un intervento radicale di abrogazione del sequestro non appare, in ultima analisi, un fuor d’opera. Si tratterebbe, più precisamente, di eliminare la sanzione reale per le violazioni meno gravi (per esempio, gli artt. 132 c. 5 e 134 cds), prevedendo un contestuale innalzamento della pena pecuniaria; di sostituire la confisca col fermo per le situazioni in cui non si possa prescindere dall’agire sul veicolo (ad esempio, taxi abusivo - art. 86 c. 2 cds); infine, di introdurre la confisca immediata, senza intercessione del sequestro, per le trasgressioni più gravi e socialmente odiose (come guida in stato di ebbrezza o sotto droghe di cui agli artt. 186 e 187 cds). Degne di note anche le proposte di introdurre una sorta di astreinte, che compulsi il proprietario del veicolo ad assumerne la custodia (o a rinunciarne al dominium in favore della p.a.) sotto la minaccia di una sanzione giornaliera; di impiegare aree di proprietà pubblica per internalizzare il servizio di deposito a costi chiaramente inferiori; o, ancora, di riesumare la disciplina contenuta nell’art. 264 c. 2 c.p.p., oggi abrogato, surrogando la discrezionalità del giudice con quella dell’amministrazione circa l’opportunità dell’alienazione del bene dopo il sequestro ove la custodia si prospetti come troppo dispendiosa[62].
[1] Gli elementi costitutivi sono, coerentemente con la concezione tripartita: la componente materiale (contegno tipico attivo od omissivo, evento dannoso, nesso di causa), l’antigiuridicità (assenza di cause di giustificazione), la colpevolezza (imputabilità, suitas, colpa o dolo). Funditus, Napolitano G., Manuale dell’illecito amministrativo, Santarcangelo di Romagna, 2021, passim; Colla G., Manzo G., Le sanzioni amministrative, Milano, 2001, passim; Cerbo P., Le sanzioni amministrative, Milano, 1999, passim; Casetta E., voce Sanzioni amministrative, in Digesto delle discipline pubblicistiche, XII, Torino, 1997, 598 e ss. e voce Illecito amministrativo, in Digesto delle discipline pubblicistiche, VIII, Torino, 1993, 89 e ss.; Paliero C. E., Travi A., voce Sanzioni amministrative, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1989, 354 e ss.; Pagliari G., Profili teorici della sanzione amministrativa, Padova, 1988, 45 e ss.; Sandulli M. A., Le sanzioni amministrative pecuniarie, Napoli, 1983, passim; Zanobini G., Le sanzioni amministrative, Torino, 1924, passim.
[2] Nel corso degli anni si sono registrate plurime iniziative in questo senso; si ricordino la l. 317/67, le leggi nn. 469, 561 e 5625 del 1993, il d.lgs. 507/99 e, da ultimo, i decreti delegati nn. 7 e 8 del 2016.
[3] L’intentio legislatoris è disvelata dall’art. 12 della stessa legge.
[4] Buona parte di essi è sovrapponibile ai canoni del diritto penale, basti guardare ai principi di legalità, tassatività, determinatezza (art. 1). Altri assumono viceversa delle sfumature, come quelli di riserva di legge (cfr. C. cost. 5/21) e di irretroattività sfavorevole. Altri non trovano proprio applicazione, come la retroattività in melius (C. cost. 193/16; Cons. St. sez. VI n. 3497/10; Cass. sez. II n. 24111/14). L’avvicinamento è comunque reso più evidente se si pone mente a quanto statuito dalla Corte EDU nel noto caso Engel c. Paesi Bassi dell’8.6.1976. Il tema è troppo vasto per essere affrontato; sia consentito rinviare alla cospicua giurisprudenza costituzionale (ex multis, C. cost. nn. 63/19, 109/17, 68/17, 43/17 e 193/16) e alla dottrina (Manes V., Profili e confini dell’illecito para-penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2017, 988 e ss.; Goisis F., La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2015, passim; Paliero C. E., Materia penale e illecito amministrativo secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo: una questione classica a una svolta radicale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1985, 912 e ss.).
[5] Come, per esempio, il concorso di persone (art. 5), la responsabilità solidale di terzi (art. 6), il concorso formale di illeciti (art. 8), la reiterazione (art. 8 bis), il concorso apparente di norme (art. 9), la prescrizione (art. 28).
[6] Gli snodi sono scanditi agli artt. 13 e ss. e si possono così sintetizzare: accertamento della violazione, contestazione (immediata o differita), rapporto dell’organo (ove manchi il pagamento in misura ridotta), segmento innanzi all’autorità amministrativa decidente (con eventuale contraddittorio), decisione finale (archiviazione o ordinanza ingiunzione). La riscossione coattiva della sanzione pecuniaria è infine analoga a quella dell’esazione delle entrate tributarie dirette (l’art. 27 rinvia al dpr 602/1973).
[7] Si fa riferimento agli artt. 22 e ss.; oggi la materia è assorbita dagli artt. 5 e 6 del d.lgs. 150/2011. L’ordinanza ingiunzione risulta così opponibile innanzi al giudice ordinario, secondo le forme del rito del lavoro (artt. 410 e ss. c.p.c.), salve deroghe.
[8] La definizione di sequestro che qui si asseconda deriva da quella presente in Sandulli A. M., Manuale di diritto amministrativo, II, Napoli, 1989, 886, differente da quella ad esempio di Giannini M. S., Diritto amministrativo, Milano, 1988, 1173, che lo etichetta come atto esecutivo endoprocedimentale, non sempre provvedimentale. Sul sequestro amministrativo in generale, Pini R., voce Sequestro. Diritto amministrativo in Enciclopedia giuridica, XXVIII, Roma, 1992, passim; si veda altresì la norma, di dubbia validità, contenuta nell’. Giova comunque ricordare che l’ordinamento conosce innumerevoli ipotesi di sequestro amministrativo, per dir così, stravagante, in quanto esterne all’ordito della legge del 1981 (per esempio, l’art. 38 c. 2 r.d. 1604/31 in tema di pesca; art. 38 c. 3 r.d. 773/1931 in tema di armi gli artt. 101, 126, 141 r.d. 1265/34 in tema di sanità; l’art. 28 c. 3 dpr 309/90 in tema di stupefacenti); tutto ciò rende ovviamente assai complessa una ricostruzione unitaria del fenomeno, tanto da indurre la dottrina a denunciare la mancanza di approfondimento scientifico della materia, spesso negletta o resa succube delle costruzioni civilistiche o penalistiche (Pini R., op. cit., 2-3).
[9] Cfr. Sandulli M. A., voce Confisca. Diritto amministrativo, in Enciclopedia giuridica, VIII, Roma, 1988, passim, che distingue tra una confisca cautelare-preventiva ed una propriamente sanzionatoria, per derivarne alcune importanti conseguenze circa le caratteristiche del bene confiscabile ed i limiti delle misure rispetto ai diritti dei terzi aventi causa. Altri spunti si possono trarre in Sandulli A. M., La potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, Napoli, 1981, 91 e ss. e in Iaccarino C. M., La confisca, Bari, 1935, passim.
[10] Queste, in sintesi, le finalità sottese il sequestro: cfr. Pini R., op. cit., 1.
[11] Tale disposizione venne introdotta quando non esisteva la sanzione reale nel contesto della circolazione stradale; oggi, con la nuova codificazione, il comma in parola è da ritenere verosimilmente abrogato. In ogni caso, le forme procedimentali del sequestro sono fissate nel regolamento di attuazione dpr 571/1982, oggetto di approfondimento nel par. 2.1; per i rimedi, valga il rinvio all’art. 19 c. 1 della l. 689 cit..
[12] Per Sandulli M. A., op. cit., 3, lo stesso vale per il prezzo ed il profitto dell’illecito.
[13] Valga qui quanto riferito nella precedente nota n. 8 per il sequestro.
[14] Come l’obbligo di contestazione immediata (art. 200) - salva la notificazione ex post (art. 201), l’enfasi per il pagamento in misura ridotta (art. 202), la rateizzazione (art. 202 bis). Dei rimedi giustiziali si occupano gli artt. 120 c. 4, 203 e 204 (rispettivamente, ricorso al ministro e ricorso al prefetto), di quelli giurisdizionali l’art. 204 bis (il quale rimanda all’art. 7 del d.lgs. 150/11 che richiama il rito lavoristico).
Ricordiamo poi che la vis espansiva della l. 689/81 (art. 12) si arresta rispetto alle sanzioni non pecuniarie.
[15] Cioè, il materiale spostamento o blocco del mezzo.
[16] Il veicolo in questo caso non può essere usato per un certo periodo di tempo, decorso il quale torna nella disponibilità dell’avente diritto. Trattasi dunque di sanzione reale a termine che impinge sostanzialmente la fruibilità concreta della res.
[17] Elenchiamo qui di seguito tutte le disposizioni codicistiche, la cui violazione è punita con la confisca: artt. 9 ter cc. 1 e 3 (gare in velocità con veicoli a motore); 70 c. 4 (uso di veicolo a trazione animale o di slitte per servizio piazza senza licenza); 80 c. 14 (reiterazione uso di veicolo senza revisione); 86 c. 2 (taxi abusivo); 93 c. 7 (veicolo privo di immatricolazione, veicolo radiato per mancato bollo o per intestazione fittizia); 93 bis c. 7 ( veicoli immatricolati all’estero e condotti in Italia da residenti senza le prescritte formalità); 97 c. 5 (fabbricazione con cilindrata maggiorata o maggiorazione della cilindrata di ciclomotore); 97 c. 7 (ciclomotore senza immatricolazione); 97 c. 14 (reiterazione di ciclomotore privo di targa o con targa non propria); 98 c. 4 (reiterazione veicolo in circolazione di prova senza titolare); 99 c. 5 (reiterazione mancanza di foglio di via); 100 c. 15 (reiterazione veicolo con targa non propria o falsa); 116 c. 17 (reiterazione veicolo guidato senza patente); 124 c. 4 (reiterazione uso veicolo agricolo senza patente); 132 c. 5 (veicolo estero da più di 1 anno in Italia); 134 c. 2 (targa EE scaduta); 168 c. 8 bis (reiterazione trasporto merci pericolose); 176 c. 22 (reiterazione guida contromano); 186 c. 2 lett. c) (guida in stato di ebbrezza); 187 c. 1 (guida sotto effetto droga); 193 c. 4 (mancanza di assicurazione); 213 c. 2 sexies (reato commesso a bordo di veicolo); 213 c. 8 (uso veicolo sotto sequestro amministrativo); 214 c. 8 (uso veicolo sotto fermo); 216 c. 6 (reiterazione guida con documenti ritirai); 217 c. 6 (reiterazione guida con carta di circolazione sospesa); 218 c. 6 (reiterazione guida con patente sospesa).
[18] Conformemente al disposto di cui all’art. 28 l. 689 cit.; ex plurimis, Cass. sez. II n. 21881/09. D’altra parte, per la l. 689/81, art. 19 c. 3, il sequestro decade di diritto se non occorre la confisca entro 6 mesi (cosiddetta perenzione).
[19] Quest’aspetto sarà più chiaro con la lettura dei paragrafi seguenti; si rinvia fin d’ora al par. 2.3. Si vedano tra l’altro le similari dizioni degli artt. 394 e 395 dpr 495/92 (contenente il regolamento esecutivo del codice) che parrebbero aver abrogato il decreto in analisi e che di fatto hanno fissato la disciplina della materia sino alle riforme del d.l. 269/2003.
[20] Per esempio, presso la prefettura di Roma, si guardino la nota 305231/2019 e il decreto tariffario 23977/2018; presso la prefettura di Campobasso, la nota 62546/2021 e il decreto tariffario 62544/2021; presso quella di Perugia, la nota 4453/2023 e il decreto 364/2021.
[21] Per le ulteriori ritualità si vedano i commi 3 e ss. dell’art. 12.
[22] Qualora l’avente diritto non ritiri la cosa entro sei mesi da quando l’atto che ne dispone la restituzione è divenuto inoppugnabile, l’amministrazione ne dispone la vendita e accantona le somme così ricavate (art. 16). Questa norma, tuttavia, dovrebbe oggi ritenersi abrogata, dal momento che per i veicoli abbandonati esiste una disciplina speciale di cui al dpr 189/2001, che vede coinvolto in prima battuta il demanio.
[23] Ovviamente il denaro ottenuto dalla vendita va devoluto all’erario. Se il bene sequestrato è di interesse storico o artistico può essere acquisito al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 15 c. 3); ai commi successivi viene dettagliata la sorte di altre tipologie di beni che qui possiamo pretermettere.
In base all’art. 17, le procedure di alienazione seguono la disciplina della contabilità di Stato (cfr. r.d. 2440/1923).
[24] Anzi, non è un fuor d’opera ipotizzare che, attualmente, in forza dei principi eurounitari di concorrenza, tali rapporti dovrebbero essere sottoposti alla disciplina del codice degli appalti (d.lgs. 36/2023). A rigore, in forza del d.lgs. 59/2010, attuativo della direttiva CE 123/2006 (cosiddetta Bolkenstein, dal nome suo promotore), le attività economiche dovrebbero essere liberalizzate (artt. 10 e ss.), salvo che, come nella fattispecie de qua, le risorse disponibili non siano scarse. È evidente che la quantità di macchine sequestrabili nel territorio provinciale è naturalmente finito; pertanto, onde evitare forme larvate di monopolizzazione del mercato, l’amministrazione dovrebbe svolgere delle gare ad evidenza pubblica che stimolino la concorrenza (art. 16 e ss.). Va però aggiunto che, in base all’art. 12 del decreto delegato, il regime autorizzatorio torna ad essere tollerato ove sussistano motivi imperativi di interesse generale e l’art. 8 lett. h) ricorda che tali sono, tra gli altri, l’ordine pubblico, la sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente, ossia tutti elementi di sicuro rilievo nella materia de qua.
[25] Circa la sentenza della Consulta, si veda infra il par. 2.2. Per approfondimenti sul fronte privatistico, sia concesso rimandare a Natoli U., I contratti reali, Milano, 1975 e a Majello U., Custodia e deposito, Napoli, 1958, passim.
È pur vero che i contratti della p.a. vanno formati per iscritto a pena di nullità (art. 1350 c.c. e artt. 16 e 17 r.d. 2440/23) e, nella fattispecie, manca un testo negoziale. Pertanto, si potrebbe pensare di inquadrare la situazione in un rapporto contrattuale di fatto, che deriva la disciplina codicistica per il solo profilo della relazione bilaterale (cfr. per approfondimenti: Bianca C. M., Diritto civile. I contratti, Milano, 2019, 29 e ss.; Irti N., Scambi senza accordo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, II, 1998, 347 e ss; Angelici C., voce Rapporti contrattuali di fatto, in Enciclopedia giuridica Treccani, XXV, Roma, 1991, 8 e ss.).
[26] Per cui si rimanda al par. 2.3.
[27] Convertito con modifiche nella l. 326/2003.
[28] La sequenza ivi delineata prevale pure sulle procedure speciali di alienazione eccezionalmente attivate dalle singole prefetture e si applica al loro posto (comma 10).
[29] Rispetto al 30 settembre 2003.
[30] Cfr. Amoroso G., Parodi G., Il giudizio costituzionale, Milano, 2020, 455 e ss. e Celotto A., Modugno F., La giustizia costituzionale, in Modugno F. (a cura di), Diritto pubblico, Torino, 2016, 754 e ss..
[31] Attualmente, le procedure di rottamazione del d.l. 269/03 sono all’evidenza tutte esaurite. La maggiore problematica che residua riguarda proprio il calcolo dei debiti nei confronti dei custodi, secondo la previgente disciplina del 1982. Ciò ha generato un contenzioso sia innanzi al giudice ordinario, che, chiamato ad accertare la posizione creditoria dei custodi, è per lo più sfociato in un esito favorevole per la parte pubblica sulla base dell’avvenuta prescrizione dei diritti privati, ormai considerati esauriti e quindi insensibili alla sentenza della Consulta (cfr. ad esempio, Trib. Roma, sez. II, 21603/2018); sia davanti al giudice amministrativo, ai fini dell’invalidazione tout court del provvedimento emanato in forza dell’art. 38 (qui il percorso processuale è stato più tortuoso; non si può che rinviare a TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 17501/2022 e a Cons. St., sez. III, n. 8182/2023).
[32] Tale termine è stato, condivisibilmente, letto come non perentorio.
[33] Si veda a tal proposito pure il decreto dirigenziale 10 settembre 2014 del capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, di concerto col demanio, sulle modalità di alienazione.
[34] In teoria, anche l’art. 214 ter rileverebbe; essendo tuttavia riferito allo specifico tema della destinazione delle auto confiscate, può essere in questa sede trascurato. Per ragioni analoghe non ci diffonderemo sull’art. 214, che tratta della sanzione del fermo; tuttavia, precisiamo che buona parte di quanto scritto nel corpo è estensibile pure a questo istituto sanzionatorio. Degni di menzione sono gli articoli del regolamento di attuazione (dpr 495/92), in specie gli artt. 394 e ss..
Le riformulazioni più significative nella materia de qua si devono al già menzionato d.l. 269/2003 (che ha introdotto la nuova figura), alla l. 120/2010, al d.l. 113/2018 e al d.l. 121/2021.
[35] Il documento di circolazione è inoltre ritirato e sul veicolo vengono apposti dei segni dell’avvenuto sequestro; le attività sono verbalizzate.
[36] La norma fa salvo anche un potere di autotutela esecutoria in capo all’amministrazione. Del profilo della giustiziabilità delle posizioni del privato si occupa il successivo comma 7, rinviando all’art. 203.
[37] Nel caso di minore, la custodia è affidata al genitore, a chi ne fa le veci o a un terzo delegato.
[38] È invero singolare che la p.a. proceda ad alienare un bene di cui ancora non è formalmente titolare (dacché manca la confisca). Potrebbe immaginarsi che, in coerenza con l’art. 42 c. 2 Cost., sia la medesima legge a disporre, a mo’ di sanzione, la traslazione della proprietà a titolo derivativo a favore del custode-acquirente, pur in mancanza del consenso del precedente avente causa. A quanto consta, non risulta che il tema sia stato approfondito né in dottrina né in giurisprudenza.
A tacer d’altro, la disposizione prevede che la somma ricavata dall’alienazione sia depositata in un conto fruttifero e che venga confiscata quando viene disposta la confisca, oppure restituita negli altri casi.
[39] Pur nel silenzio di questa parte della disposizione, pare ragionevole che il meccanismo di alienazione al custode-acquirente sia il medesimo già analizzato (pubblicazione sul sito, decorso di 5 giorni).
[40] Visto l’impatto pratico, questa opportuna valvola di sfogo è stata reintrodotta col d.l. 121/21, dopo essere stata improvvidamente cancellata col d.l. 113/18, secondo il previgente tenore testuale di cui all’art. 213 c. 2 quater (d.l. 269/03). Il problema, allo stato, rimane per i sequestri effettuati tra il 2018 ed il 2021, visto che, vigendo la regola tempus regit actum, la riforma più recente non può applicarsi retroattivamente.
[41] Il quantum debeatur è ovviamente indicato nel contratto.
[42] Nonostante la formale istituzione col d.l. 269/03, l’applicativo è entrato a pieno regime solo anni dopo. Si veda per completezza il decreto dirigenziale del 28.6.2007.
[43] Le difficoltà più ricorrenti consistono nella presenza di tante schede quanti i sequestri pur se afferenti al medesimo veicolo, nell’assenza di un sistema di contabilizzazione immediata dei costi di deposito, nella scarsa intuitività del software. In linea astratta, la sequenza immaginata dal legislatore sarebbe la seguente: sequestro, verbalizzazione e notifica da parte dell’organo accertatore; presa in custodia; compilazione sul SIVES delle schede da parte del custode e dell’organo accertatore; vaglio della prefettura ed alienazione.
[44] Subentrerà a questo punto la disciplina di cui al dpr 189/2001.
[45] Ci riferiamo alle affermazioni, piuttosto lapidarie ed apodittiche, presenti negli atti ministeriali nn. 300/19 (punto 7.4),813/19 e in quello datata 21.10.2021. Ma si veda anche il decreto interministeriale n. 152 del 2021.
[46] Retro par. 1. Questa vicinanza, sebbene osteggiata in parte della letteratura, è suggerita dalla giurisprudenza costituzionale; con una motivazione riferita al solo sequestro penale ma ragionevolmente estensibile a quello civile, nella sentenza n. 230 del 1989 la Consulta equipara senza mezzi termini la prestazione di custodia di un bene sequestrato penalmente con quella di un bene sequestrato in via ammnistrativa, in quanto l’attività è “ontologicamente identica in entrambe le ipotesi”.
[47] Ben diverso dal sequestro giudiziario disciplinato dall’art. 670 c.p.c., avente finalità più propriamente processualistiche e probatorie. Per approfondimenti sul sequestro conservativo, ex multis, Consolo C., Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2017, 240 e ss.; Mandrioli C., Carratta A., Diritto processuale civile, IV, Torino, 2017, 313 e ss.; Ferri C., voce Sequestro, in Digesto civile, XVIII, Torino, 1998, 460 e ss. e Santulli R., voce Sequestro (sequestro giudiziario e conservativo), in Enciclopedia giuridica, XXVIII, Roma, 1998, 2 e ss..
[48] Utili elementi saranno tratti dal giudice dal contegno del debitore e dalle sue effettive disponibilità.
[49] Il legame col processo esecutivo si evince dalla conversione del sequestro in pignoramento, una volta che il creditore ottiene la sentenza di merito favorevole (art. 686 c.p.c. e art. 156 disp. att.). A differenza del sequestro giudiziario, qui non rilevano i beni in quanto tali, ma nella loro consistenza economica; questo spiega come mai possa ricadere su crediti, sia convertibile su altri oggetti (art. 684 c.p.c.) e possa attuarsi solo su beni suscettibili di pignoramento (art. 545 c.p.c.).
[50] Com’è noto, dunque, nel conflitto tra aventi causa e creditore sequestratario, prevale sempre quest’ultimo, a meno che la trascrizione dell’atto concernente l’immobile o il conseguimento del possesso del bene mobile non avvengano prima della concessione del sequestro.
[51] In materia vige il decreto del Ministero della giustizia n. 109 del 1997.
[52] Sono oramai superate le tesi del contratto di deposito (Ascarelli T., In tema di esercizio del voto e di esercizio delle “opzioni” in caso di sequestro di azioni, in Foro italiano, I, 1938, 1332), della gestione di affari altrui (Giansana S., Del sequestro giudiziario e conservativo, Torino, 1884, 97), del mandatario per conto di chi spetta (Carnelutti F., Rappresentanza del sequestratario, in Rivista di diritto processuale civile, II, 1930, 283).
[53] Precisiamo che la stragrande porzione dei sequestri è figlia della violazione dell’art. 186 (guida in stato di ebbrezza) e dell’art. 193 c. 2 (circolazione senza assicurazione) del codice.
[54] Generalizzando le cifre pubblicate dalle prefetture su base annuale.
[55] Per aversi conti più accurati, le operazioni aritmetiche sono semplici: numero veicoli * costo medio annuo custodia * durata media annuale custodia.
[56] La data è meramente indicativa, ma ci sembra ragionevole in quanto non troppo remota né troppo vicina.
[57] Si rimanda nella specie all’art. 7 del decreto n. 152 del 2021, emanato dal Ministero dell’interno, di concerto con l’agenzia del demanio, che esemplifica le difficoltà gestorie.
[58] Si rimanda alla nota n. 43.
[59] Fatti salvi i fermi e i veicoli dissequestrati ma non ritirati.
[60] Cfr. quanto già detto alla nota n. 36.
[61] Appare in ogni caso opportuno un coinvolgimento tecnico dell’Avvocatura di Stato per la redazione del testo contrattuale.
[62] L’abrogazione è occorsa col dpr 115/2002. È chiaro che la riforma dovrebbe tenere in conto il ruolo del custode-acquirente, se presente, magari concedendogli un diritto di prelazione, e pertanto dovrebbe essere così concepita: “Al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5 dell’art. 213 è aggiunto il seguente: 5-bis. La prefettura può disporre la vendita del veicolo, anche immediatamente dopo il sequestro, se la custodia sia eccessivamente onerosa. Se nella provincia è presente la figura del custode-acquirente, quest’ultimo ha diritto di prelazione per l’acquisto secondo le quotazioni sancite dal contratto.”. Inutile aggiungere che avverso la valutazione dell’autorità, l’interessato potrà ricorrere innanzi al giudice amministrativo.

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
