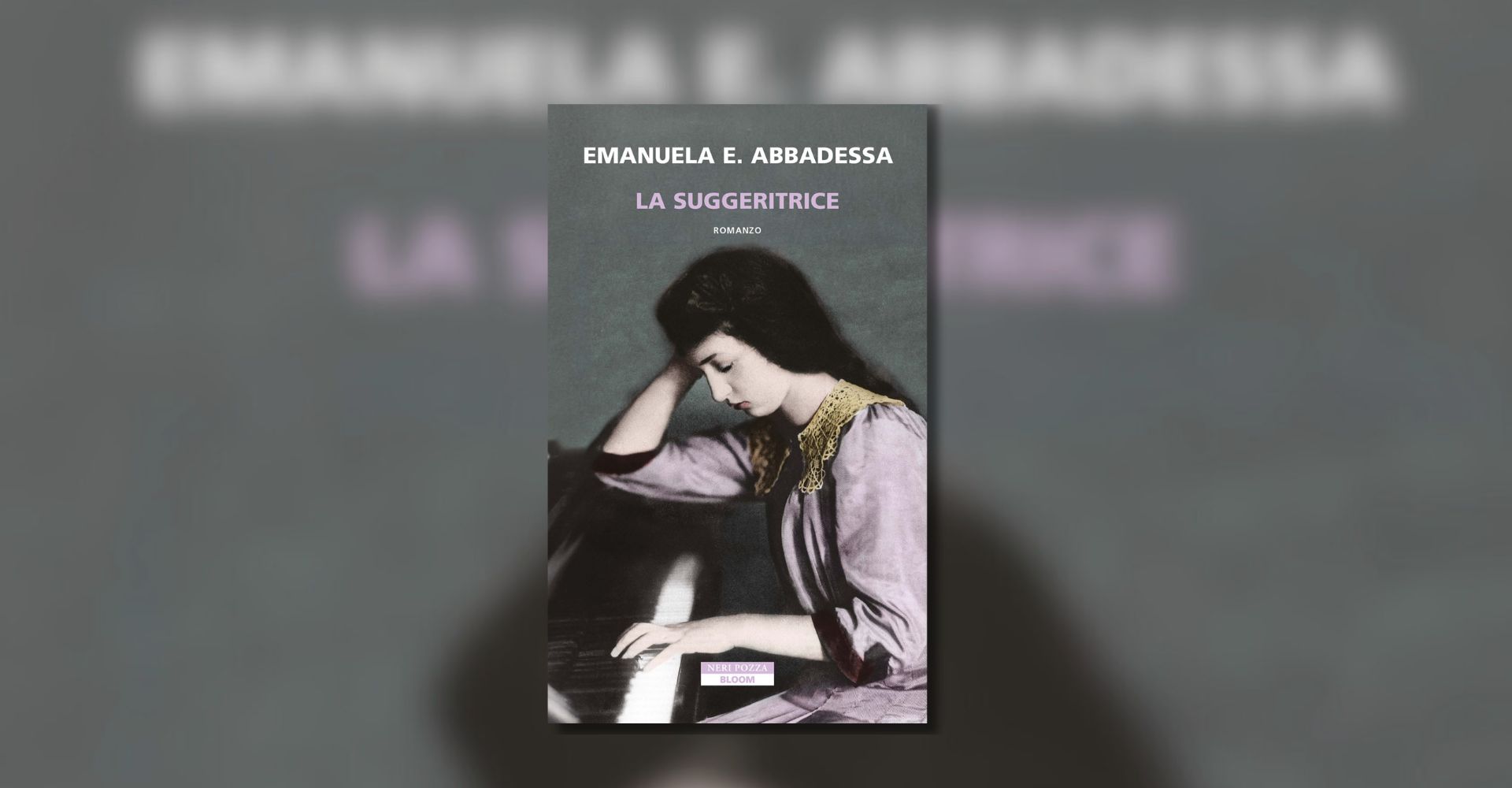Nel secondo dopoguerra romano ancora presidiato dalle forze alleate, Ivano e Delia, coppia popolare afflitta da un ménage coniugale gravato dal mito del dominio maschile, duplicato e potenziato dalla convivenza con nonno Ottorino, papà di Ivano, e con tre figli da mantenere, incarnano, con l’enfasi della rappresentazione filmica, gli estremi di un modello familiare integralista che ancora oggi genera non pochi proseliti. Un modello del quale lo schiaffo del mattutino buongiorno che Ivano dà a Delia al primo risveglio, ancora a letto, inscena il suo prologo più espressivo, avvisando lo spettatore, già da questo suo esordio, che la narrazione procederà per iperbole e come un rock in quattro quarti, dove musica e danza, che già si annunciano offrirsi in coerente sequenza, sono convocate ad animare i fotogrammi di un riscatto di genere.
Dei tre figli la ragazza, Marcella, mal tollerando la soggezione materna, alimenta la coscienza di Delia con continue arringhe, sollecitatrici di una ribellione che in verità già cova nel ventre materno, ma che per maturare necessita di una strategia del silenzio da mescolare senza troppi danni collaterali alla tirannia di un Ivano violento e sospettoso.
Le donne devono tenere la bocca chiusa! Questo il mantra destinato ad attraversare l’intero racconto, ben cadenzato nel convinto sermone fatto al figlio da sor Ottorino (un assai convincente Giorgio Colangeli) come lascito di una moribonda e malintesa saggezza sulla necessità del silenzio femminile; e pure nella flemmatica censura del ricco borghese all’azzardata incursione verbale della moglie, rea di avere espresso un suo pensiero in una salottiera discussione tra uomini; e ancora nella dispotica asserzione di Mario alla moglie Orietta - pittoreschi genitori di Giulio, promesso sposo di Marcella, e proprietari di un bar poi esploso e finito in fumo all’unisono con le nozze dell’ormai nullatenente figliolo - nel prospettare l’imposizione di una scelta paterna per il matrimonio della figlia femmina.
Ed è in questo clima che l’accesso al voto delle donne del 1946, annunciato in pressoché tutte le riprese esterne con visibili manifesti, diventa occasione e ragione di una vittoria universale della parola al femminile; una vittoria della e per la civiltà, messaggera di uno slancio rivoluzionario dall’energia creativa di un atto d’amore.
Un atto d’amore, infatti, già sospettato come tale nel contenuto della lettera spiegata solo sul finale quale certificato elettorale e sulle prime fatta invece deliberatamente equivocare allo spettatore come scritto di un innamorato; amore e ribellione civile, dunque, trasfigurati come sinonimi tattili di indipendenza esistenziale.
Un gesto d’amore, ancora, che, a ritroso di pellicola, rinviene già i suoi germi nel riuscito girotondo scenico al sapore - e colore - di cioccolata tra Delia e Nino (un ottimo Vinicio Marchioni), spiantato meccanico di periferia colmo d’amore per la donna; simboli statici ed estatici insieme di una trasgressione dei sensi, con la forza potente dell’ammutinamento e la gentile vibrazione di un’intesa che nella miseria di quei tempi, ma nell’eterna influenza dell’amore, ritrova il senso della resistenza.
La fuga di Delia da Ivano e la corsa verso la fila delle votanti - più gagliarda di un ceffone, più persuasiva di un lauto guadagno - edifica l’altare del riscatto, innanzi al quale Ivano, simbolo di un esercito ormai piegato, silenziosamente retrocede sconfitto.
Un film felicemente rock si diceva, senza implicazioni cromatiche eppure con la lucentezza di uno spettro variopinto di intime coloriture e dove musica e danza con felice espediente scenico concorrono da protagoniste nel proposito di rendere invisibili le violenze maschili, senza però privarle dell’implicita barbarie.
Ancora un prodotto d’abilità di una Cortellesi attrice, marionetta pasionaria questa volta alla sua regia d’esordio, in grado di emergere illesa in piena consonanza espressiva con un brillante e sempre efficace Mastandrea.