
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
di Elisabetta Morosini
Nel 1981, in occasione della inaugurazione, a Nizza, di una mostra del pittore Alberto Magnelli, Italo Calvino scrive un testo dal titolo “Essere pietra” che così esordisce: «Io sono una pietra. Lo ripeto: una pietra. So che non potete capirmi; dovrei spiegarvi queste quattro parole una per una e a gruppi di due e di tre e poi tutte insieme: cosa voglio dire quando dico io, e quando dico essere, e quando dico pietra, e cosa vuol dire essere pietra, e una, una pietra».
Dall’intuizione del grande scrittore, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita, prende le mosse il saggio di Federico Luisetti “Essere pietra. Ecologia di un mondo minerale”, pubblicato nel settembre 2023 dalla casa editrice wetlands (rigorosamente in minuscolo).
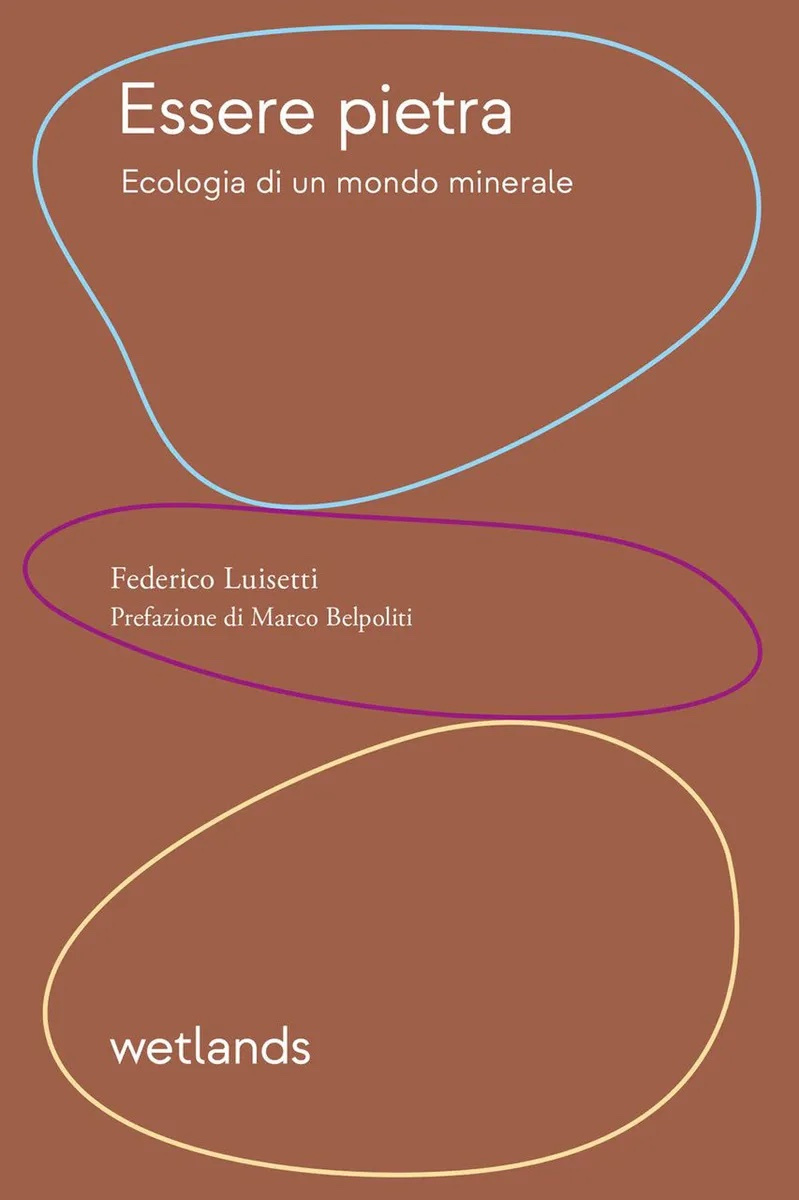
L’autore propone una riflessione sulle pietre come “esseri-terra” e sulla connessione politica e giuridica con gli “esseri-persona”, nella prospettiva di una sfida che spinge ancora più in là il pensiero ambientalista fino a riconoscere una soggettività giuridica non solo agli altri esseri viventi (animali e piante), ma anche al mondo inanimato di cui le pietre sono simbolo.
«Calvino» scrive Luisetti nella prefazione al libro «ci aiuta a percepire la distinzione tra soggetto e persona [...]. Poiché le pietre non partecipano a una vitalità universale, la loro alterità dev’essere riconosciuta come una sfida all’egemonia della persona vivente, ovvero al cuore del pensiero occidentale».
Pensiero che si è formato sul concetto, elaborato dal diritto romano, della separazione tra persona, come soggetto di diritto, e cosa, come oggetto di diritto: la persona umana è l’unica attrice sulla scena, tutto ciò che è classificato “cosa” esiste solo in funzione della persona che se ne appropria, la fa sua, la assoggetta al proprio potere per farne ciò che vuole.
Una simile concezione - che è alla base del sistema filosofico, politico, giuridico, economico occidentale incentrato sul diritto allo sfruttamento -, è estranea alle culture non occidentali, fondate, invece, sulla simbiosi tra esseri umani e “esseri-terra”.
Le popolazioni indigene del Sud America sono state protagoniste delle più significative lotte per la tutela della natura e dell’ambiente, animate da un profondo sentimento di connessione - non di opposizione o separazione - rispetto alle “cose” circostanti.
Il popolo indigeno dei Kichwa de Sarayaku ha promosso (e vinto) una causa intentata con lo Stato dell’Ecuador davanti alla Corte interamericana dei diritti umani, a tutela della “Foresta vivente”, minacciata dalla arbitraria invasione compiuta dalle multinazionali straniere del petrolio.
Sulla scia di queste lotte nel 2008 la Repubblica dell’Equador si è data una Costituzione e ha assicurato alle risorse naturali un livello di protezione molto più avanzato rispetto all’Europa e agli altri paesi del mondo che si considerano all’avanguardia. La Costituzione dell’Ecuador riconosce la “Natura”, chiamata Pachamama, come soggetto di diritti. I diritti della natura si trovano sanciti negli articoli da 71 a 74: il diritto al rispetto integrale della esistenza della Natura e al mantenimento e alla rigenerazione dei suoi cicli vitali, delle sue strutture, delle sue funzioni e dei suoi processi evolutivi; il diritto a interventi di risanamento.
Il benessere della Natura è messo in correlazione con il diritto per le persone, i popoli, le comunità di godere dell’ambiente e delle ricchezze naturali che rendono possibile una “sumak kawsay" ovvero una “coesistenza armoniosa”.
E così, dall’altra parte del mondo, è stato il popolo Maori, autoctono del fiume Whanganui, che nel 2017 è riuscito ad ottenere, da parte del Parlamento della Nuova Zelanda, il riconoscimento della titolarità di diritti in favore del proprio fiume sacro.
Quel fiume vede i propri diritti suscettibili di tutela dinanzi a un Tribunale: «Ko au te awa, ko te awa ko au», dicono i Maori, «Io sono il fiume e il fiume è me».
Negli Stati Uniti, il primo a teorizzare la capacità degli alberi a stare in giudizio è stato Christopher Stone, che nel 1973 pubblicò un articolo (ora divenuto libro) dal titolo "Should trees have standing". La tesi del professor Stone fu utilizzata nella causa promossa dal Sierra Club (la più antica e importante organizzazione ambientalista degli Stati Uniti, fondata nel 1892 dal naturalista John Muir) per bloccare il progetto della Walt Disney che intendeva costruire un enorme complesso sciistico nei territori selvaggi delle montagne della Sierra Nevada in California: la Mineral King Valley.
Quella ardita teoria giuridica incontrò il favore di un giudice della Corte Suprema americana, William O. Douglas, autore, nel 1965, della Carta dei diritti della natura selvaggia ("A Wilderness Bill of Rights"), ma non servì a vincere la causa, perché la maggioranza dei giudici della Corte votò contro; nonostante la sconfitta, si creò un tale movimento di opinione a sostegno della lotta del Sierra Club che la Walt Disney fu costretta a rinunciare alla stazione sciistica. Oggi la Mineral King Valley continua ad essere un paradiso naturale, inserito nel Sequoia National Park.
Ma ancora non basta.
Non basta riconoscere diritti agli animali, alle piante, agli esseri viventi diversi dagli umani.
Occorre, secondo Luisetti, un’idea più radicale: occorre ribaltare il pensiero antropocentrico, frutto velenoso della cultura della sopraffazione e dello sfruttamento, sino a riconoscere una soggettività anche alle pietre e a tutti gli esseri-terra.
Del resto alcune pietre hanno conquistato da sole il diritto ad imporsi come “soggetti” attraverso un atto rivoluzionario: il movimento.
Sono i massi erratici «frammenti di un tempo profondo, corpi geologici posti al crocevia di regimi temporali incompatibili». E, in questa parte, il saggio di Luisetti assume accenti poetici.
Aill na Mìrrean un masso erratico alto sei metri che in Irlanda ha dato vita a un luogo di culto druidico.
Pierre des Marmettes un masso di 1.800 metri cubi che domina la valle del Rodano nelle Alpi svizzere, un erratico del tutto fuori luogo, un intruso dal punto di vista spaziale, temporale, ecologico, estetico.
Il masso erratico di Amburgo, scoperto nell’autunno 1999 nel letto del fiume Elba.
Quest’ultimo è un masso erratico di 217 tonnellate, staccatosi 400.000 anni fa dalla Svezia meridionale e trasportato dai ghiacciai fino al sito attuale; si impone allo sguardo e al paesaggio con la sua mole enorme, sproporzionata, del tutto fuori posto rispetto al contesto. Considerato “il più antico immigrato di Amburgo”, è divenuto simbolo delle lotte a favore dei diritti degli immigrati. In questo modo ha “affermato la propria soggettività”, ha ottenuto il riconoscimento della propria identità, una identità ibrida «fatta di erranza e stabilità, alterità e familiarità».
Chissà se questo serve a capire il punto in cui ci troviamo, per metterci «una pietra sopra», come fa Calvino con i suoi Discorsi di letteratura e società raccolti da Einaudi nel 1980: «L’ambizione giovanile da cui ho preso le mosse è stata quella del progetto di costruzione d’una nuova letteratura che a sua volta servisse alla costruzione d’una nuova società. […] il mondo che ho oggi sotto gli occhi non potrebbe essere più opposto all’immagine che quelle buone intenzioni costruttive proiettavano sul futuro. La società si manifesta come collasso, come frana, come cancrena (o, nelle sue apparenze meno catastrofiche, come vita alla giornata); e la letteratura sopravvive dispersa nelle crepe e nelle sconnessure, come coscienza che nessun crollo sarà tanto definitivo da escludere altri crolli».
Appunto bibliografico:
Italo Calvino, Essere pietra (per Alberto Magnelli), in Magnelli. Les pierres: 1931-1935, catalogo della mostra, Galleria Sapone di Nizza, 1981; poi con il titolo Io sono una pietra, su «la Repubblica», 14 luglio 1981; ora in Romanzi e racconti, tomo III.
Italo Calvino, Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Einaudi, 1980
Federico Luisetti, Essere pietra. Ecologia di un mondo minerale, wetlands, 2023
Ursula Biemann e Paulo Tavares, Forest Law – Foresta giuridica, Nottetempo, 2020
Eduardo Kohn, Come pensano le foreste, Nottetempo, 2021
Francis Hallé, Ci vuole un albero per salvare la città: Un manifesto per i politici e gli amministratori pubblici, Ponte alle Grazie, 2018
Christopher D. Stone, Should trees have standing. Law, Morality, and the Environment. Oxford University Press Inc., 2010
David R. Boyd, The Rights of Nature. A legal revolution that could save the world, Tantor, 2017
Bruce Albert (direzione artistica di), Nous les arbres. Catalogo della mostra. Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2019.
Bruce Albert (direzione artistica di), Siamo foresta, catalogo della mostra, Triennale di Milano in collaborazione con la Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2023
Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Anthropocene, catalogo della mostra, Fondazione Mast di Bologna, 2019
Le scelte eticamente sensibili. Limiti e obblighi della pubblica amministrazione tra diritti e interessi legittimi fondamentali.*
di Gianpiero Paolo Cirillo
Sommario: 1. Premessa - 2. Dai «diritti pubblici soggettivi» agli «interessi legittimi fondamentali» - 3. Libertà e diritti fondamentali - 4. La teorica di Jellinek - 5. Le conseguenze processuali delle teoriche dei diritti fondamentali - 6. Le scelte eticamente sensibili come espressione di diritti o libertà fondamentali - 7. La giurisprudenza amministrativa in materia di diritti fondamentali - 8. Poteri, limiti e responsabilità del personale sanitario - 9. La responsabilità della pubblica amministrazione nella materia sanitaria - 10. Interessi legittimi fondamentali a carattere economico - 11. Il fronte sovranazionale e internazionale - 12. Il diritto sanitario durante la pandemia e il PNRR.
1. Premessa
Il tema delle “scelte eticamente sensibili”, riguardato dall’ottica della pubblica amministrazione che comunque è chiamata ad avallarle o semplicemente consentirle, impone una più ampia riflessione per comprendere la natura della posizione giuridica riconosciuta al privato che ne rivendichi l’esercizio. Esso, dunque, riveste interesse e si presenta di sicura attualità non solo per la modernità e sensibilità del relativo contenuto, ma anche e ancor prima, per il suo impatto su categorie dogmatiche che animano la dottrina da epoca risalente. Ci si trova di fronte alla possibilità di verificare la portata sostanziale di categorie concettuali di nuova configurazione, e in particolare se vi siano reali contenuti nuovi o si tratti di meri neologismi destinati a rimanere relegati nella sfera dell’involucro definitorio. Tanto più che, come è stato insegnato (RESCIGNO), il diritto soggettivo e l’interesse legittimo sono delle categorie storiche utilizzate dai giuristi per indicare situazioni soggettive dai contenuti più diversi.
Da qui l’esigenza, prima di entrare nel merito dello stesso, di riferire del dibattito assai risalente sul tema, laddove sia capace di illuminare qualsivoglia considerazione attuale sulla materia. Si allude, in particolare, alla dizione “interessi legittimi fondamentali”, che, in quanto declinazione dei diritti fondamentali –quelli nel cui ambito si collocano le scelte eticamente sensibili - in relazione alla controparte pubblica, rappresentano il punto di approdo più evoluto dei precedenti “diritti pubblici soggettivi”.
Ringrazio pertanto gli organizzatori di questo importante convegno che mi offre l’opportunità di condividere queste brevi riflessioni che, partendo dall’origine storica del problema, approdano a contesti di assoluta modernità, oggetto di dibattito, religioso, sociale, culturale e politico, prima ancora che giuridico.
2. Dai «diritti pubblici soggettivi» agli «interessi legittimi fondamentali»
La posizione dominante della dottrina settecentesca (influenzata dal pensiero giusnaturalista) era che le libertà fossero dei diritti innati dell’individuo, che lo Stato non farebbe altro che riconoscere. L’affermazione della derivazione naturale quanto meno dei principi fondamentali dell’ordinamento, che immagina norme universali, di per sé chiare ed evidenti, che precederebbero quelle positive e alle quali queste ultime dovrebbero conformarsi, sta alla base della nascita degli Stati settecenteschi. Con il superamento del fondamento innatistico delle libertà, queste seguitarono tuttavia ad essere inquadrate tra i diritti, e l’endiadi «diritti civili e politici» dell’individuo fu anche accolta dai legislatori. Il passaggio dallo stato assoluto allo stato di diritto ha comportato, come tutti sanno, che la persona fisica da suddito diviene cittadino, che, in quanto tale, ha dei diritti, tra i quali in primo luogo quelli politici e le libertà civili. Per descriverli, i teorici dei diritti pubblici soggettivi utilizzarono il modulo privatistico diritto-dovere: da un lato posero un diritto, dall’altro un dovere di astensione del pubblico potere (GIANNINI).
Quando la pandettistica pubblicistica tedesca iniziò la revisione della dogmatica del diritto pubblico anch’essa accettò la costruzione delle libertà come diritti pubblici soggettivi, rispetto ai quali lo Stato aveva solo l’obbligo di astensione. Tale costruzione non resse al vaglio della dottrina successiva, che teneva conto del diritto positivo .
Dal punto di vista filosofico, il positivismo giuridico immagina che tutto il diritto sia di origine statale o comunque positiva. L’autorità politica ha facoltà normative indipendenti da ogni ordinamento di diversa natura, sia naturale sia religiosa. Per essa i diritti assoluti in tanto sono validi in quanto tali erga omnes, e non solo nei confronti dello Stato. Inoltre, il titolare del dovere era portatore di interessi propri il cui esercizio portava a limitare gli interessi del titolare del diritto assoluto. Tali interessi propri sono talmente tutelati dalla norma da conferire all’obbligato vere e proprie potestà. Sicchè il dovere di astensione appare più come limite alla potestà che come situazione soggettiva propria, tanto più che il bene della vita oggetto dell’interesse protetto come diritto di libertà non è facilmente individuabile, come invece negli altri diritti assoluti (GIANNINI). Di qui i tentativi di apportare correttivi alla costruzione proposta, tra i quali va ricordata la teoria dei «diritti riflessi», in base alla quale i diritti di libertà sarebbero da considerare dei diritti nascenti dalle limitazioni, assunti come obbligo delle potestà pubbliche.
La massima espressione del neopositivismo giuridico è ravvisata nell’opera di Kelsen e della sua scuola. Kelsen e la sua scuola abbandonarono la costruzione pandettistica e introdussero, a caratterizzare le libertà, l’elemento “garanzia”. L’analisi delle varie libertà mostra che esse o sono delle semplici facoltà che spaziano nel campo del meramente lecito, oppure dei diritti soggettivi non diversi dagli altri. La loro vera sostanza risiede nelle garanzie costituzionali che sovrintendono alla loro istituzione, per cui le norme del legislatore ordinario in contrasto con le norme di garanzia possono essere rimosse dal giudice investito del sindacato di costituzionalità di norme primarie. In questo modo la teorica delle libertà veniva completamente separata da quella dei diritti pubblici soggettivi e anzi da qualunque situazione giuridica di vantaggio attribuita dalla norma al privato. La norma costituzionale di garanzia, così come investe posizioni civilistiche del privato (la famiglia, i figli illegittimi), così può investire situazioni soggettive attive di vantaggio, quali diritti o interessi legittimi; viceversa può non investire situazioni soggettive anche molto importanti, come quella degli enti esponenziali di ordinamenti derivati, delle cosiddette società intermedie e simili (GIANNINI).
3. Libertà e diritti fondamentali
La dogmatica delle libertà nel loro variegato atteggiarsi e dei diritti fondamentali ha da sempre dato adito a dibattiti che alla fine non hanno consentito di trovare loro un soddisfacente assetto. Troppo spesso la si è confusa, da un lato, con la teoria generale delle situazioni soggettive, dall’altro, con le posizioni fondamentali del soggetto privato nell’ordinamento giuridico generale che ha una realtà storicizzabile e non già astratta (GIANNINI).
Dunque, come ha ritenuto l’autorevolissima dottrina sinora citata e da cui è tratto questo breve resoconto e che continua in questo e nel paragrafo successivo, la realtà è molto più complessa, in quanto le situazioni soggettive del privato possono presentarsi alla pubblica amministrazione così come sono configurate dal diritto privato e quindi l’amministrazione pubblica può essere parte del rapporto e agire secondo il diritto comune. Parimenti, si può porre come autorità e quindi amministrare situazioni soggettive, beni, rapporti giuridici: in questo caso la situazione del soggetto privato rimane ancora regolata dal diritto privato.
Esistono tuttavia situazioni di diritto soggettivo che sono regolate da norme di diritto pubblico: si pensi, ad esempio, ai diritti di stato giuridico o ai diritti patrimoniali dei titolari degli uffici pubblici. Così ancora i diritti a prestazioni amministrative, dove le norme possono configurare come interessi legittimi le situazioni soggettive del privato in ordine a prestazioni dell’amministrazione, ma possono anche configurarle come diritti soggettivi (si pensi all’assistenza sanitaria ed ospedaliera, alle prestazioni postali e telefoniche, ai trasporti pubblici e così via).
Altra categoria del medesimo gruppo è costituita dai diritti che derivano dalla posizione giuridica di civis: diritti politici in primo luogo (elettorato attivo ed elettorato passivo); quei diritti che si denominano civici, in quanto il cittadino tra i benefici ragione della sua appartenenza ad un determinato “gruppo” dei consociati legati ad un ambito territoriale, quale il Comune, o addirittura una sua frazione e così via (si pensi al diritto di uso dei beni collettivi, come strade, lido del mare, acque pubbliche, pascoli comunali, con riferimento ai quali è stata teorizzata la categoria del “bene comune”, che supera le tradizionali categorizzazioni giuridiche legate al solo assetto proprietario per valorizzare quello funzionale e solidaristico/partecipativo). Tutte queste situazioni soggettive di diritto sono attribuite da norme di diritto pubblico e non presentano alcuna omogeneità.
Va anche detto che in questa materia il concetto di “privato” ha un senso convenzionale, ossia comprensivo del cittadino persona fisica e, in certi casi, dello straniero e dell’apolide, della persona giuridica privata, dell’ente pubblico in quanto assoggettato allo Stato, e persino dello Stato in quanto assoggettato ad un ente pubblico.
4. La teorica di Jellinek
La teorizzazione dei diritti pubblici soggettivi fu dominata dalla grandiosa opera di Georg Jellinek, che, ancora nell’800 ebbe l’intuizione giuridica di individuare quattro status del cittadino: subjectionis, libertatis, civitatis e activae civitatis. La dottrina successiva non fece altro che aderire o respingere o tentare di correggere il sistema del grande studioso tedesco, senza considerare che la costruzione indicata fu più un’opera politica che giuridica e fu un tentativo di portare la realtà dello Stato moderno in un sistema di definiti rapporti giuridici entro i quali cittadini trovassero precisi ambiti del proprio agire.
Non è casuale che il punto debole di questa costruzione fosse costituito proprio dallo status libertatis,che non è affatto omogeneo con gli altri e che non si concreta in diritti soggettivi, se non in modi del tutto particolari.
Infatti, i diritti positivi possono configurare in modi diversi le libertà civili.
I modi più importanti di configurazione sono tre: la libertà come oggetto di norma meramente enunciativa di un principio, come interesse legittimo garantito costituzionalmente e come oggetto di un «diritto fondamentale» dell’individuo (GIANNINI).
Nel primo caso, la dichiarazione che riconosce una libertà, come tutte le norme che enunciano un principio, serve all’interpretazione e all’applicazione di altre norme e vale come direttiva nelle costituzioni flessibili o come precetto in quelle rigide per il legislatore. Nel secondo dei tre modi le libertà non sono diritti soggettivi, anche se norme costituzionali così le denominano. Basti pensare alla costituzione di Weimar piena di tanti diritti di libertà e di clausole generali, utilizzate anche dal regime nazista. Tuttavia, la formula più onesta si trova nell’articolo 28 dello statuto Albertino dove si recita: «la stampa è libera ma la legge ne determina gli abusi». Orbene tutte le libertà interessi legittimi sono riconducibili ad un sistema siffatto. Da un lato vi sono le manifestazioni fondamentali della personalità dell’individuo e dall’altro le potestà pubbliche che agiscono sollecitate da interessi pubblici.
La situazione soggettiva del privato è di interesse legittimo di fronte ad una potestà, tutelato giurisdizionalmente secondo gli istituti generali del sistema positivo. Tuttavia, esso è garantito costituzionalmente, e in questo differisce dagli interessi legittimi che potrebbero dirsi ordinari. Orbene a questi ben si addice la denominazione di interessi legittimi fondamentali.
La garanzia consiste nel fatto che la potestà pubblica disciplinata dalla norma giuridica primaria e consiste in una «riserva di legge» in ordine all’attribuzione della misura della potestà. In ogni caso trattasi di comuni rapporti potestà-interesse legittimo. In qualche costituzione la libertà può essere rafforzata ma nella nostra non esiste uno strumento giuridico specifico nel caso di una sua violazione. Va ricordato che lo statuto Albertino, che pure regolava le libertà civili, è rimasto in vigore per un intero secolo, mentre le leggi disciplinatrici sono più volte cambiate, raggiungendo punte di sostanziale illibertà nel periodo fascista.
La giurisprudenza ha cominciato a ritenere le leggi disciplinatrici illegali e ha favorito l’evolvere verso il terzo modo, in cui la libertà diviene oggetto di un diritto soggettivo assoluto, classificabile nei diritti della personalità. L’adozione di costituzioni rigide con il perfezionamento del sindacato di costituzionalità delle norme accrescono la tutela delle situazioni giuridiche soggettive del privato. Esse vengono oramai denominate «diritti fondamentali» dell’individuo e sono assoluti non solo nei confronti dei pubblici poteri ma di qualunque soggetto giuridico.
Nelle costituzioni moderne si trovano giustapposte delle enunciative del primo del secondo e del terzo modo. Ad esempio, buona parte dei cosiddetti «diritti sociali» danno luogo ad enunciative del primo e del secondo modo. Il secondo modo è quello correttamente usato quando si vogliano garantire istituti giuridici più complessi di una mera situazione soggettiva, si pensi alla famiglia alla proprietà a talune prestazioni di protezione sociale (GIANNINI).
I termini della relazione tra diritti fondamentali e potere amministrativo, all’indomani della seconda guerra mondiale, vanno letti all’interno del paradigma dello Stato sociale di diritto, ossia di un ordinamento che riconosce, accanto ai diritti di libertà classici, i diritti della persona e i diritti sociali, la cui piena attuazione deriva non solo da un atteggiamento negativo, ma anche da un approccio positivo, ossia da un comportamento in grado di soddisfare la pretesa avanzata dal singolo. Questo è l’effetto dello Stato pluriclasse, dove le classi sociali subalterne reclamano diritti e chiedono servizi alla P. A.
La relazione che si instaura è tra la posizione giuridica del cittadino e lo specchio del moltiplicarsi di interessi che l’amministrazione assume su di sé. Quindi non solo una relazione che vede potere e diritto escludersi a vicenda, dove c’è potere non c’è diritto e viceversa, ma al contrario posizione che vengono accumularsi nella misura in cui il potere amministrativo assume il senso pieno della funzione, quindi dove c’è potere c’è diritto (TARANTINO).
5. Le conseguenze processuali delle teoriche dei diritti fondamentali
Quando erano conosciuti e studiati soltanto i diritti di libertà classici, la relazione tra poteri amministrativi e diritto era descritta secondo le formule della degradazione del diritto e dell’indegradabilità dei diritti fondamentali. Il risvolto processuale era che tutte le volte in cui la posizione azionata fosse qualificabile in termini di diritto fondamentale vi era giurisdizione del giudice ordinario, il che comportava una negazione in radice della presenza di un potere amministrativo.
La pretesa dell’automatica prevalenza del diritto fondamentale sul potere amministrativo porterebbe il primo a sterilizzare automaticamente il secondo, anche quando quest’ultimo ha il compito di comporre una relazione tra diritti dello stesso rango; evenienza quest’ultima che risulta immanente all’interno di un sistema che non poggia su risorse economiche illimitate. Di qui la tendenza ad una scomposizione del diritto fondamentale in due distinte componenti: una difensiva e una pretensiva. Solo la prima è sottratta a qualsivoglia logica di bilanciamento rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione (TARANTINO).
Per contro, l’assenza di una gerarchia tra i diritti fondamentali consente di superare l’impostazione secondo la quale i diritti in questione godono di una situazione di intangibilità da parte del potere amministrativo. La componente difensiva afferisce ad un nucleo essenziale del diritto sottratto alla disponibilità del legislatore come ribadito nella sentenza n. 146 / 1988 della Corte costituzionale.
Più di recente, il giudice costituzionale ha affermato anche che la concezione soggettiva del processo delinea «la giurisdizione amministrativa, nelle controversie tra amministrati e pubblico potere, [come] primariamente rivolta alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive e solo mediatamente al ripristino della legalità dell’azione amministrativa, legalità che pertanto può e deve essere processualmente perseguita entro e non oltre il perimetro dato dalle esigenze di tutela giurisdizionale dei cittadini» (Corte cost., sent. n. 271 del 2019). Alla luce di tale evoluzione è l’interesse alla mera legittimità dell’azione amministrativa diventato in certo qual modo un interesse occasionalmente protetto in sede di tutela dell’interesse legittimo, cioè protetto di riflesso in sede di tutela della situazione di interesse legittimo, come affermato dal presidente del Consiglio di Stato, Patroni Griffi, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 (SCODITTI).
Rispetto all’epoca di elaborazione della tesi dell’indegradabilità, il quadro della giustizia amministrativa è dunque radicalmente mutato ed è ormai “pronto” a rendersi protagonista di interventi di tutela dei diritti fondamentali. Alla base delle pronunce della Cassazione che in particolare a far data dalla fine degli anni ottanta avevano negato in tali ambiti alcun margine di giurisdizione del giudice amministrativo, vi era la concezione oggettiva del processo amministrativo limitata all’esclusivo sindacato sull’atto, connotato anche dalla limitatezza dei mezzi probatori di accesso al fatto – tesi peraltro ancora di recente ribadita, ma non per questo necessariamente da condividere, da Cass., Sez. U., sent. n. 23436 del 2022.
Essa ha avuto il merito storico per lunghi decenni di dare una risposta a bisogni di tutela che non trovavano adeguata soddisfazione nel vecchio regime degli interessi occasionalmente protetti dalla giurisdizione amministrativa di legittimità. A fronte, tuttavia, della riconosciuta estensione della conoscenza al fatto posto a fondamento della scelta dell’autorità amministrativa, consentita dalle potenzialità probatorie presenti nella nuova configurazione del giudizio amministrativo, non può più negarsi una cognizione piena del rapporto, per cui il processo non costituisce più soltanto uno strumento di garanzia della legalità dell’azione amministrativa, ma ben potendo rappresentare una giurisdizione preordinata alla tutela di pretese sostanziali (TARANTINO).
6. Le scelte eticamente sensibili come espressione di diritti o libertà fondamentali
Le considerazioni da ultimo riportate già anticipano le conclusioni cui si intende addivenire. Ossia, la nozione di interesse legittimo fondamentale altro non è che la declinazione terminologica dei diritti fondamentali con riferimento ai quali il giudice amministrativo è chiamato a valutare la forbice di scostamento tollerabile, in una logica di bilanciamento tra valori egualmente tutelati dalla Costituzione, rispetto al nucleo intangibile tutelato dalla stessa.
Le scelte “eticamente” sensibili, d’altro canto, rappresentano a loro volta soltanto l’esercizio di diritti sicuramente riconducibili a tale soglia di rilevanza, in quanto attengono comunque alla personalità dell’individuo, in termini di dignità, identità sessuale, diritto a divenire genitore e così via. Lo stesso avverbio “eticamente”, a connotarne la sensibilità, richiama infatti un concetto di valore che ove semplicemente correlato al sotteso contesto socio-culturale si presenta necessariamente fluttuante, e soprattutto tipicamente soggettivo. Esso risente, cioè, necessariamente, dell’angolo visuale dal quale viene riguardato, rendendo il dibattito inevitabilmente scivoloso verso una china morale, appunto, ovvero religiosa, che inevitabilmente rischia di condizionare la decisione dei giudici, ma non incide, o quanto meno non dovrebbe farlo, sulle categorie concettuali di riferimento.
La conflittualità ideologica ha influito sulle discussioni giuridiche.
A partire dal caso Englaro, la sentenza della Cassazione, n. 21748 del 2007, che, pur criticata in quanto “creativa” e manipolatrice, è considerata alla base della sopravvenuta legge n. 219 del 2017. Essa ha disciplinato a distanza di anni il tema della relazione di cura fra medico e paziente; nonché quello delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ponendo al centro della disciplina la tutela della dignità, dell’autodeterminazione e del consenso che la sentenza aveva valorizzato. Questo rende di immediata percezione la “sensibilità” delle scelte del privato e, a valle delle stesse, la possibilità dell’ordinamento di assecondarle, ovvero quanto meno di non ostacolarle.
Il tema del diritto a fine vita, peraltro, che tipicamente si colloca nell’ambito di tali tematiche, può essere riguardato anche dall’angolazione diametralmente opposta, pure ampiamente dibattuta proprio in concomitanza della stesura delle presenti note (si pensi, ad esempio, al caso della neonata inglese Indy Gregory, che un ospedale italiano si era offerto di accogliere, il cui trasferimento è stato negato ai genitori che ne facevano richiesta dalla Corte del Regno unito chiamata ad occuparsene, che vi ha ravvisato un inutile accanimento terapeutico).
Proprio l’esemplificazione riportata (ma analoghe riflessioni potrebbero riguardare l’altrettanta controversa questione meglio conosciuta come “utero in affitto”, o maternità surrogata) fa emergere come la mancanza di scelte chiare, in un senso o nell’altro, da parte del legislatore, e la necessità di utilizzare il quadro normativo di riferimento, se del caso “strumentalizzando” – come pure è stato criticamente affermato in relazione a talune casistiche – il rinvio pregiudiziale al giudice delle legge, ricada, o meglio sia ricaduta, fino ad oggi sul giudice ordinario.
E, tuttavia, proprio la cornice sopra delineata della valutazione dei diritti fondamentali anche in relazione al contrapposto potere della p.a., e della nuova concezione del giudizio amministrativo e della tecnica del bilanciamento seguita dalla giurisprudenza costituzionale, sembrano aprire una nuova stagione di coinvolgimento del giudice amministrativo, appunto, nella tutela dei diritti fondamentali. Anche l’interesse legittimo, dunque, in quanto correlato ad una norma che attribuisce il potere alla pubblica amministrazione, è uno strumento di tutela dei diritti fondamentali e in tale logica diviene “interesse legittimo fondamentale”. Esso si pone come limite alle scelte dell’Amministrazione astrattamente ispirate a ragioni scientifiche.
Negli ultimi decenni, infatti, anche la scienza medica ha finito per travalicare l’ambito tradizionale della cura della malattia e della ricerca, invadendo spazi più propriamente “spirituali”, quali il diritto alla procreazione, alle modalità e al tempo del fine vita, come già detto, ovvero all’identità sessuale. Come è stato sostenuto dalla dottrina costituzionalistica, il corpo costituisce il substrato generatore della persona, anzi si identifica con la persona stessa e la identifica, perché è attraverso il corpo che diventa possibile entrare in relazione con altri soggetti ed essere sul situato nella società. Esso cioè non solo ci colloca nello spazio e nel tempo, ma soprattutto ci mette in relazione con i nuclei sociali nei quali viviamo (famiglia, scuola, società). È dunque stato necessario nel tempo ricostruire lo statuto giuridico del corpo umano, individuando e analizzando i diversi dispositivi giuridici apprestati dall’ordinamento a tutela degli interessi che variamente si intrecciano intorno alle vicende della vita umana. Come per i diritti della personalità nel diritto civile, il suddetto processo di “giuridificazione” è stato caratterizzato dal passaggio da una logica proprietaria, che vede il soggetto disporre del proprio corpo come di un bene materiale, ad un’altra, dinamica e relazionale permeata dalla libertà di autodeterminazione, in cui le scelte che riguardano il fisico, anche nella sua mera esteriorità, impattano necessariamente sullo sviluppo della personalità e sui diritti inviolabili che fanno capo alla stessa. Esemplare è stata pure l’evoluzione del rapporto tra l’individuo e i propri dati personali in materia di privacy.
7. La giurisprudenza amministrativa in materia di diritti fondamentali
Senza ancora attingere alla categoria degli interessi legittimi fondamentali, il giudice amministrativo è stato più volte chiamato ad esprimersi in relazione alla tutela del diritto alla salute, anche quale declinazione del diritto alla tutela ambientale in termini di diritto ad un ambiente salubre (nello stesso ambito si colloca il diritto al lavoro). Particolarmente significative al riguardo le numerose pronunce che in tempo di pandemia hanno visto proprio nel giudice amministrativo l’arbitro dei contrapposti valori in gioco, tra cui la libertà di movimento e la libertà di autodeterminazione, propugnandone una lettura in chiave solidaristica, mutuata cioè pur sempre dalla portata cogente dei principi rivenienti dall’art. 2 della Costituzione (NOCCELLI). Particolarmente significativa, al riguardo, è sicuramente la sentenza n. 7045 del 2021 del Consiglio di Stato, nella quale è stata affrontata, con dovizia di analisi storica anche del regime autorizzatorio alla circolazione del farmaco, la tematica dell’imposta obbligatorietà di vaccinazione al personale sanitario, chiamato comunque a garantire il ridetto “ambiente” salubre, anche attraverso la propria autotutela, ai pazienti fragili che allo stesso devono necessariamente accedere.
In materia di limiti e obblighi della P. A., il giudice amministrativo ha mostrato una particolare sensibilità nell’affrontare le varie sfaccettature dalle quali può essere riguardata la tutela del diritto alla salute, stabilendo, in via generale, che sono proprio le strutture sanitarie, e dunque l’amministrazione pubblica, «ad attivarsi per promuovere la conservazione ed il recupero, approntando le strutture i mezzi per attuare i programmi di prevenzione, cura, riabilitazione ed intervento a favore di cittadini». La giurisprudenza ha anche chiarito da tempo che «l’amministrazione sanitaria programma, regola, vigila, finanzia, mentre la scelta dell’operatore sanitario spetta di norma all’utente» (Tar Campania, sent. n. 5498/2013).
Sicuramente degna ancora oggi di nota una risalente sentenza avente ad oggetto il mancato aggiornamento del prontuario farmaceutico da parte dell’AIFA, che chiama in causa il tema della pretesa a ricevere prestazioni da altri soggetti pubblici o privati, oltre quelle rientranti nelle modalità procedurale sottesi al menzionato strumento. Nella pronuncia cui si riferisce è stata ritenuta necessaria l’adozione del chiesto provvedimento amministrativo in quanto individuato come l’unico in grado di soddisfare la specifica pretesa dedotta. È stato dunque ottenuto l’ordine giudiziale rivolto all’amministrazione di provvedere alla somministrazione gratuita del farmaco in attesa dell’aggiornamento del prontuario farmaceutico. Si è trattato di un importante esempio di tipo propulsivo per offrire una tutela effettiva che ha implicato la valutazione in concreto dell’efficacia del medicinale, in assenza di alcuna valida alternativa terapeutica. Le argomentazioni svolte sono molto vicine a quelle che, negli anni novanta, spinsero i tribunali ordinari a pronunciarsi a favore della cosiddetta terapia Di Bella (Tar Lombardia, sent. n. 791/2008). In proposito si è parlato anche di un «diritto alla speranza».
È stato affermato anche che l’amministrazione è responsabile per i danni alla salute arrecati ai soggetti che lavorino in un plesso scolastico in stato di cattiva manutenzione e per le patologie che derivino da emotrasfusioni, nonostante le azioni esecutive non possano toccare i beni strumentali di proprietà del servizio sanitario nazionale.
Un discorso a parte, per la peculiarità della tematica affrontata che ha assunto sfaccettature etiche progressivamente più accentuate, va fatto in relazione alla procreazione assistita. Sulla materia sono intervenute due importanti sentenze della Corte costituzionale a breve distanza l’una dall’altra. Con la prima, n. 162 del 2014, partendo dalle premesse per cui la scelta di una coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, riconducibile agli artt. 2, 3, e 31 Cost. e può riguardare anche due persone sterili o infertili, che si determinino allo scopo a ricorrere, appunto, alla tecnica di procreazione medicalmente assistita (p.m.a.) di tipo eterologo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, l. n. 40 del 2004, nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso alla stessa qualora sia stata diagnostica alla coppia una patologia genetica trasmissibile grave. La sentenza, cioè, ha il dichiarato scopo di consentire la “previa individuazione”, in funzione del successivo impianto nell’utero della donna, «di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro». Con la successiva pronuncia, n. 229 del 2015, che si inserisce nel solco della precedente, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4, della medesima legge n. 40/2004, si è nella sostanza esclusa la configurabilità come reato della selezione di embrioni nella procreazione assistita, purché finalizzata soltanto a evitare di impiantarne nell’utero della donna di affetti da malattie genetiche ritenute gravi (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 194/78). È evidente il fil rouge che lega le due pronunce, alla luce della elementare considerazione per cui ciò che era già divenuto lecito per effetto della prima sentenza non poteva essere considerato illegale per il principio di non contraddizione.
Sulla scorta dei dettami discendenti da tali fondamentali sentenze, ed in particolare di quella del 2014, il giudice amministrativo ha quindi ritenuto discriminatorio un intervento normativo regionale nella parte in cui manteneva, per la sola fecondazione omologa, criteri e requisiti soggettivi più favorevoli rispetto a quella eterologa (T.A.R. Veneto, n. 5021 del 2015). La distinzione conseguente al mantenimento, per la sola omologa, del limite soggettivo di 50 anni, laddove per la eterologa era fissato quello di 43, è stata dunque, considerata in evidente contrasto sia con la normativa statale (che non pone alcuna analoga distinzione), sia con i principi generali di eguaglianza, così come ricordati dalla Corte costituzionale proprio in occasione dell’affermata analogia delle due tecniche procreative assistite. Ciò in quanto, avuto riguardo all’età della donna, la norma nazionale non dà indicazione precisa, ma fa riferimento all’età potenzialmente fertile, che quindi deve valere per entrambe le ipotesi.
Altrettanto irragionevole è stata ritenuta la distinzione posta da altro ente regionale riguardo ai costi richiesti per l’assistenza in caso di p.m.a. eterologa ed omologa, essendo stato previsto il pagamento dell’intero trattamento nel primo caso e del solo ticket nel secondo. Parimenti in una decisione del Consiglio di Stato (sent. n.1486/2015) è stata annullata la decisione dell’amministrazione di ammettere a carico del servizio sanitario nazionale la sola PMA omologa a scapito di quella eterologa, essendo illogico e non ragionevole, in patente contrasto con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza più volte citata (n.162/2014). Le due situazioni, essendo sostanzialmente identiche, contribuiscono a superare le obiezioni relative al potenziale incremento di spesa in ragione della necessità di garantire la sostanza di un diritto fondamentale, che non può essere compresso richiamando non meglio precisate ragioni economiche.
Per riassumere il quadro generale fissato dal Consiglio di Stato è il seguente:
Va peraltro ricordato come la pronuncia è stata anticipata dai principi affermati dalla Corte europea diritti dell’uomo, sez. I, 1 aprile 2010, n. 57813, secondo cui il divieto di utilizzare le tecniche di procreazione assistita di carattere eterologa non è compatibile con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Gli Stati sono dunque liberi di prevedere il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, ma nel momento in cui ammettono la possibilità di utilizzare tale tecnica non devono discriminare tra le coppie a seconda del tipo di infertilità (TIGANO).
8. Poteri, limiti e responsabilità del personale sanitario
Anche le pronunce che hanno riguardato il personale sanitario toccano la tematica dei diritti fondamentali, dovendosi contemperare la libertà di esercizio della relativa professione, anche in relazione alle scelte “etiche”, appunto, di ciascuno, con gli obblighi derivanti dalla peculiarità della stessa, solidaristicamente orientata in forza del c.d. giuramento di Ippocrate. Agli esercenti professioni sanitarie, dunque, è espressamente riconosciuta in determinati ambiti dall’ordinamento la facoltà di avvalersi della cosiddetta obiezione di coscienza, ossia il diritto di rifiutare una certa prestazione ordinariamente dovuta, tutte le volte che essa entri in conflitto con i principi di carattere morale cui gli stessi ispirino le proprie condotte in ragione del proprio personale convincimento (A. PATRONI GRIFFI). Il perimetro entro il quale può trovare spazio espressivo ridetta libertà di coscienza ha dato adito a sua volta a molteplici controversie. I giudici sono andati ancora una volta alla ricerca del giusto punto di equilibrio tra tutela della libertà di coscienza da parte del sanitario, appunto, ed esigenza di non paralizzare l’erogazione del servizio richiesto, in quanto garantito dalla legge, collocando la sfera delle potenziali responsabilità al di là di tale ricercato punto di equilibrio ottimale. L’operatore sanitario sarà dunque perseguibile sul piano disciplinare – ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili, in presenza dei rispettivi presupposti – laddove il proprio rifiuto di eseguire una prestazione, seppure rispondente a libere scelte “etiche”, si palesi indebito in quanto causativo di danni all’amministrazione o a terzi. L’esempio più diffuso è riconducibile alla materia dell’interruzione volontaria della gravidanza. La giurisprudenza ha al riguardo distinto il momento in cui venga effettuato l’intervento, ove si può opporre l’obiezione di coscienza, da quello successivo, laddove non è consentito. In ogni caso il sanitario deve intervenire ogniqualvolta vi sia un imminente pericolo di vita (TIGANO).
Per quanto riguarda il rapporto del medico con il tema del “fine vita” è sufficiente, in questa sede, richiamare le due sentenze fondamentali della Cassazione e del Consiglio di Stato sopra ricordate. Ci si riferisce alle sentenze della Cassazione, (I sez.,16/10/2007, n. 21478) e del Consiglio di Stato, (III sez., 2/9/2014 n. 4460), redatte da due magistrati dalle apprezzabili capacità di analisi giuridica e di contesto, Giusti e Noccelli.
Mentre sulla prima pronuncia vale quanto frettolosamente già osservato, sulla seconda si propone una sintesi dei passaggi fondamentali, anche perché essi sono più attinenti al tema e ci consentono di comprendere più efficacemente i termini reali di tutte le questioni trattate.
Essi sono: 1. Con riferimento alla giurisdizione, mentre il primo giudice (Tar) aveva ritenuto la propria giurisdizione in base all’articolo 33 del decreto legislativo n. 80/ 1998 (poiché si verteva in ipotesi di giurisdizione esclusiva), la sentenza ha affermato la competenza del giudice amministrativo proprio facendo leva sul concetto di diritto soggettivo costituzionalmente garantito, partendo proprio dalla sentenza della Cassazione, sezioni unite n. 27187 del 2007, laddove afferma il principio che anche in materia di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, compete ai giudici amministrativi in rapporto all’interesse generale pubblico all’ambiente salubre. In tal modo ha superato la tesi sostenuta dalla Regione secondo la quale si sarebbe al cospetto di servizi erogabili sulla base di rapporti convenzionali di diritto pubblico, di carattere concessorio, che era materia di giurisdizione esclusiva, ma di una domanda proposta da un privato tesa a far valere il suo preteso diritto di interruzione delle cure e sugli obblighi di renderla da parte del servizio pubblico. Nella sentenza viene riportato l’orientamento, da ritenersi superato, secondo cui per la Suprema Corte, trattandosi di diritto soggettivo non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica, esclude la giurisdizione del giudice amministrativo. Si fa riferimento alla vicenda dei crocefissi presenti nelle aule scolastiche. Si ribadisce che la dottrina dei diritti incomprimibili è priva di un solido e convincente sostegno; 2. l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario. Siffatta qualificazione è convalidata dalla comunità scientifica internazionale, come sostiene anche la succitata sentenza della Cassazione; 3.il diritto di autodeterminazione terapeutica del paziente, comporta che, laddove decida l’interruzione del trattamento, non significa affermare il diritto a morire;4.il principio personalistico che anima la nostra Costituzione vieta ogni intrusione nella sfera personale che non sia voluta. La salute non è assenza di malattie ma è uno stato di completo benessere fisico e psichico, che va visto in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche negli aspetti interiori della vita così come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza; 5. l’ordinamento si muove nel quadro della cosiddetta alleanza terapeutica che tiene uniti il malato e il medico nella ricerca comune di ciò che è bene. Il rifiuto del paziente è sempre legittimo non esistendo un principio di ordine pubblico che impone il dovere di curarsi; 6. l’art. 32 della Costituzione impone trattamenti sanitari nei soli casi espressamente previsti dalla legge e solo nel caso in cui la salute del singolo possa arrecare danno alla salute degli altri; 7. il rapporto tra consenso informato e responsabilità del medico o del servizio sanitario nel suo complesso necessiterebbe di un intervento legislativo; 8. per la Corte costituzionale organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente. Non c’è organizzazione che direttamente o indirettamente non sia finalizzata a garantire diritti, così come non c’è diritto a prestazione che non condizioni l’organizzazione (sentenza n. 383 del 1998); 9. l’amministrazione sanitaria non può sottrarsi al suo obbligo di curare il malato e di accettarne il ricovero, adducendo una propria ed autoritativa visione della cura o della prestazione sanitaria; 10. il rapporto tra autodeterminazione del paziente e autonomia professionale del medico merita di essere risolto legislativamente. Tuttavia si può dire che <<motivi di coscienza possono essere avanzati solo dagli individui, mentre la coscienza delle istituzioni è costituita dalle leggi che la regolano>>.
9. La responsabilità della pubblica amministrazione nella materia sanitaria
Dalla pregevole sentenza diventa più agevole tracciare la netta linea di demarcazione tra libertà di rifiutare, per coerenza con i propri principi etici, una prestazione sanitaria e responsabilità derivante dall’omessa prestazione, anche se anche così non è affatto semplice. La giurisprudenza ha cercato di trovare un punto di equilibrio che deve tenere conto dei punti di approdo della scienza, del diritto e della coscienza del singolo.
In generale, sembra prevalere il principio secondo cui nessuna obiezione di coscienza può essere opposta al fine di giustificare il diniego rispetto ad una prestazione ordinaria legittimamente richiesta e come tale dovuta dall’Amministrazione sanitaria. L’elemento soggettivo della responsabilità risulta così individuato in un comportamento che viene considerato addirittura doloso nella misura in cui si sostanzia in un espresso diniego posto attraverso un provvedimento illegittimo. Non serve a scriminare l’illiceità della condotta alcun motivo di coscienza, giacché solo gli individui hanno una coscienza, mentre la coscienza delle istituzioni è costituito dalle leggi che le regolano, come si trova scritto nella sentenza testé riassunta. Ne scaturisce in sede risarcitoria la liquidazione del danno patrimoniale, consistente nella rifusione delle spese di cura, e di quello non patrimoniale per la lesione di diritti fondamentali.
I trattamenti sanitari sono oggetto di una disciplina normativa complessa in ragione delle singole disparate fattispecie ivi contemplate. Tuttavia, è obbligato il riferimento al diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, cui sono correlati altri valori costituzionali rientranti tra i principi fondamentali, segnatamente quelli di solidarietà e di uguaglianza (articoli 2 e 3 Cost.).
Poiché le prestazioni sono rese dal servizio nazionale la medesima disciplina deve essere coerente con i principi posti materia di pubblica amministrazione, anzitutto l’imparzialità e il buon andamento, declinati in funzione dei budget di spesa assegnati e con il principio del pareggio di bilancio (TIGANO).
I medesimi principi trovano conferma nelle fonti comunitarie: basti ricordare il diritto alla vita solennemente proclamato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) e dall’articolo 2 della Cedu, nonché il diritto all’integrità della persona, che, secondo la Corte di giustizia e parte del diritto dell’Unione Europea comprende, nell’ambito della biologia della medicina, il consenso libero e consapevole del donatore e del ricevente (TIGANO).
L’amministrazione sanitaria si trova spesso nella posizione di chi sia chiamato ad adottare decisioni scomode, talora complicate dalla concorrenza di questioni etiche la cui scivolosità è ben nota. Peraltro, se da un lato la funzione amministrativa è legata alla disciplina posta dal legislatore, dall’altro la fase esecutiva risulta spesso impegnativa a causa delle incertezze interpretative che discendono dal varo di normative compromissoria e incerte.
Ciò comporta: 1) l’ampliamento dei limiti della discrezionalità amministrativa che diventa non più ponderazione degli interessi, ma operazione interpretativa pura; 2) il rinvio del caso alla sede giurisdizionale circa la verifica dell’operato degli organi amministrativi, rischiando di incidere sul merito delle valutazioni discrezionali, tradizionalmente soggette al solo sindacato di legittimità (TIGANO, TARANTINO).
A ciò va aggiunto la perduta centralità delle fonti primarie, la inveterata inefficienza amministrativa scoordinata e non sempre in linea con i budget assegnati nei risvolti di natura etica superabile se la legge e le fonti normative in genere non attraversassero l’attuale fase di crisi (D’AMICO).
Oggi vanno sempre più affermandosi nuovi valori intesi perlopiù alla riscoperta del ruolo dei diritti fondamentali, rispetto ai quali la normativa di dettaglio cede continuamente il passo.
A tutto ciò l’amministrazione non è estranea e non lo è a maggior ragione tutte le volte in cui debba misurarsi su un terreno ove il potere discrezionale si trova in una condizione nella quale non sono sempre certi punti di riferimento.
La scienza, con i suoi progressi e le sue problematiche incertezze, non è di grande aiuto sotto questo profilo: le tecniche terapeutiche, infatti, non sempre costituiscono verità assolute, risultando anch’esse fallibili e contingenti. Sicché le scelte che ne derivano sono quelle convenzionalmente considerate corrette “rebus sic stantibus”, ossia secondo l’esperienza empirica fissata negli eventuali protocolli approvati in un certo torno di tempo (TIGANO, A. PATRONI GRIFFI).
10. Interessi legittimi fondamentali a carattere economico
La permanente tendenza del mercato ad incidere sul livello di tutela dei diritti fondamentali risulta del tutto evidente nella relazione tra i mercati finanziari il debito pubblico; relazione che pone la legislazione speciale sui diritti sociali. I fallimenti del mercato evidenziati dalle recenti crisi economiche ripropone nuovamente all’attenzione della politica il problema della soluzione delle tensioni sociali e dell’indebolimento che ne deriva sul piano dei diritti sociali. Questi in particolare si ritiene possano avere un contenuto conformato dal legislatore e possano essere bilanciati con altri diritti e interessi di parte. Tuttavia, l’art. 3 del trattato di Lisbona sancisce uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva. Il mercato non più come fine ma come strumento (TARANTINO).
Un rilievo particolarmente importante da attribuire ad un orientamento della Corte costituzionale che fa il punto sui rapporti tra diritti sociali e bilancio. La questione è particolarmente delicata specie all’indomani della modifica dell’art. 81 della Costituzione da parte della legge costituzionale n. 1/2012 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio in Costituzione. Anche in questo ambito si sono avute molteplici pronunce di giudici della Consulta, nelle quali si giunge ad individuare un dovere posto in capo al legislatore di graduare l’allocazione delle risorse, distinguendo le spese necessarie per il soddisfacimento dei diritti da quelle per così dire “facoltative”. Anche a tale riguardo si è rivendicato un sindacato sulla coerenza intrinseca che deve essere rispettata da parte del legislatore nell’individuazione di quel nucleo di garanzie indefettibili che devono essere assicurate agli interessati. Secondo i giudici della Consulta, dunque, il principio di priorità nel soddisfacimento dei diritti incomprimibili incide sul bilancio, nel senso che la sostenibilità complessiva di quest’ultimo non può in alcun caso portare a far sì che il danaro pubblico venga erogato per spese facoltative, prima che vengano individuate le poste economiche necessarie per far fronte a quelle volte a garantire il soddisfacimento dei diritti fondamentali (V. Corte cost., sentt. n. 80/2010; n. 250/2013; n. 266/2013; n. 10/2016; n. 275/2016; n. 279/2016, ma anche LUCIANI).
11. Il fronte sovranazionale e internazionale
L’11 gennaio 2019, presso Palazzo della consulta, si è tenuto un importante incontro tra i vertici della Corte europea dei diritti dell’uomo, della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Consiglio superiore della magistratura, al fine di favorire il dialogo tra tali corti. Era in discussione il protocollo n. 16 recante emendamento alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, redatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. I temi principali oggetto di discussione sono stati: le materie eticamente sensibili, la disciplina prevista dal protocollo, l’indipendenza dei giudici e, infine, la disciplina delle questioni sul ne bis in idem. Sono state sottolineate le divergenze che riguardano specialmente la regolazione delle scelte di fine vita, del matrimonio omosessuale o ancora del transgender, ovverosia tutte materie considerate eticamente sensibili in cui è più difficile raggiungere quel consenso europeo in grado di determinare l’eventuale restringimento del margine di apprezzamento degli Stati (Resoconto curato da Sarah Lattanzi).
I diritti fondamentali si impongono nell’ordinamento nazionale e in quello europeo secondo direttrici difformi. Nell’esperienza nazionale i diritti fondamentali si affermano attraverso il varo della Costituzione, dove si avverte la preoccupazione di sottrarre alla maggioranza politica alcune posizioni giuridiche del singolo per farlo diventare un bagaglio irrinunciabile del sistema di socialità che alla base del progetto costituzionale.
Nella dimensione europea la tutela dei diritti fondamentali certamente non si rinviene nei trattati fondativi della comunità economica europea, ma sicuramente nell’opera della corte di giustizia, che ha elaborato un principio giuridico specifico. Questo è stato un modo di reagire all’operato delle Corti costituzionali che dinnanzi al principio di primazia del diritto comunitario e della possibile lesione di diritti fondamentali hanno elaborato la teoria dei controlimiti, in virtù della quale le Corti costituzionali nazionali si sono riservate di non applicare il diritto comunitario nel caso in cui questo violasse i diritti fondamentali.
Le modifiche apportate nel tempo ai trattati dimostra che l’Atto unico europeo del 1986 si limitava ad indicare nel preambolo la promozione della democrazia basata sui diritti fondamentali, mentre solo con il trattato di Maastricht del 1992 viene introdotta la prima norma, successivamente modificata dal trattato di Amsterdam e dal trattato di Lisbona, ossia l’articolo 6 TUE, che afferma la centralità della tutela dei diritti fondamentali. Per avere un elenco di diritti fondamentali occorre attendere la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000. Per molti anni, dunque, in assenza di un documento scritto ove fossero individuati, i diritti fondamentali hanno trovato tutela nell’ordinamento eurounitario solo attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia. Ciò si spiega con il fatto che la comunità europea non è solo composta da Stati, ma anche dagli individui che l’abitano e che reclamano tutela.
Ciò comunque ha determinato una particolare triangolazione tra giudici, dal momento che la stessa materia diviene oggetto di pronunce di tre distinti organi giurisdizionali, ossia la Corte costituzionale, la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti dell’uomo secondo trame di norme profondamente distinte. Infatti, mentre il contrasto della norma nazionale con la norma del diritto dell’unione europea determina la diretta disapplicazione della prima, il contrasto della norma nazionale con quella contenuta nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che è priva di effetto diretto nell’ordinamento nazionale, determina una situazione di illegittimità costituzionale dalla norma nazionale in forza del dettato dell’articolo 117 della Costituzione (TARANTINO).
Il controllo da parte della Corte di giustizia del rispetto dei diritti fondamentali avviene in tre casi: nei confronti degli atti delle istituzioni europee; nei confronti degli atti dell’istituzione degli Stati membri attuativi di un atto comunitario; nei confronti delle giustificazioni offerte da uno Stato membro su di una misura nazionale che si sospetta incompatibile con il diritto dell’unione.
La cosa più importante che qui va posta consiste nel fatto (Corte giustizia 26 febbraio 2013, C-617/10) che il diritto dell’unione europea non disciplina i rapporti tra Cedu e ordinamenti nazionali, né orienta l’interpretazione che il giudice nazionale deve seguire in caso di conflitto tra norma nazionale e Cedu. Pertanto, il meccanismo dei collegamenti tra diritti contenuti nella carta dei diritti fondamentali l’unione europea, diritti contenuti nella convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritti contenuti nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri viene risolta dagli articoli 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Infatti, detta normativa stabilisce che laddove la presente carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato della portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione.
Afferma, inoltre, che, laddove la presente carta riconosca diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni. Inoltre, secondo l’art. 53, il livello di protezione offerta dalla carta non può essere inferiore a quello riconosciuto dalla Cedu o dalle costituzioni degli Stati membri.
Al contempo, la Corte di giustizia mantiene un ruolo di garante della tutela dei diritti fondamentali, evitando che una tutela differenziata dei diritti fondamentale da parte degli Stati membri ponga in crisi l’unità e la coerenza dell’ordinamento europeo. In questo senso, la tutela più incisiva concessa da uno Stato membro ad un diritto fondamentale può risultare contrastante rispetto al grado di tutela assicurato dal diritto dell’Unione e recessiva nella misura in cui pregiudica l’unità e il primato dell’effettività del diritto dell’unione. È utile ricordare che nell’ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017 della Corte costituzionale è stata rimessa alla Corte di giustizia la soluzione del contrasto tra primazia del diritto europeo e tutela di un diritto fondamentale consacrato nella Costituzione.
La risposta della Corte di giustizia contenuta nella sentenza 5 dicembre 2017, C-42/17, è stata nel senso di escludere la presenza di una tutela rafforzata all’interno dell’ordinamento nazionale in grado di infrangere la primazia del diritto dell’Unione europea. Ciò in quanto il principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti di prevedibilità, determinazione e irretroattività della legge penale, trova base nell’articolo 49 della CDFUE e si impone agli Stati europei in quanto attuano il diritto unionale e poi riflette le tradizioni comuni agli Stati membri e ha identica portata rispetto alla corrispondente diritto garantita dalla convenzione EDU. Pertanto, lo stesso diritto europeo potrà essere applicato con prevalenza su quello nazionale solo se in grado di rispettare quel livello di tutela del diritto fondamentale che trova unica corrispondenza in tutti gli ambiti sopraindicati.
Ma quello che è più importante qui notare è che la conseguenza dell’adozione della carta fondamentale del 2000 è quella relativa al riconoscimento di una pari dignità ai diritti sociali rispetto alle altre categorie di diritti fondamentali, ossia quelli che si caratterizzano per un’attuazione che non necessita di un ruolo attivo da parte dello Stato. Con ciò si pone il tema della loro efficacia, sia pure nell’ambito delle competenze del diritto dell’Unione, e delle ricadute in termini di obblighi positivi in capo agli Stati membri. Anche tale questione va affrontata in base all’articolo 52 della carta fondamentale, che distingue tra diritti e principi, assumendo chiaramente che alcune norme della stessa non fondino diritti immediatamente giustiziabili, se non a fini interpretativi o di parametri di legalità, ma necessitante in prima battuta di una attuazione da parte del legislatore e degli organi esecutivi (TARANTINO).
Questa precisazione sembra orientata a porre i diritti sociali nell’ambito dei principi al fine di fronteggiare il pericolo avversato da alcuni Stati di una giurisdizionalizzazione delle proprie politiche pubbliche in settori particolarmente sensibili per i bilanci pubblici (TARANTINO).
In definitiva anche la Carta europea dei diritti fondamentali distingue tra diritti e principi. Tuttavia, la Corte di giustizia ha sempre scelto un approccio casistico al problema.
12. Il diritto sanitario durante la pandemia e il PNRR
La guerra contro il Coronavirus non è soltanto una lotta tra la scienza contro il nuovo e invisibile virus, ma è anche una battaglia di civiltà giuridica, ossia la riaffermazione di un nuovo volto del diritto alla salute, quello della solidarietà. È stata anche l’occasione per la riscoperta del valore della persona, e della sua dignità, in quanto tale (NOCCELLI).
In termini più espliciti, è venuto in rilievo il problema dell’ambito e dei limiti di tutela dell’essere umano, ossia della concezione che l’uomo ha di sé stesso e della propria identità. In tale materia si ha una perenne contrapposizione dialettica tra la concezione utilitaristica dell’uomo-massa o uomo-mezzo, ossia dell’utilitarismo statuale collettivistica, dell’utilitarismo maggioritario, ossia della maggiore felicità dei più (di matrice anglosassone) a scapito dei pochi o dell’utilitarismo individualistico-egoistico della maggiore felicità propria. A fronte di tali concezioni, vi è l’opposto principio della indisponibilità dell’essere umano, che subordina la liceità degli interventi sul medesimo ad un duplice ordine di limiti coessenziali, ossia i limiti oggettivi salvaguardati dai principi della salvaguardia della vita, dell’integrità fisica, della salute, della dignità umana, dell’eguaglianza e pari dignità dei soggetti umani e i limiti soggettivi segnati dal principio del consenso del soggetto.
La nostra Costituzione si fonda sul primato della persona umana e funzionalizza le consistenti componenti solidaristico sociali e la tutela dei beni mezzo sopraindividuali (della famiglia, della comunità, dello Stato amministrazione, delle istituzioni democratiche) alla salvaguardia dei beni fini della conservazione, della dignità e dello sviluppo della persona umana. C’è bisogno di stabilire una volta per tutte a quale persona e a quale “antropologia” fare riferimento, stante il pluralismo ideologico culturale della nostra società che genera talora radicali divergenze. Va, infine, segnalato come sia necessario riflettere molto sulla portata scriminante del consenso, che vede contrapposte le posizioni personalistiche o garantistiche a quelle utilitaristico-individualistiche fino a quelle egoistico-libertarie a sfondo nichilistico, contrabbandato talora come personalistiche, ma eccentriche rispetto all’autentico personalismo (MANTOVANI).
Abbiamo già detto dell’importanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 7045 del 2021, che, pur riferendosi al tema delle vaccinazioni obbligatorie, essa contiene ineludibili principi a valere a livello più generale. Ad essa si può associare il parere della Commissione speciale, affare n. 1614/2017, estensore Carlotti, che, rispondendo al quesito posto dalla Regione Veneto se fosse o meno legittima la preclusione alla frequenza dei corsi scolastici a coloro che rifiutavano i vaccini obbligatori, ha fatto uso di concetti destinati ad avere poi una rilevanza planetaria, quali l’immunità di gregge e l’assenza del rischio zero in ogni trattamento sanitario.
Ad essi può farsi riferimento per una chiusura circolare di queste brevi considerazioni.
La riserva di scienza, alla quale il decisore pubblico, sia a livello normativo che amministrativo, deve fare necessario riferimento (nello specifico, nell’adottare le misure sanitarie atte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica), «lascia a questo, per l’inevitabile margine di incertezza che contraddistingue anche il sapere scientifico nella costruzione di verità acquisibili solo nel tempo, a costo di severi studi e di rigorose sperimentazioni e sottoposte al criterio di verificazione-falsificazione, un innegabile spazio di discrezionalità nel bilanciamento tra i valori in gioco, la libera autodeterminazione del singolo, da un lato, e la necessità di preservare la salute pubblica e con essa la salute dei soggetti più vulnerabili, dall’altro, una discrezionalità che deve essere senza dubbio usata in modo ragionevole e proporzionato e, in quanto tale, soggetta nel nostro ordinamento a livello normativo al sindacato di legittimità del giudice delle leggi e a livello amministrativo a quello del giudice amministrativo.»
*Relazione tenuta a Ravello il 27 e 28 ottobre 2023 nell’ambito del Primo convegno della Giustizia Amministrativa, organizzato dal Consiglio di Stato, dal titolo “Protezione, garanzie e tutele in una società fluida, globalizzata e multilivello. Principi, diritti e interessi fondamentali.” Sono in corso di pubblicazione gli atti relativi.
Elenco delle opere dei principali autori citati:
di Roberto Leonardi
Sommario: 1. Il fatto. – 2. Gli artt. 14 bis e 17 bis, l. n. 241/1990. - 3. Il silenzio assenso orizzontale e l’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8610/2023. - 4. Brevi considerazioni conclusive.
1. Il fatto
Un privato, proprietario di un terreno insistente nel Piano del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sottoposto a tutela paesaggistica, ai sensi dell’art. 142, c. 2, lett. f), del d.lgs. n. 42/2004, chiedeva il rilascio del permesso di costruire per l’edificazione di una residenza turistico-alberghiera, formulando a tal fine anche la domanda di autorizzazione paesaggistica[1]. Il Comune interessato indiceva una conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona, al fine di acquisire tutti gli atti di assenso, compreso il parere della Soprintendenza competente, nonché il nulla osta dell’Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Quest’ultimo rilasciava il proprio nulla osta, mentre la Soprintendenza, dopo aver chiesto, in un primo momento, la trasmissione di integrazioni e di chiarimenti, esprimeva, successivamente, un parere negativo. Riattivata ad opera del Comune competente l’istruttoria procedimentale, la Soprintendenza confermava il proprio parere negativo. Da qui seguiva la determina del Comune, con la quale si statuiva che “l’intervento dal punto urbanistico è conforme al PRG e alle norme di attuazione attualmente vigenti e pertanto è assentibile”, mentre “il dissenso espresso non era superabile, senza apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza così come rappresentato dal parere contrario della Soprintendenza”.
Tale decisione veniva impugnata dal soggetto privato interessato e il Tar Campania, Salerno, 4 novembre 2022, n. 2946, accoglieva il ricorso, annullando, pertanto, la determina comunale.
Il giudice di prime cure, innanzi tutto, rilevava la tardività del parere negativo della Soprintendenza, generando, in questo modo, il cd. silenzio assenso orizzontale nell’ambito della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 bis, l. n. 241/1990, implicando l’inefficacia del parere medesimo, ai sensi dell’art. 2, c. 8 bis, l. n. 241/1990[2]. Pertanto, si osserva che secondo l’art. 17 bis, cit., nell’ambito della conferenza di servizi, gli assensi delle Amministrazioni preposte alla tutela dei cd. interessi sensibili, tra cui la tutela beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti decorsi 90 giorni dalla richiesta del parere. Allo stesso tempo, gli artt. 22 e 25, d.lgs. n. 42/2004, non si applicano cumulativamente, “la prima norma escludendo”, seguendo le parole del giudice campano e le previsioni di legge, “ espressamente che il procedimento ivi disciplinato (diffida del privato e ricorso avverso il silenzio inadempimento) possa essere applicato agli atti di assenso resi nelle conferenze di servizi”. Nel secondo caso, artt. 25 e 26, d.lgs. n. 42/2004, in tema di conferenza di servizi, i pareri delle Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili si intendono acquisiti decorsi 90 giorni dalla richiesta, ai sensi dell’art. 17 bis, cit.. Applicando diversamente la norma, il silenzio della Soprintendenza nell’ambito della conferenza di servizi arrecherebbe un danno al privato e, allo stresso tempo, si andrebbe in contrasto con il dato letterale dell’art. 17 bis, cit., che non troverebbe mai applicazione nell’ambito di una conferenza di servizi in materia di beni culturali, dovendo, anche in questo, il privato impugnare il silenzio inadempimento dell’Amministrazione. In conclusione, “attesa l’inefficacia del parere reso tardivamente dalla Soprintendenza, in ragione dell’intervenuta formazione del silenzio assenso”, la determina di conclusione dei lavori del Comune è da reputarsi illegittima.
Il Ministero dei beni culturali propone appello avverso tale decisione e il Consiglio di Stato si pronuncia con la sentenza in esame. Il Ministero sostiene che il silenzio assenso orizzontale, disciplinato dall’art. 17 bis, cit., debba applicarsi esclusivamente nell’ambito dei rapporti tra Amministrazioni e non nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica, inteso dal Ministero come procedimento monostrutturato in cui prevale la volontà di una singola Amministrazione. Pertanto, nella fattispecie in esame, il parere della Soprintendenza non sarebbe tamquam non esset, dovendo il Comune tenerne conto nell’ambito della determinazione inerente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
2. Gli artt. 14 bis e 17 bis, l. n. 241/1990
Prima di esaminare la sentenza del Consiglio di Stato, pare opportuno soffermarsi, se pur brevemente, suoi caratteri degli istituti oggetto di contrasto interpretavo, per poi esaminare la loro applicazione nello specifico caso dell’autorizzazione paesaggistica[3].
L’art. 14 bis, cit., dispone che la conferenza di servizi decisoria, art. 14, c. 2, l. n. 241/1990, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo le modalità previste dall’art. 47 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82[4]. La conferenza semplificata è stata considerata in dottrina[5] un ossimoro o una contraddizione in termini, mancando l’esame contestuale degli interessi coinvolti, vero tratto caratterizzante della conferenza di servizi, oltre alla certezza della decisione finale, superando il dissenso, che ha contraddistinto la conferenza di servizi fin dalla l. 24 novembre 2000, n. 340, con la quale il principio dell’unanimità del consenso è stato sostituito con il principio maggioritario.
A conferma di quanto appena detto potremmo considerare quanto disposto dalla legge delega n. 124/2015 e dal successivo decreto delegato, per poter affermare che anche il legislatore non consideri la conferenza simultanea come la vera conferenza di servizi decisoria. Infatti, l’art. 2, c. 1, lett. a), della legge delega, tra i criteri direttivi, fa riferimento alla ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza dei servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento. L’art. 14 bis, c. 2, cit., dispone che la conferenza simultanea è indetta dall’Amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Al contempo, il previgente art. 14, c. 2, cit., prevedeva che la conferenza di servizi fosse sempre indetta qualora l’Amministrazione procedente dovesse acquisire atti di assenso da parte di altre Amministrazioni e non li avesse ottenuti nel termine di 30 giorni dalla richiesta. Pertanto, una volta ricevuti gli atti di assenso, la conferenza di servizi non era più necessaria.
Secondo il dettato attuale, la conferenza semplificata è obbligatoria, ma non è la vera conferenza di servizi, mentre quella simultanea, la vera conferenza di servizi, nel rispetto del criterio di riduzione della legge delega, è diventata residuale e, quindi, limitata ai casi in cui l’Amministrazione procedente debba superare il dissenso espresso da un’altra Amministrazione nel corso della conferenza semplificata, ovvero, qualora sia necessaria per la complessità del provvedimento da adottare.
Un primo profilo di esame, che in modo particolare rileva in questa sede, è il rapporto tra la conferenza di servizi semplificata e il silenzio assenso tra Amministrazioni e tra un’Amministrazione e un gestore di beni o servizi, art. 17 bis, cit..
La legge delega prevede, tra i criteri guida, il coordinamento delle norme inerenti ai due istituti, mentre la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo ha sintetizzato il tema osservando che “la formulazione della disposizione, art. 14 bis, cit., che fa riferimento a più atti di assenso, chiarisce che ove sia necessario un solo atto di assenso, si applica l’art. 17 bis della stessa l. n. 241/1990”[6]. In realtà, il Cons. Stato, Comm. Spec., n. 1640/2016, nel parere reso in riferimento ad alcuni profili critici dell’art. 17 bis, cit., ha osservato che “la tesi secondo cui l’art. 17 bis trova applicazione nel caso in cui l’Amministrazione procedente debba acquisire l’assenso di una sola Amministrazione, mentre nel caso di assensi di più Amministrazioni opera la conferenza di servizi, rappresenta, in effetti, quella che fornisce il criterio più semplice per la risoluzione dell’apparente sovrapposizione normativa (…). In alternativa, per estendere l’ambito applicativo dell’art. 17 bis, cit., in modo che appaia, comunque, compatibile con il suo tenore letterale, si potrebbe sostenere che il silenzio assenso di cui all’art. 17 bis, cit., opera sempre, anche nel caso in cui siano previsti assensi di più Amministrazioni e, se si forma, previene la necessità di convocare la conferenza di servizi. Quest’ultima andrebbe convocata, quindi, nei casi in cui il silenzio assenso non si è formato a causa del dissenso espresso dalle Amministrazioni interpellate e avrebbe lo scopo di superare quel dissenso nell’ambito della conferenza appositamente convocata”.
Il Consiglio di Stato sembra, così, voler superare la conferenza semplificata, la quale, invece, viene confermata nel testo definitivo e applicata qualora gli atti di assenso siano più di uno, escludendo in questo caso l’applicazione dell’art. 17 bis, cit.. Infatti, l’art. 14, c. 2, cit., dispone che “la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’Amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici”.
In definitiva, come osservato in dottrina, seguendo un mero criterio quantitativo, gli istituti della conferenza di servizi semplificata e quello dell’art. 17 bis non verrebbero a sovrapporsi, seguendo una modulazione della procedura in relazione alle questioni sostanziali da affrontare: per gli affari più semplici, il silenzio assenso, ex art. 17 bis; per quelli leggermente più complessi, la conferenza semplificata; per quelli di una certa complessità, la conferenza simultanea[7].
Tuttavia, il criterio quantitativo non pare essere l’unico alla base di una netta distinzione tra i due istituti. Si pensi, ad esempio, al differente ambito oggettivo di applicazione. L’art. 17 bis, cit., si applica anche all’adozione di provvedimenti amministrativi e provvedimenti normativi, mentre la conferenza di servizi ai soli provvedimenti amministrativi. Inoltre, l’art. 14, c. 2, cit., tra gli assensi da acquisire, menziona i pareri e le intese, esclusi dall’art. 17 bis[8].
La conferenza di servizi e il silenzio assenso tra Amministrazioni troveranno spazio nell’acquisizione di pareri vincolanti per la loro natura decisoria, principio fondamentale che rileva per la sentenza in esame. Al contempo non si applica l’art. 17 bis ai pareri non vincolanti, per i quali, come del resto per le valutazioni tecniche, continuano ad applicarsi le procedure di cui agli artt. 16 e 17, l. n. 241/1990.
L’art. 17 bis, cit., opera, quindi, solo nella fase decisoria, nella fase in cui l’amministrazione procedente, completata l’istruttoria e nella quale operano anche gli artt. 16 e 17, cit., propone uno schema di provvedimento ad un’altra Amministrazione, anche preposta alla cura degli interessi sensibili, alla cui inerzia, nei termini di 30 o 90 giorni, segue il silenzio assenso. Invece, la conferenza simultanea, essendo obbligatoria per l’acquisizione di più atti di assenso e dovendo essere convocata nel termine di cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal deposito dell’istanza di parte, deve effettuare un’istruttoria completa e in questa devono essere acquisiti anche i pareri meramente consultivi e non vincolanti, oltre alle valutazioni tecniche.
Un altro tratto distintivo della conferenza di servizi semplificata (art. 14 bis) e del silenzio assenso orizzontale (art. 17 bis) è dato dalla disciplina della qualificazione dell’assenso implicito e dalla modalità di superamento del dissenso. Nel primo caso, l’art. 14 bis, c. 3, introduce i requisiti necessari per far valere il dissenso e in assenza dei quali si ha un assenso implicito[9], mentre l’art. 17 bis non menziona qualità specifiche del dissenso, operando così in caso d’inerzia dell’Amministrazione. Inoltre, in riferimento al superamento del dissenso, l’art. 17 bis, c. 2, stando alla lettera della norma, ritiene superabile solo il dissenso tra Amministrazioni statali, nel quale caso, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle eventuali modifiche da apportare allo schema di provvedimento presentato dall’amministrazione procedente.
Un ulteriore tratto distintivo dei due istituti è dato dal profilo soggettivo della conferenza di servizi simultanea e del silenzio assenso tra amministrazioni. Difatti, l’art. 14 fa riferimento a tutte le Amministrazioni pubbliche, compresi i gestori dei beni e dei servizi pubblici, mentre l’art. 17 bis, cit., individuerebbe, come amministrazioni procedenti, le sole Amministrazioni pubbliche, mentre le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sarebbero i soggetti a cui chiedere gli atti di assenso comunque denominati.
Soffermandoci ancora sui caratteri essenziali dell’istituto introdotto dall’art. 17 bis, cit., possiamo dire che è un silenzio assenso endoprocedimentale, con effetti all’interno di un procedimento amministrativo, “come fatto equivalente alla valutazione, da parte delle autorità interpellate, circa la sussistenza di elementi contrari all’adozione e al contenuto del provvedimento prospettato dall’autorità decidente”[10].
Tale silenzio si differenzia, pertanto, da quello ‘provvedimentale’ operante per l’inerzia dell’Amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte, nei quali, allo scadere del termine per la conclusione del procedimento, il privato ottiene l’effetto utile previsto dalla norma di riferimento, rispondendo in questo modo, tale istituto, alle istanze di liberalizzazione delle attività economiche private[11]. Questa conseguenza all’inerzia dell’Amministrazione, applicata al rapporto verticale amministrazione/privato, da cui dobbiamo distinguere, ai sensi dell’art. 17 bis, cit., il silenzio applicato al rapporto orizzontale tra amministrazioni, è disciplinata ancora oggi dall’art. 20, l. n. 241/1990, il quale, tra le sue specificità, contempla al c. 4 l’espressa esclusione del silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte riguardanti i cd. interessi sensibili, tra cui la tutela dei beni culturali, ai quali, invece, come si è detto, l’art. 17 bis, c. 3, cit., applica il silenzio assenso tra Amministrazioni[12].
La differenza tra l’art. 17 bis e l’art. 20, c. 4, cit., permane, almeno formalmente, e da qui sono scaturiti nella giurisprudenza amministrativa i dubbi interpretativi sulla compatibilità dei due articoli in una visione di sistema[13].
Il silenzio endoprocedimentale e quello provvedimentale sollevano un altro profilo critico legato alla ratio stessa dei due istituti. Infatti, se in entrambi i casi si vogliono perseguire esigenze di semplificazione, con i rischi annessi, allo stesso tempo il silenzio provvedimentale deve garantire un equilibrio e un bilanciamento tra la tutela dell’interesse pubblico e quello del privato cui si lega un legittimo affidamento. In quello endoprocedimentale, invece, l’equilibrio da cercare è tra la tutela di diversi interessi pubblici, il principio di legalità, il principio delle competenze e quello della leale collaborazione tra Amministrazioni e non tanto l’istituto del silenzio in quanto tale, ma la sua generalizzazione tra Amministrazioni solleva qualche dubbio sulla realizzazione di tale equilibrio. Come del resto ha sollevato qualche dubbio, per rimanere nell’ambito della necessità di un coordinamento tra Amministrazioni, soprattutto nella tutela dei beni culturali, ma non solo, il rapporto tra il silenzio assenso tra Amministrazioni e la conferenza di servizi, di cui si è già detto, come strumento di semplificazione amministrativa da impiegare nei procedimenti a struttura complessa e nei procedimenti collegati. Non a caso, la delega per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, ex art. 2, l. n. 124/2015, indica tra i princìpi e i criteri direttivi per il legislatore delegato “il coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell’art. 17 bis”.
La rilevanza dell’art. 17 bis, cit., e i profili critici derivanti da importanti dubbi interpretativi del medesimo per problemi di coordinamento e di sovrapposizione fra gli interventi dell’Amministrazione, a causa della sua non piena sincronizzazione con gli altri strumenti già presenti, hanno prodotto la formulazione di un quesito da parte della Presidenza del Consiglio, Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, a seguito del quale è stato reso il parere n. 1640/2016, della Commissione speciale del Consiglio di Stato, appositamente istituita[14], parere diventato centrale anche nelle argomentazioni della sentenza in esame.
La Commissione ha, innanzitutto, sottolineato la portata sistemica e il valore di principio del silenzio assenso tra Amministrazioni, paragonandolo per la sua portata di principio generale alle modifiche introdotte dalla l. n. 124/2015 all’art. 21 nonies, l. n. 241/1990, in tema di annullamento d’ufficio[15] e in particolare in riferimento al termine di 18 mesi entro il quale poter intervenire da parte dell’amministrazione in autotutela. Infatti, secondo la Commissione, come sono stati posti limiti temporali all’esercizio del potere pubblico allo scopo di dare certezza ai rapporti tra l’amministrazione e i cittadini, consolidando le situazioni giuridiche soggettive di questi ultimi, allo stesso tempo la generalizzazione del silenzio assenso tra amministrazioni rappresenterebbe un secondo principio generale da applicare ai rapporti tra Amministrazioni nei casi in cui il procedimento debba concludersi con una decisione pluristrutturata[16], nella quale, ex lege, il provvedimento finale dell’amministrazione procedente deve essere preceduto da un assenso vincolante di un’Altra amministrazione che assumerebbe, in tale procedimento amministrativo, il ruolo di codecisore.
Nel definire la portata generale di tale nuovo paradigma, la Commissione speciale ha enunciato tre fondamenti: uno costituzionale, uno di sistema e uno europeo.
Per il primo, il principale fondamento costituzionale dell’art. 17 bis, cit., è individuato nel principio del buon andamento, ex art. 97, c. 2, Cost.[17], letto in un’ottica moderna, volto a tutelare, attraverso una conclusione tempestiva dei procedimenti, “il primato dei diritti della persona, dell’impresa e dell’operatore economico rispetto a qualsiasi forma di dirigismo burocratico”[18] e a qualificare l’attività amministrativa come prestazione che deve soddisfare i diritti civili e sociali, ex art. 117, c. 2, lett. m), Cost.[19].
In riferimento al secondo, il silenzio assenso tra Amministrazioni attua il principio di trasparenza, a sua volta declinazione del principio della buona amministrazione[20], alla cui attuazione darebbe un importante contributo “l’introduzione di rimedi di semplificazione dissuasivi e stigmatizzanti il silenzio”[21].
L’ulteriore fondamento è, secondo la Commissione speciale, da rinvenirsi nel diritto europeo, in un principio desumibile dalla cd. direttiva Bolkestein (2006/123/CE, definita dalla stessa Commissione microcosmo per sottolinearne la specificità dell’oggetto), la quale, allo scopo di prevenire gli effetti negativi dell’incertezza sul mercato, ha limitato i casi in cui un’attività possa essere sottoposta ad autorizzazione e ha introdotto il principio della tacita autorizzazione, sostenendo “come anche in ambito europeo sia sempre più avvertita l’esigenza di introdurre rimedi semplificanti per neutralizzare gli effetti negativi dell’inerzia dell’amministrazione”. In realtà, se la direttiva Bolkestein rappresenta appunto un microcosmo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, come del resto quella della Corte costituzionale, ha tradizionalmente espresso un orientamento contrario nei confronti di una tipizzazione del silenzio assenso in luogo del provvedimento espresso.
L’art. 17 bis, cit., come si diceva, dispone che l’assenso deve intendersi acquisito qualora l’Amministrazione codecidente sia rimasta inerte per 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. In tal modo, s’inserisce un termine unico, per così dire ordinario, che va a determinare e a delimitare i tempi dell’azione amministrativa, prevalendo su termini diversi disposti dalla normativa vigente, a eccezione di quanto disposto dal c. 3 del medesimo articolo, che introduce esso stesso un termine diverso, di 90 giorni, per gli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili. Il termine di 30 giorni è suscettibile di un’unica interruzione, qualora, nel medesimo termine, vengano manifestate esigenze istruttorie o motivate richieste di modifica, provando in questo modo, a mio parere, che l’istruttoria procedimentale non possa essere considerata completa e conclusa solo a seguito della decisione presa dall’amministrazione procedente, necessitando, di contro, che l’istruttoria debba essere considerata completa e conclusa anche da parte dell’amministrazione a cui sia stato richiesto l’assenso comunque denominato.
Qualora, pertanto, non lo fosse, l’assenso, il concerto o il nulla osta dovranno essere comunicati nei 30 giorni successivi alla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento. Decorso tale ulteriore termine, entra in gioco il nuovo meccanismo di semplificazione: l’amministrazione codecidente non potrà più esprimere il proprio dissenso e così l’inerzia viene “sanzionata”, come espressamente e significativamente scritto dalla Commissione speciale nel parere citato, e l’equipollenza del silenzio con il provvedimento espresso favorevole diventa il rimedio nei confronti della natura patologica dell’inerzia dell’amministrazione.
Sempre in riferimento al termine, per i procedimenti relativi alla tutela degli interessi sensibili, come si diceva, l’art. 17 bis, c. 3, fissa un termine più di lungo, di 90 giorni, per la formazione del silenzio, pur facendo salvo, contestualmente, un termine ancora diverso, previsto per le discipline di settore.
L’utilizzo dell’aggettivo diverso, nella sua genericità e in assenza di ulteriori specificazioni, lascia intendere che il termine per la formazione del silenzio possa essere più lungo, ma anche più breve di 90 giorni, come è il caso del termine di 45 giorni, previsto dall’art. 146, d.lgs. n. 42/2004[22], riducendo drasticamente, in questo caso, la differente tutela prevista dall’art. 17 bis, cit., tra interessi ordinari e interessi sensibili[23].
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione soggettivo, l’art. 17 bis, cit., si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, regioni ed enti locali compresi, come ribadito nel parere n. 1640/2016, cit..
Difatti, la disciplina del silenzio assenso è da ricondurre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato attinente ai livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, c. 2, lett. m), Cost.[24]. Inoltre, in riferimento a questi ultimi, l’art. 29, c. 2 ter, l. n. 241/1990, nel ricondurre anche le disposizioni della legge sul procedimento sul silenzio assenso ai livelli essenziali delle prestazioni, non distingue il silenzio endoprocedimentale e quello provvedimentale, anche perché, pur nella diversità strutturale dell’art. 17 bis e dell’art. 20, cit., in entrambi i casi l’obiettivo, almeno negli intenti, è quello della semplificazione e dell’accelerazione dell’azione amministrativa.
Sempre nell’ambito soggettivo di applicazione, devono essere considerate le Regioni a Statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano[25], le Autorità indipendenti, in virtù della natura amministrativa loro riconosciuta[26], nonché gli organi politici, sia nella qualità di organo procedente, sia in quella di organo che deve esprimere un assenso comunque denominato. In questo caso, si potrebbe porre un problema in ordine alla modalità di composizione del disaccordo, di cui all’art. 17 bis, c. 2, in caso d’inerzia dell’organo politico, che si aggiunge alle perplessità anche nei confronti della stessa scelta di affidare a un organo politico, come avviene già per la conferenza di servizi, la composizione amministrativa definitiva degli interessi da tutelare in caso di dissenso di un’amministrazione: scelta ancor più critica se si tratta d’interessi sensibili per l’alto profilo tecnico sotteso, in violazione del principio della separazione dell’indirizzo politico dall’attività di gestione amministrativa.
Quanto ai gestori di beni o servizi pubblici, ultimando con l’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 17 bis, il richiamo sembrerebbe indicare l’applicazione del silenzio assenso ai casi in cui essi siano chiamati a rendere un atto di assenso comunque denominato, e non a quelli in cui gli stessi quali amministrazioni procedenti che necessitino di un assenso per concludere un proprio procedimento. Sul punto, il parere n. 1640/2016, cit., della Commissione speciale ha seguito un orientamento estensivo, equiparando i gestori alle amministrazioni, negli ambiti e nei limiti in cui la loro attività sia procedimentalizzata[27].
Passando all’ambito di applicazione oggettivo, l’art. 17 bis, si applica espressamente ai procedimenti diretti all’adozione di provvedimenti non solo amministrativi, ma anche quelli normativi di competenza delle amministrazioni. In questo ambito, tuttavia, la questione più significativa e critica attiene all’applicabilità o meno dell’istituto anche nei casi in cui sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini[28].
In riferimento a questi interessi, l’art. 17 bis, c. 3, cit., introduce, come si diceva, una disciplina diversa rispetto a quella prevista dall’art. 20, c. 4, cit., il quale continua a regolare, pur dopo l’introduzione dell’art. 17 bis, il silenzio assenso dell’Amministrazione procedente a seguito di un’istanza di parte, il cui c. 4, esclude la generalizzazione del silenzio assenso, come disposto dall’art. 20, c. 1, nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggio, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità[29].
L’estensione del silenzio assenso endoprocedimentale agli interessi sensibili solleva una serie di profili critici cui la Commissione speciale, con il parere n. 1640/2016, ha cercato di dare una risposta, trovando un’adesione completa dalla sentenza in esame.
Il riferimento è, innanzi tutto, alla necessità di coordinamento tra l’art. 17 bis e gli artt. 16 e 17, cit., nonché al rapporto tra il silenzio assenso tra Amministrazioni e il silenzio che si produce nell’ambito della conferenza di servizi. Non meno di rilievo è la necessità di coordinamento, come si diceva, tra l’art. 17 bis, l’art. 20, c. 4, cit., e l’art. 146, d.lgs. n. 42/2004 in tema di beni culturali, oltre alle implicazioni dell’applicazione dell’art. 17 bis al medesimo decreto legislativo. Il tutto inserito, come già si è detto, in un orientamento generale della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia UE contrario all’applicazione all’inerzia dell’amministrazione del rimedio preventivo e generalizzato del silenzio assenso quando gli interessi coinvolti siano di rango primario e tra questi figurano di certo gli interessi ambientali.
3. Il silenzio assenso orizzontale e l’art. 146, d.lgs. n. 42/2004 nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8610/2023
In un primo quadro legislativo così delineato, il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, è chiamato a pronunciarsi sull’applicabilità del cd. silenzio assenso orizzontale agli atti di tutela dei cd. interessi sensibili, nello specifico al parere paesaggistico reso tardivamente nell’ambito di una conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 bis, cit.. Tale questione, oggetto di contrasto interpretativo e di ampio dibattito dottrinale, è strettamente correlata, come già si è detto, con l’applicabilità o meno dell’art. 17 bis, cit., al procedimento di autorizzazione paesaggistica[30].
Il giudice d’appello ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Prima della riforma introdotta dalla l n. 124/2015[31], l’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, prevedeva che l’Amministrazione competente, il Comune a seguito della delega della Regione, doveva provvedere sulla domanda del privato nel termine di 60 giorni, dopo aver acquisito il parere della Soprintendenza da rendere nel termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti. Decorso inutilmente tale termine, il Comune doveva provvedere sulla domanda anche senza l’acquisizione del parere della Soprintendenza, la quale poteva comunque intervenire tardivamente fino alla conclusione formale del procedimento di autorizzazione paesaggistica. In tale fattispecie, il silenzio della Soprintendenza era da configurare come silenzio devolutivo e, pertanto, l’autorizzazione paesaggistica veniva imputata al Comune che l’aveva rilasciata.
La l. n. 124/2015 ha mutato radicalmente questa impostazione tradizionale, ripensando e modificando profondamente l’attenuazione dell’applicazione dei procedimenti di semplificazione qualora siano coinvolti interessi cd. sensibili[32]. Pertanto, proponendo una trasformazione del ruolo della semplificazione, da valore strumentale a bene o valore di natura finale e, allo stesso tempo, attenuando la primarietà degli interessi cd. sensibili in favore di un loro bilanciamento con altri valori costituzionalmente rilevanti, la cd. legge Madia ha modificato l’istituto della conferenza di servizi, artt. 14 ss., e ha introdotto il cd. silenzio assenso orizzontale tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 17 bis, di cui si è già detto.
La giurisprudenza, anche dopo la Riforma Madia, ha, in diversi casi, ancora utilizzato il modello del silenzio devolutivo[33]. Secondo questo modello interpretativo, in caso di inerzia della Soprintendenza, il parere tardivo sarebbe obbligatorio, ma non vincolante, obbligando, pertanto, l’Amministrazione procedente ad una sua valutazione anche in riferimento ai profili paesaggistici[34]. Questo in applicazione dell’art. 146, c. 9, d.lgs. n. 42/2004, non abrogato dall’art. 17 bis, cit., ai sensi del quale “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”. In definitiva, secondo questo primo orientamento giurisprudenziale[35], l’autorizzazione paesaggistica costituirebbe un provvedimento mono-strutturato, nel quale il parere della Soprintendenza verrebbe ad inserirsi, condividendo con l’Amministrazione procedente la fase istruttoria e non quella decisoria. Se si accetta tale orientamento, non può trovare applicazione in questo modello l’art. 17 bis, cit., che ha introdotto una forma di co-decisione attraverso il silenzio, imponendo all’Amministrazione procedente di condurre un’istruttoria completa al fine di predisporre uno schema di provvedimento da sottoporre, nel caso di specie, alla Soprintendenza come Amministrazione co-decidente. Si tratta, dunque, di un atto a contenuto decisorio e di un giudizio di merito tecnico-discrezionale. Il parere di compatibilità paesaggistica rientra tra i pareri a contenuto tecnico, in ragione della specificità della materia su cui deve esprimersi ed è qualificato dallo stesso legislatore obbligatorio non vincolante[36].
A questo primo orientamento se ne è opposto un altro, secondo il quale il silenzio assenso orizzontale, di cui all’art. 17 bis, cit., si applicherebbe anche al parere reso dalla Soprintendenza. Condivide tale orientamento la sentenza in esame, considerandolo “maggiormente conforme al quadro normativo di riferimento”[37].
Sul piano sistematico, i pareri vincolanti contribuirebbero alla formazione di un provvedimento finale pluristrutturato[38], considerando il parere della Soprintendenza “espressione di una cogestione attiva del vincolo paesaggistico”[39], modello considerato dalla sentenza in esame maggiormente conforme al dettato costituzionale. Infatti, la dequotazione di tale parere a mero parere consultivo indebolirebbe il delicato equilibrio sotteso all’art. 146, d.gs. n. 42/2004, rispetto al riparto delle funzioni legislative di cui all’art. 117 Cost.. Sarebbe, invece, maggiormente in linea con un quadro costituzionalmente vincolato riconoscere al parere della Soprintendenza un carattere co-decisorio, come si desume anche dalla riforma dell’art. 146, operata dal d.l. n. 70/2011, conv. in l. n. 106/2011 con la quale si è stabilito che la Regione, o il Comune delegato, devono trasmettere alla Soprintendenza una proposta motiva, dopo un’adeguata istruttoria.
In definitiva, a tali pareri vincolanti, necessari per definire il contenuto della decisione finale in qualità di atti co-decisori (cd. decisione pluristrutturata), si applicherebbe l’art. 17 bis, cit., partendo anche da una sua esegesi letterale inequivocabile, come affermato dal citato parere del Consiglio di Stato, n. 1640/2016, il quale ha affermato che “la formulazione testuale del comma 3 dell’art. 17 bis, l. n. 241 del 1990, consente di accogliere la tesi favorevole all’applicabilità del meccanismo di semplificazione anche ai procedimenti di competenza di Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali e la salute dei cittadini. Sul punto la formulazione letterale del c. 3 è chiara e non lascia spazio a dubbi interpretativi: le Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi sensibili beneficiano di un termine diverso (quello previsto dalla normativa di settore o, in mancanza, del termine di novanta giorni), scaduto il quale sono, tuttavia, sottoposte alla regola generale del silenzio assenso”[40].
Ed è proprio sulla base di indici ermeneutici in favore della tesi della natura co-decisoria del parere della Soprintendenza che il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, argomenta la condivisione di tale orientamento.
Oltre alle disposizioni già esaminate dell’art. 14 bis e dell’art. 17 bis, cit., anche la ratio e il dato letterale del novellato art. 2, c. 8 bis, l. n. 241/1990, pare sostenere questa tesi[41]. Infatti, si afferma che “le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 bis, c. 2, lett. c), 17 bis, c. 1 e 3, 20, c. 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’art. 14 ter, c. 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’art. 19, c. 3 e 6 bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.
Afferma il Consiglio di Stato che “la lettera di tale disposizione, riferendosi espressamente alle fattispecie del silenzio maturato nel corso di una conferenza di servizi, ex art. 14 bis e nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 17 bis, è inequivocabile nell’affermare il principio (che non ammette eccezioni) secondo cui le determinazioni tardive sono irrilevanti in quanto prive di effetti nei confronti dell’autorità competente, e non soltanto privi di carattere vincolante. Da ciò discende che non c’è più spazio, alla luce del novum normativo in disamina, per tentare la strada della sopravvivenza del c.d. silenzio-devolutivo, stante la formulazione volutamente onnicomprensiva della nuova norma. Come già ricordato, il testo della legge, specie quando formulata, come nel caso in esame, mediante la c.d. tecnica per fattispecie analitica, fornisce la misura della discrezionalità giudiziaria e costituisce un limite insuperabile rispetto a opzioni interpretative che ne disattendano ogni possibile risultato riconducibile al suo potenziale campo semantico (così come delimitato dalla disposizione), per giungere ad esiti con esso radicalmente incompatibili”.
Così come simili previsioni si ricavano anche dal d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), che, all’art. 11 (Semplificazioni procedimentali), c. 9, il quale prevede espressamente che “in caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal c. 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’art. 17 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”.
Tale disposizione è chiarissima nel qualificare il parere (semplificato) della Soprintendenza come atto co-decisorio ai sensi dell’art. 17 bis, cit., come ulteriormente ribadito dal Ministero dei Beni culturali con le circolari 10 novembre 2015, prot. n. 27158 e 20 luglio 2016, prot. N. 21892.
Fondamentale, secondo la sentenza in esame, nell’affermare la conformità a Costituzione dell’applicazione del silenzio assenso orizzontale al procedimento di autorizzazione paesaggistica, è la decisione della Corte cost., 22 luglio 2021, n. 160.
Questa sentenza, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, c. 6, della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), che aveva introdotto il silenzio-assenso c.d. verticale (ovvero nel rapporto con il privato) sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, formula delle argomentazioni a sostegno della compatibilità costituzionale dell’applicazione del silenzio assenso orizzontale agli interessi culturali paesaggistici.
Afferma, infatti, la Corte che il silenzio assenso previsto dalla norma regionale citata assume una valenza del tutto diversa rispetto a quanto disciplinato all’art. 11, c. 9, del d.P.R. n. 31 del 2017 (ovvero allo schema del silenzio assenso c.d. orizzontale). Non si tratta, infatti, sempre secondo la Corte, “di silenzio assenso endoprocedimentale, destinato a essere seguito da un provvedimento conclusivo espresso dell’Amministrazione procedente, ma di un silenzio assenso provvedimentale, destinato a sostituire l’autorizzazione paesaggistica richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 20, cit., (…); l’assenso del soprintendente sulla proposta di assenso ricevuta dall’Amministrazione procedente si forma per silentium, ma ciò non esonera quest’ultima dalla necessità di concludere il procedimento con una decisione espressa, come si desume, del resto, dall’ultima parte del citato c. 9 dell’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017, secondo cui l’Amministrazione procedente, una volta formatosi il silenzio assenso sul parere del soprintendente, «provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica». Ciò, in linea con il divieto stabilito all’art. 20, c. 4, cit., che esclude l’applicazione del silenzio assenso nei rapporti verticali tra privati e pubbliche amministrazioni preposte alla tutela dei cd. interessi sensibili, tra cui, per quanto qui rileva, quelli relativi agli atti e ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”.
Proprio muovendo dalla distinzione con il silenzio assenso orizzontale, la decisione della Corte censura la disposizione regionale sottoposta al suo esame, la quale, introducendo una surrettizia forma di silenzio assenso verticale, contrasta con il principio generale stabilito all’art. 20, c. 4, cit., che vieta la formazione per silentium del provvedimento conclusivo nei procedimenti ad oggetto la tutela di interessi sensibili.
4. Brevi considerazioni conclusive
L’orientamento che esclude l’applicazione del silenzio assenso verticale al parere da rendere, da parte della Soprintendenza, nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, contraddice anche la ratiodell’art. 17 bis, cit., intesa come funzionale a evitare che, ove il procedimento debba concludersi con l’adozione di una decisione pluristrutturata, la condotta inerte dell’Amministrazione interpellata possa produrre un blocco del procedimento, impedendo, così, l’adozione del provvedimento finale.
In tale quadro, l’istituto in esame si inserisce in un’evoluzione normativa che ha nel tempo reso più fluida l’azione amministrativa, tentando di neutralizzare gli effetti negativi dell’inerzia dell’Amministrazione, in un primo momento nei rapporti con i privati e, in seguito, anche nei rapporti tra Amministrazioni.
Il nuovo strumento di semplificazione conferma, pertanto, la natura per così dire patologica che caratterizza il silenzio dell’Amministrazione, soprattutto nell’ambito di un rapporto orizzontale con un’altra Amministrazione co-decidente.
L’istituto del silenzio-assenso orizzontale è la prova della contrarietà del legislatore nei confronti dell’inerzia amministrativa, inerzia che viene stigmatizzata al punto tale da ricollegare al silenzio dell’Amministrazione interpellata la più grave delle “sanzioni” o il più efficace dei “rimedi”, ossia l’equiparazione del silenzio all’assenso con conseguente perdita del potere di dissentire e di impedire la conclusione del procedimento.
Queste esigenze non sono circoscrivibili alla specifica natura del procedimento di volta in volta preso in esame, imponendosi in via generalizzata, pur le eccezioni previste dall’art. 17 bis, c. 4, l. n. 241/1990) per ogni forma di esercizio del pubblico potere, amministrativo o normativo, qualora il provvedimento finale presupponga una fase di co-decisione di competenza di un’altra Amministrazione.
A tal proposito, sono rilevanti le argomentazioni del citato parere del Consiglio di Stato nel quale si afferma che “il Consiglio di Stato ritiene si possa parlare di un ‘nuovo paradigma’: in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione pluristrutturata nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione, il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis ad un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo. Il silenzio assenso orizzontale, previsto dall’art. 17 bis, opera, nei rapporti tra Amministrazioni co-decidenti, quale che sia la natura del provvedimento finale che conclude il procedimento, non potendosi sotto tale profilo accogliere la tesi che, prospettando un parallelismo con l’ambito applicativo dell’art. 20 concernente il silenzio assenso nei rapporti tra privati, circoscrive l’operatività del nuovo istituto agli atti che appartengono alla categoria dell’autorizzazione, ovvero che rimuovono un limite all’esercizio di un preesistente diritto. La nuova disposizione, al contrario, si applica a ogni procedimento (anche eventualmente a impulso d’ufficio) che preveda al suo interno una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione, senza che rilevi la natura del provvedimento finale nei rapporti verticali con il privato destinatario degli effetti dello stesso”.
Le medesime conclusioni si impongono in riferimento all’art. 14 bis, cit., così come modificato con il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), che presenta un analogo meccanismo semplificatorio.
In definitiva, il quadro normativo è chiaro e lo è anche la ratio sottesa agli artt. 14 bis e 17 bis, anche in riferimento alle autorizzazioni paesaggistiche, come ben argomentato dal parere del Consiglio di Stato, comm. spec., n. 1640/2016, cit., al quale la sentenza in esame aderisce. Tuttavia, provando ad andare oltre il quadro sistematico normativo e la sua inequivocabile interpretazione letterale e preso atto di un orientamento giurisprudenziale maggioritario nell’applicazione di tale quadro normativo anche alla tutela degli interessi cd. sensibili, si potrebbe concludere sostenendo che, se il silenzio assenso orizzontale è la “cura” e l’inerzia della Pubblica Amministrazione e il dirigismo burocratico sono la “malattia” del sistema, bisognerebbe approfondire se, in materia di tutela del patrimonio culturale-paesaggistico, la cura individuata in sede politica-legislativa non sia peggiore della malattia[42].
[1] Per un inquadramento generale della materia, si rinvia al Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, Milano, 2019, 1161 ss.; P. Marzaro, La “cura” ovvero “l’Amministrazione del paesaggio”: livelli, poteri e rapporti tra Enti nella riforma del 2008 del Codice Urbani (dalla concorrenza dei poteri alla paralisi dei poteri?), in Riv. Giur. Urb., 2008, 4, 416 ss.; G. Mastronardo, Valore del paesaggio, in A. Angiuli, V. Caputi Jambrenghi (a cura di), Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, 2005, 344 ss..
[2] Si rinvia a Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2022, n. 255, in www.giustizia-amministrativa.it.
[3] Sul tema, v. S. Caggegi, Funzione del parere di compatibilità paesaggistica e sindacabilità degli atti finalizzati alla tutela ambientale. Nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836, in www.giustiziainsieme.it; G. Delle Cave, «In interpretatione non fit claritas»: sulla duplice (anzi triplice) esegesi pretoria in materia di silenzio assenso ex art. 17 bis l. n. 241/1990 e parere paesaggistico soprintendizio, ivi; Id., Autorizzazione paesaggistica e silenzio assenso tra P.A.: un connubio (im)possibile? competenze procedimentali e portata applicativa dell’art. 17 bis l. n. 241/1990; ivi; S. Speranza, Silenzio assenso tra P.A. e autorizzazione paesaggistica. Le prospettive del Consiglio di Stato (nota a Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 4098 del 24 maggio 2022); ivi; F. D’Angelo, Note in tema di «concerto», «parere vincolante» e «cogestione» di funzioni amministrative, ivi.
[4] Ai sensi dell’art. 47, d.lgs. n. 85/2005, Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni.
[5] In questi termini, L. De Lucia, La conferenza di servizi nel d.lgs. 30 giugno 2016 n. 127, cin Riv. Giur. Urb., 201621. Contra, S. Battini, La trasformazione della conferenza di servizi e il sogno di Chuange-Tzu, in S. Battini (a cura di), La nuova conferenza di servizi, Roma, 2016, rileva che “la conferenza semplificata risponde allo scopo di distinguere, secondo il principio di adeguatezza, tipi di conferenze diversi per categorie di decisioni differenti. Per le decisioni più semplici, la conferenza con riunione può rappresentare perfino una soluzione di complicazione, mentre può risultare utile come strumento che della conferenza di servizi tradizionale presenta alcuni tratti, come le istruttorie parallele e il dialogo telematico, ma non la riunione contestuale”.
[6] Il criterio strettamente quantitativo è stato sostenuto da P. Marzaro, Il coordinamento orizzontale tra amministrazioni, in Riv. Giur. Urb.., 2016, 25. Contra, L. De Lucia, La conferenza di servizi nel d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, cit., 21, il quale considera tale distinzione fondarsi “su un labilissimo dato testuale”. Si veda, altresì, il parere del Cons. Stato, Comm. Spec., n. 890/2016, con il quale s’invita il governo a chiarire il rapporto tra la conferenza di servizi e l’art. 17 bis, cit., “il quale risulta a propria volta finalizzato ad acquisire secondo una particolare modalità ulteriormente semplificata per silentium i medesimi atti di assenso”.
[7] In questi termini, L. De Lucia, La conferenza di servizi, cit., 22. Cfr., altresì, P. Marzaro, Silenzio assenso tra amministrazioni, in www.federalismi.it, 28, in cui si afferma che “il coordinamento orizzontale tra amministrazioni si muoverà, dunque, lungo una linea che va dalla decisione pluristrutturata più semplice a quella più complessa; dall’art. 17 bis, quando il provvedimento richiede l’acquisizione di un solo atto di consenso, e dunque vi sia una sola amministrazione co-decidente, all’art. 14, quando sia coinvolta una pluralità di amministrazioni, accanto a quella procedente”. S. Battini, La trasformazione della conferenza di servizi, cit., 21, osserva che “la disciplina della conferenza semplificata assorbe e persino sopravanza quella del silenzio assenso fra amministrazioni, introdotto dall’art. 3 della stessa l. n. 124/2015: i due istituti sono sovrapponibili e si coordinano nel senso che l’uno si applica in casi di decisione pluristrutturata con due amministrazioni, l’altro nei casi di decisioni pluristrutturate complesse, che coinvolgono un numero più elevato di amministrazioni”.
[8] Sulla necessità di considerare anche le intese tra gli atti di assenso comunque denominati e acquisibili sia con la conferenza di servizi, sia con il silenzio assenso, v. F. Scalia, Prospettive e profili problematici della nuova conferenza di servizi, cit., 634, il quale osserva che “non si vedono difficoltà nel comprendere anche le intese tra gli assensi comunque denominati acquisibili con entrambi gli strumenti. Se il silenzio amministrativo è, al pari della conferenza di servizi, uno strumento di coordinamento orizzontale tra amministrazioni codecidenti, esso deve poter operare anche nei rapporti tra Stato e regione e anche quando la norma imponga l’acquisizione dell’intesa di quest’ultima. Ciò salvo che la norma stessa preveda l’unanimità dei consensi (è il caso, ad esempio, dell’accordo di programma disciplinato dall’art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ipotesi in cui l’intesa non è acquisibile tacitamente neanche in sede di conferenza di servizi”.
Contra, L. De Lucia, La conferenza di servizi, cit., 21, il quale rileva che per evidenti ragioni costituzionali, l’art. 17 bis non menzioni le intese. Ancora, F. Scalia, Prospettive e profili problematici della nuova conferenza di servizi, Riv. Giur. Edil., 2016, 6, II, 634, rileva che “non paiono condivisibili i rilievi di una possibile illegittimità costituzionale della norma per la sua applicabilità anche a materie di competenza regionale. Invero, a tacer del fatto che tale profilo non è stato colto dalle stesse Regioni, che non hanno impugnato la norma dinanzi alla Corte costituzionale, la legittimità dell’estensione del suo ambito di applicazione alle Regioni ed enti locali è garantita dall’art. 117, c. 2, lett. m), Cost., che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. L’art. 29, c. 2 ter, della l. n. 241/1990 riferisce ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, c. 2, lett. m) Cost. le disposizioni della legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso. Il generico richiamo al silenzio assenso non è da ritenersi riferito al solo istituto operante su istanza del privato e disciplinato dall’art. 20 della legge, quanto anche al nuovo istituto operante tra amministrazioni, e ciò sia per il dato letterale (la norma non distingue le due ipotesi oggi disciplinate, sia per il profilo logico-sistematico, essendo entrambi gli istituti informati ai medesimi obiettivi di semplificazione ed accelerazione”.
Di avviso diverso, E. Scotti, Il silenzio assenso tra amministrazioni, in Alb. Romano, a cura di, L’azione amministrativa, Torino, 2017, 570, la quale rileva “nell’estensione dell’applicazione del nuovo istituto alle amministrazioni regionali e locali un profilo di illegittimità costituzionale, in quanto si determinerebbe così una disciplina generale delle decisioni complesse che supera lo stesso autolimite posto dall’art. 29, c. 1, all’ambito della disciplina della l. n. 241/1990 e che vorrebbe applicarsi universalmente, a prescindere dall’amministrazione coinvolta e a prescindere dalla materia (e dunque, dalla competenza legislativa, statale o regionale coinvolta)”. P. Marzaro, Silenzio assenso tra amministrazioni, cit., 13, individua il fondamento costituzionale dell’art. 17 bis non tanto nell’art. 117, c. 2, lett. m) Cost., tramite l’art. 29, c. 2 ter, ma piuttosto “direttamente nella giurisprudenza costituzionale in materia di semplificazione, da cui si possono trarre innumerevoli segni circa l’applicabilità dei regimi di semplificazione alla generalità delle amministrazioni pubbliche in quanto attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lett. m) dell’art. 117, c. 2, Cost.”.
[9] Ai sensi dell’art. 14 bis, c. 3, cit., “entro il termine di cui al c. 2, lett. c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico”.
Cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 22 gennaio 2019, n. 38, in Foro amm., 2019, 1, 186, in cui si afferma che “l’espressione — attraverso la relazione dell’’autorità (regionale o, in subdelega, comunale) chiamata ex art. 146, c. 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 alla cogestione della tutela paesaggistica delle aree soggetta a tutela — di un motivato parere negativo, in ordine alla possibilità del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, implica l’impossibilità di qualificare come silenzio assenso la mancata partecipazione del Ministero alla conferenza di servizi convocata per definire la domanda autorizzatoria”.
[10] In questi termini, v. G. Sciullo, Legge Madia e amministrazione del patrimonio culturale: una prima lettura, in Aedon, 2015, 3, che richiama G. Falcon, Lezioni di diritto amministrativo, Padova, 2013, 112.
[11] Sul punto, F. Merusi, Metamorfosi dell’intervento pubblico nell’economia. Dall’autorizzazione alla riserva di provvedimento inibitorio, in Dir. amm., 2015, 579 ss., afferma che “il silenzio assenso s’ispira a una logica di semplificazione della macchina amministrativa, ma la sua applicazione, secondo gli intenti del legislatore, serve a muover l’economia”.
[12] Sul tema, si è espresso subito, in modo critico, sull’art. 17 bis, cit., F. de Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale, in www.federalismi.it, 2015, sostenendo che sarebbe in atto “una vera e propria fuga in avanti in quella che si potrebbe definire la guerra di logoramento degli interessi sensibili che vengono sempre parificati a quelli ordinari”.
Contra, G. Vesperini, Le norme generali sulla semplificazione, in La riforma della pubblica amministrazione, in Gior. dir. amm., 2015, 5, 629 ss., definisce la semplificazione come uno dei princìpi chiave della Riforma Madia e ‘la riduzione del regime speciale riservato ai cd. interessi sensibili’ momento fondamentale attraverso il quale si realizza tale principio.
Sulle difficoltà di contemperamento tra la disciplina del silenzio assenso previsto dall’art. 17 bis e quello previsto dall’art. 20, l. n. 241/1990, si vedano anche le osservazioni di F. de Leonardis, Il silenzio-assenso in materia ambientale, cit., 4 ss.; P. Marzaro, Certezze e incertezze, in www.giustamm.it, 7 ss. e F. Scalia, Il silenzio assenso, cit., 15.
Il problema delle incongruenze nell’individuazione degli interessi sottoposti a una disciplina differenziata, rispettivamente, nell’art. 17 bis e nell’art. 20 cit. è evidenziato da M.A. Sandulli, Gli effetti diretti, della l. 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche, in www.federalismi.it, 2015, 5.
Allo stesso tempo, F. Scalia, Il silenzio assenso, cit., osserva che “la norma non introduce nulla di nuovo quanto al profilo dell’intensità della tutela degli interessi sensibili e anzi, letta insieme alla norma di delega legislativa in materia di silenzio assenso, contenuta nella stessa l. n. 124/2015, art. 5, può rappresentare l’occasione per ricondurre in ambito di coerenza costituzionale la normativa già vigente in tema di silenzio in materia ambientale”. L’art. 5, l. n. 124/2015, ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi “uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli artt. 19 e 20 della l. n. 241/1990”. L’A., inoltre, sottolinea che “l’esame della disciplina della conferenza di servizi consente di affermare che almeno dal 2010 il meccanismo del silenzio assenso opera nel nostro ordinamento come strumento di acquisizione di atti di assenso anche nelle materie sensibili. Il d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, è intervenuto sugli artt. 14 ter e 14 quater della l. n. 241/1990, recanti rispettivamente la disciplina dei lavori della conferenza di servizi e gli effetti dei dissensi espressi in seno alla stessa. All’esito di tale intervento l’art. 14 ter prevede che ‘si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata’. Tale innovazione, quindi, estende l’ipotesi di silenzio assenso, prevista dal testo originario del c. 7, alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili, le quali potranno esprime il loro dissenso solo in conferenza, pena altrimenti il considerarsi acquisito il relativo atto di assenso”.
Un rimedio analogo è previsto anche da altre norme di settore. Ad esempio nei procedimenti affidati allo Sportello unico attività produttive si prescinde dall’applicazione del silenzio assenso disponendo che “in caso di mancato ricorso per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l’amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell’avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”. Art. 38, c. 3, lett. h), d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, art. 1, c. 1, a cui fa riferimento l’art. 7, c. 3, d.p.r. n. 160/2010.
[13] M. Bombardelli, Il silenzio assenso tra amministrazioni, in Urb. e app., 2016, 765, rileva che “le disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni non vanno direttamente a modificare la disciplina d’istituti già esistenti. Tuttavia, esse alimentano l’instabilità del quadro normativo perché calano in un contesto già fortemente strutturato - quello appunto degli strumenti di semplificazione di cui al Capo IV, l. n. 241/1990 - delle opzioni interpretative non pienamente coerenti, che creano incertezza per le amministrazioni chiamate ad applicarle e per alcuni aspetti introducono anche dei vincoli contrastanti con la disciplina di altri strumenti di semplificazione”.
Il problema della collocazione dell’art. 17 bis, cit., in un sistema normativo complesso è stato affrontato da P. Marzaro, Coordinamento tra Amministrazioni, cit., 6 ss., con riferimento alle difficoltà di coordinamento tra le previsioni in materia di silenzio assenso di cui all’art. 17 bis, cit., e le regole settoriali come quelle previste nel Testo Unico dell’edilizia, nella disciplina dello Sportello unico per le attività produttive o nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui art. 146, d.lgs. n. 42/2004.
[14] C. Vitale, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni: il parere del Consiglio di Stato, in Gior. dir. amm., 2017, 1, 95.
[15] Sul tema, v. M.A. Sandulli, Gli effetti della 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio assenso e autotutela, cit..
[16] Cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 7 giugno 2019, n. 3099, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui si afferma che “a seguito dell’introduzione della disciplina contenuta nell’art. 17 bis, cit. , viene in rilievo un’ipotesi di silenzio assenso orizzontale tra amministrazioni, connesso al decorso dello speciale termine di novanta giorni, da ritenersi applicabile alla fattispecie in quanto riferita (anche) alle autorizzazioni paesaggistiche - procedimento caratterizzato da una fase decisoria pluristrutturata, subordinata ad acquisire un parere vincolante”.
[17] Il buon andamento è un principio costituzionale “cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale” (Corte. cost. 9 dicembre 1968, n. 123, in www.giurcost.org), consacrato dall’art. 97, c. 2, Cost., che “coincide con l’esigenza dell’ottimale funzionamento della pubblica amministrazione, tanto sul piano dell’organizzazione quanto su quello della sua attività” (V. Cerulli Irelli, Lineamenti di diritto amministrativo, Torino, 2023, 163). Il buon andamento si traduce nell’esigenza di un’amministrazione che sia efficace, efficiente ed economica, criteri enunciati dall’art. 1, l. n. 241/1990, e che costituiscono parametri giuridici dell’attività e dell’organizzazione amministrativa (E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, 2023, 56 s.; G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2020, 158; M.R. Spasiano, I princìpi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2019, 117 ss.). L’efficacia esprime il rapporto tra obiettivi programmati e obiettivi/risultati raggiunti; l’efficienza indica il rapporto tra risultati/obiettivi raggiunti e risorse impiegate per raggiungerli; infine, l’economicità implica l’ottimale impiego di risorse (di persone e mezzi) da acquisire per il perseguimento dell’interesse pubblico.
Per una disamina sul tema, cfr. A. Andreani, Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, Padova, 1979; A. Police, Principi generali dell’azione amministrativa, in M.R. Spasiano, D. Corletto, M. Gola, D.U. Galetta, A. Police, C. Cacciavillani (a cura di), La pubblica amministrazione e il suo diritto, Milano, 2012, 73 ss.; R. Caridà, Princìpi costituzionali e pubblica amministrazione, 2014, in www.giurcost.org; M.R. Spasiano, Il principio di buon andamento, in M.A. Sandulli (a cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, Milano, 2023, 47.
[18] Ad una prima lettura dell’art. 17 bis, cit., si è percepito che il nuovo silenzio assenso fosse un istituto per superare il costante veto delle Sovrintendenze.
Sul tema annoso, cfr. P. Marzaro, Autorizzazioni paesaggistiche: sta per tramontare il veto della sovrintendenza, in Edilizia e territorio, 2009, 10 ss.; Id., L’amministrazione del paesaggio. Profili critici ricostruttivi di un sistema complesso, Torino, 2009, passim.
[19] Sul punto, v. Corte cost. 9 maggio 2014, n. 121, in Giur. cost., 2014, 2118.
[20] Sul diritto alla buona amministrazione e le sue declinazioni, v. C. Celone, Il diritto alla buona amministrazione tra ordinamento europeo e italiano, in Il diritto dell’economia, 2016, 3, 669 ss., e dottrina e giurisprudenza ivi citata; A. Police, Princìpi e azione amministrativa, in F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2022, 214; F. Manganaro, Trasparenza e obblighi di pubblicazione, in Nuove Autonomie, 2014, 3, 561; F. Merloni, La trasparenza come strumento di lotta alla corruzione tra legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 33 del 2013, in B. Ponti (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Rimini, 2013, 17-18; M. Immordino, Strumenti di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione tra ordinamento italiano e brasiliano. Relazione introduttiva, in Nuove Autonomie, 2014, 3, 395 ss.; A. Contieri, Trasparenza e accesso civico, ivi, 569, 576; A. Zito, Il ‘diritto ad una buona amministrazione’ nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nell’ordinamento interno, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2002, 431.
Cfr., inoltre, M.R. Spasiano, Riflessioni in tema di trasparenza anche alla luce del diritto di accesso civico, in Nuove Autonomie, 2015, 1, 65 ss., il quale osserva come la trasparenza amministrativa imponga scelte precise a livello organizzativo e funzionale, ma ancora prima a carattere culturale, che presuppongono, tra l’altro, la loro comprensibilità, la predisposizione di forme di partecipazione a monte delle stesse, la chiarezza, la qualità e la semplicità dell’informazione, la certezza dei tempi, l’effettivo esercizio delle funzioni amministrative con l’abbandono delle diverse forme di silenzio (73-74). La valorizzazione del modello partecipativo differenzia, tra l’altro, secondo l’A., l’accezione di trasparenza che emerge dall’art. 1 del d.lgs. n. 33/2013, prima citato, da quella che si ricava dall’art. 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), poiché la norma europea prospetta un principio fondato più sulla partecipazione che sull’accessibilità, in quanto imperniato sul dialogo e sulla consultazione preventiva, da parte degli organi dell’Unione, delle associazioni rappresentative e della società civile (64). L’esigenza di sviluppare la dimensione partecipativa della trasparenza viene tuttavia avvertita anche dal legislatore italiano, che, nel 2016, con la modifica all’art. 1, c. 1, del predetto decreto, ha voluto precisare come la trasparenza serva anche a promuovere la partecipazione dei soggetti interessati all’attività amministrativa.
Il principio di imparzialità è uno dei princìpi che presiedono l’attività amministrativa, art. 1, cit.. Il principio in parola trova fondamento costituzionale nell’art. 97, c. 2, Cost. ed è richiamato dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE e consiste nel divieto, rivolto alle amministrazioni di operare discriminazioni e favoritismi durante l’esercizio della loro attività. Il principio d’imparzialità è, pertanto, posto a garanzia della parità di trattamento e dell’eguaglianza dei cittadini di fronte all’amministrazione, in ossequio al generale principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost..
Per un approfondimento, per tutti si rinvia a M.R. Spasiano, Princìpi generali dell’attività amministrativa, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., 117 ss., e dottrina e giurisprudenza ivi indicata.
[21] M.A. Sandulli, Conclusioni di un dibattito sul principio della certezza delle regole, in F. Francario, M.A. Sandulli (a cura di), Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica, Napoli, 2018, 305, osserva che “l’incertezza del diritto amministrativo e, a maggior ragione, nel diritto processuale amministrativo, è sempre molto grave perché lede il diritto alla buona amministrazione”.
[22] L’art. 146, d.lgs. n. 146/2004 dispone che sull’istanza di autorizzazione paesaggistica è competente la regione, dopo aver acquisito, su una proposta di provvedimento, il parere vincolante del soprintendente ai sensi del c. 5. Quest’ultimo deve pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento progettato entro 45 giorni, c. 8. Il c. 9 dell’art. 146, così come modificato dall’art. 25, d.l. n. 133/2014, cd. Sblocca Italia, dispone che “in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione”. Non si tratta di ipotesi di silenzio assenso, ma di silenzio devolutivo, in quanto la norma riconduce al decorso del termine, non il formarsi di un assenso tacito, ma l’onere per l’amministrazione procedente di provvedere pur senza il parere vincolante che il soprintendente non ha reso nei termini. Si pone così un problema di compatibilità tra questa disposizione, l’art. 16 e l’art. 17 bis, cit. Quello previsto dall’art. 146 è da considerarsi un parere vincolante e come tale escluso dall’applicazione dell’art. 16 e da ricomprendere, invece, tra gli assensi comunque denominati di cui all’art. 17 bis, cit..
Sul tema, V. Parisio, L’attività consultiva, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, cit., 708, osserva che “ricomprendere i pareri vincolanti nella sfera di operatività dell’art. 16 condurrebbe ad un’insanabile contraddizione logica, in quanto un parere definito dalla legge come vincolante finirebbe di fatto con perdere tale sua qualificazione se si riconoscesse all’amministrazione attiva la possibilità di prescinderne”. Inoltre, v. M.S. Giannini, Diritti amministrativo, II, Milano, 1988, 565, in cui si afferma che “i pareri vincolanti non sono pareri, ma atti di decisione”.
Critico sull’applicazione del silenzio assenso in materia di beni culturali, P. Carpentieri, Beni culturali. Semplificazione e tutela del patrimonio culturale, in Libro dell’anno del diritto, Roma, 2012, il quale afferma che “il silenzio assenso postula la dispensabilità del controllo e la disponibilità dei beni interessi coinvolti, mentre la tutela è lo spazio dell’indispensabilità e della indisponibilità. La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che per il profilo paesaggistico opera il principio fondamentale risultante da una serie di norme in materia ambientale, della necessità della pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell’amministrazione preposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso”.
[23] Sul d.lgs. n. 42/2004, cd. Codice dei beni culturali e del paesaggio, con particolare riferimento all’art. 146, v. M.R. Spasiano, Commento all’art. 146, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2019, 1321, il quale condivisibilmente osserva che “l’ambito di applicazione e i notevoli benefici in termini di celerità e semplificazione della procedura sono senza dubbio da salutare positivamente, nella misura in cui rappresentano l’esito di un corretto bilanciamento tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, in una prospettiva di razionalizzazione della disciplina paesaggistica, lontana da approcci assolutizzanti”.
Cfr., inoltre, sulla semplificazione in tema di patrimonio culturale, M. Sinisi, L’autorizzazione paesaggistica tra liberalizzazione e semplificazione (D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31): la ‘questione aperta’ del rapporto tra semplificazione amministrativa e tutela del paesaggio, in Riv. giur. edil., 2017, 4, 235 ss.; S. Amorosino, Il nuovo regolamento di liberalizzazione e di semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche (d.P.R. n. 31 del 2017), in Riv. giur. urb., 2017, 174 ss.; P. Marzaro, Autorizzazione paesaggistica semplificata e procedimenti connessi, ivi, 2017, 220 ss.; G. Mari, La rilevanza della disciplina del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche nei procedimenti relativi a titoli abilitativi edilizi: il ruolo dello sportello unico dell’edilizia: considerazioni a margine di una recente Circolare del MIBACT, in Riv. giur. edil. 2016, 61 ss.; E. Zampetti, La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica tra esigenze di semplificazione e garanzie costituzionali, in Nuove autonomie, 2014, 316.
In giurisprudenza, sull’applicazione del silenzio assenso all’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, v. TAR Sardegna, Sez. II, 8 giugno 2017, n. 394, in Rivi. giur. edil., 2017, 3, 759, nota di A. Del Prete, Il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni: profili critici e problematici, ivi, 2018, 3, I, 705.
Il TAR Sardegna afferma che “dal momento che il nuovo silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 17 bis, l. n. 241/1990, si applica anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi concreti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche il pare vincolante riservato alla soprintendenza dal c. 5 dell’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004, s’intende formato per silentium, decorso il termine di 90 giorni dalla ricezione della relazione tecnica istruttoria predisposta dalla regione contenente una proposta di provvedimento”.
In termini simili, cfr. TAR Abruzzo, 10 maggio 2018, n. 153, in www.giustizia-amministrativa.it.
[24] Sul punto, v. Corte cost., 27 giugno 2012, n. 164, in Giur. cost., 2012, 2233, in cui si afferma che “l’art. 117, c. 2, lett. m), Cost., permette una restrizione dell’autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (…). Inoltre, l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di ‘prestazione’ della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati”.
[25] Sul punto, v. Corte cost. 20 luglio 2012, n. 203, in Giur. cost., 2012, 2966; Id., 24 luglio 2012, n. 207, ivi, 2012, 3017.
[26] La Commissione speciale citata osserva “il termine di 30 giorni per rendere o ricevere l’assenso da parte delle autorità amministrative indipendenti ed il silenzio assenso non trovano applicazione esclusivamente quando una norma speciale preveda un diverso meccanismo di coordinamento o una disciplina incompatibile con il silenzio significativo, in base al principio di specialità”. Il riferimento è, ad esempio, all’art. 5, c. 5 bis, d.lgs. n. 58/1998, che esclude l’applicazione del silenzio assenso nei rapporti tra la Banca d’Italia e la Consob.
[27] La Commissione speciale del Consiglio di Stato si è spinta oltre includendo nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 17 bis, cit., anche le società in house quando siano titolari di procedimenti amministrativi, data “l’assenza di un rapporto di alterità soggettiva con l’ente pubblico di riferimento”.
[28] V. Parisio, Interessi ‘forti’ e interessi ‘deboli’: la natura degli interessi come limite alla semplificazione del procedimento amministrativo nella legge 7 agosto 1990 n. 241, in Dir. e proc. amm., 2014, 4, 839. Di semplificazioni ‘prudenti’ parla M. Renna, Le semplificazioni amministrative (nel decreto legislativo n. 152 del 2006), in Riv. giur. amb., 2009, 5, 649.
[29] M.A. Sandulli, Gli effetti della 7 agosto 2015 l. n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio assenso e autotutela, cit., afferma che “nonostante la carenza fosse stata espressamente rimarcata in sede di audizione, la medesima deroga temporale non è prevista per gli assensi delle amministrazioni preposte alla difesa e alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza. Dal momento che si tratta d’interessi sicuramente non meno rilevanti di quelli considerati dal c. 3, è da ritenere che l’omissione non sia voluta ed è auspicabile che la disposizione sia sollecitamente integrata”.
[30] A sostegno della conclusione per cui le disposizioni di cui agli artt. 14 bis e 17 bis sono animate da un’analoga ragione giustificatrice, merita di essere richiamata la decisione della Corte cost. n. 246/2018 nella quale è stato chiarito che l’art. 17 bis, sebbene collocato al di fuori degli articoli espressamente dedicati alla conferenza di servizi (artt. 14-14-quinquies), trova applicazione anche nel caso in cui occorra convocare la conferenza di servizi in quanto «il silenzio assenso di cui all’art. 17 bis opera sempre (anche nel caso in cui siano previsti assensi di più amministrazioni) e, se si forma, previene la necessità di convocare la conferenza di servizi.
[31] Per un inquadramento generale del tema, cfr. R. Leonardi, La tutela dell’interesse ambientale tra procedimenti, dissensi e silenzi, Torino, 2020; M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della l. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a. silenzio assenso e autotutela, in federalismi.it, 2015, 17 ss.; P. Marzaro, Silenzio assenso tra Amministrazioni: dimensioni e contenuti di una nuova figura di coordinamento orizzontale all'interno della nuova amministrazione disegnato dal Consiglio di Stato, in federalismi.it, 2016; Id., Il coordinamento orizzontale tra amministrazioni: l'art. 17 bis della l. n. 241 del 1990 dopo l'intervento del Consiglio di Stato. Rilevanza dell'istituto nella gestione dell'interesse paesaggistico e rapporti con la conferenza di servizi, in Riv. giur. urb., 2016, 2, 10 ss.; G. Mari, Autorizzazioni preliminari e titoli abilitativi edilizi: il ruolo dello sportello unico dell'edilizi, la conferenza di servizi e il silenzio assenso id cui agli artt. 17-bis e 20 l. n. 241/1990, in Aa.Vv., Semplificazione e trasparenza amministrativa: esperienze italiane ed europee a confronto, atti dei convegni Strategie di contrasto alla corruzione: l. 06/11/2012 n. 190 e s.m.i. e Titoli abilitativi edilizi, Sblocca Italia e Decreti del Fare, Napoli, 2016, 39 ss.; A. Police, Il dovere di concludere il procedimento e il silenzio inadempimento, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell'azione amministrativa, Milano, cit.
[32] Si veda per questo profilo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167 – secondo cui “Negli ordinamenti democratici e pluralisti si richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Così come per i “diritti” (sentenza della Corte cost. n. 85 del 2013), anche per gli “interessi” di rango costituzionale (vieppiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) va ribadito che a nessuno di essi la Costituzione garantisce una prevalenza assoluta sugli altri. La loro tutela deve essere “sistemica” e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca. La primarietà di valori come la tutela del patrimonio culturale o dell’ambiente implica che gli stessi non possano essere interamente sacrificati al cospetto di altri interessi (ancorché costituzionalmente tutelati) e che di essi si tenga necessariamente conto nei complessi processi decisionali pubblici, ma non ne legittima una concezione “totalizzante” come fossero posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato - dal legislatore nella statuizione delle norme, dall’Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo - secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza”.
[33] Consiglio di Stato, Sez. I, 28 giugno 2021, n. 1114, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui qualora “sia trascorso inutilmente il termine, l'organo statale non è privato del potere di esprimersi, ma il parere in tal modo dato perde il proprio carattere di vincolatività. In ordine all’efficacia eventualmente da riconoscere a un parere negativo da parte della Soprintendenza, reso successivamente al decorso del termine di quarantacinque giorni, si possono infatti dare tre possibili esiti: a) la consumazione del potere per l'organo statale di rendere un qualunque parere (di carattere vincolante o meno)…; b) la permanenza in capo alla Soprintendenza del potere di emanare un parere di carattere comunque vincolante (dovendosi in particolare riconoscere carattere meramente ordinatorio al richiamato termine); c) la possibilità per l'organo statale di rendere comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, privo di effetti vincolanti ma autonomamente valutabile dall'amministrazione titolare dell'adozione dell'atto autorizzatorio finale” (nello stesso senso Id., parere 25 gennaio 2021, n. 103”
[34] Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4765; Id., 29 marzo 2021, n. 2640; Id., 7 aprile 2022, n. 2584, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
[35] Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2640, cit..
[36] A. Berlucchi, Il parere tardivo espresso dalla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004: spunti di riflessione, in Riv. giur. ed., 2017, 1, 130 ss.
[37] La soluzione preferita dal Collegio trova conferma anche in ulteriori precedenti del Consiglio di Stato: Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 2022, n. 255; Id., Sez. IV, 14 luglio 2020, n. 4559; Id., Sez. VI, 1° ottobre 2019, n. 6556, tutte in www.giusitizia-amministrativa.it.
[38] A sostegno di questa conclusione, il Collegio ricorda che una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che aveva già in passato chiarito la natura co-decisoria del parere vincolante. V. Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4843; 15 maggio 2017, n. 2262, 17 marzo 2020, n. 1903; 16 giugno 2020, n. 3885; 5 ottobre 2020, n. 5831; 18 marzo 2021, n. 2358; 27 maggio 2021, n. 4096; Sez. IV, 19 aprile 2021, n. 3145, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
[39] Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 aprile 2021, n. 3145; Id., sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4843; Id., 18 marzo 2021, n. 2358; Id., 19 marzo 2021 n. 2390, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.
[40] Si legge nella sentenza in esame che “il testo della legge, specie quando formulata, come nel caso in esame, mediante la c.d. tecnica per fattispecie analitica, fornisce la misura della discrezionalità giudiziaria; esso, come è stato autorevolmente osservato, rappresenta il punto fermo da cui occorre muovere nell’attività interpretativa e a cui, (all’esito del combinato ricorso a tutti gli altri canoni di interpretazione) è necessario ritornare. Ne consegue che il testo della legge costituisce, almeno nei casi come quello in esame, un limite insuperabile rispetto ad opzioni interpretative che ne disattendano ogni possibile risultato riconducibile al suo potenziale campo semantico (così come delimitato dalla disposizione), per giungere ad esiti con esso radicalmente incompatibili. Tali considerazioni trovano pedissequo riscontro nella giurisprudenza delle Corti superiori interne e internazionali.
Nella medesima direzione è, in primo luogo, orientata la giurisprudenza costituzionale che ha individuato nell’univoco tenore letterale della norma un limite all’interpretazione costituzionalmente conforme (Cort. cost 26 febbraio 2020, n. 32). A non dissimili conclusioni giunge anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea, la quale ha ricordato in proposito che, nell’applicare il diritto nazionale (in particolare le disposizioni di una normativa appositamente adottata al fine di attuare quanto prescritto da una direttiva) il giudice nazionale deve interpretare tale diritto per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva. Tuttavia l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (Corte di giustizia, Grande Sezione, 15 aprile 2008,C-268/06,v. sentenze 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969, punto 13, nonché Adeneler e a., cit., punto 110; v. anche, per analogia, sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, Racc. pag. I-5285, punti 44 e 47). Analoghe e, sotto certi profili ancora più stringenti considerazioni (in quanto relative anche alla interpretazione delle c.d. clausole generali), si rivengono nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella quale si legge che “anche quando non si trova al cospetto di un enunciato normativo concepito come regola a fattispecie, ma è investito del compito di concretizzare la portata di una clausola generale… il giudice non detta né introduce una nuova previsione normativa. La valutazione in sede interpretativa non può spingersi sino alla elaborazione di una norma nuova con l'assunzione di un ruolo sostitutivo del legislatore. La giurisprudenza non è fonte del diritto. Il giudice comune, nel ruolo – costituzionalmente diverso da quello del legislatore – di organo chiamato non a produrre un quid novi sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere generale, ma a individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi normativi e dal sistema. Una pluralità di ragioni giustifica l'indicato approccio metodologico. Il rispetto del pluralismo e dell'equilibrio tra i poteri, profilo centrale della democrazia, perché la ricerca dell'effettività deve seguire precise strade compatibili con il principio di leale collaborazione e con il dialogo istituzionale che la Corte costituzionale ha avviato con il legislatore…. Non c'è spazio, in altri termini, né per una penetrazione diretta - attraverso la ricerca di un bilanciamento diverso da quello già operato dal Giudice delle leggi - di quell'ambito di discrezionalità legislativa che la Corte costituzionale ha inteso far salvo, né per una messa in discussione del punto di equilibrio da essa indicato. La riserva espressa della competenza del legislatore si riferisce, evidentemente, al piano della normazione primaria, al livello cioè delle fonti del diritto: come tale, essa non estromette il giudice comune, nel ruolo - costituzionalmente diverso da quello affidato al legislatore - di organo chiamato, non a produrre un quid novi sulla base di una libera scelta o a stabilire una disciplina di carattere generale, ma a individuare e dedurre la regola del caso singolo bisognoso di definizione dai testi normativi e dal sistema” (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni unite civili del 30 dicembre 2022, n. 38162)”.
[41] Il comma 8 bis dell’art. 2 della l. n. 241/1990, introdotto dal d. l. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), sancisce, in estrema sintesi, l’inefficacia del provvedimento emanato oltre i termini procedimentali in tutti i casi in cui operi il regime del silenzio assenso, nonché nelle ipotesi di SCIA.
Sul tema, v. M. Calabrò, Il silenzio assenso nella disciplina del permesso di costruire. L’inefficacia della decisione tardiva nel d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), in giustiziainsieme.it, 2020. Anche sulla base di questa disposizione, si è giunti a considerare irrilevante, in quanto privo di effetti nei confronti dell’autorità competente, il parere tardivo della Soprintendenza.
[42] Per riflessioni critiche sul crescente impiego dell’istituto del silenzio assenso, v. M. A. Sandulli, Silenzio assenso e termine per provvedere. Esiste ancora l’inesauribilità del potere amministrativo?, in Il processo, 1/2022, 11 ss. e ivi ulteriori riferimenti.
Sulle criticità in merito all’applicazione dell’art. 17 bis alle materie sensibili, si veda, in particolare, G. Corso, La riorganizzazione della P.A. nella legge Madia: a survay, in www.federalismi.it, 2015; F. Scalia, Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia, in Urb. e app., 2016, 1, 11 ss.; E. Scotti, Silenzio assenso tra amministrazioni, in A. Romano (a cura di), L’azione amministrativa, 2016, Torino, 566 ss.; F. Martines, La “non decisione” sugli interessi pubblici sensibili: il silenzio assenso fra amministrazioni pubbliche introdotto dall'art. 17 bis della l. 241/1990, in Dir. amm., 2018, 3, 747 ss.; F. de Leonardis che (nel citato scritto Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull'art. 17 bis introdotto dalla cd. riforma Madia) osserva come «appare chiaro che norma costituisce una vera e propria fuga in avanti in quella che si potrebbe definire la guerra di logoramento degli interessi sensibili che vengono sempre più parificati a quelli ordinari»; M. Calabrò, Silenzio assenso e dovere di provvedere: le perduranti incertezze di una (apparente) semplificazione, in www.federalismi.it, 2020, 10.
Sommario: 1. «Diritto vivente»: un'introduzione - 2. La «nomofilachia» e la forza del «precedente» - 3. I rapporti nel tempo fra Corte di Cassazione e Corte costituzionale.
1. «Diritto vivente»: un’introduzione
La dottrina del diritto vivente, in disparte la solidità dei riferimenti tecnico-giuridici del concetto, riflette la fluidità e il dinamismo del tessuto delle relazioni e delle tensioni fra Corte costituzionale e Potere giudiziario - in particolare la Corte di cassazione, ma anche il Consiglio di Stato e la Corte dei conti - e nello stesso tempo identifica e monitora la tenuta del modello italiano di giustizia costituzionale [1].
Risulta invero fluida e dinamica la stessa definizione del sintagma «diritto vivente», con riguardo alla identificazione della norma (non della disposizione, secondo la tradizionale lezione crisafulliana [2]), «come essa vive nell’esperienza giurisprudenziale»[3], perciò nell’effettività dell’ordinamento, che costituisce l’oggetto (e il presupposto interpretativo) dello scrutinio di costituzionalità delle leggi in via incidentale.
Con riguardo alla regola procedurale del giudizio di costituzionalità, la Corte qualifica come situazione di fatto, idonea ad attestare l’esistenza di un diritto vivente [4] l’interpretazione giurisprudenziale consolidata della norma, le cui coordinate sono offerte dal tenore univoco, reiterato, costante e conforme dell’orientamento del giudice di legittimità (soprattutto delle sezioni unite della Cassazione laddove compongono conflitti infrasezionali, ma anche di una sezione semplice se esclusivamente competente nella materia), nonché dalla specificità della questione di diritto attinta da quella opzione ermeneutica.
2. La «nomofilachia» e la forza del «precedente»
La dottrina del diritto vivente s’intreccia con il progressivo affermarsi nel tempo, anche nel lessico del legislatore, del ruolo di guida coerenziatrice della Corte suprema di cassazione nella formazione del «precedente» [5], con la conseguente logica conformativa ad esso.
In funzione della tendenziale certezza del diritto, particolarmente avvertita nella materia processuale, e degli elementi qualitativi della prevedibilità e omogeneità delle decisioni e della uguaglianza degli spazi di tutela dei diritti fondamentali della persona, il legislatore moderno (dall’ancora vigente art. 65 ord. giud. di cui al r.d. n. 12/1941 fino alle più recenti riforme del processo civile e penale di cassazione: d.lgs. n. 40/2006; d.l. n. 168/2016, conv. dalla l. n. 197/2016; l. n. 103 del 2017; d.lgs. n. 149 del 2022) riscopre il valore della «uniforme applicazione della legge», enfatizzando, per il perseguimento dell’obiettivo, lo strumento della «nomofilachia».
Le moderne teorie dell’interpretazione hanno messo in risalto la centralità della figura dell’interprete, il suo ruolo integrativo o parzialmente creativo della norma - sempre che non superi la linea di rottura con il dato positivo emergente dalla letteralità del testo («non contro ma oltre la legge» [6]) -, l’assetto multilevel delle fonti, sia legislative che giurisprudenziali, e il conseguente pluralismo delle letture ermeneutiche.
Sicché, a fronte del rischio di liquidità e incalcolabilità del diritto [7], il sistema di giustizia appresta, mediante la sapiente costruzione da parte della Corte di cassazione di una rete di autorevoli precedenti, «una bussola agli operatori del diritto per orientarsi in un contesto ordinamentale tanto fluido» [8].
Si avverte tuttavia che la nomofilachia, nella più larga e moderna accezione, orizzontale e circolare, «non è un valore assoluto ma metodologico» che, nell’inarrestabile evoluzione della giurisprudenza, confluisce dinamicamente nel «dovere funzionale di ragionevole mantenimento della soluzione ragionevolmente conseguita» [9].
Essa si atteggia nella veste di metodo discorsivo, ispirato al principium cooperationis, e si qualifica in termini di procedura di formazione del precedente, il cui vincolo ermeneutico, seppure indiretto e mediato [10], assume un carattere logico-argomentativo in forza delle ragioni che lo giustificano (auctoritas rerum similiter iudicatarum).
Ne discende, come lineare corollario, che i relativi canoni debbano essere assistiti da un rigoroso disciplinamento, anche deontologico, che assicuri il rispetto, insieme con la «legalità penale», anche della «legalità dell’interpretazione» [11].
3. I rapporti nel tempo fra Corte di cassazione e Corte costituzionale
Le relazioni fra le due Corti hanno vissuto fasi di tensioni e conflitti talora anche aspri. Dalla «prima» alla «seconda guerra», meglio: dalla concorrenza fra le due Corti per l’occupazione degli spazi di autonoma lettura interpretativa della norma, passando attraverso vari e progressivi assestamenti delle tecniche di composizione di volta in volta adottate (ad esempio: le sentenze interpretative di rigetto o di accoglimento, la doppia pronuncia e la teoria dell’interpretazione conforme), sembra intravedersi, dopo circa trent’anni, la transizione verso una più matura e virtuosa età del dialogo e della cooperazione, in coerenza sia con gli interventi legislativi che si sono sviluppati nel tempo a favore degli schemi e delle prospettive della nomofilachia, sia con la contestuale e operosa apertura al dialogo con le Corti europee di Strasburgo e Lussemburgo.
Appaiono, infatti, significativamente apprezzabili sia la progressiva valorizzazione da parte delle decisioni della Corte costituzionale degli approdi ermeneutici della Cassazione (soprattutto delle sezioni unite), sia il self restraint esercitato dalla stessa Corte a favore del rilievo nomofilattico del diritto vivente formatosi sulla questione controversa, fatti salvi in ogni caso il margine di apprezzamento degli indici rivelatori circa la effettiva «vivenza» della norma e la riserva di valutazione della compatibilità di questa con la Costituzione.
Si è perspicuamente affermato che fluidità, criticità e nuove declinazioni nella concreta applicazione della dottrina del diritto vivente rendono l’equilibrio sempre incerto e instabile quanto alle rispettive linee di confine. Si avverte tuttavia la comune consapevolezza che il modello italiano di giustizia costituzionale si andrà delineando storicamente anche alla stregua della qualità delle relazioni che s’instaureranno, di tempo in tempo, fra Corte costituzionale e Potere giudiziario, in particolare la Corte di cassazione.
[1] L’assunto è confermato dal titolo - “A che punto è la dottrina del diritto vivente?” - del confronto sul tema, aperto ai giovani studiosi dalla Direzione della Rivista Giurisprudenza costituzionale, i cui contributi saranno pubblicati nel n. 5/2023 della stessa Rivista.
[2] V. CRISAFULLI, voce Disposizione (e norma), in Enc. Dir., XIII, 1964, Milano, p. 195 ss.
[3] T. ASCARELLI, Giurisprudenza costituzionale e teoria dell’interpretazione, Cedam, 1957.
[4] L’espressione compare, per la prima volta, in C. cost., n. 276/74, cui adde, per gli indicatori dei caratteri del diritto vivente, C. cost., n. 89/2018 e n. 89/2021.
[5] M. TARUFFO, Precedente e giurisprudenza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2007, p. 709 ss.; P. CURZIO, Il giudice e il precedente, in Quest. giust., n. 4/2018, p. 578 ss. Cfr., volendo, G. CANZIO, Legalità penale, processi decisionali e nomofilachia, Atti del convegno “Tra legge e giudice alla ricerca di un equilibrio per la legalità penale” (Firenze, 20 maggio 2022), in Sist. pen., n. 12/2022, p. 49 ss.; ID., La funzione nomofilattica fra dissenting opinion ed esigenze di trasparenza, in Scenari e trasformazioni del processo penale. Ricordando Massimo Nobili, a cura di C. Iasevoli, ESI, 2020, p. 125 ss.
[6] Si esprime esattamente e sorprendentemente in termini G. MATTEOTTI, Il concetto di sentenza penale, in Riv. Pen., 1918, vol. LXXXVIII, p. 362. Sul tema, v. Cass., sez. un. pen., n. 8770/2018, Mariotti e n. 18288/2010, P.G. in proc. Beschi.
[7] N. IRTI, Un diritto incalcolabile, in Riv. dir. civ., 2015, p. 11 ss. Sulla crisi del normativismo e sulle moderne tecniche di legistica, cons. AA.VV., Giudici e legislatori, in Dir. pubbl., 2016, p. 483 ss.
[8] B. SBORO, Il “diritto vivente” nel giudizio incidentale, in Quad. cost., n. 2/2023, p. 381 ss.
[9] G. BORRE’, L’evoluzione della Corte nel diritto commerciale e del lavoro, nel diritto pubblico e processuale civile, in La Corte di cassazione nell’ordinamento democratico, Milano, 1996, p. 252 ss.
[10] Sulla regola di raccordo fra sezioni semplici e sezioni unite della Cassazione, v. per il giudizio civile l’art. 374, comma 3, c.p.c., sost. dall’art. 8 d.lgs. n. 40 del 2006, e per il giudizio penale l’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., ins. dalla l. n. 103 del 2017, in coerenza con quanto analogamente previsto sia per il giudizio amministrativo dall’art. 99, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 che per quello contabile dagli artt. 42, comma 2, l. n. 69 del 2009 e 117 d.lgs. n. 174 del 2016, con riguardo alle decisioni dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato e, rispettivamente, delle sezioni riunite della Corte dei conti. Per il positivo scrutinio di legittimità costituzionale della regola, C. cost. n. 30 del 2011.
[11] F. PALAZZO, Legalità penale, interpretazione ed etica del giudice, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2020, 1249; V. MANES, Dalla fattispecie al precedente: appunti di deontologia ermeneutica, in Dir. pen. contemp., 17/1/2018; A. SANTANGELO, Precedente e prevedibilità. Profili di deontologia ermeneutica nell’era del diritto penale giurisprudenziale, Torino, 2022.
[12] L. SALVATO, La nomofilachia nella dialettica tra Corte costituzionale e Corte di cassazione, in www.forumquaderni costituzionali.it, 9/11/2018; F. VIGANO’, Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale, in Sist. pen., 19/1/2021.
*Intervento pronunciato in occasione del convegno, I Cento anni della Corte di cassazione "Unica", Roma 28 novembre 2023.
Nel primo decennale della Cassazione unificata Piero Calamandrei la definì «la porta, per la quale la scienza del diritto entra più liberamente nelle aule di giustizia». Resta tuttavia vivo il dibattitto sulla “questione cassazione”, che è anche quella dell’eccessivo numero di ricorsi, segnalato già alla fine del 1800 da Pisanelli, insito in una delle funzioni della Corte, attinente allo ius litigatoris: verificare la corretta applicazione della legge in ogni singola vertenza, in una sorta di terzo grado di giudizio. Radicandosi quest’ultimo, scrisse Mortara, nel «pregiudizio […] il quale canonizzò nel numero tre una mistica guarentigia di verità e di giustizia», questa mistica è causa della proliferazione dei ricorsi e di una crisi rimediabile con un accorgimento semplice: ripristinare le cassazioni regionali.
La questione è più complessa, specie con riferimento alla funzione inerente allo ius constitutionis: rendere principi uniformanti di interpretazione, quale organo supremo «custode della legge», in virtù di un’idea risalente, come lo è il dubbio sulla possibilità di tenerla unita alla prima e sulla sua attualità. La funzione si radica nel modello del giudice “bocca della legge”, fissato nel Corpus iuris di Giustiniano, non realizzato dall’onnipotenza dell’imperatore, assurto secoli dopo a fondamento della concezione della giurisdizione della modernità giuridica, improntata all’ideale illuministico del diritto chiaro e preciso, al primato della legge scritta.
Note ragioni hanno condotto al declino della identificazione del diritto nella legge, sembrando assegnare alla giurisdizione una funzione di creazione del diritto. Stabilire «qual è il “diritto” dello Stato di diritto» è diventato complicato; è entrata in crisi la giustificazione concettuale della funzione nomofilattica. Alla questione sono dedicate intere biblioteche; a noi spetta operare avendo quale faro la Costituzione.
La funzione nomofilattica, come configurata dal nostro ordinamento, ha recepito le intuizioni di Piero Calamandrei secondo cui «la norma che fa obbligo al giudice di giudicare secondo la legge, è una norma di diritto costituzionale che regola i rapporti tra la funzione giurisdizionale e la funzione legislativa»; «il carattere costituzionale del principio della “fedeltà del giudice alla legge”» giustifica un organo incaricato di verificarne l’osservanza. A questa concezione è ispirata la nostra Carta, che ci ha liberato dall’origine divina del potere dei governanti, che ha disarticolato, fissando un equilibrio tra diritti e doveri, sovranità popolare e pluralismo, tra i poteri dello Stato. L’antico dilemma del rapporto tra legiferare e giudicare è stato sciolto stabilendo (art. 101, secondo comma, Cost.): «i giudici sono soggetti soltanto alla legge». La nozione di «legge» è stata resa riferibile all’ordinamento giuridico, interno ed internazionale, nella sua complessità, ma ne è stato mantenuto fermo il primato, fissando, mediante un sapiente sistema di raccordi, i cardini essenziali dello Stato costituzionale di diritto e di una moderna democrazia pluralista: i principi di separazione dei poteri e di legalità quali aspetti della forma democratica, garantiti anche dal primato della legge.
Nell’ordinamento costituzionale l’interpretazione della disposizione implica il potere-dovere di scegliere tra diverse possibili risposte, ma la scelta presuppone un quadro di diritto positivo che il giudice deve leggere nel miglior modo possibile, che preesiste alla sua decisione, non è creato da lui: è una funzione "dichiarativa", con esclusione di un’efficacia direttamente creativa.
La Costituzione ha stabilito il perdurante primato della legge; è, quindi, attuale la funzione nomofilattica, garanzia dell’equilibrio dei poteri, del principio di uguaglianza e del diritto fondamentale alla certezza, funzione che, per contenuto e finalità, deve spettare ad una Corte unica. Aveva ragione Piero Calamandrei quando nel corso dei lavori della Costituente esclamò: «voler parlare di una Cassazione plurima è una mostruosità!», certo lo è per la funzione nomofilattica.
Questa funzione dà ragione della configurazione del pubblico ministero di legittimità quale parte della Corte, non mero agente “presso” quest’ultima (art. 104, Cost.), portatore dell’interesse pubblico alla difesa del diritto e della sua unità, cui spetta, quale parte pubblica, fornire gli elementi per la corretta identificazione del significato e dell’applicazione della legge, per garantire una formazione dialettica del giudizio che deve prescindere dagli interessi specifici delle parti.
Il legislatore ha rivitalizzato la funzione nomofilattica, da ultimo, disegnando una Corte che opera a tre livelli, per dare risposte tempestive ed adeguate alle finalità per le quali è nata. Gli input sono stati valorizzati dalla Corte e dalla Procura generale con misure che stanno dando positivi risultati, di cui non posso dare conto.
Vi sono criticità della disciplina, ma involgono tecnicalità alle quali si può dare soluzione, purché siamo consapevoli della sfida da affrontare: recuperare la consapevolezza della nomofilachia quale funzione di garanzia dell’equilibrio costituzionale, che ha il suo fondamento nel primato della legge, cui solo spetta assicurare la razionalità politica e giuridica di cui ogni collettività ha bisogno; recuperare la fiducia nella capacità ordinante della scienza giuridica: coerenza sistematica e precisione dommatica sono irrinunciabili ai fini della certezza; ricordare che la cultura giuridica è di tutti gli operatori del diritto ed è centrale il dialogo, che vuol dire capacità di ascolto e rifiuto dell’autoreferenzialità; affermare che finalità del processo è accertare la «verità giudiziaria», che è tale solo se raggiunta nel rispetto dei principi del giusto processo, di cui custode ultimo è la Corte, baluardo contro il rischio della plebiscitarizzazione del giudizio, alimentato dalle nuove forme della comunicazione.
È una sfida difficile, che può, deve, essere vinta, non dalla sola Corte, ma da questa insieme al Foro ed all’Accademia, nel ricordo dell’affermazione di Pisanelli riportata da Calamandrei in apertura al II volume sulla Cassazione civile: la Corte è «una di quelle grandi conquiste che la civiltà non può più perdere senza indietreggiare essa stessa».
*Intervento pronunciato in occasione del convegno, I Cento anni della Corte di cassazione "Unica", Roma 28 novembre 2023.
[Immagine: Giorgio Vasari, Giustizia, 1542, Venezia, Gallerie dell'Accademia]

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
