
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
L'articolo esplora il tema della mediazione dei conflitti focalizzandosi principalmente sulla chiave di volta: scioglie il conflitto il desiderio di riparare: prezioso per ogni tipo di contenzioso, non solo quello penale.
Valorizza un approccio filosofico-umanistico che integra aspetti etici, teologici, giuridici e psicologici. Offre una trattazione multidisciplinare con esempi concreti, riflessioni teoriche e riferimenti a nomi autorevoli, oltre a un caso pratico reale che illustra i limiti della giustizia formale rispetto alla mediazione riparativa.
Sommario: 1.Introduzione: Il valore della cura nell'era del consumismo - 2. L’insufficienza della giustizia formale: un caso studio - 3. Le radici multidisciplinari del dovere di riparare - 3.1. La riparazione in ambito psicologico: la cura intergenerazionale - 3.2. Prospettive etiche e filosofiche: responsabilità e bene comune - 3.3. Giustizia dialogica e diritto fiduciario - 3.4. Fondamenti teologici: dovere di giustizia e amore - 4. Conclusione: trasformare la crisi in rigenerazione.
1. Introduzione: Il valore della cura nell'era del consumismo
La mediazione dei conflitti, in particolare nel suo modello filosofico-umanistico, trova la sua chiave di volta nel far scattare nei contendenti il desiderio profondo e autentico di riparare.
Il verbo "riparare," rischia di dissolversi nel mondo consumistico contemporaneo, ove la cura e il recupero sono stati soppiantati dalla logica dell'usa-e-getta. Se un tempo si dava nuova vita alle calze smagliate e le scarpe venivano risuolate, oggi le cose vengono gettate e sostituite. Questo progressivo allontanamento dalla pratica di "ridare vita alle cose" si riflette inevitabilmente anche nel vissuto umano e nelle dinamiche relazionali.
Viviamo in un’epoca definita da Zygmunt Bauman come quella delle relazioni "liquide[1] ," caratterizzate dalla tendenza a scartare ciò che non appare più immediatamente utile, anche nelle interazioni tra persone. La conseguenza più grave è l'amnesia rispetto a quelle relazioni che, se trascurate, lasciano nel cuore e nell’anima una voragine—un "buco nero" che ostruisce la crescita autentica e le conquiste umane. Le incomprensioni diventato muri e le differenze diventano distanze come baratri. Ignoriamo il monito di Italo Calvino:” Se alzi un muro, pensa a cosa lasci fuori”.
La mediazione si pone l'obiettivo di cucire con cura proprio queste relazioni incrinate.
L’esito delle sedute della mediazione, praticata secondo il modello filosofico-umanistico, non si misura tanto né esclusivamente in base all’accordo formale raggiunto, bensì nella nascita del bisogno autentico di riparare il male e risarcire la dignità lesa. La vera mediazione apre, infatti, lo spazio per il desiderio di cura e ristoro, andando ben oltre la mera contesa giuridica.
2. L’insufficienza della giustizia formale: un caso studio
Il divario tra la giustizia formale e la riparazione umana emerge con chiarezza in recenti episodi. Si pensi al caso di una disputa tra comproprietari in un borgo lombardo, dove la richiesta ostinata di stacco da un contatore d’acqua comune ha trasformato la mediazione in un palcoscenico di sopraffazione e scontro. La parte istante non era assolutamente interessata alla ricerca della verità e di una soluzione rispettosa di Nonostante l'infondatezza della richiesta, la parte convenuta ha dovuto affrontare oneri economici, stress emotivo e la sofferenza dell'ingiustizia percepita.
La mediazione fallisce — come previsto e auspicato dalla parte più aggressiva, che cercava "un giudice a Berlino" piuttosto che il dialogo. Non era assolutamente interessata alla ricerca della verità e di una soluzione rispettosa ma di un modo per imporre il suo volere[2].
Segue ovviamente il ricorso al tribunale che ha prolungato la sofferenza dell’altro proprietario per tre lunghi anni. Quando finalmente si è giunti a una soluzione tecnica e a un accordo, questo è risultato privo di ogni gesto di riconoscimento o scusa. La parte lesa è rimasta gravata da spese e amarezze, senza alcun risarcimento morale, vittima di una giustizia che è stata mera forma senza sostanza.
Questo esempio dimostra perché la mediazione filosofica-umanistica miri a qualcosa di più del diritto: mira alla riparazione, intesa come un atto di responsabilità e umanità che coinvolge sia chi ha commesso il torto sia chi ne ha sofferto, permettendo così la ricostruzione di un tessuto di dignità e relazione. Solo un riconoscimento delle reciproche responsabilità e un risarcimento, anche simbolico, le cosiddette scuse, avrebbero riequilibrato i rapporti e, forse, consentito una ripresa. La chiusura giudiziaria del problema che li opponeva non ha smosso di un centimetro i motivi veri della lite.
La mediazione appartiene alla “restorative justice” (“giustizia che reintegra” di derivazione anglosassone), alternativa alla giustizia di tipo retributivo (la giustizia che stabilisce con una sentenza, in diverso modo, il risarcimento dei danni alla vittima ). Comunque l’accento viene posto sull’azione del riparare. Dove l’applicazione della pena tradizionale potrebbe apparire in relazione sia al destinatario (il reo) che alla vittima, inutile o addirittura controproducente.
La giustizia riparativa processo informale in cui vittima e autore del reato, che si assume pienamente responsabilità del suo comportamento, guidati da un mediatore insieme alla vittima, familiari delle parti in conflitto e alcuni componenti fondamentali delle rispettive comunità di appartenenza decidono collettivamente le modalità con cui gestire la soluzione del conflitto. Guidati da un mediatore si incontrano, discutono sviscerando cause ed effetti del fatto reato.
Ciò che non esclude affatto l’istituto della pena, ma ne modifica e chiarisce il profilo di utilità sociale mediante azioni di reale riconoscimento della vittima, riparazione dell’offesa nella sua dimensione globale, autoresponsabilizzazione del reo, coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, rafforzamento degli standard morali e contenimento dell’allarme sociale.
Ma è riduttivo ascrivere questo concetto solo alla mediazione penale. È il nocciolo di ogni mediazione che tratti il cuore del conflitto (le ferite e le offese relazionali) e il conflitto con il cuore (con la comprensione, il riconoscimento, il racconto di sé, la rielaborazione, la crisis e la catarsi). Qualunque sia l’oggetto del contendere, nella lite la persona viene coinvolta e travolta nei suoi vissuti più profondi, nelle sue vulnerabilità, nelle sue paure, nella sua dignità. Sono queste le ferite relazionali che è doveroso, e possibile, sanare o almeno curare.
Si annoverano quindi numerose e diversificate forme operative a elevato grado di flessibilità, in relazione al tipo e all’intensità del conflitto da affrontare, ma sempre resta fermo il senso del non giudicare ma di promuovere e vigilare sulla riparazione.
3. Le radici multidisciplinari del dovere di riparare
Il valore del riparare è un concetto universale, oggetto di riflessione oltre che da parte giuristi, anche dei teologi, filosofi, e psicologi.
3.1. La riparazione in ambito psicologico: la cura intergenerazionale
In ambito psicologico, la riparazione si traduce anche nella cura intergenerazionale. La psicogenealogia[3] insegna che eventi traumatici o dinamiche familiari irrisolte possono essere trasmesse inconsciamente, influenzando il benessere dei discendenti. In questa logica la riparazione psicologica è dunque il processo di presa di coscienza e guarigione delle ferite emotive che attraversano le famiglie. Il discendente "ripara" quando riconosce queste "eredità invisibili" e interrompe le catene di sofferenza attraverso l'elaborazione terapeutica e simbolica. L'obiettivo è duplice: liberare la persona dal peso emotivo degli antenati e permetterle di costruire un’identità più libera e autentica.
3.2. Prospettive etiche e filosofiche: responsabilità e bene comune
Il concetto di riparazione è centrale nell'etica delle relazioni, come dimostrato dai contributi di Paolo Bettineschi e Salvatore Natoli.
Paolo Bettineschi definisce la riparazione come un impegno etico profondo di presenza e responsabilità[4]. Richiede l’adesione attiva di entrambe le parti (chi ha causato il male e chi lo ha subito) in un processo di manifestazione e riconoscimento reciproco. Non è mera compensazione materiale, ma un'etica che integra memoria, fiducia e cura, rigenerando ciò che è stato ferito, coinvolgendo anche la dimensione esistenziale e l'ambiente.
Salvatore Natoli colloca la riparazione in un contesto politico e sociale[5]. La vede come un imperativo morale finalizzato alla costruzione del bene comune. Sottolinea la necessità di un'etica della pietas, vista come il legame umano fondamentale per la cura e la salvezza della specie. La riparazione diviene un compito etico e politico concreto per la giustizia sociale e la riconciliazione.
3.3. Giustizia dialogica e diritto fiduciario
Tommaso Greco introduce la prospettiva giuridico-fiduciaria[6], dove la riparazione richiama la giustizia dialogica. Essa non è né mero perdono né condanna, ma la ricostruzione della fiducia attraverso la responsabilità e la tutela del bene comune. Greco sostiene che il diritto si fonda sulla fiducia tra le persone. La riparazione, in questo quadro, è un atto che rinnova la relazione sociale, in cui la mediazione funge da ambiente per sperimentare questa "etica relazionale".
3.4. Fondamenti teologici: dovere di giustizia e amore
Nella teologia cristiana, e in particolare nella tradizione cattolica, la riparazione ha radici profonde: è un dovere fondamentale di giustizia e amore verso Dio e il prossimo, espressione della riconciliazione comunitaria spezzata dal peccato. Il credente è chiamato a riparare l'offesa fatta a Dio con le proprie colpe, unendo i propri atti di zelo e sacrificio all'azione redentrice. La riparazione, in questo senso, non riguarda solo l'offensore ma anche l'Offeso, cioè Dio e si manifesta in tre forme concrete: 1. Affettiva: preghiere e partecipazione ai sacramenti. 2. Effettiva: azioni quotidiane ispirate alla carità e alla giustizia.3. Afflittiva: sofferenze e tribolazioni accettate in unione a quelle di Cristo. La riparazione è quindi un percorso spirituale di conversione e giustizia, distinta concettualmente dall'espiazione (l'atto salvifico di Cristo, a cui l'uomo partecipa) e dalla penitenza (il sacramento e mezzo pratico per la soddisfazione e la correzione).
4. Conclusione: trasformare la crisi in rigenerazione
Da queste diverse angolazioni emerge un quadro convergente sull'essenziale: riparare è un atto che plasma sia la persona che la società, richiedendo il riconoscimento del danno, la disponibilità al cambiamento e l'inclusione di chi ha subito l'offesa in un percorso di recupero.
Nel percorso della mediazione filosofico-umanistica, il vero valore della pratica si incarna in questa tensione vitale al riparare. Non si tratta di un nostalgico ritorno al passato o di una rinuncia al conflitto, ma di una sfida contemporanea: trasformare la crisi in rigenerazione, la lacerazione in cura e l'offesa in responsabilità condivisa. In un tempo dominato dall'effimero, la mediazione chiama al coraggio di interrompere questa deriva e di riscoprire, con consapevolezza e passione, la forza di riparare, rigenerando non solo le cose, ma soprattutto le relazioni e, in definitiva, noi stessi.
[1] Zygmunt Bauman e la teoria delle "relazioni liquide": Bauman Z., Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Polity Press, 2003.
[2] Storiella o metafora delle interazioni umane? Si racconta che due uomini stavano litigando. La discussione era: “Una fetta di pane cade con il lato imburrato sopra o sotto?”. Il primo disse: “Con il lato imburrato sotto, ovviamente”. Il secondo: “Con il lato imburrato sopra”. “Facciamo la prova”, disse il primo, “e vedrai che ti sbaglierai!”. Così la fetta di pane fu ben imburrata e lanciata in aria. Ricadde con il lato imburrato sopra. “Ho vinto!”, disse il secondo. “Solo perché io ho commesso un errore”, disse il primo. “Quale errore?”, riprese il secondo. “Ovviamente ho imburrato il lato sbagliato”, rispose il primo.
La persona che litiga non cerca la verità ma la conferma delle proprie convinzioni.
[3] Anne Ancelin Schützenberger, Gli Antenati e noi: Scoprire i numeri simbolici nelle storie familiari, Mondadori, 1991
[4] Paolo Bettineschi, Etica del riparare, Morcelliana 2021
[5] Salvatore Natoli, Etica della pietà, Laterza, 2010.
[6] Greco T., Il diritto fiduciario e la giustizia dialogica, Giuffrè, 2015; la legge della fiducia, Laterza 2023
Immagine: Paul Troger, L'Armonia tra Religione e Scienza, Affresco della Seitenstetten Abbey (Austria), 1735.
È ormai da più di un secolo - vale a dire dalla dichiarazione del Ministro degli Esteri britannico Balfour del 1917, in cui appare per la prima volta in un documento diplomatico il concetto di un “focolare” (home) ebraico in Palestina - che va avanti quella che lo scrittore israeliano Amos Oz ha definito anni fa una tragedia in senso greco, una situazione cioè in cui entrambe le parti in conflitto hanno valide ragioni da far valere a sostegno del proprio punto di vista, con la conseguenza che è maledettamente difficile venirne a capo. Matassa che, se non trattata, rischia di degenerare sempre di più, come l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 dimostra tristemente, con il pericolo che la violenza diventi la cifra inevitabile ed eterna della vita di quei due popoli.
Proviamo a capire come si è arrivati al punto in cui siamo. A mio parere, la migliore chiave di lettura è la parabola storica delle posizioni assunte nel tempo dalle due parti contrapposte rispetto alla possibile soluzione dei due Stati. Credo che si possano individuare tre fasi principali:
PRIMA FASE (1947-1978)
Nel 1947, l’ONU – con la Risoluzione 181 dell’Assemblea Generale - propone la creazione di uno Stato palestinese e di uno Stato ebraico, ma i Palestinesi e i Paesi arabi vicini non accettano tale soluzione e, per annientarlo, decidono di attaccare Israele (più disposto, viceversa, a seguire l’impostazione onusiana, a parte qualche frangia estremista). Gli Israeliani prevalgono e avviene l’esodo, per lo più forzato, di circa 750.000 Palestinesi dalle loro case (cd. Nakba, cioè catastrofe). In questo trentennio hanno luogo altre tre guerre (1956, 1967 e 1973), nonché gravi episodi di terrorismo (come l’uccisione di atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco nel 1972). Israele riesce ad accaparrarsi vaste parti di territorio, vale a dire la striscia di Gaza (che era sotto amministrazione egiziana), la Cisgiordania (che era sotto controllo giordano) e l’intera città di Gerusalemme (la cui parte orientale era in mano ai Giordani), da allora denominati dall’ONU “Territori Occupati” (definizione non accettata da Israele) con tutti gli obblighi giuridici connessi a tale situazione.
SECONDA FASE (1978-1995)
I Palestinesi – intanto organizzatisi formalmente nell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) a partire dal 1964 e guidati dal carismatico leader laico Arafat – cominciano ad accettare l’idea di rinunciare alla distruzione dello Stato israeliano e di vivere in due entità statuali distinte, tanto che – passando per gli Accordi di Camp David del 1978 (che portano alla pace tra Israele e l’Egitto) e la prima Intifada (rivolta) palestinese del 1987 - si arriva agli Accordi di Oslo del 1993. Questo è il momento di massima vicinanza ad una possibile risoluzione del conflitto, dato che essi prevedono, insieme al reciproco riconoscimento politico tra l’OLP (in rappresentanza del popolo palestinese, pur ancora privo di uno Stato) e Israele, alcuni principi negoziali basati sul ritiro israeliano da aree della Striscia di Gaza e della Cisgiordania e sul diritto palestinese all'autogoverno attraverso la nascita dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP). Si giunge dunque faticosamente all’accettazione del diritto all’esistenza di Israele e si pongono le premesse per la creazione di un vero Stato palestinese. Purtroppo, il meccanismo negoziale messo in piedi non ha successo, a causa del sabotaggio degli estremisti di entrambe le parti (soprattutto l’assassinio, da parte di un fanatico sionista di destra, del Premier israeliano Yatzik Rabin nel 1995, artefice degli Accordi di Oslo insieme ad Arafat).
TERZA FASE (1995-2025)
Prevalgono a poco a poco in entrambi gli schieramenti coloro che si oppongono alla soluzione delle due entità statuali, decisi invece ad instaurare il proprio Stato su tutto il territorio conteso dal fiume Giordano al mare. Tale cambio di atmosfera fa naufragare anche due successivi importanti tentativi (arenatisi in particolare sulla questione del ritorno dei rifugiati nelle loro case in Israele e sullo status di Gerusalemme): uno al Vertice di Camp David del 2000 , in cui un Arafat improvvidamente rigido, forse anche per timore di essere assassinato dagli estremisti islamici, rifiuta le offerte negoziali del Premier israeliano Ehun Barak; l’altro con riferimento all’“Iniziativa di pace araba” elaborata dai Sauditi nel 2002, malauguratamente non accettata da Israele, anche perché spaventato dalla maggiore violenza della seconda Intifada palestinese iniziata nel 2000 e poi proseguita fino al 2005. In sostanza, dal 1996 in poi comincia a farsi gradualmente strada nella dirigenza israeliana la nuova idea che non sia più necessario accettare uno Stato palestinese accanto ad Israele (vale a dire la formula “terra in cambio di pace”) e che si debba invece puntare ad uno Stato ebraico inglobante anche i “Territori Occupati” (Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme) privando i Palestinesi di un loro territorio, in parte spingendoli ad emigrare in Giordania, in parte assorbendoli in uno Stato a guida ebraica. Tale nuovo approccio si è appunto incarnato nel Premier Benjamin Netanyahu, in carica dal 1996 al 1999, poi dal 2009 al 2021 e infine dal 2022 a oggi. Netanyahu ha basato la sua strategia su una massiccia e inarrestabile politica di nuovi insediamenti illegali di coloni nei territori occupati e su un’ambigua tolleranza nei confronti della fazione islamista radicale palestinese di Hamas (nata negli anni Ottanta e rafforzatasi nel tempo, fieramente contraria a ogni ipotesi di compromesso con Israele e impadronitasi di Gaza dopo l’abbandono della striscia da parte israeliana nel 2005), allo scopo di indebolire l’Autorità Nazionale Palestinese (al potere in Cisgiordania) e così vanificare la soluzione dei due Stati, accettabile solo per quest’ultima fazione. In pratica, Netanyahu ha alimentato la divisione tra i gruppi palestinesi per poter dire che la dirigenza palestinese non era d’accordo sugli obiettivi da raggiungere e dunque indisponibile per un negoziato serio. Si è al tempo stesso illuso di poter gestire indefinitamente Hamas - consentendo tra l’altro il passaggio di ingenti fondi del Qatar verso la striscia di Gaza – nella convinzione che tale fazione si sarebbe accontentata di arricchirsi e di governare la striscia senza creargli problemi reali, diventando così la sua polizza assicurativa contro la soluzione dei due Stati. In questo modo, mirava a far apparire l’opzione di un solo e grande Stato a controllo ebraico come l’unica soluzione realisticamente possibile. Ma la sua parallela strategia di allacciare relazioni con i Paesi arabi scavalcando i Palestinesi (tramite gli Accordi di Abramo del settembre 2020, favoriti dalla prima Amministrazione Trump e stipulati con le monarchie degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrein, nonché il graduale avvicinamento all’Arabia Saudita ) ha fatto comprendere ad Hamas e al suo sponsor ideologico iraniano che tale evoluzione rischiava di provocare la loro emarginazione nel mondo musulmano (a vantaggio dell’Autorità Nazionale Palestinese guidata dal vecchio leader Abu Mazen) e il consolidamento definitivo della posizione di Israele nella regione, rendendone impossibile la cancellazione. Si è pertanto verificato un cortocircuito che il 7 ottobre 2023 ha fatto scoppiare tutto il meccanismo in mano a Netanyahu, rivelando il fallimento del suo progetto politico. Hamas – verosimilmente assistita tecnicamente dall’Iran e da Hezbollah – si è preparata nell’ombra per due anni, mentre il Premier israeliano si cullava nell’erronea certezza di avere sterilizzato il gruppo estremista, abbassando di conseguenza la guardia nei suoi confronti (anche perché la sua attenzione era rivolta in quel momento alle massicce proteste interne contro la riforma giudiziaria da lui caldeggiata per evitare i processi relativi alle gravi accuse di corruzione rivoltegli in patria). In realtà, ha semplicemente ottenuto il risultato di incattivire i miliziani terroristi di Hamas, spingendoli a radicalizzarsi e disumanizzarsi sempre di più, come dimostra il comportamento incredibilmente barbaro adottato nel corso del loro feroce attacco.
A quel punto, Israele si è trovato di fronte a uno dei dilemmi più difficili della tormentata storia del Paese. Da un lato, aveva la necessità di riaffermare con forza la propria credibilità di deterrenza sia di fronte ai nemici (per intimorirli) sia di fronte ai propri cittadini (per rassicurarli), dall’altro doveva tutelare la propria immagine internazionale. Poteva scegliere una via mediana, atta a dimostrare la propria forza in maniera ragionevole e proporzionata (per esempio con bombardamenti di alcuni giorni come rappresaglia immediata e poi omicidi mirati dei capi politici e militari di Hamas), chiedendo al contempo il supporto dell’ONU per negoziare uno scambio tra i circa 200 ostaggi israeliani e i prigionieri palestinesi nelle proprie carceri, preservando in qualche modo il ruolo di vittima aggredita. Viceversa - anche per l’interesse personale di Netanyahu ad una guerra lunga, che gli consentisse di rinviare i processi a suo carico e restare in sella – il Governo estremista da lui guidato ha scelto una reazione del tutto sproporzionata facendo migliaia di vittime civili (con altissima percentuale di bambini) e ricorrendo addirittura all’arma della fame. Israele è così caduta in pieno nella trappola di Hamas, che aveva posto in essere azioni particolarmente odiose proprio per provocare Tel Aviv e spingerla ad un comportamento bellicoso ed aggressivo che avesse l’effetto di isolarla sul piano mondiale, facendola apparire come uno Stato violento e inumano, incurante di macchiarsi di crimini di guerra e contro l’umanità, se non addirittura di genocidio (spetterà alla Corte di Giustizia Internazionale, su impulso del Sudafrica e di altri Paesi, decidere formalmente se ricorrono gli estremi per configurare tale gravissimo reato, come peraltro recentemente ritenuto da una Commissione indipendente nominata dall’ONU).
Dopo i tragici fatti del 7 ottobre 2023 e dei mesi successivi, che hanno incendiato il Medio Oriente (con l’estensione delle ostilità anche a Libano, Siria, Yemen e Iran), appare ormai chiaro che la “madre di tutti i problemi” era e rimane la questione israelo-palestinese, frettolosamente archiviata una dozzina di anni fa nell’illusione che sarebbe svaporata da sola come per magia. Pertanto, per risolvere il “puzzle” mediorientale, si deve ripartire dalla ricerca di una definitiva soluzione politica di tale annosa questione. La maggior parte dei Governi di tutto il mondo ha indicato la formula dei due Stati come la soluzione auspicabile dello spinoso problema. Ma tale approccio, che resta senza dubbio lo sbocco più razionale ed equo, si scontra al momento con due ordini di difficoltà: la continua erosione del territorio che andrebbe spartito per via negoziale, a causa dell’espansione degli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania; la radicalizzazione delle due popolazioni, che sembrano mostrare al momento meno fiducia nella possibilità di una convivenza pacifica fianco a fianco, a causa di un radicato processo di disumanizzazione della controparte. D’altro canto, le soluzioni alternative a quella dei due Stati sarebbero:
-uno Stato unico binazionale, con pari diritti per ebrei e palestinesi, che , pur idealmente valida, appare ancor meno realizzabile dei due Stati, alla luce della aumentata diffidenza reciproca tra le due popolazioni, senza contare che gli Israeliani sarebbero destinati a perdere la partita demografica nel lungo termine;
-uno Stato unico di natura ebraica, con i Palestinesi cittadini di serie B, che esporrebbe Tel Aviv a serie accuse di “apartheid”, con probabili conseguenti pesanti sanzioni da parte della comunità internazionale (senza dimenticare il già citato futuro problema demografico) Tanto più che la vicenda di Gaza ha fatto cadere per la prima volta il tabù sinora imperante della tolleranza e impunibilità di qualsivoglia azione israeliana, derivante dalla drammatica vicenda della Shoah, aprendo la strada a provvedimenti punitivi recentemente adottati da vari Stati, nonché al riconoscimento, seppure simbolico, dello Stato palestinese da parte di un rimarchevole numero di Paesi occidentali);
-uno Stato ebraico senza i Palestinesi di Gaza e Cisgiordania, espulsi e trasferiti nei Paesi vicini, che costituirebbe una seconda Nakba (cacciata) dopo quella del 1948 (sogno del Governo di estrema destra di Netanyahu), con tutti gli strascichi di odio che ne conseguirebbero, perpetuando un clima di violenze e attentati nell’area;
-una Confederazione composta da Israele, Giordania e neonato Stato palestinese (inclusivo di Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est), ipotesi che sta acquistando un certo favore tra gli osservatori, in quanto intermedia tra l’opzione dei due Stati e quella dello Stato unico binazionale. Tale formula consentirebbe in sostanza di soddisfare, da un lato, l’esigenza di auto-determinazione dei Palestinesi e, dall’altro, la necessità di sicurezza di Israele, garantita da un controllo congiunto insieme alla Giordania sulla nuova entità palestinese, al fine di prevenirne una deriva estremista ed aggressiva. Ma è tutto da appurare se le tre parti in causa siano convinte della bontà di tale approccio…
In questo intricato quadro, si è adesso inserito con prepotenza il fattore Trump al suo secondo mandato, con il suo stile dirompente ed eccentrico rispetto al comportamento politico a cui il mondo si era abituato negli ultimi 80 anni. Il nuovo Presidente USA sta infatti inoculando nel contesto mondiale una massiccia dose di aggressività spiazzante e pragmatismo affaristico, prestandosi ad accuse di pericoloso disprezzo del diritto interno e internazionale.
Ciò detto, va ammesso che il suo caparbio attivismo sta smuovendo le acque sia nel conflitto ucraino (con scarsi risultati per il momento), sia nel conflitto israelo-palestinese, dove è invece riuscito ad ottenere – tramite il suo Piano di Pace in 20 punti e pressioni mai viste prima sulle parti - una tregua che ha fermato o quantomeno ridimensionato la furia omicida a danno della popolazione di Gaza, consentendo al tempo stesso la liberazione degli ostaggi israeliani e la scarcerazione dei prigionieri palestinesi. Ai fini pratici, poco importa se le motivazioni hanno le proprie radici prevalentemente nel suo narcisismo patologico (aspirazione al Premio Nobel per la Pace) e nella sua avidità venale (contratti lucrosi con i ricchi Paesi del Golfo). Naturalmente, la tregua è solo il primo e più facile passo del Piano proposto, che prevede nelle fasi successive il disarmo di Hamas (vero e spinosissimo nodo del problema) e un’articolata “governance” della striscia, non esente tra l’altro da critiche di neo-colonialismo (un “Board” internazionale guidato dal Presidente Trump, un Comitato di gestione con tecnocrati palestinesi e una forza militare multinazionale di stabilizzazione, propedeutici al subentro a data non stabilita di un’Autorità Nazionale Palestinese rinnovata). Purtroppo, l’Amministrazione Trump maneggia gli strumenti diplomatici in maniera goffa e spesso improvvisata, per cui l’esito positivo del suo tentativo è tutt’altro che certo e la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro, tanto più che la seconda fase del suo Piano sta procedendo troppo lentamente, con il rischio che Hamas riconsolidi il suo potere sul terreno, divenendo più rigida, e i Ministri israeliani estremisti convincano Netanyahu a riprendere la guerra. Ma in realtà – dato l’immobilismo della precedente Amministrazione USA e la ormai inesistente influenza europea nell’area – l’azione di Trump è l’unico elemento di speranza presente sul tavolo, anche perché è riuscito a porre i Paesi arabi della regione di fronte alle proprie responsabilità, spingendoli ad andare oltre le semplici dichiarazioni ideologiche di principio per rendersi disponibili ad impegnarsi in prima persona, soprattutto facendo una effettiva pressione su Hamas.
A ben vedere – anche se l’attuale tentativo di Trump dovesse malauguratamente fallire - la responsabilizzazione dei Paesi del Golfo (in particolare Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti), spalleggiati da Egitto e Giordania, potrebbe costituire un cambio di paradigma utile e forse cruciale nel medio e lungo termine, in vista di ulteriori tentativi di soluzione del problema. Sono infatti proprio questi i Paesi che possono godere della fiducia di entrambe le parti e in grado di andare incontro a molti dei loro concreti interessi. Sono in realtà gli unici attori capaci di spingere i due contendenti ad individuare un meccanismo di convivenza (auspicabilmente la creazione di due entità indipendenti, ovvero soluzioni creative che vi assomiglino) sufficiente a rassicurare Tel Aviv quanto alla sua sicurezza e i Palestinesi quanto alla loro auto-determinazione.
Da una parte, Israele - tramite i Paesi del Golfo - può anzitutto ottenere il riconoscimento generalizzato del proprio diritto ad esistere da parte degli Stati che la circondano (sulla scia della già menzionata "Iniziativa di pace araba " proposta nel 2002 proprio da Riyadh, dato il ruolo di leadership anche religiosa svolto dall’Arabia Saudita). Questo fortissimo e prioritario interesse può convincere Tel Aviv ad accettare una qualche forma di entità palestinese, considerato che tale sviluppo costituisce la "conditio sine qua non" di Riyadh per aderire agli Accordi di Abramo (in quanto le masse arabe e islamiche non perdonerebbero un tradimento della causa palestinese), spianando appunto la via della definitiva normalizzazione tra Israele e mondo arabo/islamico. In secondo luogo, ciò aprirebbe la strada ad un aumento esponenziale dei rapporti economici di Tel Aviv con i Paesi della regione, dal punto di vista commerciale, tecnologico e turistico, regalando ad Israele una supremazia pacifica di fatto, con benefici per tutti. Inoltre, i Paesi del Golfo hanno un proprio vitale interesse alla pace e alla stabilità nell’area, unica condizione che consente loro di prosperare grazie alla produzione energetica, agli investimenti esteri, ai trasporti marittimi ed aerei, nonché al turismo proveniente da tutto il mondo. Da ultimo , si creerebbe un vasto fronte politico di contenimento del comune avversario Iran. In conclusione, solo il Golfo può offrire un pacchetto così ricco e appetibile a Tel Aviv.
Dall’altro lato, i Palestinesi possono trovare nei Paesi del Golfo – appoggiati da Amman e Il Cairo - dei mediatori in cui avere piena fiducia, condividendone la stessa mentalità, fattore che facilita il dialogo e la comprensione reciproca. Infine, la potenza di fuoco finanziaria di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti rappresenta una forte garanzia per la sopravvivenza di una futura entità palestinese (aiuti cruciali che verrebbero sicuramente condizionati ad un’attitudine pacifica nei confronti di Israele). Gli Emiri del Golfo sono anche gli unici a poter imporre il necessario cambio nella leadership palestinese, facendo emergere personalità più oneste e carismatiche (magari convincendo Tel Aviv a liberare Marwan Barghuthi, il cd. “Mandela” palestinese), favorendo al tempo stesso un‘evoluzione politica più moderata di Hamas (non eliminabile tout court, godendo nei sondaggi dell’appoggio di almeno un 20% dei consensi).
Se invece, nonostante tutti i vantaggi sopraelencati di un compromesso ragionevole, a Tel Aviv dovessero prevalere su ogni altra cosa gli impulsi messianici e irrazionali al possesso della terra (con la cacciata di tutti i Palestinesi da Gaza e Cisgiordania) e/o la parte palestinese non fosse capace di elaborare – sotto una leadership più credibile - una posizione unitaria incentrata sul diritto di Israele alla propria esistenza, il ciclo di violenza non si interromperebbe, condannando all’instabilità tutto il Medio Oriente. Episodi traumatici come quello del 7 ottobre 2023 - se non ancora peggiori – rischierebbero di ripetersi all’infinito, imponendo una condizione di timore e orrore perpetuo. E questo non è certamente ciò che le due popolazioni, israeliana e palestinese, meriterebbero. Spetterà peraltro a loro decidere i propri destini al momento in cui – in un prossimo futuro – avranno la possibilità di recarsi alle urne per scegliere i rispettivi rappresentanti.
1. Mentre prosegue indisturbata l’ormai ultra-triennale aggressione russa all’Ucraina e una tregua precaria sopisce il conflitto medio-orientale, una giurista esperta e uno storico della contemporaneità ci regalano un volume che ha lo scopo di fare chiarezza sulla storia, le finalità e la crisi della giustizia penale internazionale.
Caos – La giustizia internazionale sotto attacco (Laterza, 2025) è uno strumento prezioso per chiunque, giurista o laico curioso, intenda farsi un’idea e prendere una posizione consapevole nel dibattito, rovente e talvolta ideologico: sull’utilità della giustizia penale internazionale, sull’appropriata qualificazione dei crimini attribuiti alle parti in conflitto, sul rapporto tra pace e giustizia in quadro che impone di aggiornare l’ormai sessantennale motto di Luther King “No Peace without Justice, No Justice without Peace”.
Il volume ripercorre agilmente l’iter del diritto penale internazionale dai processi di Norimberga, Tokyo e Gerusalemme (il processo Eichmann, cui Hanna Arendt dedicò il noto reportage su La banalità del male, un tòpos ineludibile per gli studiosi del male incommensurabile e delle ragioni della sua affermazione su larga scala), ai Tribunali ad hoc costituiti per i crimini commessi nella ex-Yugoslavia e nel Ruanda, fino alla istituzione, con lo Statuto di Roma, della Corte Penale Internazionale.
La traiettoria, agilmente illustrata nel volume, in estrema sintesi, è scandita dalle seguenti tappe: giustizia dei vincitori sui vinti, attuata da Tribunali militari che applicano, talvolta retroattivamente, un diritto di guerra a conflitto finito; definizione convenzionale del genocidio nella Risoluzione Onu del 1946 e nella Convenzione del 1948; giustizia amministrata dagli Stati in applicazione dei crimini definiti in sede convenzionale o interna; Tribunali internazionali e Tribunali misti (composti cioè da giudici interni e internazionali) istituiti ad hoc al termine di sanguinosi conflitti; fino ad arrivare allo Statuto di Roma che definisce e sanziona con apposite disposizioni il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità e, attraverso dettagliate previsioni processuali, istituisce la Corte penale internazionale come Corte permanente, fondata sul consenso degli Stati e indipendente dalle Nazioni Unite, che interviene in funzione complementare quando gli Stati non siano capaci o non siano disponibili a reprimere il male smisurato, superando lo schema della giustizia dei vincitori e le deroghe ai principi di irretroattività della norma penale sostanziale e della naturalità e precostituzione del giudice.
La ricostruzione di Emanuela Fronza e Marcello Flores non manca di segnalare alcune criticità insite nel meccanismo di funzionamento della Corte che ne hanno condizionato politicamente l’operato, restituendo nei primi anni del suo funzionamento l’immagine di un organismo sostanzialmente concentrato sulle questioni africane.
Tra questi limiti rilevano innanzitutto la mancata adesione o la mancata ratifica di Stati importanti sullo scenario internazionale, come la Russia, gli Stati Uniti, la Cina, Israele, alcuni dei quali compongono il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sono perciò in grado di impedire, esercitando il diritto di veto, il referral che costituisce l’unico meccanismo di investitura della Corte nei confronti di Paesi che non aderiscono alla convenzione istitutiva.
Si tratta di un limite, per così dire, istituzionale, in forza del quale può procedersi nei confronti di Putin e della commissaria per l’Infanzia Lvova Belova per la sottrazione dei bambini ucraini (parte del piano di deportazione della popolazione delle zone occupate) ma non anche per il crimine di aggressione perché questo richiederebbe l’adesione della Russia allo Statuto di Roma: ragione per la quale il Comitato dei Ministri degli esteri del Consiglio d’Europa, sollecitati dalla cd. dichiarazione di Leopoli del 9 maggio 2025, ha avviato un percorso che dovrebbe condurre all’istituzione di un Tribunale speciale che se ne occupi.
Un altro limite è segnato dalla sostanziale discrezionalità delle policies di scelta dei casi da parte del Procuratore presso la Corte penale internazionale che ha fatto sì, per esempio, che le indagini sul caso afghano si concentrassero sui crimini dei talebani, trascurando gli abusi dei militari statunitensi.
2. Il libro fornisce informazioni importanti che possono aiutare il lettore ad orientarsi nell’acceso dibattito sull’esatta qualificazione delle condotte di Israele a Gaza, sottraendolo al furore delle contrapposte ideologie.
Gli autori ci fanno comprendere, anzitutto, le ragioni di questo furore, segnalando come convivano nella nozione di genocidio una dimensione strettamente giuridica, una dimensione storica ed una forte risonanza emotiva. Di qui il valore aggiunto di un volume curato da una giurista colta e da uno storico.
In questo quadro Fronza e Flores ci ricordano che:
a) il delitto di genocidio non era annoverato dallo Statuto di Norimberga e non fu perciò applicato alla Shoah che pure rappresenta, nella dimensione storica ed emotiva, l’archetipo del male assoluto;
b) quella carenza ci rimanda ad un dibattito della dottrina internazionalistica novecentesca, vividamente ricostruito da Philip Sands, nel bellissimo La strada verso est (Guanda, 2024), che vide quali protagonisti Rahael Lemkin, sostenitore della categoria del genocidio quale crimine contro i gruppi (nazionali, etnici, religiosi) e Hersch Lauterpacht, fiero avversario di quella categoria che riteneva sbilanciata in favore della tutela dei gruppi, anziché degli individui, e foriera di difficoltà probatorie e che perciò sosteneva, piuttosto, la categoria dei crimini contro l’umanità: un dibattito che vide prevalere le teorie di quest’ultimo, nonostante gli intensi sforzi di persuasione profusi da Lemkin (autore del fondamentale saggio nel collegio del procuratore Jackson;
c) il mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Netanyahu, Gallant e dei leader di Hamas non contempla il crimine di genocidio (si contestano crimini di guerra e contro l’umanità), mentre la Corte Internazionale di Giustizia (che, come precisano gli Autori, si occupa della responsabilità degli Stati e non degli individui), su impulso del Sud Africa, ha ritenuto “plausibile” una deriva genocidiaria delle condotte israeliane, ammonendo il governo di quel Paese.
Soprattutto però Fronza e Flores ci ricordano che il dibattito sulla qualificazione dei crimini di Israele è, nella prospettiva del diritto, meno rilevante di quanto suggeriscano i toni accesi del dibattito pubblico perché lo Statuto della Corte penale internazionale non sancisce gerarchie tra il genocidio e gli altri crimini di guerra o contro l’umanità e stabilisce una cornice edittale unica, nell’ambito della quale a fare la differenza sono le concrete modalità della condotta e la gravità delle sue conseguenze; e perché i crimini contro l’umanità annoverano figure come la starvation, lo sterminio, l’apartheid, le sparizioni forzate che, anche sul piano evocativo, possono qualificare adeguatamente certi fatti senza banalizzarli.
Nel contempo, il libro dissolve alcune delle principali obiezioni mosse dai sostenitori della natura non genocidiaria delle condotte israeliane, a partire da quella che fa leva sulla quantità (migliaia e non milioni) dei civili uccisi e sulla circostanza che, nel tempo della reazione, considerata la sua superiorità militare, Israele avrebbe potuto sterminare un numero ben maggiore di palestinesi se davvero avesse inteso distruggere quella entità (laddove la nozione convenzionale si accontenta dell’intenzione di distruzione parziale di «un gruppo nazionale, etnico, razziale religioso»).
In breve, gli autori ci ricordano che l’archetipo della Shoah non corrisponde alla fattispecie giuridica del genocidio che, infatti, è stata riconosciuta in casi (quantitativamente) meno gravi dello sterminio nazifascista degli ebrei, come il massacro dei tutsi in Ruanda, quello delle minoranze musulmane bosniache a Srebrenica (circa 8mila civili), e delle minoranze vietnamite, cinesi e cham in Cambogia; mentre l’elemento intenzionale genocidiario – escluso dai commentatori più vicini alle ragioni del governo di Israele – è seriamente indiziato da alcune dichiarazioni delle autorità israeliane riportate in un bel saggio di Didier Fassin (Une étrange défaite, La Découverte, 2024), nel quale si sottolinea anche la forte rilevanza sintomatica di alcune condotte come l’ostacolo ai soccorsi umanitari e all’operatività delle agenzie internazionali a ciò preposte.
Come dire che, sottratta agli stereotipi ideologici, agli slogan e alle semplificazioni dei social media, la questione definitoria si fa complessa, non consente prese di posizione emotive e svela come sia prematura e, forse, non immediatamente necessaria una presa di posizione critica nei confronti di esponenti del mondo ebraico - prime fra tutte, due sopravvissute alla Shoah come la senatrice a vita Segre e la scrittrice Edith Bruck - che, pur rifiutando l’etichetta genocidiaria, si sono già pronunciate, così come molti intellettuali israeliani, in termini inequivocabili sulla gravità e la sproporzione della reazione israeliana ai fatti del 7 ottobre.
3. Rifuggendo da ingenui entusiasmi, il libro esalta il valore irrinunciabile della giustizia penale internazionale come garanzia della soggezione degli Stati e dei governanti ai principi supremi del diritto umanitario, garanzia di eguaglianza tra occidente e oriente, tra nord e sud del mondo, tra Stati forti e Stati deboli, tra vincitori e vinti, una conquista che – insieme alla preminenza delle Costituzioni e alla necessità di presidiare il rischio della legge ingiusta - costituisce il portato più rilevante e irrinunciabile delle tragedie umanitarie del novecento: un’utopia necessaria e concreta, dicono gli autori, rifuggendo, ad un tempo, dal cinismo della realpolitik (il diritto internazionale che vale fino ad un certo punto; la guerra che non può non produrre morti) e dalla cecità verso i diversi segnali della crisi.
La narrazione è attraversata da diversi paradossi.
Proprio quando si emancipa dalla dimensione della giustizia dei vincitori la giustizia penale internazionale è sabotata: dalle sanzioni statunitensi contro il procuratore e i suoi collaboratori impegnati nelle indagini su Israele e sui crimini dei soldati americani in Afghanistan, dalla dichiarata indisponibilità di alcuni Paesi occidentali (Italia, Germania, Polonia, Francia) ad eseguire l’arresto di Netanyahu; dall’analoga indisponibilità di Paesi tradizionalmente o politicamente vicini alla Russia (Ungheria e Mongolia) di eseguire l’arresto di Putin; dai mandati di arresto emessi dalla Federazione russa nei confronti del Procuratore e di alcuni giudici della Corte.
Proprio nei confronti del male smisurato il diritto penale sembra incapace di esprimere quella funzione preventiva che sa esprimere, a livello domestico, nei riguardi di condotte assai meno gravi.
4. Attualizzando la massima di Luther King dalla quale abbiamo preso le mosse, gli autori non mancano di segnalare, alla luce dell’esperienza, la problematicità del rapporto tra giustizia e pace: se da un lato il rito della giustizia è condizione essenziale perché la soluzione dei conflitti sia in qualche modo accettata e condivisa dalle comunità, emarginando la vendetta (lo scempio di piazzale Loreto, le esecuzioni sommarie, il dileggio del cadavere di Gheddafi); dall’altro, le istanze della punizione possono ostacolare i processi di pace, che spesso esigono il coinvolgimento dei protagonisti del conflitto autori dei crimini, come avvenuto nel contesto del conflitto tra il governo ugandese e il Lord’s Resistance Army di Joseph Kony, dove il processo di pace fu interrotto dal mandato emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti di Kony.
Il libro apre così scorci sulle esperienze di giustizia transizionale e riparativa del Sud Africa e della Colombia, come tentativi, più o meno fortunati, di conciliare la messa al bando delle blanket amnesty per i crimini internazionali con le esigenze di pacificazione e di ripresa della convivenza nelle comunità attraversate da cruente guerre civili.
5. Condivisibile è, infine, l’argomentata analisi dei fattori politici e culturali che permeano uno spirito del tempo ostile al funzionamento della giustizia penale internazionale.
Le tendenze autoritarie e i rigurgiti sovranisti muovono gli Stati, anche appartenenti al novero delle democrazie occidentali, a recuperare gli spazi della politica e della ragion di Stato, pure a discapito dei vincoli illo tempore liberamente accettati[1].
L’approssimazione culturale indotta dai social e dalla disintermediazione delle espressioni politiche dei cittadini favorisce il rifiuto della complessità delle logiche del diritto e del processo che è chiamato a ricostruire verità affidabili, un rifiuto che ha talvolta derive giustizialiste, talaltra produce esiti di cinico lassismo.
A questo Zeitgeist non sembrano sottrarsi alcuni intellettuali, pur muniti di conoscenze storiche, per i quali «Leggi, trattati e tribunali possono stabilire quanto gli aggrada, tutto quanto sembra loro “giusto”, ma se il mondo ha deciso di andare da un’altra parte si può essere certi che ci andrà. Ora, da più di un secolo (in verità direi da sempre) la guerra colpisce in maniera più o meno indiscriminata le popolazioni civili. Non ne ricordo neppure una, e sfido chiunque a farlo, in cui ciò non sia accaduto»[2].
Forse nobilitandola, gli autori riconducono questa affermazione ad una logica hegeliana secondo la quale “tutto il reale è razionale”.
Può darsi sia così, ma allora si potrebbe dire lo stesso dei crimini domestici, anche più efferati, la cui repressione produce raramente risultati di stabile eradicazione.
È questa una prospettiva troppo cupa per essere supinamente accettata. Ed allora Fronza e Flores ci invitano, senza velleitarismo, a reagire coltivando l’utopia necessaria di una giustizia, anche internazionale, uguale per tutti.
[1] A tale proposito (p. 95), gli autori richiamano, riproducendola, la lettera aperta inviata il 22 maggio 2025 dai governi italiano e danese (con l’adesione dei governi austriaco, belga, ceco. Estone, lettone, lituano e polacco) alla Corte europea dei diritti dell’uomo, accusata di aver fornito interpretazioni dei diritti umani eccessivamente penalizzanti per la capacità dei leader di «prendere decisioni politiche nelle nostre democrazie…di proteggere le nostre società democratiche e le nostre popolazioni dalle sfide che il mondo di oggi ci pone», con riferimenti esemplificativi alla materia dell’espulsione dei cittadini stranieri criminali «in cui l’interpretazione della Convenzione ha portato alla protezione delle persone sbagliate e ha posto troppe limitazioni alla capacità degli Stati di decidere chi espellere dai propri territori».
[2] Ernesto Galli della Loggia, La guerra e i crimini di guerra, in «Corriere della Sera», 11 dicembre 2024.
Il volume di Marcello Flores ed Emanuela Fronza, Caos. La giustizia internazionale sotto attacco, Laterza, 2025 verrà presentato a Roma nel pomeriggio del 3 dicembre 2025 nell'ambito dell'incontro
IL DIRITTO INTERNAZIONALE NEL CAOS: L’IMPATTO DELLA CRISI DELL’OCCIDENTE SULLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
L'incontro è a cura dei Magistrati di Area Democratica per la Giustizia, Corte di cassazione.
Segreteria organizzativa: antonio.scalera@giustizia.it
Mercoledì 3 dicembre 2025, h. 15.00
Aula Magna – Facoltà Teologica Valdese Via Pietro Cossa n. 40 – ROMA oppure da remoto su piattaforma ZOOM https://us06web.zoom.us/j/.86426268125?pwd=9qRXcUb3aNCGff2INQJQYrQNrLENOa.1 ID riunione: 86423238125 codice accesso: 016651

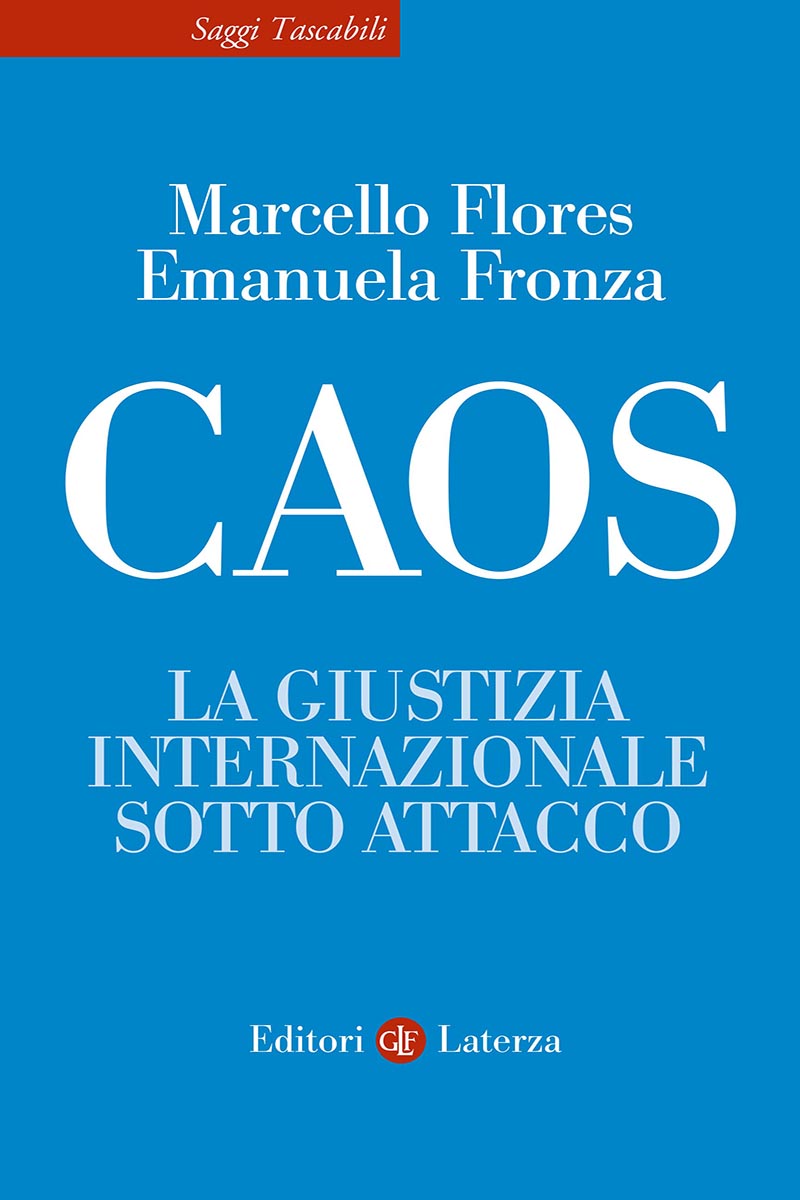
Marcello Flores - Emanuela Fronza, Caos. La giustizia internazionale sotto attacco, Laterza, 2025.
Era un venerdì come tanti quel terribile 13 novembre del 2015, giorno in cui Parigi è stata teatro degli attentati terroristici al Bataclan, allo Stadio di Francia e presso alcuni bistrot della città.
Centotrenta i morti e trecentocinquanta i feriti.
I numeri (impressionanti) non raccontano le storie di quei ragazzi e ragazze le cui vite sono state spezzate mentre si godevano momenti di spensieratezza: una passeggiata, un aperitivo o un concerto.
Erano le 21: 20 e al Bataclan gli Eagles of Death Metal stavano suonando la canzone Kiss the Devil (“Io amo il Diavolo, amo cantare la sua canzone, amerò il Diavolo e la sua canzone”) quando una scarica di proiettili ha atterrato centinaia di corpi.
Forse solo un altro terribile scherzo del destino, o forse gli attentatori avevano studiato in anticipo la scaletta (chissà); certamente quel famoso V13 non il Diavolo ma la parte più oscura dell’essere umano ha fatto ingresso in un luogo ove allegria, musica e leggerezza fino a quel momento erano stati gli unici ospiti graditi.
Quegli eventi hanno squarciato non solo la Francia, ma tutta l’Europa. Una ferita profonda che nel corso degli anni è stata al centro di dibattiti ed oggetto di riflessioni da parte di storici, esperti di geopolitica, giornalisti e non solo.
Nel 2022 la penna illuminata di Emmanuel Carrère ha dato luce a V13, un’opera difficilmente catalogabile nei canonici generi letterari, ma con un impatto emotivo che lascia il segno .
Un resoconto delle udienze del processo ai complici e all’unico sopravvissuto tra gli autori del massacro; un processo a cui l’autore ha assistito per una decina di mesi e di cui ha riferito in articoli settimanali, rielaborati poi nel libro.
Il racconto si apre l’8 settembre 2021 quando all’ Île de la Cité, nel pieno centro di Parigi, nel tribunale sito tra la Sainte-Chapelle e il quai des Orfèvres, in un’aula appositamente costruita, inizia il processo. Nella prima parte (forse la più toccante) sono presentate le parti civili, “feriti, congiunti, persone offese”; parlano i sopravvissuti o i parenti degli uccisi, le cui testimonianze fanno vivere le scene orribili e strazianti dell’attacco, i vissuti di chi lo ha subito, le conseguenze devastanti e permanenti in chi è rimasto in vita.
Tra le vittime di quella strage c’era anche un’italiana, Valeria Solesin, giovane ricercatrice veneziana di 28 anni, simbolo di una generazione europea che vede oltre i confini territoriali una opportunità e sogna la libertà, la ricerca e gli scambi, umani e culturali.
Valeria, come tanti, credeva in una Europa aperta e inclusiva: uno spazio dove viaggiare, sperimentare e confrontarsi.
Quel progetto non è fallito, ma occorre accettare il fatto che sia stato tradito da persone che sono cresciute e vissute in Europa proprio grazie a quell’idea inclusiva; un’idea che hanno volontariamente deciso di sporcare con il sangue di corpi innocenti.
È innegabile che ciò faccia male, a tutti.
Lo spiega bene la testimonianza di Nadia Montagner, madre di Lamia, uccisa in un bistrot di boulevard Voltaire, a centocinquanta metri da casa: “Pensare che quelli che l’hanno uccisa avevano la sua età. L’età di tutti loro, tra i venticinque e i trent’anni. Che sono stati accompagnati a scuola tenendoli per mano, come lei accompagnava Lamia, tenendola per mano. Erano dei bambini che venivano tenuti per mano.”
Salah Abdeslam, l’unico degli attentatori sopravvissuti (condannato all’ergastolo all’esito del processo nel quale, senza essere creduto, ha riferito: “ho rinunciato a far esplodere la mia cintura per umanità”) è nato il 15 settembre 1989 a Bruxelles, in Belgio ed è cresciuto nel quartiere di Molenbeek – Saint Jean. Figlio di genitori marocchini, immigrati in Belgio negli anni ’70, ha vissuto in una famiglia normale e rispettata nel quartiere . Salah aveva due fratelli, tra cui Brahim Abdeslam, che ha partecipato agli attentati di Parigi e si è fatto esplodere in un bar la sera del 13 novembre.
Salah ha frequentato un istituto tecnico e poi, per un periodo, ha lavorato per la compagnia dei trasporti pubblici di Bruxelles. In seguito, con il fratello, Salah ha gestito un bar a Bruxelles e solo nel 2014-2015 ha iniziato un percorso di radicalizzazione islamista.
La sua biografia pone tanti interrogativi sulla evoluzione del pensiero verso la scelta finale. Né le indagini, né il processo hanno consentito di comprendere – prima ancora che accertare – cosa abbia indotto Salah, suo fratello ed altri giovani ragazzi “normali” a organizzare, nel nome dello Stato islamico, un commando armato che ha seminato solo morte e terrore.
Ed allora occorre indagare il mistero del male, della radicalizzazione e della colpa, senza temere di non saper trovare risposte ai molti interrogativi che la vicenda ha posto nella mente di ciascuno di noi.
Interrogativi sulla esistenza umana, ma anche sulla stessa funzione del linguaggio, della memoria e dello stesso processo penale.
Nel tribunale parigino la giustizia si è trasformata in rito civile: il processo non solo quale strumento verso la punizione, ma quale senso del dolore che trova posto al centro di Parigi ( nella “scatola bianca” costruita ad hoc per celebrare il processo), perché è al centro dell’attenzione, anche mediatica, che deve essere ricollocato, così come prima è stato protagonista il terrore.
E poi vi è il trauma collettivo ed il tentativo di una società intera di “processare” un evento che è contemporaneamente causa ed epilogo.
In questa prospettiva il linguaggio diventa la stampella della memoria e la parola diviene l’unico strumento per affrontare l’orrore.
È ancora la voce di Nadia, la mamma di Lamia, a descrivere il dolore per la perdita della figlia in modo lucido e realistico: “Allora si è aperta una botola. Siamo stati risucchiati, ingoiati dal fondo di una stiva. Al di sopra sul ponte gli altri continuano ad agitarsi. Noi non facciamo più parte di questo mondo con il quale pochi minuti prima eravamo in empatia. Non ho urlato. In me è venuta una dissociazione. Era irreale e reale”.
È reale ammettere che anche noi, quali spettatori non protagonisti, abbiamo provato spaesamento e dubitato dell’idea che la sicurezza di tutti abbia come presupposto le parole accoglienza e integrazione.
Dobbiamo ammettere che quell’attentato ha spezzato anche la nostra empatia verso il mondo ed il genere umano. Ma da quello strappo occorre ripartire per non far sì che la strategia del terrore porti con sé, come strascico, la risposta dell’odio.
Lo strazio subito dalle vittime, il dolore dei loro familiari e lo stress post-traumatico con il quale convivono i sopravvissuti devono responsabilizzare tutti per perseguire e perseverare in quella strada di apertura e integrazione.
Nel giorno della commemorazione delle vittime (la parola anniversario – come ha ricordato un sopravvissuto in una recente intervista pubblicata su La Repubblica – suona troppo allegra) è stato inaugurato il “Jardin du 13 novembre 2015”, un nuovo spazio verde nel cuore di Parigi dedicato al ricordo delle stragi.
Un luogo che oltre ad essere simbolo della memoria si auspica diventi spazio di incontro e convivialità: tutto può ripartire da un giardino, come progettualità di una effettiva integrazione che inizia dalle strade, dai bar, dagli stadi e dai teatri.
Forse anche un piccolo gesto quotidiano può divenire un vero atto politico, un grido contro la paura in grado di lenire una ferita collettiva che (forse) non sarà mai completamente rimarginata.
Mi piace immaginare che in quel giardino ci sia una panchina in cui tra qualche giorno potrà sedersi una giovane e brillante ricercatrice italiana, giunta a Parigi per inseguire i propri sogni e con lo sguardo trasparente di chi intravede nell’altro una opportunità e non un pericolo.
E nel frattempo al Bataclan si suona ancora.
Con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a chiarire i dubbi interpretativi conseguenti alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 (“Decreto Cutro”), che aveva soppresso, dall’art. 19, comma 1.1, T.U. Immigrazione, ogni riferimento esplicito alla tutela della vita privata e familiare dello straniero, ha fornito un chiarimento di particolare rilievo in materia di protezione speciale.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Venezia, nell’ambito del procedimento promosso da un cittadino senegalese al quale la Commissione territoriale di Verona–Padova aveva negato ogni forma di protezione internazionale e speciale, ritenendo non credibile la narrazione della conversione religiosa addotta come causa di persecuzione ed insussistenti i presupposti di forme complementari di protezione.
Tre pilastri e una clausola sempre aperta
La Cassazione, con ampia ricostruzione sistematica, ha ricordato che il sistema italiano di protezione dello straniero poggia su tre pilastri: lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione complementare, quest’ultima di matrice interna e fondata su una clausola elastica di salvaguardia dei diritti fondamentali. Pur non trovando diretta disciplina nel diritto dell’Unione, tale protezione resta pienamente legittima anche alla luce della disciplina di attuazione del cd. Patto sull’immigrazione (reg. UE n. 1347 e 1348/2024), che riconosce agli Stati membri la facoltà di accordare status umanitari nazionali su presupposti diversi dalle forme di protezione internazionale già previsti.
Nessun arretramento dei diritti fondamentali
Nel merito, la Corte ha escluso che le modifiche del 2023 abbiano ridotto la portata della tutela. Il rinvio, tuttora presente nell’art. 19 T.U.I. all’art. 5, comma 6 — che impone il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano — consente di ricomprendere nel divieto di espulsione e respingimento anche il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dagli artt. 8 CEDU e 7 Carta di Nizza, oltre che dagli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.
Secondo la Corte, l’abrogazione delle frasi che esplicitavano tali tutele non ha “forza né significato” di precludere l’applicazione di norme e principi di rango sovraordinato, che restano vincolanti in virtù del combinato disposto degli artt. 10 e 117 Cost. e della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 194/2019).
Continuità con il diritto vivente
La decisione riafferma la continuità con gli orientamenti di legittimità sviluppati a partire da Cass. n. 4455/2018 e dalle Sezioni Unite n. 24413/2021, secondo cui il giudizio sulla protezione deve fondarsi su una valutazione comparativa tra la condizione del richiedente in Italia e quella cui verrebbe esposto nel Paese d’origine. L’inserimento sociale e lavorativo, la durata del soggiorno, i legami familiari e l’effettiva integrazione costituiscono indicatori significativi di una “vita privata e familiare” meritevole di tutela, purché la loro compromissione, in caso di rimpatrio, determini un sacrificio sproporzionato dei diritti fondamentali della persona.
Nel rapporto tra fonti interne di diverso rango e fonti convenzionali la Corte ribadisce che “il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009). Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell’osmosi tra gli stessi, secondo una logica di “et et”, non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco”.
E dunque che “non può seguirsi la tesi secondo cui i titolari del diritto convenzionale di cui all’art. 8, nella lettura offerta dalla Corte Edu, sarebbero esclusivamente i settled migrants, con esclusione delle cittadine e dei cittadini stranieri, magari in Italia da un tempo non breve e apprezzabilmente significativo, che siano in attesa dell’esame della loro domanda di protezione internazionale”.
Il principio di diritto
In conclusione, la Corte formula il principio secondo cui:«Anche successivamente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, il cittadino straniero ha diritto alla protezione complementare allorché ricorrano i presupposti per la tutela del diritto alla vita privata e familiare, secondo l’interpretazione dell’art. 8 CEDU fornita dalla giurisprudenza di legittimità.», salvo il riscontro di ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, se prevalenti.
Un segnale di continuità
La sentenza n. 29593/2025 assume dunque un valore sistemico: riafferma che la legge ordinaria non può comprimere il nucleo dei diritti fondamentali della persona straniera, garantendo continuità al principio di proporzionalità e al bilanciamento tra sovranità statuale e dignità umana.
Per questo «Il giudice dovrà compiere l’operazione sussuntiva con rigore e, allo stesso tempo, con umanità. Con rigore, perché la condizione di vulnerabilità derivante dallo sradicamento da una vita familiare in atto o da un’integrazione sociale realizzata o in corso di realizzazione nel territorio nazionale deve essere effettiva. (….. ) Ma anche con umanità, perché, quando viene in rilievo la persona umana in situazioni talora di estrema fragilità con la sua fondamentale esigenza di solidarietà, il giudice, nell’interpretare e nel dare applicazione alle disposizioni poste dal legislatore, concorre, nel dove-roso rispetto dell’equilibrio tra la forza orientativa della fonte sovraordinata e il vincolo del testo, alla elaborazione di una norma giusta.»

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
