
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Pubblichiamo questo contributo in occasione del centenario della morte del Maestro Giacomo Puccini, nato a Lucca il 22 dicembre 1858 e scomparso a Bruxelles il 29 novembre 1924.
All’alba vincerò!
La vittoria di Giacomo Puccini sul tempo. PARTE PRIMA.
di Gerardo Casiello
Sommario: 1. Sei generazioni di musicisti – 2. Trenta chilometri a piedi per Aida – 3. Anni difficili a Milano – 4. Tonio Puccini e la fine di una stirpe di musicisti – 5. Un miracolo a Milano – 6. Le Villi, l’esordio operistico di Puccini – 7. L’influenza di Wagner – 8. Edgar: “la cosa più orribile che sia mai stata scritta” – 9. Anni difficili alla vigilia della gloria – 10. In anticipo sulla musica per il cinema – 11. Puccini e i suoi contemporanei – 12. Bohème: una sfida tra amici – 13. Il gioco e la caccia – 14. Caruso e Puccini: due amici ambasciatori dell’Italia nel mondo – 15. E lucean le stelle – 16. Il grammofono di casa Puccini – 17. Puccini e le “sue donne” – 18. Madama Butterfly – 19. Un fortunatissimo fiasco. [Seguirà PARTE SECONDA].
All’alba del primo quarto di secolo di questo millennio, si può dire che il Maestro Giacomo Puccini ha vinto la battaglia contro il tempo; la sua anima nella sua musica vive ancora oggi nel 2024, a cento anni dalla sua morte, e sopravvivrà nei tempi a venire.
Questo scritto ripercorre la “vicenda” biografica del grande Maestro Toscano condensando gli eventi salienti anche attraverso aneddoti, estratti da lettere e citazioni dello stesso compositore. È fondamentale parlare della produzione operistica del Maestro sia per dare al lettore un’infarinatura sulla trama e i caratteri salienti di ciascun lavoro, sia perché nelle opere si può riscontrare l’essenza profonda della vita di Puccini.
Nella chiusura di questo saggio si lancia un’idea per rendere un originale omaggio all’immortale compositore e alla sua italianità.
1. Sei generazioni di musicisti.
Giacomo Antonio Domenico Michele Secondo Maria Puccini, per brevità Giacomo, nacque a Lucca il 22 dicembre 1858; il suo lungo nome porta la memoria dei suoi avi, una stirpe di musicisti che per 124 anni furono direttori musicali della Cattedrale di San Martino a Lucca.
A soli cinque anni, nel 1864, Giacomo divenne orfano del padre Michele, la madre Albina Magi si trovò sola a crescere sette figli.
Nonostante le difficoltà economiche, l’educazione musicale di Giacomo gli fu assicurata dal suo incarico di chierichetto e successivamente di organista presso la chiesa della Confraternita di San Girolamo, occupazione retribuita che mantenne dal 1872 al 1880; frequentò inoltre la Scuola di Musica Pacini a Lucca dove insegnavano lo zio Fortunato Magi e il Maestro Carlo Angeloni.
Secondo lo zio, Giacomo non aveva particolari attitudini musicali, era un allievo poco attento e indisciplinato; il Maestro Carlo Angeloni intravvedeva invece nel ragazzo un’importante propensione per la melodia e un acuto intuito armonico.
Essendo organista e passando molto tempo in chiesa, Giacomo iniziò a trafugare i preziosi spartiti musicali conservati nell’archivio parrocchiale per studiarli a casa. Un giorno fu scoperto dai preti che furono però colpiti dalla sua grande dedizione e gli fu dunque permesso di prendere in prestito le partiture in modo appropriato.
2. Trenta chilometri a piedi per Aida.
Il 1876 fu l’anno in cui arrivò la svolta: l’adolescente Puccini camminò, per 30 chilometri, da Lucca a Pisa per assistere a una rappresentazione di Aida di Giuseppe Verdi. Poté permettersi solo un biglietto per i posti in piedi, ma l’esperienza gli cambiò la vita. In seguito disse: «Quando ho sentito Aida a Pisa, ho sentito che una finestra musicale si era aperta per me». Quella rappresentazione lo rapì al tal punto da convincerlo a intraprendere una carriera nell’opera lirica piuttosto che diventare un organista di chiesa come i suoi antenati.
Convinto di voler percorrere la strada dell’operista, chiese una borsa di studio alle autorità lucchesi per trasferirsi a Milano e studiare al Conservatorio, ma non gli fu accordata secondo la seguente motivazione: «… perché sostenere, con denaro pubblico, un musicista dal quale la città non ricaverebbe alcun beneficio?...». Il Comune di Lucca voleva che Giacomo continuasse la tradizione di famiglia.
3. Anni difficili a Milano.
Dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto Musicale Pacini e grazie alla tenacia della madre Albina, Giacomo ottenne una modesta borsa di studio dalla Regina Margherita; nel 1880 poté iscriversi al Conservatorio di Milano per studiare composizione con Antonio Bazzini e Amilcare Ponchielli. Furono anni di sacrifici e stenti, proprio quel tipo vita che anni dopo avrebbe immortalato nella sua opera Bohème; era uno studente squattrinato ma ricco di ambizioni, talento e non poca paura di fallire. Così scriveva alla sorella Ramelde il 9 dicembre 1880: «[…] L’abbuono alla Scala è 130 lire per il carnevale e quaresima, che roba […] maledetta miseria! […]»; e in una lettera del primo dicembre alla madre:
«[…] Avrei bisogno di una cosa ma ho paura a dirgliela, perché capisco anch’io Lei non può spendere. Ma stia a sentire, è roba da poco. Siccome ho una gran voglia di fagioli (anzi un giorno me li fecero ma non li potei mangiare a cagione dell’olio che qui è di sezamo o di lino!), dunque, dicevo… avrei bisogno di un po’ d’olio, ma di quello nuovo. La pregherei di mandarmene un popoino. Basta poco, l’ho promesso di farlo assaggiare anche a quelli di casa. Dunque se le mie geremiadi frutteranno, mi farà la gentilezza (come l’ungo, già si parla d’olio) di mandarmene una cassettina, che costa quattro lire […] Qui fanno opere a tutto andare, ma io nulla… Mi mangio le mani dalla bile! […]»
Nonostante le ristrettezze il giovane Puccini era costante negli studi e frequentatore assiduo dei circuiti musicali e intellettuali milanesi insieme ai suoi compagni di conservatorio tra i quali Pietro Mascagni, con il quale condivideva anche l’alloggio.
Gli incontri precoci di Puccini con la povertà e la miseria, non solo condizionarono la sua vita, ma influenzarono profondamente anche i temi e le risonanze emotive delle sue composizioni, in particolare in opere come Bohème e Tosca.
La familiarità con le difficoltà economiche gli permise in seguito di ritrarre in modo autentico la vita della gente comune. L’integrazione delle esperienze personali nel suo lavoro di composizione contribuirono a spingerlo oltre lo stile verista dei suoi amici Mascagni e Leoncavallo, e a sottolineare emozioni e situazioni della vita reale.
Nel 1883 conseguì il diploma in composizione e Carpiccio sinfonico, l’elaborato che presentò alla commissione, fu accolto con entusiasmo riscuotendo poi successo e notorietà negli ambienti musicali milanesi.
Nel 1884 iniziò una relazione con la lucchese Elvira Bonturi; la donna, già madre di due figli, Fosca e Renato, era sposata con Narciso Gemignani, ricco commerciante di Lucca. Fu proprio il Gemignani, marito poco fedele, a consigliare alla moglie di prendere lezioni di pianoforte dal suo amico d’infanzia Puccini. Fu durante uno dei lunghi viaggi lavorativi di Narciso che Elvira e Giacomo divennero amanti. La relazione dei due destò grande scandalo nella provinciale Lucca tanto da costringere la coppia a trasferirsi a Monza e poi a Milano portando con loro Fosca, lasciando con il padre il piccolo Renato del quale oggi non si hanno notizie; non si poteva più nascondere la gravidanza di Elvira incinta di Antonio, detto Tonio, che sarebbe nato il 22 dicembre del 1886.
4. Tonio Puccini e la fine di una stirpe di musicisti.
Il rapporto di Puccini con il figlio fu molto complesso e per alcuni versi anche turbolento. Giacomo fu sempre un padre molto severo nonostante amasse profondamente il figlio; alla severità di Puccini si contrapponeva l’eccessiva premura di Elvira che invece fu sempre molto permissiva. Puccini capì che la stirpe di musicisti si sarebbe fermata con lui quando, avendo regalato a Tonio un violino per invogliarlo a studiare musica, vide che il bambino aveva trasformato lo strumento in una simpatica barchetta che faceva galleggiare nell’acqua. Il rapporto di Tonio con il padre fu molto difficile a causa della schiacciante personalità di Giacomo che difficilmente approvava le scelte e i desideri del giovane; lo raccomandò personalmente per numerosi lavori, tutti rifiutati da Tonio che invece era dedito alla “bella vita”. Puccini disapprovò sempre pesantemente le relazioni amorose del figlio e a questo si può ricondurre anche il difficile rapporto che il compositore aveva con Elvira che divenne sua moglie solo nel 1904, dopo la morte di Narciso Gemignani.
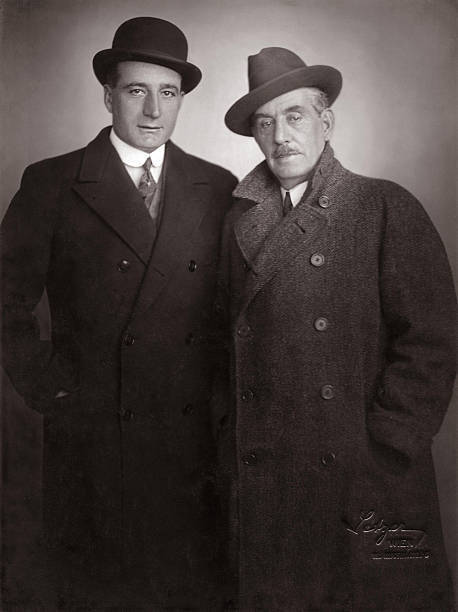
[Antonio e Giacomo Puccini]
5. Un miracolo a Milano.
La Milano degli studi di composizione al Conservatorio, degli stenti e dei sacrifici fu anche la Milano delle opportunità: grazie alle sue frequentazioni ebbe modo di conoscere l’editore Giulio Ricordi, proprietario della storica casa editrice Ricordi che aveva promosso la realizzazione di opere liriche importanti della tradizione italiana, e che contribuì alla gloria di compositori quali Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi.
Giulio Ricordi intuì subito il grandissimo talento drammaturgico di Puccini che lo differenziava dai musicisti a lui coevi quali Mascagni e Leoncavallo. C’è una simpatica leggenda dietro all’opera d’esordio Le Villi: nel 1883, qualche mese dopo il suo diploma in composizione, su suggerimento del maestro Amilcare Ponchielli, Puccini partecipò a un concorso indetto dalla casa editrice Sonzogno per il finanziamento e la messinscena di una nuova opera.
Compose la musica, tra giugno e dicembre, per il libretto già scritto dal poeta e scrittore Ferdinando Fontana.
La giuria giudicatrice, composta dallo stesso Ponchielli e altri maestri vicini a Giulio Ricordi, non assegnò il premio a Puccini ma a Guglielmo Zuelli in ex-aequo con Luigi Mapelli; Giacomo Puccini non fece così parte della scuderia Sonzogno e Ricordi, grazie alla sua “manovra editoriale”, poté avere il tempo di lavorarsi il giovane talento.
Fontana, già in accordo segreto con Giulio Ricordi, organizzò un ascolto privato dell’opera presso la casa del giornalista e critico Marco Sala, alla presenza di numerosi intellettuali, scrittori e musicisti della Milano di quegli anni, tra i quali Arrigo Boito, Alfredo Catalani e l’editrice Giovannina Lucca. L’ascolto destò grande interesse tra i presenti che, sempre sotto la guida di Giulio Ricordi, organizzarono una raccolta fondi per la messinscena dell’opera.
6. Le Villi, l’esordio operistico di Puccini.
La prima rappresentazione de Le Villi si tenne presso il teatro Dal Verme di Milano il 31 maggio 1884 ed ebbe un immediato successo di pubblico e di critica; solo qualche giorno dopo, l’otto maggio, Giulio Ricordi concluse la sua “operazione editoriale” contro la rivale Sonzogno acquistando i diritti dell’opera di Puccini e annunciando sarcasticamente «[…] un’altra delle opere presentate al concorso del “Teatro Illustrato” (la rivista di Casa Sonzogno) che non ebbero né premio né menzione[…]».
La trama de Le Villi è ispirata alle leggende nord europee sulle donne abbandonate che cercano vendetta.
La storia è ambientata nella Foresta Nera dove, dinanzi alla modesta casa di Wilhelm Wulf, si sta celebrando il fidanzamento tra Anna, figlia di Wulf, e il giovane Roberto. Il protagonista partirà presto alla volta di Mainz per riscuotere un’eredità ma lì sarà coinvolto in una storia di passione con un’altra donna dimenticando completamente Anna che, morta di dolore, si trasforma in una villi, ossia uno spirito vendicativo. Abbandonato poi dall’amante, Roberto fa ritorno alla foresta Nera ma viene travolto dal fantasma di Anna che lo costringe in una vorticosa danza mortale, vendicandosi così per il suo tradimento.
Dato l’immediato successo dell’opera, tra il 1884 e il 1889, Puccini rimaneggiò più volte la partitura portando l’atto unico originario a due atti e inserendo la romanza di Anna Se come voi piccina e il monologo di Roberto Per te quaggiù sofferse ogni amarezza, assenti nell’originale. Fu aggiunta anche una quartina corale durante l’intermezzo L’abbandono e ampliata la scena finale.
7. L’influenza di Wagner.
Sin dalla prima opera, una grande presenza nell’arte pucciniana fu Richard Wagner.
L’influenza di Wagner su Le Villi è evidente in vari aspetti compositivi e drammaturgici. Puccini, grande ammiratore del compositore tedesco, incorporò l’uso dei Leitmotiv e una struttura sinfonica fortemente legata al “dramma musicale”.
L’uso dei leitmotiv ossia di frasi musicali associate a personaggi, eventi o emozioni permise a Puccini di creare connessioni emotive più profonde e continuità tematiche all’interno delle sue opere, migliorando così la narrativa drammatica.
Il preludio de Le Villi presenta riferimenti diretti al Parsifal di Wagner, evidenziando così l’adozione di tecniche armoniche ardite e innovative poco usuali nell’opera lirica tradizionale italiana. La narrazione e l’impianto drammatico seguono anch’essi i modelli wagneriani, utilizzando gli impasti timbrici orchestrali e i motivi melodici per sottolineare il carattere dei personaggi e rendendo così più fluido lo svolgimento del dramma.
Già nella sua prima opera Puccini inserì tutti gli elementi stilistici che, evolvendo con il tempo e l’esperienza, divennero poi un marchio di fabbrica; enfatizzò l’orchestra come elemento centrale della narrazione utilizzandola, non come semplice accompagnamento ai cantanti, ma per creare trame ricche che supportassero le linee vocali migliorandone l’impatto emotivo, ponendo grande attenzione ai sentimenti umani.
Puccini si mosse dunque verso una forma musicale più continua, integrando recitativo e aria in un flusso senza soluzione di continuità.
Mentre Wagner era votato al realismo psicologico dei suoi personaggi, Puccini era concentrato a riflettere le emozioni interiori dei personaggi affidandole alla sua grande abilità melodica e all’innata attitudine drammaturgica.
Le Villi fu rappresentata in tutto il mondo e diretta da grandissimi maestri tra i quali Gustav Mahler.
8. Edgar: “la cosa più orribile che sia mai stata scritta”.
La consacrazione mondiale doveva però ancora arrivare. Puccini era ormai un compositore di casa Ricordi e Giulio lo sostenne economicamente e moralmente nei periodi di difficoltà prima del grande successo internazionale che arriverà solo nel 1893 con Manon Lescaut.
Fu Ricordi ad affidargli il libretto di Edgar scritto da Ferdinando Fontana tratto dal romanzo La coupe et les lèvres di Alfred de Musset.
La composizione dell’opera ebbe una gestazione molto difficile anche a causa di quell’insicurezza che accompagnò Puccini per tutto il suo percorso artistico; la composizione iniziò quasi subito dopo il debutto de Le Villi e si trascinò fino ai primi mesi del 1889; fu rappresentata per la prima volta il 21 aprile dello stesso anno presso il Teatro Alla Scala di Milano riscuotendo un tiepido successo.
L’opera è ambientata in un villaggio nelle Fiandre; qui il giovane Edgar è diviso tra l’amore per la dolce Fidelia e la passione carnale per la provocante Tigrana, ragazza dal passato misterioso. Gli atteggiamenti irriverenti di costei, che intona una canzone blasfema davanti alla chiesa nel bel mezzo della messa, suscitano lo sdegno degli abitanti del villaggio ed Edgar accorre in sua difesa e, in preda a un’irrefrenabile esaltazione, afferra una torcia accesa e appicca il fuoco alla propria casa fuggendo poi con Tigrana verso una vita di dissolutezze. I due amanti si ritrovano poi a vivere in un ricco castello, passando da un piacere all’altro. Ben presto però il ricordo di Fidelia e della vita semplice trascorsa nel proprio villaggio cominciano a tormentare Edgar; il giovane decide così di riscattarsi arruolandosi nelle truppe che andavano in battaglia.
I soldati sono guidati da Frank, fratello di Fidelia, anch’egli in passato sedotto da Tigrana; durante una cruenta battaglia Edgar risulta disperso. Al villaggio si preparano poi le esequie del compianto Edgar ma un misterioso frate ne infanga la memoria suscitando l’ira di Fidelia; il frate, d’accordo con Frank, offre grandi ricchezze a Tigrana in cambio della denigrazione pubblica di Edgar. Gli attacchi al defunto suscitano l’indignazione dei compaesani che profanano il catafalco scoprendo l’assenza della salma; il misterioso frate, toltosi il cappuccio, si rivela essere Edgar e Tigrana, accecata dall’ira si lancia su Fidelia pugnalandola a morte.
Come già successo per Le Villi, Puccini rimaneggiò più volte l’opera, composta in principio da quattro atti poi ridotti poi a tre, non trovando mai completa soddisfazione. Nonostante l’opera non fosse amata da Puccini perché insoddisfatto del lavoro, «[…] la cosa più orribile che sia mai stata scritta […]», così definì il finale del secondo atto, Edgar rappresenta un lavoro importante del giovane Giacomo verso la maturità artistica.
9. Anni difficili alla vigilia della gloria.
La sua relazione tumultuosa con Elvira e la morte della madre, avvenuta nel 1884, influenzarono profondamente il suo stato emotivo e creativo. Questi eventi portarono a una maggiore introspezione nei temi dell’amore e della redenzione presenti nell’opera, riflettendo le sue esperienze di conflitto interiore, desiderio e peccato. Inoltre, il dramma psicologico dei personaggi può essere visto come un riflesso delle sue stesse tensioni affettive e delle sue fragilità.
Già dall’estate del 1889, tra un rimaneggiamento e l’altro di Edgar, Puccini si mise a lavoro per la composizione di una nuova opera; Ricordi aveva messo sotto contratto i librettisti Marco Praga e Domenico Oliva per lavorare sul soggetto tratto del romanzo di Prévost intitolato Storia del cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut.
Nonostante dallo stesso soggetto fosse già stata tratta un’opera intitolata Manon, messa in scena con la musica di Jules Massenet e il libretto Mehilac e Gille, Puccini si calò anima e corpo nella composizione.
Essendo sempre insoddisfatto delle liriche, non ebbe facile rapporto con i librettisti Praga e Oliva che passarono la scrittura ad altri intellettuali tra i quali Ruggero Leoncavallo, non ancora affermato come musicista e poi infine a Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. Si può infine dire che il vero librettista di Manon Lescaut fu proprio Puccini che riuscì a cucire, con l’aiuto di Ricordi, il meglio dei testi più confacenti alla musica che andava via via componendo.
L’eco di Wagner è molto forte pure in quest’opera, anche per il fatto che Giulio Ricordi affidò a Puccini la riduzione per pianoforte de I maestri cantori di Norimberga e Giacomo dovette recarsi, nel luglio del 1889, a Bayreuth per assisterne ad una rappresentazione.
Ricordi svolse un ruolo fondamentale nella consacrazione di Giacomo Puccini come erede di Giuseppe Verdi attraverso strategie editoriali e promozionali:
organizzò la prima di Manon Lescaut presso il Teatro Regio di Torino il primo febbraio del 1893, solo otto giorni prima del debutto di Falstaff, l’ultima opera di Giuseppe Verdi, al Teatro Alla Scala, creando così un parallelo simbolico tra i due compositori e consacrando Puccini come nuovo compositore di punta dell’opera italiana a livello internazionale e futuro erede di Verdi.
Il pubblico di Torino reagì con grandissimo entusiasmo a Manon Lescaut destando grande interesse anche nella critica specializzata; George Bernard Shaw elogiò Puccini sottolineandone la sua unicità. I critici lodarono la “potente concezione musicale” e l’abilità di Puccini nel fondere melodie evocative con una drammaturgia incisiva, capace di esprimere emozioni profonde senza contorsioni artistiche. La sua scrittura orchestrale, densa e ricca, contribuì a creare un’atmosfera intensa mentre i temi musicali accompagnavano e amplificavano la narrazione.
La scrittura musicale evita le strutture rigide dei numeri tradizionali per una melodia continua che va a favorire una narrazione più fluida; l’utilizzo timbrico della compagine orchestrale riesce così a rendere al meglio gli stati emotivi dei personaggi integrando al meglio il tutto con l’azione scenica.
Puccini, per sostenere ancor di più la drammaturgia, inserisce anche elementi stilistici tipici del Settecento e del romanticismo.
L’opera fu diretta da Alessandro Pomè e interpretata da Cesira Ferrani e Giuseppe Cremonini Bianchi nei ruoli di Manon e Des Grieux.
La vicenda si svolge ad Amiens, alle porte di Parigi nei pressi di un’osteria dove sono radunati degli studenti che scherzano sul tema dell’amore; giunge sul piazzale una carrozza dalla quale scendono la bella Manon, ragazza destinata alla vita monastica e il fratello Lescaut. Il giovane Renato Des Grieux si innamora perdutamente di Manon e riesce a strapparle un appuntamento. Lescaut vuole dare in sposa la sorella al vecchio e ricco Geronte ed escogita dunque un piano per rapire Manon ma viene scoperto dal giovane studente Edmondo che riferisce subito a Des Grieux che, a sua volta, convince Manon a scappare con lui. Stanca poi della vita modesta condotta con Renato, Manon cede alla vita di lusso di Geronte e si rifugia da lui.
L’insoddisfazione di Manon la porta poi a stancarsi anche della vita agiata e, durante un ricevimento nella lussuosa casa di Geronte, è in preda ad una crisi di nervi così il fratello fa chiamare Des Grieux che giunge al palazzo. Alla vista di Manon, Renato dimentica le sofferenze passate e si getta tra le sue braccia; nell’istante in cui la ragazza apprende che Geronte l’ha denunciata per furto, cerca di fuggire ma viene arrestata dai gendarmi.
Nella prigione di Le Havre Manon attende di essere deportata in America; Renato non si rassegna a perdere la sua amata e convince il sergente a lasciarlo imbarcare insieme a lei; giunti poi oltre oceano Manon muore lasciando Des Grieux nella totale disperazione.
10. In anticipo sulla musica per il cinema.
Possiamo dire che con Manon Lescaut Puccini abbia posto basi solide sulle quali costruire la futura drammaturgia cinematografica; non è un caso che la musica e l’approccio drammaturgico del Maestro toscano siano stati studiati, assimilati e talvolta anche trafugati dai compositori contemporanei di musica per il cinema. Un esempio è l’Intermezzo proprio da Manon Lescaut che ha fortemente ispirato John Williams nella composizione e orchestrazione del tema principale della famosa saga Star Wars, un’ ispirazione ai limiti del plagio.
Giacomo Puccini, grazie al grandissimo successo internazionale della sua ultima opera, comprese di aver scoperto le “formule giuste” e trovato il suo modo di lavorare; aveva allestito il suo laboratorio ben attrezzato dove poter inventare e sperimentare.
Nelle opere successive si ritroveranno tutti gli elementi drammaturgici e narrativi sperimentati nei primi tre lavori, ma sempre con la costante ricerca di elementi nuovi spesso esotici, soggetti moderni per esaltare i sentimenti dell’animo umano.
11. Puccini e i suoi contemporanei.
Musicisti italiani contemporanei a Giacomo, tra i quali Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, stranieri come Claude Debussy e Richard Strauss, contribuirono a plasmare il panorama musicale di fine Ottocento e inizi Novecento; le interazioni e le influenze reciproche fecero emergere numerose similitudini ma anche differenze stilistiche.
Mascagni e Leoncavallo furono i due principali esponenti del verismo musicale, movimento che cercava di rappresentare la vita reale e i drammi quotidiani attraverso la musica.
Mascagni, con la sua Cavalleria Rusticana (1890) diede vita a un’opera esemplificativa del verismo, esaltando i temi della passione e della vendetta. La sua musica è caratterizzata da melodie forti e da un uso drammatico dell’orchestra. Sebbene Puccini e Mascagni condividessero la volontà di rappresentare la realtà umana, come anche Leoncavallo che con Pagliacci esplorò la vita degli artisti di strada, Giacomo andò oltre il verismo distaccandosi da entrambi gli amici grazie alla sua capacità di sviluppare personaggi più complessi e psicologicamente profondi.
Un altro importante contemporaneo di Puccini, che ebbe su di lui grande influenza, fu Claude Debussy.
Il collega francese, con il suo approccio impressionista, cercava di evocare atmosfere e stati d’animo attraverso il colore sonoro dell’orchestra e la delicatezza armonica. Le sue opere, tra le quali Pelléas et Mélisande (1902), condividono con Puccini una sensibilità per l’emozione e il lirismo. Tuttavia, mentre Debussy tendeva a enfatizzare l’ambiguità, Puccini mantenne una struttura narrativa più definita con un forte impatto melodico.
Entrambi i compositori esplorarono nuove sonorità, spesso esotiche, e orchestrazioni ardite con la differenza che Puccini utilizzava l’orchestra come strumento di sostegno drammatico e supporto emotivo, mentre Debussy la impiegava per evocare immagini e atmosfere, creando una sorta di paesaggio sonoro spesso onirico.
Puccini trovò dei punti di connessione drammaturgica anche con il tedesco Richard Strauss, autore di opere importanti quali Salomé (1905) e Il Cavaliere della rosa (1911); Puccini si distinse da Strauss per il suo focus sulle emozioni umane e sulla vulnerabilità dei personaggi, mentre il tedesco esplorò la psicologia umana in modi più provocatori e simbolici.
La maestria di Strauss nell’orchestrazione fu notevole e influenzò molto Puccini; tuttavia, mentre il primo spesso utilizzava l’orchestra per creare effetti grandiosi e imponenti, Puccini riuscì a combinare l’intimità delle sue melodie con un’orchestrazione evocativa, creando un’armonica coesistenza tra voci e strumenti.
12. Bohème: una sfida tra amici.
La sete di affermazione e la continua voglia di sperimentare per trovare nuove strade portò Giacomo, nel 1894, a imbarcarsi in una sfida con Ruggero Leoncavallo, suo caro amico che aveva avuto grande notorietà e successo a livello internazionale con Pagliacci: entrambi avrebbero scritto un’opera col medesimo soggetto, Bohème, ispirato al romanzo Scene della vita di Bohème di Henri Murger.
L’egocentrismo misto all’insicurezza furono la miscela esplosiva che catapultò Puccini in un forsennato lavoro di composizione, facendogli terminare l’opera nel novembre del 1895, in anticipo su Leoncavallo.
La Bohème pucciniana fu messa in scena per la prima volta il primo febbraio del 1896 presso il Teatro Regio di Torino con la direzione del ventinovenne Maestro Arturo Toscanini.
La prima rappresentazione fu un successo di pubblico ma la critica si dimostrò molto scettica, uno scetticismo portatore di fortuna: poco dopo avrebbe trionfato nei teatri in tutto il mondo.
Si racconta che Puccini dopo il debutto, emozionato dalla reazione del pubblico, si recò in un bar vicino al teatro e ordinò un drink per festeggiare. Un’ora dopo il barista gli riferì che le persone in teatro continuavano a chiedere di lui.
L’opera, suddivisa in quattro “quadri” piuttosto che atti, presenta una fluidità musicale che elimina le tradizionali separazioni tra recitativi e arie.
Qui Puccini affronta i temi della giovinezza, della precarietà, della misera ma anche dell’ambizione.
L’amore e la fragilità segnano la storia intensamente romantica tra Rodolfo e Mimì, intrisa però di precarietà e malattia.
Con quest’opera Puccini ricorda la sua vita precaria di studente a Milano, quando condivideva la camera e i sogni di gloria con il suo amico Pietro Mascagni; Bohème rappresenta la vita di giovani artisti che sognano fama e felicità, confrontandosi purtroppo con la dura realtà della povertà e delle delusioni.
Il tema del tempo che passa è centrale: le continue reminiscenze musicali dei leitmotif evocano momenti del passato che si mescolano al presente, creando un senso di malinconia e nostalgia.
Il libretto dell’opera fu scritto da Luigi Illica e Giuseppe Giacosa che seppero, con tenacia e pazienza, trovare le liriche giuste per vestire la musica di Puccini suscettibile di continui ripensamenti e cambiamenti.
La storia si svolge a Parigi, in una fredda soffitta del Quartiere Latino dove vive un gruppo di giovani artisti bohémien: lo scrittore Rodolfo, il pittore Marcello, il filosofo Colline e il musicista Schaunard; sono poveri ma, da buoni amici, si aiutano e si confortano vicendevolmente.
Per la vigilia di natale decidono di cenare fuori ma, proprio all’ora di cena, Benoit, il padrone di casa, si presenta a riscuotere l’affitto; con uno stratagemma riescono a mandarlo via e poi si avviano tutti verso la trattoria Café Momus. Rodolfo, attardatosi qualche momento per finire di scrivere un articolo, sente bussare alla porta: è Mimì la sua vicina fiorista venuta a chiedergli un favore.
I due giovani fanno conoscenza e si scoprono subito innamorati. Rodolfo porta Mimì al Café Momus e la presenta ai suoi amici. Il clima si fa teso dopo l’arrivo di Musetta, ex amante di Marcello, che ora si accompagna all’anziano e ricco Alcindoro.
Musetta cerca in tutti i modi di farsi notare da Marcello, lui vorrebbe resisterle ma alla fine la loro passione si riaccende e Musetta si unisce all’allegra brigata, lasciando ad Alcindoro il conto dell’osteria da pagare per l’intera comitiva.
Dopo qualche tempo Mimì va a trovare Marcello che lavora come ritrattista in una taverna dove Musetta si esibisce da cantante; gli confida che il suo rapporto con Rodolfo è in crisi a causa della sua eccessiva gelosia. Marcello le promette che cercherà di far ragionare Rodolfo. Anche Marcello però ha problemi con Musetta che fa la civetta con tutti. Intanto Rodolfo sta andando incontro a Marcello per confidarsi. Mimì si nasconde e ascolta la loro conversazione.
Rodolfo dapprima dice che vuole interrompere la relazione con Mimì a causa del suo comportamento troppo leggero ma poi confessa il vero motivo: la salute di Mimì è in continuo peggioramento e quindi non può restare più con lui nella fredda soffitta che purtroppo è la sola casa che può permettersi.
Mimì, molto turbata da questa rivelazione, si lascia sfuggire un colpo di tosse rivelando la sua presenza; lei e Rodolfo decidono così di separarsi.
Nel frattempo Marcello, sempre nel locale, sente la risata di Musetta e vede che sta flirtando con un uomo e, dopo un litigio, anche loro due decidono di separarsi.
Il tempo passa, Rodolfo e Marcello soffrono molto per amore essendo entrambi separati dalle loro donne; mentre gli amici cercano di rallegrarli, arriva Musetta chiedendo aiuto per Mimì che è gravemente malata. Rodolfo corre subito a soccorrerla e la ragazza è felice di riunirsi a lui, ma si spegnerà quietamente di lì a poco, tra la commozione di tutti i presenti.
Puccini dipinge con la musica, in ciascuno dei quattro quadri, le emozioni che caratterizzano la storia.
Nel primo quadro si trovano gioia e spensieratezza, con i giovani artisti che vivono momenti di allegria e amicizia; si intravede però già la fragilità della loro esistenza.
Nel secondo quadro abbiamo la passione e il desiderio. L’amore tra Rodolfo e Mimì si intensifica, mentre Musetta esprime vivacità e gran voglia di libertà, creando così un contrasto tra le due coppie. Il terzo quadro invece è caratterizzato dal sentimento di tristezza per la malattia di Mimì e dal conflitto interiore sia di Rodolfo sia di Marcello.
Il quarto e ultimo quadro è contraddistinto invece dalla desolazione per la morte della protagonista e dalla nostalgia per la giovinezza che svanisce col passare del tempo.
Con Bohème, Puccini ha regalato al mondo brani immortali ancora oggi molto eseguiti tra i quali Che gelida manina, Sì, mi chiamano Mimì, O soave fanciulla, Sono andati? Fingevo di dormire.
La figura femminile nelle opere di Giacomo Puccini è complessa e stratificata, rivelando un ampio spettro di emozioni, aspirazioni e conflitti.
Attraverso i suoi personaggi femminili, Puccini non solo esplora le relazioni umane, ma affronta anche temi sociali e culturali del suo tempo.
Mimì è una figura che incarna la fragilità e la passione. La sua storia d’amore con Rodolfo è intrisa di dolcezza ma anche di tragedia. La protagonista rappresenta il sogno e la speranza ma anche la vulnerabilità e la malattia. La sua morte non è solo un evento tragico, ma una riflessione sulla precarietà della vita e delle aspirazioni giovanili.
La complessità dei sentimenti che Puccini esalta attraverso le sue opere è lo specchio della sua stessa identità caleidoscopica, caratterizzata da numerosissime sfaccettature che vanno dal serio al goliardico.
Un episodio singolare si verificò durante le prove per la prima al Teatro Regio di Torino: il soprano Cesira Ferrani, interprete di Mimì, aveva problemi con la scena della morte. Puccini le consigliò di osservare l’uccisione di un’anatra per comprendere il graduale svanire della vita. Quando la Ferrani protestò, Puccini fece portare un’anatra nel suo camerino e la fece macellare, con grande orrore della donna. Tuttavia, l’interpretazione di Ferrani della morte di Mimì divenne leggendaria.

[Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Titta Ruffo al funerale di Ruggero Leoncavallo]
13. Il gioco e la caccia.
Puccini era un grande appassionato di caccia, in particolare di uccelli acquatici nei dintorni della sua villa che si era fatto costruire a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio.
Diceva spesso che era “tanto felice di una buona giornata di caccia quanto di una prima d’opera di successo”. Si fece persino realizzare degli stivali speciali che gli permettevano di guadare il lago per recuperare le sue prede; le battute di caccia spesso gli fornivano ispirazione per la sua musica.
Puccini era noto anche per il suo amore per i giochi di carte e biliardo. Spesso procrastinava le sue composizioni impegnandosi in maratone di gioco con gli amici. Quando a volte si trovava bloccato su un passaggio musicale difficile diceva: “…giochiamo a carte, la soluzione verrà da sola”.
Le sue abitudini lavorative erano notturne. Spesso componeva tutta la notte fumando sigarette a catena e bevendo whisky. Per non essere disturbato mentre dormiva durante il giorno, aveva fatto costruire la sua villa a Torre del Lago con muri molto spessi. Per i suoi orari strani la gente del posto lo soprannominò “il gufo”.
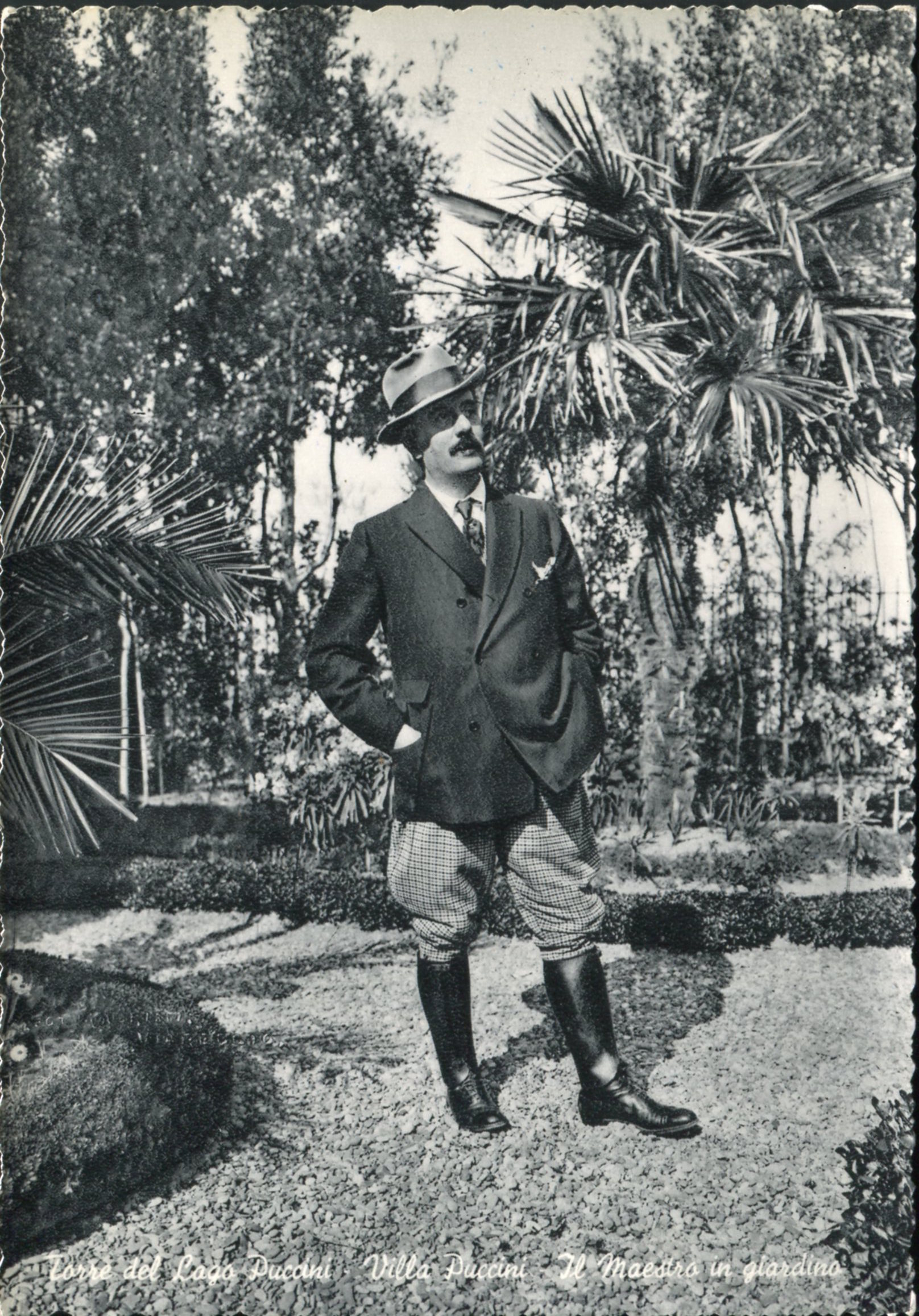
Giacomo Puccini nel giardino della sua villa a Torre del Lago
14. Caruso e Puccini: due amici ambasciatori dell’Italia nel mondo.
Bohème fu fondamentale anche per un altro personaggio molto importante per Puccini e per la storia della musica mondiale: Enrico Caruso.
L’allora emergente tenore napoletano e il Maestro toscano si conobbero nel 1897 al Teatro Goldoni di Livorno in occasione di una ripresa dell’ultima opera; Puccini dopo avere ascoltato l’interpretazione di Caruso nel ruolo di Rodolfo esclamò «Ma chi ti manda, Dio?».
Questa edizione dell’opera sugellò sia una profonda amicizia tra il cantante e il compositore ma fu anche la circostanza in cui nacque la leggendaria storia d’amore tra Caruso e il soprano Ada Giachetti. Due anni dopo la coppia rese omaggio a Puccini chiamando il primogenito Rodolfo, come il personaggio di Bohème.
Il critico Fausto Torrefranca diceva che il compositore toscano fosse pigro e che scrivesse un’opera ogni quattro o cinque anni.
Puccini era tutt’altro che pigro, lavorava molto alla sua musica anche quando svolgeva altre attività; leggeva molto, assisteva a tante rappresentazioni teatrali, operistiche, prendeva continuamente appunti per non perdere idee musicali, letterarie e intuizioni di vario tipo.
15. E lucean le stelle.
L’opera successiva a Bohème fu Tosca. Nel 1889 Puccini aveva assistito a Milano alla rappresentazione del dramma La Tosca di Victorien Sardou e ne era rimasto immediatamente colpito; chiese subito a Giulio Ricordi di acquisirne i diritti per trarne un’opera lirica. Ricordi si recò a Parigi per contrattare con Sardou che, in un primo momento, si dimostrò riluttante, ma poi accettò anche grazie all’influenza di Giuseppe Verdi che, essendo a Parigi per un allestimento, fu presente insieme a Ricordi a una riunione col drammaturgo francese.
Lo stesso Verdi fu molto colpito dal dramma di Sardou ma si reputò troppo vecchio e stanco per poterci lavorare.
In un primo momento Ricordi affidò il soggetto di Tosca al compositore Alberto Franchetti che però dopo qualche mese rinunciò al progetto; fu naturale che Ricordi affidasse a Puccini il soggetto per la composizione della nuova opera.
Qualche mese dopo la prima rappresentazione di Bohème, nella primavera del 1896, il Maestro iniziò a comporre Tosca che terminò nell’ottobre del 1899.
L’opera fu rappresentata per la prima volta il 14 gennaio del 1900 a Roma presso il Teatro Costanzi, attuale Teatro dell’Opera, ricevendo un’accoglienza contrastante; il pubblico, che alla fine applaudì entusiasta, fu inizialmente teso a causa di problemi tecnici, di voci di un probabile attentato, e infine per la protesta di alcuni ritardatari che costrinsero il direttore Leopoldo Mugnone a fermare l’orchestra e a ricominciare da capo.
Nonostante gli intoppi il pubblico applaudì calorosamente e chiese il bis delle arie Vissi d’arte e E lucean le stelle. I critici della stampa furono invece freddi; l’opera ebbe però più di venti repliche consecutive a teatro pieno, anticipando il grande successo internazionale.
Nonostante l’acclamazione Puccini era noto per essere molto sensibile alle critiche. Si dice che, dopo una recensione negativa di un’opera, potesse rimanere sconvolto per giorni.
Questo lato della sua personalità mette in evidenza l’intensità emotiva con cui affrontava la sua arte e il desiderio di essere apprezzato non solo come compositore, ma anche come uomo.
Con quest’opera volle affrontare i temi della gelosia, del sacrificio ma anche della brama di potere e desiderio; il barone Scarpia, con la sua brutalità manipolatrice, simboleggia l’abuso di potere maschile mentre Tosca è contemporaneamente la ribelle che ammazza il potente Scarpia ma anche la vittima che si toglie la vita.
La storia si svolge nella Roma papalina d’inizio Ottocento, periodo molto effervescente a livello politico.
Cesare Angelotti, già console della Repubblica e per questo prigioniero politico, riesce a evadere da Castel Sant’Angelo e trova rifugio nella Chiesa di Sant’Andrea Della Valle. Sua sorella, la Marchesa Attavanti, gli ha lasciato la chiave della cappella di famiglia dove potersi nascondere.
Il pittore Mario Cavaradossi, fidanzato con la cantante Floria Tosca, è impegnato nella chiesa a realizzare un affresco raffigurante la Madonna; ha tratto ispirazione dal viso di una fedele devota ignorando che quella donna fosse proprio la Marchesa Attavanti.
Angelotti, credendo di esser rimasto solo, esce dal nascondiglio. Incontra però Cavaradossi, suo vecchio amico e anch’egli simpatizzante per Napoleone Bonaparte. I due vengono interotti bruscamente dall’arrivo di Tosca che ha sentito il suo amato parlare con qualcuno e teme la presenza di un’altra donna. Dopo essere stata rassicurata, la gelosissima Tosca riconosce nello sguardo della Madonna gli occhi della Marchesa Attavanti e viene presa nuovamente da un impeto di gelosia.
Allontanatasi Tosca, Angelotti esce dal nascondiglio e Cavaradossi gli consiglia di recarsi nella sua villa e, in caso di pericolo, nascondersi nel pozzo. Sopraggiunge allora in chiesa il barone Scarpia, capo della polizia, per cercare l’evaso Angelotti e per un caso fortuito, nota che vicino all’affresco c’è un ventaglio femminile con lo stemma degli Attavanti e una forte somiglianza tra il volto della Marchesa e quello della Madonna ritratta nell’affresco.
Intuisce così che il piano di fuga di Angelotti è stato ordito con la complicità di Cavaradossi. Tosca, tornata in chiesa per avvisare il suo amato che la sera sarebbe stata ospite a Palazzo Farnese, viene avvicinata da Scarpia che utilizza il ventaglio per instillare nella ragazza il dubbio del tradimento di Mario con la Marchesa. Tosca corre quindi alla villa del pittore per poter cogliere i due amanti in flagranza ma viene seguita da alcuni poliziotti.
Il duplice scopo di Scarpia è catturare Angelotti e avere Floria Tosca tutta per sé.
Cavaradossi viene arrestato e condotto a palazzo Farnese per essere interrogato da Scarpia; il pittore si rifiuta di tradire l’amico Angelotti e quindi viene torturato e condannato a morte.
Tosca, pur di salvare la vita al suo amato, decide di concedersi a Scarpia in cambio della salvezza di Mario e di un documento che li autorizzi insieme a lasciare Roma. Il furbo Scarpia le dona il salvacondotto e la rassicura che l’esecuzione di Cavaradossi sarà solo una fucilazione simulata. Quando il barone si avvicina a Tosca per possederla, la ragazza afferra un pugnale e ferisce mortalmente Scarpia al cuore. Dopo la finta fucilazione di Mario, Tosca si avvicina al corpo dell’amato scoprendo con orrore che si è trattato di una vera esecuzione e, in preda alla disperazione, si lancia dalla torre di Castel Sant’Angelo dove è appena avvenuta la disgrazia.
Come quasi tutte le opere, anche Tosca fu soggetta a revisioni, tagli, aggiustamenti; Puccini non era mai completamente soddisfatto e qualsiasi critica lo feriva terribilmente. In quest’opera non vi è ouverture, la scena parte direttamente con dei forti accordi dissonanti che lasciano presagire subito la tragedia; il Maestro fu attentissimo al connubio tra musica e parola, ancora una volta Illica e Giacosa riuscirono a tener testa a Giacomo, ai suoi continui ripensamenti e alle richieste di rifacimenti testuali per i tre atti di cui l’opera si compone.
Tosca si può considerare l’opera più drammatica di Puccini, con colpi di scena, tensione costante, evidenziata da armonie dissonanti, materiali tematici brevi ma emotivamente molto incisivi.
La scrittura timbrica dell’orchestra è fondamentale nella drammaturgia dell’intera rappresentazione, oltre ai Leitmotif, a ciascun personaggio sono associati degli strumenti o gruppi di strumenti che ne identificano la personalità e l’emotività, donando grande fluidità e tensione drammatica alla narrazione, anticipando di qualche anno l’espressionismo musicale.
Altra innovazione della partitura è l’ambiente sonoro della Roma di prim’Ottocento: Puccini inserisce le campane, il colpo di cannone che si ode dal Gianicolo ma anche uno stornello romanesco cantato per strada, il tutto per fare immergere totalmente il pubblico in un altro tempo storico. Inserisce inoltre il Te Deum con effetti drammatici significativi per far emergere il contrasto tra sacro e profano e la lotta tra sostenitori della restaurazione pontificia e rivoluzionari repubblicani.
I capolavori melodici dell’opera sono tre, ciascuno per ogni atto: Te Deum nel primo, Vissi d’arte nel secondo, E lucean le stelle nel terzo.
16. Il grammofono di casa Puccini.
Il nuovo secolo fu carico di novità tecnologiche, scoperte scientifiche e cambiamenti sociali; l’incisione fonografica fu una delle più importanti innovazioni d’inizio Novecento. Prima con il fonografo a cilindro di cera messo a punto da Thomas Edison nel 1877 e poi con il grammofono su disco in ceralacca inventato da Emile Berliner, la musica, anche se solo riprodotta, divenne accessibile a un pubblico molto più vasto di quello teatrale.
Una data fondamentale per la storia della fonografia, che cambierà poi l’approccio dell’essere umano alla musica e alla performance sonora, fu l’undici aprile del 1902: nel pomeriggio di questa data, presso l’Hotel et de Milan, a Milano, il tenore Enrico Caruso incise 10 arie d’opera per la compagnia fonografica Gramophone&Typewriter; tra i titoli ovviamente non poteva mancare la musica di Puccini.
L’interpretazione del tenore napoletano di E lucean le stelle per sola voce e pianoforte cambiò per sempre il modo di cantare nell’opera lirica. L’incisione fonografica, prima di Caruso, veniva considerata una cosa poco seria, un gioco per bambini; il tenore ne aveva intuito invece le potenzialità e quindi accettò di registrare per una somma di 100 sterline, pari al compenso di una recita al Teatro alla Scala. Nel giro di pochi mesi la Gramophone&Typewriter vendette più di un milione di dischi rendendo Caruso ancora più celebre e gettando le basi per la grande industria discografica di massa.
Puccini fu entusiasta delle incisioni di Caruso e credeva che la fonografia potesse influire positivamente sulla diffusione della musica per il teatro.
Giacomo inoltre era un appassionato di tecnologia e acquistava subito qualsiasi nuova invenzione lo interessasse. Il grammofono e i dischi non mancarono in casa Puccini, come non mancarono le automobili, i più avanzati impianti di innaffiamento automatico del tempo e poi, verso gli anni Venti, la radio.
Possedeva diverse automobili, quando in Italia erano ancora una rarità, e nel 1903 fu vittima anche di un grave incidente automobilistico che lo costrinse per mesi con una gamba rotta, durante i quali lavorò a Madama Butterfly.
Puccini amava anche molto cucinare e, durante i suoi soggiorni a Torre del Lago, spesso organizzava cene per amici e colleghi. Era noto per la sua abilità nel preparare piatti tipici toscani; un aneddoto racconta che, durante una cena, il compositore servì un piatto di spaghetti così delizioso che i suoi ospiti, fra cui Caruso, ne rimasero estasiati.
17. Puccini e le “sue donne”.
Tutto il percorso operistico di Puccini è dominato dalla figura della donna; risulta dunque essere un elemento centrale che contribuisce alla ricchezza e alla complessità delle sue narrazioni.
Attraverso personaggi come Mimì di Bohème, Tosca e Ciò-Ciò-San di Madama Butterfly, il compositore riesce a catturare l’essenza delle emozioni umane, esplorando temi di amore, sacrificio e identità.
Le sue opere non solo celebrano la forza delle donne ma pongono anche interrogativi sulle dinamiche sociali e culturali, rendendo la figura femminile un punto di partenza per riflessioni più ampie sulla condizione umana.
Nella sua vita privata Puccini fu sempre circondato da numerose donne ed ebbe con loro un rapporto controverso; la relazione con Elvira fu conflittuale e contraddistinta da astio e amore profondo, infatti le sue ultime parole, che scrisse sul letto di morte il 29 novembre del 1924, furono proprio a lei dedicate: “Elvira, povera donna finita”.
Puccini non riusciva a resistere al fascino femminile ed ebbe numerose storie extraconiugali. Uno dei suoi primi “giardini”, come definiva le sue avventure, fu nel 1900 con una signora di nome Corrina che si pensa fosse un avvocato di Torino. Questa storia clandestina causò naturalmente grossi problemi con Elvira e fu interrotta solo dopo l’intervento di Ricordi.
La successiva relazione conosciuta fu con Sybil Seligman, moglie di un ricco banchiere londinese che, dopo un solo incontro sessuale, interruppe la relazione per paura di essere scoperta e cadere in disgrazia. Tuttavia rimase la fedele amica di Puccini assistendolo persino sul letto di morte.
Ebbe storie anche con Blanke Lendvai, sorella del compositore ungherese Ervin Lendvai; con l’aristocratica tedesca Josephine von Stengel per la quale nel 1915 fece costruire una villa a Viareggio.
Anche molte delle interpreti delle sue opere furono sue amanti come la cantante tedesca Rose Ader.
Ebbe anche relazioni con donne che non appartenevano all’aristocrazia tra le quali Giulia Manfredi di cui parlerò più avanti.
18. Madama Butterfly.
Già dal 1901 Puccini aveva iniziato a lavorare a una nuova opera che terminò nel dicembre del 1903.
Nell’estate del 1900 il compositore aveva assistito a Londra al dramma scritto da David Belasco intitolato Madame Butterfly innamorandosene follemente; il soggetto fu tratto da un racconto del 1898 dello scrittore americano John Luther Long.
Ciò-Ciò-San, la protagonista, è una delle figure femminili più iconiche di Puccini.
La sua innocenza e la sua devozione nei confronti dell’amato Pinkerton, ufficiale della Marina Americana, rendono la narrazione tragica e commovente. Ciò-Ciò-San incarna l’idealizzazione dell’amore ma anche la brutalità della realtà coloniale.
La sua tragica fine, segnata dal rifiuto e dall’abbandono di Pinkerton, pone interrogativi sull’identità e sul sacrificio. La storia di Ciò-Ciò-San, ambientata all’inizio del Novecento nella città di Nagasaki in Giappone, è una riflessione sul colonialismo e sulla condizione femminile.
Una costante nelle opere di Puccini è l’idea dell’amore che porta al sacrificio. Le sue protagoniste spesso si trovano a dover scegliere tra la loro felicità e il bene dei loro amati. Questo è particolarmente evidente nei personaggi di Tosca e Ciò-Ciò-San, dove l’amore diventa un elemento di conflitto che conduce alla tragedia.
Le donne pucciniane sono rappresentate con una duplice natura: sono vulnerabili e forti al contempo; le loro scelte, anche quando sono influenzate da fattori esterni, riflettono una volontà di agire e di difendere ciò che amano. Puccini utilizza i suoi personaggi femminili anche per mettere in luce questioni sociali e culturali. Le loro storie affrontano temi di classe, di identità e oppressione, specialmente nel contesto storico in cui vivono.
Ciò-Ciò-San, ad esempio, rappresenta le conseguenze del colonialismo e della disparità culturale tra occidente e oriente, sollecitando il pubblico a riflettere su questioni di giustizia e umanità.
Per Madama Butterfly Puccini si avvalse nuovamente dei librettisti delle due opere precedenti, Luigi Illica e Giuseppe Giacosa.
L’opera inizia con Pinkerton che sta organizzando il suo matrimonio con Ciò-Ciò-San ma considera l’unione come un affare temporaneo, poiché prenderà una moglie “seria” quando sarà tornato in America. L’ingenua Ciò-Ciò-San crede sinceramente nel loro amore. Nonostante il disaccordo della famiglia, in particolare dopo aver abbracciato il cristianesimo per amore di lui, Ciò-Ciò-San è piena di speranza per il futuro anche se dovrà affrontare un periodo di solitudine a causa del ritorno di Pinkerton negli Stati Uniti.
Per tre lunghi anni Ciò-Ciò-San resta devota al marito, aspettandolo con ansia. Sharpless, console americano a Nagasaki, si reca dalla donna per farle visita; vedendo quanto lei s’illudesse dell’amore di Pinkerton, le suggerisce di accettare la corte del principe Yamadori che vorrebbe sposarla, ma lei rifiuta ostinatamente poiché si considera già sposata con l’americano.
Il console la avvisa che il “marito” sta per arrivare in Giappone; la ragazza gli mostra così il figlio che ha avuto da Pinkerton e che ha nascosto a tutti. Successivamente Cio-Cio-San, scrutando l’orizzonte, scorge la nave su cui è imbarcato il suo amato e, insieme alla sua governante Suzuki, addobba la casa per accoglierlo degnamente.
Le donne, insieme al bambino, restano in attesa per tutta la notte senza che nessuno si presenti.
Pinkerton, appreso da Sharpless di avere un figlio, si reca da Ciò-Ciò-San con l’unica intenzione di portare con sé il bambino negli Stati Uniti ed educarlo insieme alla sua moglie americana Kate secondo gli usi occidentali. A questo punto Butterfly capisce che la sua grande storia d’amore, la sua felicità, sono state solo un’illusione. Con il volto coperto di lacrime, pone il bambino in una stuoia, lo benda delicatamente e gli mette tra le mani una bambola e una bandierina americana. Nella disperazione, dopo aver pregato le statue dei suoi Dei ancestrali, si toglie la vita con un antico pugnale ereditato dal padre.
Pinkerton è dunque il simbolo dell’arroganza occidentale, considera il matrimonio con Butterfly come un’avventura temporanea, riflettendo così la mentalità imperialista che tratta le culture extra-occidentali come inferiori e sfruttabili.
La figura di Ciò-Ciò-San, che rinuncia alla sua cultura per adattarsi a quella americana, evidenzia le devastanti conseguenze del colonialismo: isolamento e annientamento personale. La sua tragica fine evidenzia dunque l’impossibilità di una vera integrazione culturale, mostrando come il colonialismo distrugga identità e dignità.
19. Un fortunatissimo fiasco.
La prima di Madama Butterfly al Teatro alla Scala, il 17 febbraio 1904, fu un clamoroso fiasco. Nonostante le aspettative elevate, il pubblico accolse l’opera con schiamazzi e disapprovazione.
Puccini e Giulio Ricordi avanzarono l’ipotesi che fosse stato costruito un clima di ostilità attorno all’opera e che una claque di rivali aveva disturbato la rappresentazione.
La critica specializzata fu spietata, il musicista compositore Ferruccio Busoni la giudicò persino “indecente”.
Puccini così scrisse all’amico Camillo Bondi: «[…] con animo triste ma forte ti dico che fu un vero linciaggio. Non ascoltarono una nota quei cannibali. Che orrenda orgia di forsennati, ubriachi d’odio. Ma la mia Butterfly rimane qual è: l’opera più sentita e suggestiva ch’io abbia mai concepito. E avrò la rivincita, vedrai, se la darò in un ambiente meno vasto e meno saturo d’odi e di passioni […]».
Dopo l’insuccesso della prima al Teatro alla Scala, Puccini decise di rivedere pesantemente la partitura, eliminando scene e modificando alcuni passaggi musicali per rendere l’opera più agile ed equilibrata.
Tre mesi dopo, la versione rivisitata fu presentata a Brescia dove riscosse un enorme successo.
Per la composizione di quest’opera, Puccini studiò molto il folklore musicale giapponese, si documentò sulla storia delle tradizioni e dei costumi. Utilizzando melodie intrise di pentatonismo e orchestrazione ricercata, il compositore cercò di evocare quel mondo esotico e lontano sconosciuto alle masse occidentali. L’utilizzo di ritmi ternari per esprimere momenti di gioia e passione, di ritmi binari per caratterizzare melodie più drammatiche, resero la narrazione emozionante e fluida.
Come già successo in Tosca, Puccini utilizza musiche esistenti rendendole funzionali alla drammaturgia: inserisce The Star-Spangled Banner, all’epoca inno della Marina Militare e attualmente inno degli Stati Uniti d’America, per evocare l’imponenza della supremazia statunitense in contrasto con le delicate melodie orientali.
Brani come Un bel dì, vedremo, Coro a bocca chiusa e Addio fiorito asil sono e resteranno pagine importanti nella storia della musica.
Il cruscotto della cassazione civile[1
di Franco De Stefano
Uno sguardo d’insieme alla recente introduzione di uno strumento di rilevamento, organizzazione e rappresentazione dei dati statistici dell’ufficio giudiziario giudicante di legittimità, funzionale alle scelte di pianificazione di trattazione delle pendenze, ad iniziare da quelle di composizione dei ruoli di udienza e adunanza, funzionale all’adeguamento flessibile ed in progress dei relativi strumenti processuali di gestione di pendenze e sopravvenienze ed al complessivo miglioramento della risposta complessiva alla domanda di giustizia di legittimità.
Sommario: 1. Premessa metodologica. - 2. Il cruscotto direzionale, in generale. - 3. Il cruscotto direzionale in Cassazione. - 4. Il ruolo del cruscotto direzionale in Cassazione. - 5. Le utilità offerte dal cruscotto della Cassazione. - 6. Qualche idea sulle opportunità offerte. - 7. Gli interventi coordinati. - 8. Notazioni conclusive.
1. Premessa metodologica.
È innegabile che, con il generalizzato recepimento – a partire dall’introduzione dei programmi di gestione e dalla loro implementazione nella legislazione e nella successiva normazione secondaria di attuazione – di un’impostazione definibile, a fini comunque meramente descrittivi o in via prudenziale, sostanzialmente aziendalistica di attenzione al risultato quantitativo del “prodotto” della funzione giurisdizionale quale parametro della sua efficienza, negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata su quest’ultima soprattutto in termini di riduzione o contenimento dei tempi di lavorazione delle pendenze prima e, in generale, delle sopravvenienze.
È, del resto, questa l’impostazione del PNRR, dal nostro Paese liberamente accettata al momento della sollecitazione dell’erogazione delle risorse europee.
Non è questa la sede per una riflessione o un approfondimento sulla congruità di tale impostazione e della matrice di una simile scelta efficientistica, né per alcuna considerazione sull’utilità o sulla funzionalità dell’opzione di rispondere alla dilagante domanda di giustizia con strumenti volti a consentire alla relativa offerta di rincorrerla, incrementando in termini quantitativi il prodotto dell’attività degli uffici investiti della funzione giurisdizionale, anziché mediante interventi strutturali in grado di incidere sul contesto, sulle condizioni e sulle cause che quella domanda generano, idonei a contenerne l’irrefrenabile espansione e a ridurre l’indispensabilità dell’impegnativa risposta pure così sollecitata.
Una tale impostazione viene qui presa a riferimento come dato di realtà, da studiare e valutare in quanto tale: cioè, da un punto di vista meramente empirico e tecnico, mantenendosi una posizione che si dichiara espressamente volersi mantenere quanto più neutrale possibile in ordine all’assetto assiologico che la sostiene.
Una tale premessa di neutralità non esime, peraltro, almeno dal richiamo al fatto che, a prescindere dalle impellenti esigenze produttivistiche (comunque utili, quando non indispensabili, ad impostare efficienti tecniche di gestione della domanda di giustizia), il “prodotto” su cui si ragiona ed il cui procedimento di realizzazione si analizza è pur sempre una risposta giurisdizionale: non soltanto un bene materiale, per quanto delicato o di lusso possa – di volta in volta – qualificarsi, ma soprattutto un risultato, quello della risoluzione o della prevenzione dei conflitti interpersonali e della ponderata regolazione dei rapporti tra i consociati, quale precondizione per la loro piena realizzazione quali persone umane e nel riconoscimento e contemperamento dei loro diritti e delle loro libertà fondamentali.
In quest’ottica, può comunque anticiparsi la conclusione che l’adozione e la stessa applicazione di strumenti propri della gestione aziendale, finalizzati all’equilibrio – anche solo di lungo termine – della domanda e dell’offerta di “prodotto” all’esito di un procedimento di lavorazione – assimilato sempre più ad una catena produttiva – è, da un lato, indotta da questa impostazione e, dall’altro, comunque in grado di avvalersi dei progressi e degli sviluppi delle tecniche di organizzazione e gestione aziendale: ai quali va ricondotto anche il “cruscotto” oggi in esame, con una valutazione senz’altro positiva se non altro per le opportunità offerte ai decisori ed ai responsabili.
2. Il cruscotto direzionale, in generale.
Un’impostazione sostanzialmente aziendalistica impone, necessariamente, di mutuare dalla relativa disciplina alcuni concetti fondamentali, con l’avvertenza che, appunto, essi vanno applicati a grandezze che, probabilmente, fino a qualche tempo fa non erano considerate a livello di meri manufatti in esito ad un ciclo produttivo: e, così, con la necessaria attenzione alle esigenze di adeguamento indotte dalla peculiarità dell’oggetto del ciclo stesso.
In primo luogo, occorre prendere dimestichezza con l’acronimo KPI, che sta per Key Performance Indicator, vale a dire, letteralmente “indicatore chiave di performance”[2] (o di prestazione), una definizione che riflette efficacemente la sua funzione: il compito di tali indicatori è la somministrazione di informazioni (sia a consuntivo che in corso d’opera, a seconda delle esigenze da soddisfare) rispetto alle performance – o risultati attesi o prestazioni – di un determinato processo di produzione di beni o servizi; e deve trattarsi di elementi da monitorare che siano rilevanti ed utili, se non decisivi, ai fini dell’impostazione di una qualunque strategia e del perseguimento degli scopi prefissati. Generalmente, può – in linea di grande approssimazione – rimarcarsi una differenza sostanziale tra KPI e Obiettivi: i primi sono, infatti, funzionali ai secondi (che possono definirsi, sia pure descrittivamente, i traguardi che un’attività si propone di raggiungere) e forniscono elementi puntuali e misurabili sulle estrinsecazioni, sugli aspetti e sulle caratteristiche della strategia adottata (o, se si vuole, su impostazione e funzionalità delle diverse fasi del processo produttivo).
In questo contesto, “cruscotto direzionale” (o “dirigenziale”, nel senso di messo a disposizione del dirigente, a sua volta inteso quale decisore) – o dashboard[3] – può definirsi uno strumento di misurazione e valutazione con la finalità di integrare in un’ottica multidimensionale gli obiettivi strategici, le performance attese e il conseguimento di outcome desiderati; in particolare, un sistema più o meno articolato di supporto al processo decisionale, in grado di fornire ai decisori tutte e solo le informazioni necessarie, presentandole in un determinato formato, con l’obiettivo generale di migliorare il processo decisionale ampliando la capacità cognitiva dei decisori stessi[4].
Esso presuppone la definizione dei suoi fini ed obiettivi (programmazione, monitoraggio, performance management, comunicazione, ecc.), l’identificazione dei suoi utilizzatori e la mappatura del loro fabbisogno informativo, nonché la definizione delle caratteristiche funzionali e grafiche.
Un cruscotto funzionale deve garantire: tempestività (cioè, i dati devono essere forniti nel minor tempo possibile o, comunque, in quello indispensabile al decisore per adeguare opportunamente il proprio operato); chiarezza (immediata leggibilità ed interpretabilità da parte dei responsabili e, in generale, dei decisori cui quello è rivolto); affidabilità (solidità e genuinità dei dati raccolti); selettività (capacità di somministrare dati organizzati in informazioni prioritarie e fruibili, diverse dalla mera esposizione grezza o collezione di dati analitici interpretabili con difficoltà)[5].
Applicate tali conclusioni alla P.A. ed al ciclo della produzione dei servizi da essa resi (cui, descrittivamente e a questi soli fini, equiparare mutatis mutandis la giurisdizione), può convenirsi con chi ascrive il cruscotto ad uno degli strumenti del controllo di gestione: il quale va qualificato come «sistema integrato» in grado di rendere visibile e trasparente, ai vari livelli dell’organizzazione, la traduzione delle linee strategiche in obiettivi operativi, in un contesto che fa maturare la condivisione di strategie ed obiettivi, attraverso le varie fasi nelle quali si realizza l’attività di pianificazione e controllo di gestione. Un cruscotto direzionale – che consenta di tenere sotto controllo l’andamento delle attività, sia sotto il profilo dell’efficienza e della qualità del servizio erogato che dell’economicità della gestione – oltre a svolgere un ruolo importante per le esigenze legate al controllo della gestione (e quindi, di autentica guida all’azione) e al controllo strategico, svolge un importante servizio di supporto per le funzione di indirizzo e controllo dei decisori[6].
Più in particolare, quanto all’esperienza della funzione giurisdizionale è decisiva la circostanza che la CEPEJ, cioè la Commissione europea per l’efficienza della giustizia costituita in seno al Consiglio d’Europa, ha dedicato, non molti anni addietro (ed anzi, significativamente, in tempi coincidenti con l’avvio della sperimentazione di cui oggi ci si occupa), una specifica attenzione proprio agli strumenti di rilevazione dei dati nel sistema giudiziario.
In quella sede definito il cruscotto di indicatori, in base ad una definizione ormai classica quale “rappresentazione visiva dei dati sotto forma di tabelle, diagrammi, grafici, codificati con scale di colori che mira a tracciare, analizzare e visualizzare dati sul livello di prestazione di un’organizzazione o di un processo” e quindi[7] quale “strumento per comprendere, gestire e migliorare le prestazioni di una data organizzazione, sistema, o processo, incentrando l’attenzione sugli indicatori di prestazione rilevanti”, è stato – in esito alla 36a seduta plenaria del 16 e 17 giugno 2021 della CEPEJ – adottato un articolato “Handbook on Court Dashboards” ( “Manuale sui cruscotti giudiziari”)[8].
La sua complessità ne impedisce un approfondito esame in questa sede: dovendo allora qui essere sufficiente un richiamo alla sua ampia strutturazione, idonea a fornire agli operatori le indicazioni necessarie per la costruzione di cruscotti efficienti ed utili[9], a loro volta funzionalizzati a migliorare l’efficienza della risposta di giustizia.
Anche in questo caso, può dirsi che la linea di tendenza degli studiosi dell’efficienza del sistema giudiziario è quella di acquisire strumenti di gestione consapevole del ruolo, questo da intendersi sia come funzione vera e propria nell’assetto istituzionale, sia come magazzino o coacervo degli affari di cui è richiesta la trattazione e l’esaurimento in termini di efficiente risposta di giustizia.
3. Il cruscotto direzionale in Cassazione.
Come rilevato dalla Prima Presidente nella sua relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024, la Corte di cassazione ha avviato, dalla fine del 2021, un progetto diretto a sviluppare un sistema di monitoraggio dei dati statistici e delle attività giudiziarie sulla gestione dei procedimenti civili e penali della Corte.
Alla sua realizzazione hanno contribuito il Politecnico di Milano e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), con la collaborazione del CED della Corte di cassazione, in forza di Convenzione sottoscritta tra il Ministero della Giustizia e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane.
Dal settembre 2023 è operativo il Cruscotto per il settore civile, mentre è in corso di realizzazione, sviluppo ed applicazione quello per il settore penale; pertanto, anche in considerazione delle specifiche esperienze finora maturate, si concentra qui l’attenzione su quello civile, rimandati ad altre sedi gli approfondimenti su quello penale.
Nell’impostazione della Prima Presidenza, il “cruscotto direzionale” realizzato per la Corte (e, al momento, funzionante per il settore civile) assolve a quattro principali funzioni, tra loro sovrapponibili e intersecabili:
1) una funzione operativa (o ricognitiva), diretta a descrivere lo stato delle cose momento per momento e le performance o prestazioni dell’organizzazione nel tempo;
2) una funzione analitica (letteralmente, di analisi dei dati), diretta a presentarli in modo chiaro e leggibile per l’utente destinatario;
3) una funzione tattica: di filtraggio dei dati e di combinazione tra loro dei filtri per consentire un’interpretazione più dettagliata e precisa dello stato dell’arte e delle dinamiche storiche dei dati;
4) una funzione strategica, intesa a far emergere le potenziali evoluzioni rispetto ad obiettivi di medio e lungo termine e, quindi, consente di valutare, in termini prognostici, quali interventi privilegiare per il loro raggiungimento.
In tale prospettiva, questo strumento fornisce una rappresentazione aggiornata sostanzialmente in tempo reale (con frequenza tendenzialmente giornaliera) dello stato di avanzamento dei procedimenti della Corte, attingendo direttamente dal sistema informatico interno (al momento, per civile, il SIC).
Il cruscotto è pensato come strumento aggiuntivo e non sostitutivo delle rilevazioni e delle elaborazioni di competenza dell’Ufficio Statistico della Corte, predisposte e pubblicate con frequenza almeno mensile: in altri termini, si tratta di uno strumento versatile di interpretazione, combinazione, lettura e approfondimento dei dati grezzi comunque disponibili.
Nella pratica, sono stati sviluppate due specie di cruscotto, entrambe visualizzabili via web e fruibili senza necessità di installazione di programmi dedicati, ma differenti nel tipo di indicatori inclusi – ripartiti in diverse schede di analisi – e nell’obiettivo di utilizzatori definito: il Cruscotto direzionale e il Cruscotto sezionale.
Il primo (Cruscotto direzionale) è destinato ai vertici della Corte, che accedono alle informazioni di carattere generale relative all’andamento del Settore (civile o penale) di interesse: l’assoluta specialità dello strumento, essendo appunto riservato alle posizioni direttive apicali, impedisce la sua illustrazione analitica in questa sede.
Il Cruscotto sezionale, invece, è destinato principalmente ai presidenti di sezione – titolari e non titolari – ed ai magistrati addetti alle attività di spoglio, che possono così disporre in ogni momento di dati immediatamente fruibili sull’andamento degli indicatori principali con un dettaglio utile alla gestione della sezione stessa (ad es. la classificazione dei fascicoli per materia, la pendenza per ciascuna di esse, la sopravvenienza, lo stato di lavorazione dei procedimenti dalla fase della preparazione della trattazione a quella successiva all’udienza o all’adunanza, compresi i tempi di lavorazione e deposito).
Entrambi i Cruscotti, poi, contengono una scheda denominata “Obbiettivi e previsioni”, composta di due sezioni.
La prima, statica, riporta gli obiettivi semestrali da perseguire in termini di pendenze per ogni sezione, al fine di raggiungere l’obiettivo finale di volta in volta previsto, che, attualmente e com’è noto, è quello fissato dal PNRR; è un piano di riduzione dell’arretrato calcolato a partire dalle pendenze in essere a marzo 2023 e dalla media di ricorsi iscritti (dodici mesi) e di ricorsi definiti nei tre mesi precedenti; e viene rappresentato in modo tale da consentire il raffronto tra gli obiettivi intermedi e quello finale, durante il tempo preso a riferimento per conseguire il secondo.
La seconda, invece, ha natura dinamica, perché propone una proiezione, ossia opera una stima ipotetica futura in base al ritmo di lavoro dei tre mesi precedenti alla data di consultazione e della media mensile delle iscrizioni degli ultimi 365 giorni. Il variare delle condizioni (tra cui, a titolo esemplificativo, l’aumento o la diminuzione delle sopravvenienze, la modifica dell’organico, la frequenza e l’intensità dell’impegno per ogni singola udienza o adunanza) influenza, di conseguenza, nel singolo momento in cui è operata, la stessa proiezione, che è suscettibile di modificarsi nel tempo ed anzi è pensata per variare in rapporto alla variazione dei dati immessi e relativi alla diversa situazione del tempo in cui questi sono elaborati. L’indicazione assolve, pertanto, ad una funzione strategica mirata a somministrare gli elementi indispensabili per consentire di verificare la correttezza delle scelte gestionali già prese e, se del caso, di adottare gli eventuali adeguamenti per perseguire l’obbiettivo prefissato nel medio-lungo periodo.
4. Il ruolo del cruscotto direzionale in Cassazione.
Ora, deve convenirsi con l’Autrice[10] che qualifica il cruscotto “espressione di una mutata cultura dei giudici della Corte, consapevoli che il loro ruolo non si limita all’impegno di studio, ricerca, approfondimento per garantire ‘l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale’ della legge, in vista di una razionale sintesi coerenziatrice dei plurimi indirizzi interpretativi nell’ambito di un confronto sia interno che con la giurisdizione di merito, ma si traduce anche nel contributo propositivo ad un efficace assetto organizzativo in grado di coniugare fluidità e tempestività dei processi lavorativi, ampia collaborazione tra le diverse componenti dell’ufficio, sollecita individuazione delle eventuali criticità ostative al rispetto di tempi ragionevoli nella definizione delle procedure”.
È indubbio, poi, che l’adozione, l’implementazione e, soprattutto, il costante utilizzo del cruscotto possono concretare l’estrinsecazione di una concezione del ruolo del dirigente dell’ufficio giudiziario innovativa, frutto di un lungo e complesso percorso.
Si può, al riguardo, condividere l’individuazione di un’ideale linea evolutiva, che parte dalla previsione costituzionale (dell’art. 107, comma terzo, della Carta fondamentale) della differenziazione dei giudici soltanto in base alle funzioni svolte e della soppressione del previgente assetto gerarchico (in virtù della legge 24 maggio 1951, n. 392), si consolida negli interventi della Consulta[11] a tutela dell’indipendenza già solo nella necessaria motivazione dei provvedimenti di revoca delle assegnazioni degli affari e poi si afferma, capillarmente, nella previsione di un ruolo dei dirigenti intermedi caratterizzato sempre più da una collaborazione con i dirigenti dell’ufficio (basti ricordare gli artt. 42-bis, 47 e 47-quater ord. giud., introdotte con d.lgs. 51/1998), con riserva ai primi di precisi compiti di organizzazione del lavoro, di sorveglianza sui servizi di cancelleria, di vigilanza sui magistrati componenti la sezione, di promozione di scambi di informazioni in ordine agli orientamenti giurisprudenziali maturati all’interno della stessa. In tale contesto, un ruolo decisivo ha svolto ed assunto la normativa secondaria del Consiglio superiore della magistratura, “tesa a superare l’idea tradizionale della dirigenza come approdo di un cursus honorum e come esercizio di poteri insindacabili e a valorizzare la dimensione di servizio che richiede sensibile attenzione a tutti gli ambiti interessati dall’amministrazione della giustizia” [12].
Alla tradizionale concezione dell’esercizio del potere giurisdizionale, sempre più inteso come servizio reso alla collettività[13], si è via via sostituita altra, connaturata alla costituzionalizzazione del principio (peraltro, già recepito a livello sovranazionale e vincolante in forza dell’adesione della Repubblica italiana alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali) della ragionevole durata del processo, che esige ormai una chiara consapevolezza del nesso inscindibile tra fattore tempo e organizzazione come “precondizione di effettività di una risposta giudiziaria che sappia coniugare tutela dei diritti fondamentali, efficienza, tempestività, qualità delle decisioni all’esito di un processo che ponga al centro il rispetto del diritto di difesa e il contraddittorio” [14].
In quest’ottica, “il cruscotto costituisce l’indice di una nuova dimensione professionale del giudice di legittimità, consapevole che l’efficiente strutturazione dell’ufficio, il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria e dei servizi ad essa correlati, la complessiva capacità di fornire risposta alle numerose e sempre nuove domande di giustizia sono il frutto dello sforzo ideativo e progettuale di tutte le varie componenti, chiamate a fornire il loro corale contributo propositivo in una dimensione collaborativa e partecipe delle scelte da compiere, possibilmente d’intesa anche con l’avvocatura, interlocutore ineliminabile della magistratura” [15].
È innegabile che l’introduzione del cruscotto direzionale e la sua stessa diuturna e continuativa disponibilità deve indurre “i giudici di legittimità ad affinare le loro conoscenze tecnico-giuridiche e ordinamentali, la sensibilità e l’attenzione al tema dell’organizzazione quale dimensione complessa che opera su molteplici livelli e di cui essi si rendono garanti, ad acquisire la consapevolezza del rilievo centrale di dati attendibili su cui costruire proposte efficaci”.
Infatti, “organizzare significa, innanzitutto, conoscere la Corte in tutte le sue articolazioni, analizzare i flussi degli affari, le pendenze, le definizioni, predisporre seri e concreti piani di definizione e di recupero dell’arretrato, avere piena contezza delle varie fasi del lavoro sia più squisitamente giudiziario che amministrativo, tra loro inscindibilmente connessi, al fine di cogliere eventuali criticità e di porvi sollecitamente rimedio, elaborare, all’esito di un’attenta analisi, progetti in vista di un servizio più moderno e rispondente alle attese di un corpo sociale in continuo divenire, oltre che del conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR.
Impegnarsi per fornire una risposta effettiva alla tutela dei diritti fondamentali, assicurare l’accesso e la trasparenza dei dati disponibili, delle informazioni, delle decisioni e delle logiche ad esse sottese, rafforza la legittimazione dell’intera Corte, di quanti vi operano e, più in generale, dell’intera magistratura.
Rendere conto all’intera collettività della propria azione, dei risultati conseguiti e delle criticità perduranti è fondamentale per superare lo schermo di diffidenza e di sfiducia che spesso connota i rapporti tra giustizia e cittadino” [16].
È innegabile che queste considerazioni valgono a maggior ragione per i direttivi della Corte di cassazione: i cinquantanove presidenti di sezione, dodici dei quali soltanto titolari delle rispettive sezioni civili e penali, rivestono, formalmente e sostanzialmente, la qualifica di ufficio direttivo giudicante di legittimità; e hanno assunto via via un ruolo sempre più incisivo nella gestione dell’organizzazione del lavoro, ben maggiore rispetto a quello di meri presidenti dei singoli collegi giudicanti: sul quale non è questa la sede per ulteriori riflessioni[17].
5. Le utilità offerte dal cruscotto della Cassazione.
Come è possibile ricavare dalla sua stessa struttura, il cruscotto rende disponibili in tempo reale i dati aggiornati, alimentati da un’interazione continua con i sistemi informatici in funzione, alle ventiquattro ore precedenti e relativi alla gestione dei ricorsi. È, pertanto, un innovativo strumento dinamico, non solo perché integra l’elaborazione statistica già effettuata su base mensile dalla Corte e destinata a confluire nella statistica ufficiale curata dal ministero della Giustizia su base trimestrale, semestrale, annuale, ma, soprattutto, perché il monitoraggio è costante ed aggiornato.
Infatti, la disponibilità immediata di dati raffinati e depurati, per quanto possibile, di inevitabili errori (false pendenze, difetti di imputazione, ritardi nelle annotazioni, ecc.) è fondamentale per il dirigente dell’ufficio giudiziario e i presidenti titolari delle sezioni, o, comunque, per tutti coloro (compresi i presidenti non titolari, coordinatori o meno di una delle aree interne alla sezione di assegnazione), per avere piena contezza dell’efficacia dell’assetto organizzativo adottato, per introdurre eventuali correttivi, per intervenire prontamente rispetto a situazioni di ritardo riscontrate nell’adozione delle decisioni, nel deposito delle motivazioni dei provvedimenti da parte del relatore, nella sottoscrizione degli stessi da parte del presidente del collegio. È, altresì, funzionale ad una perequazione dei carichi di lavoro tra i singoli magistrati componenti la sezione e ad una più razionale distribuzione degli affari tra le diverse aree specialistiche interne alla sezione stessa in caso di obiettive, rilevanti asimmetrie rispetto alle unità di organico effettivamente disponibili[18].
Il carattere intuitivo, l’immediatezza dell’utilizzo, la duttilità e l’agilità dello strumento ne hanno reso possibile, dopo una pur sempre necessaria fase di illustrazione e formazione, la fruizione da parte dei presidenti di sezione – titolari e non, ma pure degli spogliatori o degli altri consiglieri che vi fossero stati delegati – senza la necessità dell’assistenza tecnica di personale qualificato (che, invece, resta necessaria per estrarre i dati ed elaborarli in tabelle e grafici quanto all’impiego di altri strumenti, quali, ad esempio, la “consolle del Presidente” o il c.d. “pacchetto ispettori”, del resto ispirati ad altre finalità e comprensibilmente connotati da un maggior livello di sofisticazione).
Come icasticamente sottolineato[19], attraverso una costante analisi dei dati contenuti nel cruscotto direzionale, raggruppati organicamente per temi e settori di ricerca, il dirigente dell’ufficio e i presidenti titolari e non titolari delle sezioni sono attualmente in grado di verificare in tempo reale il conseguimento, entro i tempi prefissati, degli obiettivi concordati e di modificare e adeguare le scelte a suo tempo adottate in base alla rilevazione dei risultati medio tempore ottenuti, suscettibili di utile confronto e discussione – anche collegiale – all’interno delle singole sezioni e fra presidenti titolari delle diverse sezioni in un’ottica di rappresentazione coordinata dell’ufficio.
In particolare, rimandando ad altri contributi degli specialisti e dei progettisti per una analitica illustrazione, il cruscotto sezionale (sul quale è forse opportuno concentrare l’attenzione, per il carattere assai specialistico di quello riservato ai vertici della Corte) prevede una schermata di apertura, ove si precisa: “Il cruscotto di monitoraggio fornisce una rappresentazione aggiornata su base giornaliera dello stato di avanzamento dei procedimenti della Sezione e attinge direttamente dal sistema informatico interno. Per questo motivo i dati visualizzati potrebbero riportare piccole imprecisioni, che sono poi corrette nella reportistica ufficiale trimestrale. La sua funzione è quindi di aiuto al controllo del lavoro e alla pianificazione di breve e medio periodo delle attività e non di valutazione strategica, come è il caso invece della reportistica ufficiale. Lo strumento di visualizzazione è costituito da diverse schede che possono essere navigate tramite PC, tablet o smartphone. Le grafiche sono interattive, l'utente può quindi filtrare i dati desiderati ed evidenziarne i dettagli informativi.”.
Le singole schede riguardano poi, sempre con la possibilità di riferire i rilevamenti a specifici momenti o lassi temporali e di applicare filtri anche trasversali: i procedimenti pendenti; lo stato di lavorazione dei pendenti; la ripartizione per materia dei pendenti (con l’utile suddivisione ulteriore per aree); i dati dei definiti (utilmente disaggregabili per tipologie di provvedimento, epoca di iscrizione a ruolo, tempi di definizione complessivi e così via); le materie dei definiti (anche qui riaggregabili e disaggregabili in funzione di una o più di esse e delle sezioni e rispettive aree di attribuzione); il disposition time (con possibilità di confronto tra due periodi discrezionalmente scelti, ma, per sua stessa natura, non disponibile – allo stato – per l’anno in corso); l’indice di ricambio; le udienze (con indicazione sia del carico medio per relatore, sia della media dei definiti); infine, gli obiettivi (in relazione a quelli del PNRR, ma con facoltà di fissarne discrezionalmente altri; e specificamente evidenziati sia quelli per pendenze che quelli per disposition time).
6. Qualche idea sulle opportunità offerte.
L’illustrazione pratica di ognuna di queste non è possibile nei tempi a disposizione e si rinvia, pertanto, alla sperimentazione sul campo.
Ma, fin d’ora e in via di prima approssimazione (e, pertanto, senza porre limiti alle possibilità di fruizione), si può ipotizzare un impiego massivo dello strumento:
a) in generale, da parte dei presidenti titolari o da quelli coordinatori di area per verificare il corretto funzionamento dei meccanismi interni di gestione delle pendenze;
b) da parte di tutti i presidenti, titolari e non e dei singoli collegi giudicanti, per il rilevamento delle eventuali criticità – o, al contrario, per il rilievo delle auspicabili utilità – nelle fasi non strettamente dipendenti dal lavoro di coordinamento dei colleghi o all’interno dei collegi, cioè in quelle, complementari ma indispensabili, della fluidità delle lavorazioni complessive in cancelleria: in tal caso, in stretta cooperazione con i responsabili di questa e col personale, ivi compreso – a seconda delle concrete modalità di organizzazione prescelte – quello dell’Ufficio per il processo;
c) da parte di tutti i presidenti, titolari e non e dei singoli collegi giudicanti, per la verifica della fluidità dei procedimenti e dei tempi di pubblicazione e dell’attività della cancelleria a tal fine preposta, se del caso con adeguato coinvolgimento dei dirigenti di quella, in relazione ai singoli ricorsi o a gruppi di ricorsi per settori di attività, onde intervenire sulle criticità e individuare i settori o segmenti procedimentali in cui sollecitare il superamento dei ritardi nell’apprestamento delle attività serventi alla preparazione del singolo ricorso e, poi, delle fasi successive alla decisione;
d) da parte dei presidenti titolari per verificare l’adeguatezza della ripartizione in aree in relazione all’andamento delle relative sopravvenienze e pendenze in relazione al numero delle udienze e adunanze fissate;
e) da parte dei presidenti titolari – se del caso, opportunamente coinvolti anche i non titolari – per modulare periodicamente le linee strategiche (ovvero di orientamento generale) da applicare – o da delegare ad applicare – per la ponderata formazione dei singoli ruoli di udienza o adunanza;
f) da parte di coloro che si occupano della formazione dei ruoli di udienza o adunanza, per la composizione sempre più consapevole e meditata di quelli ed al fine di conseguire una progressiva erosione delle pendenze afflitte da più risalenti epoche di iscrizione a ruolo;
g) da parte dei presidenti di collegio per verificare l’andamento dei tempi di deposito da parte degli estensori e prevenire le anomalie (con l’avvertenza che non pare di immediata ed intuitiva disponibilità la verifica nominativa delle singole situazioni, dovendo al riguardo attivarsi separati strumenti) nel lavoro dei colleghi o all’interno dei collegi;
h) da parte di tutti gli spogliatori per indirizzare ed orientare l’attività di spoglio alla più opportuna composizione delle categorie di “magazzino” e, poi, degli stessi ruoli di adunanza e di udienza;
i) da parte di tutti gli operatori coinvolti per la verifica della congruità del funzionamento del procedimento di proposta di definizione accelerata (anche per intervenire, in caso di incongrui scostamenti dalle medie fisiologiche di “opposizioni”, sui redattori delle proposte stesse, pure soltanto per sottoporre loro le problematiche indotte da una eccessiva tendenza ad istanze di decisione).
7. Gli interventi coordinati.
La filosofia e l’impostazione del cruscotto direzionale ha implicato l’adozione di altri interventi di sistema, indispensabili per coordinare i diversi ambiti interessati.
È stato necessario definire con puntualità, nel rispetto delle previsioni processuali e con un’interazione costante anche in fase progettuale, le diverse cadenze procedimentali e, all’interno di ciascuna di esse, i tempi e le modalità di lavorazione, oltre che la corretta individuazione delle attribuzioni di ciascuna componente; importante e delicato è stato, poi, il momento di individuazione attenta delle definizioni da attribuire ai termini prescelti, anche al fine di prevenire eventuali ambiguità nella interpretazione dei dati; infine, si è reso necessario implementare la digitalizzazione ed il raccordo con i database informativi del SIC e di quelli ad esso collegati, in modo da consentire modalità e meccanismi di aggiornamento automatico a cadenze prefissate nel corso della giornata; né si è mancato di rendere possibile un adeguato raffronto con gli anni decorsi (che pure hanno compreso la parentesi – auspicabilmente eccezionale – del periodo pandemico), popolando il database dei dati storici del lavoro a partire dal 2019.
Contemporaneamente, sono stati istituiti gruppi di lavoro interdisciplinari per seguire lo sviluppo del progetto complessivo, cui hanno concorso, oltre ai professori del Politecnico di Milano, i magistrati del Segretariato generale, il personale giudiziario e amministrativo del CED, l’ufficio statistico della Corte di cassazione: con successiva messa a disposizione dei risultati di tali discussioni collegiali per il confronto con i presidenti titolari e non titolari delle sezioni, con il Presidente aggiunto e con la Prima Presidente. Questa modalità di interazione tra le diverse professionalità si è rivelata determinante per condividere progetti e scelte destinati a riverberarsi, nella quotidiana attività della Corte, sull’efficacia della sua azione e sull’assetto organizzativo e tabellare[20].
È intuitivo che, a mano a mano che il cruscotto si raffina con la disponibilità sempre più sofisticata di dati ed elementi, sarà possibile individuare i settori dei nuovi interventi, interdisciplinari o meno, nonché gli oggetti delle successive interlocuzioni con tutti i coprotagonisti della gestione dell’ufficio, a cominciare dal personale non togato (cancellieri e ufficio del processo in generale).
8. Notazioni conclusive.
È stato efficacemente sottolineato[21] che “il cruscotto direzionale si è rivelato, sotto questo punto di vista, non un ordinario sistema di analisi e di gestione di dati conoscitivi, ma una sollecitazione importante a ripensare in chiave più moderna l’intero assetto della Corte di cassazione in modo da renderla più rispondente alle esigenze di una società in continua evoluzione, al rispetto della centralità del tempo nella vita delle persone, alle programmate politiche economiche di crescita e di sviluppo del Paese, influenzate anche dai tempi della giustizia nel settore civile”.
Al contempo, “il carattere assolutamente innovativo dell’esperienza vissuta dalla Corte di cassazione ha una valenza generale che trascende il peculiare assetto dell’ufficio in cui è maturata e meriterebbe ampia condivisione con gli uffici di merito, con l’Organo di governo autonomo della Magistratura, con la Scuola Superiore della Magistratura nella consapevolezza che il confronto fra le diverse Istituzioni sulle buone prassi rappresenta un’occasione utile e preziosa per suggerire ulteriori contributi propositivi e per riannodare i fili di un dialogo, talora spezzato, tra magistrati e collettività” [22].
Una gestione con mezzi moderni, duttili ed interattivi, di una pendenza dalla composizione spesso inadeguatamente conosciuta e dal peso sempre soffocante non è più differibile.
Il ruolo del dirigente dell’Ufficio, sia pure nella sua declinazione specifica propria dell’ufficio direttivo di presidente di sezione in Cassazione, deve quindi evolversi verso una compartecipazione proattiva nell’organizzazione della gestione della sezione, ad iniziare dalla consapevole composizione dei ruoli delle udienze e delle adunanze, in uno alla specifica e mirata utilizzazione degli strumenti processuali deflattivi specificamente disegnati (come, appunto, nel caso della Corte di cassazione, la proposta di definizione accelerata), con una disponibilità ad un’impostazione progettuale che va ben al di là del primario e fondamentale compito di organizzazione della giurisprudenza e della decisione della mole – pure, sempre crescente – di ricorsi da definire. Sarà, infine, importante che anche sugli strumenti incisivi, a tal fine offerti, di piena e completa informazione dello stato di pendenze e sopravvenienze, ci si possa confrontare, nel pieno rispetto dei ruoli, con gli altri magistrati dell’ufficio, gli altri dirigenti ed il personale di cancelleria indispensabile a sostenere le scelte gestionali.
[1] Testo dell’intervento tenuto il 28 ottobre 2024 a Scandicci, Villa Castel Pulci, al 3° modulo del Corso per magistrati neodirettivi e neo-semidirettivi (art. 26-bis, co. 5 bis, D.Lgs. n. 26/2006), organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura (cod.: FPFP24020-DIR24001).
[2] I. Tsiouras, La progettazione del sistema di gestione per la qualità nelle organizzazioni ad alta intensità informativa. Dalla ISO 9000 alla modellazione del business, F. Angeli editore, 2005, pp. 99 ss.
[3] La definizione, icastica, di “schermata che permette di monitorare in tempo reale l’andamento dei report e delle metriche più importanti” è in S. Ruffini, Competenze Digitali per la PA - Termini, definizioni e acronimi, Youcanprint editore (e-book), p. 65.
[4] Aa.Vv., La valutazione delle performance per il governo strategico delle Aziende Sanitarie Pubbliche, EGEA editore (e-book), 2013, p. 48, ove riferimenti bibliografici.
[5] Aa.Vv., La valutazione etc., cit., p. 49, ove si specifica pure che, inoltre, il buon cruscotto direzionale deve essere in grado di rappresentare la performance attraverso: a) indicatori “sempre validi”, con potenziale diagnostico elevato indipendentemente da obiettivi strategici specifici; b) indicatori specifici, da attivare in presenza di obiettivi strategici definiti e delle correlate leve azionate e iniziative strategiche perseguite per evitare il rischio di “omologazione”.
[6] A. De Luca, Il sistema di controllo di gestione in INPS: la misurazione e la valutazione delle performance, in Lavoro nelle P.A., fasc.1, 2013, pag. 83. Vi si osserva che “il ‘controllo’, da attuare nelle sue diverse espressioni, manifestazioni e applicazioni, deve essere inteso come quella funzione che rende i sistemi capaci di autoregolamentazione e non già come mera ‘verifica di conformità’ degli atti … alle prescrizioni normative e regolamentari. Per incidere efficacemente sull’efficienza, efficacia e qualità dei servizi non è sufficiente promuovere iniziative di controllo che intervengano solo al termine del ciclo produttivo, ma occorre inserire tale valutazione all’interno di un sistema di ‘controllo di gestione’ che consenta, in itinere, di attivare modifiche organizzative ed operative in direzione di obiettivi assegnati. Tutto ciò nell’ambito di un corretto e trasparente sistema di regole e rapporti, dovendo considerarsi in sede di analisi e valutazione le diverse specificità e i differenti contesti socio-economici ed ambientali nei quali si trovano ad operare le strutture”.
[7] R. Eccles, The performance measurement manifesto, in Harvard Business Review, (1991) 69(1), pp. 131-137.
[8] Reperibile all’URL https://rm.coe.int/cepej-2021-8-handbook-on-court-dashboards-en/1680a2c2f6.
[9] Questo il contenuto, poi analiticamente sviluppato:
A. Content of the dashboards. A.1 General definitions and purpose. A.2 Initial classification of the dashboards. A.3 Recommended KPIs for courts systems.
B. Visualisation of data. B.1 Data filtering. B.2 Composition of KPIs, layout and flow. B.3 Types of visual representation and correct use of colours.
C. Court-level template dashboards. C.1 Overall court performance. C.2 Incoming and pending cases in multiple case categories. C.3 Resolved cases comparison between different case categories. C.4 Focus on an individual case category. C.5 Timeframes comparison between multiple case categories. C.6 National overview.
D. Judge-level template dashboards. D.1 Electronic task board. D.2 Case counts and CR dashboard. D.3 Pending cases dashboard. D.4 Resolved cases dashboard.
E. Technical requirements. E.1 Data availability and access. E.2 Dashboard platform (software).
F. Guidelines for creating court dashboards.
[10] M. Cassano, Misurare per apprendere e migliorare: il cruscotto direzionale della Cassazione, in La Magistratura, 2024, on line dal 14/10/2024.
[11] Corte cost. 18 luglio 1973, n 143.
[12] M. Cassano, op. ult. cit., § 1.1.
[13] Fondamentali le prese di posizioni che si leggono in Cass. civ., Sez. U., 9 ottobre 2008, n. 24883, a mente della quale va preso atto “dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli”. Una tale impostazione si è consolidata nella giurisprudenza di legittimità: tra le ultime, Cass. civ., Sez. U., 17 gennaio 2019, n. 1248, oppure Cass. civ., ord. 4 ottobre 2024, n. 26046.
[14] M. Cassano, op. loc. ult. cit..
[15] M. Cassano, op. ult. cit., § 1.2.
[16] M. Cassano, op. loc. ult. cit..
[17] Basti pensare che, in base all’art. 224 della Circolare del C.S.M. per la formazione delle tabelle per il prossimo quadriennio (diramata, com’è noto, con nota 08/07/2024, n. P13382/24 del CSM), in linea generale i presidenti di sezione non titolari collaborano con il titolare con incarichi e modalità determinate nelle tabelle dell’ufficio, anche al fine di evitare l’insorgere di contrasti inconsapevoli tra le decisioni, come pure nella determinazione di criteri omogenei ed efficaci con cui individuare i processi destinati alla pubblica udienza, nonché della elaborazione dei criteri generali per la formazione del ruolo di udienza. Le tabelle in vigore, del triennio 2020-2022 e tuttora in regime di prorogatio, disciplinano minuziosamente le attribuzioni dei presidenti non titolari, al § 14:
“14.1. Il presidente di sezione non titolare presiede i collegi e svolge la correlata attività giudiziaria, collabora con il presidente titolare nello svolgimento di ogni attività funzionale all'organizzazione della sezione e all'esercizio della nomofilachia.
14.2. Il presidente di sezione non titolare svolge, su incarico del presidente titolare, funzioni di coordinamento di aree omogenee.
14.3. Nelle aree omogenee oggetto di attribuzione, i presidenti di sezione non titolari contribuiscono a prevenire i contrasti, anche inconsapevoli, di giurisprudenza mediante ogni opportuna misura, tenendone informato il presidente titolare. Essi coordinano, inoltre, la predisposizione e la diffusione all'interno della sezione di massime provvisorie su questioni di diritto nuove o di particolare importanza e curano l'aggiornamento dei magistrati sulla normativa e sulla giurisprudenza costituzionale ed europea nelle materie di loro competenza.
14.4. Ulteriori specifiche attività, in aggiunta a quelle indicate, possono essere attribuite, con decreto motivato del presidente titolare, tenuto conto della competenza e della disponibilità del presidente di sezione non titolare, per particolari e comprovate esigenze della sezione da indicarsi specificamente, sentiti gli altri presidenti di sezione e dandone informazione al Primo Presidente”.
Infine, i decreti della Prima Presidente – fra tutti segnalandosi il n. 76 del 2023 – di riorganizzazione dell’intero assetto del settore civile (con la ripartizione di aree tematiche all’interno di ogni sezione civile) hanno individuato compiti anche più ampi e delicati: per l’espletamento dei quali, già solo prendendo a riferimento la sostanziale istituzionalizzazione della formazione dei ruoli di udienza o adunanza e la gestione dell’ufficio spoglio sezionale, il cruscotto effettivamente fornisce elementi e dati preziosi ed utili.
[18] M. Cassano, op. ult. cit., § 1.3.
[19] M. Cassano, op. loc. ult. cit..
[20] Su tutti tali aspetti, si veda M. Cassano, op. ult. cit., § 1.4.
[21] M. Cassano, op. ult. cit., § 1.5.
[22] M. Cassano, op. loc. ult. cit..
Immagine: Alvesgaspar, CC BY-SA 4.0
Lo strano caso, o forse no, delle elezioni dei Consigli giudiziari
di Riccardo Ionta
Un gruppo di uomini indecisi a tutto. La pratica letteraria, icastica, di Ennio Flaiano restituisce sempre una immagine della nostra complessa realtà. Il presente scritto ripercorre la vicenda, ancora aperta, delle elezioni dei Consigli giudiziari (e, seppur non espressamente, del Consiglio direttivo della Cassazione) come occasione per una riflessione sullo stato, e sulle sorti, della nostra democrazia ordinamentale.
Sommario: 1. La tormentata epoca delle nuove elezioni: parte prima (3 aprile 2016-13 dicembre 2023) - 2. I termini del procedimento elettorale e la durata dei Consigli - 3. La tormentata epoca delle nuove elezioni: parte seconda (13 dicembre 2023-25 novembre 2024) - 4. Quale partecipazione, quale democrazia ordinamentale - Approfondimenti.
1. La tormentata epoca delle nuove elezioni: parte prima (3 aprile 2016-13 dicembre 2023)
3 e 4 aprile 2016. Elezioni dei Consigli giudiziari per il quadriennio 2016-2020. L’art. 1.1 del decreto legislativo 28 febbraio 2008 n. 35 prevede che le elezioni avvengano ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile.
9 marzo 2020. Lockdown. Il governo estende le misure di contenimento a tutto il territorio italiano.
17 marzo 2020. È con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che inizia lo strano caso delle elezioni dei Consigli Giudiziari. L’art. 83.19, per evidenti necessità dettate dalla pandemia, per l'anno 2020, dispone che le elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione si svolgeranno, invece che ad aprile 2020, la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre 2020. L’effetto indiretto della norma è la proroga dei Consigli insediati (art. 7.2 decreto legislativo 28 febbraio 2008 n. 35 secondo cui fino al completamento delle nuove operazioni elettorali, rimane in carica il precedente consiglio e art. 13.5 decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 secondo cui finché non è insediato il nuovo consiglio giudiziario, continua a funzionare quello precedente).
4 e 5 ottobre 2020. Elezioni dei Consigli giudiziari per il quadriennio 2020-2024.
13 dicembre 2023. Il Plenum del C.S.M. discute in merito alla risposta da fornire al quesito posto dal Consiglio giudiziario di Firenze (e ai dubbi di molti). Quando si svolgeranno le elezioni dei nuovi Consigli? Se il comma 19 dell’art. 83 ha differito le elezioni all’ottobre 2020, l’art. 1.1 del decreto legislativo 28 febbraio 2008 n. 35 prevede ancora che le elezioni si svolgano ad aprile. Allo stesso tempo, celebrare le elezioni nell’aprile 2024 contrasta con la previsione della durata quadriennale dei Consigli di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. La Sesta Commissione vota all’unanimità: la normativa può interpretarsi nel solo senso che le elezioni si svolgeranno nell’aprile 2025. Solo in tal modo è possibile superare l’apparente contrasto e rispettare al contempo – con l’ausilio degli art. 7.2 d.lgs. n. 35/2008 e 13.5 d.lgs. n. 25/2006 – sia la norma sulla durata dei Consigli, sia quella sull’epoca delle elezioni. Il Plenum a maggioranza, su proposta di un consigliere di MI, decide il ritorno in Sesta Commissione della pratica per acquisire il parere dell’Ufficio Studi.
2. I termini del procedimento elettorale e la durata dei Consigli
Senza che vi sia una apparente, o quantomeno evidente, ragione logica la disciplina dei Consigli è contenuta in due separati decreti legislativi: il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 “Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari” e il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 “Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari”.
La durata quadriennale dei Consigli, come visto, è indicata dall’art. 13 del d.lgs. n. 25/2006. Il decreto disciplina - oltre alla composizione e alle competenze dell’organo di autogoverno - anche parte del procedimento elettorale (art. 12 e ss.)
Il decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 contiene la gran parte della disciplina elettorale e quindi la disciplina dei termini del procedimento.
- Le elezioni avvengono ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile (art. 1.1). Avendo previsto le elezioni nell’unico mese in cui cade la principale festività mobile dell’anno, il legislatore ha avuto cura di precisare che qualora nella prima domenica di aprile cada la festività della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedì immediatamente successivi (art. 1.2).
- Le schede elettorali sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni a cura del Ministero della giustizia (art. 4.1).
- Entro il martedì precedente lo svolgimento delle elezioni, sono costituiti gli uffici elettorali (art. 2.1).
- Entro il giovedì precedente lo svolgimento delle elezioni devono esser presentate le liste di candidati all'ufficio elettorale competente, unitamente alle firme dei sottoscrittori, ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione (art. 2.1).
- Il venerdì e il sabato antecedenti le elezioni, ogni ufficio elettorale verifica che le liste siano conformi, in base alle rispettive attribuzioni, alle disposizioni di cui agli articoli 4, 12 e 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (art. 2.6).
- La votazione si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedì successivo (art. 4.1).
- Alle ore quattordici del lunedì, dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale: dichiara chiusa la votazione; accerta il numero dei votanti; procede allo spoglio dei voti; forma separati elenchi per categoria; proclama gli eletti. In caso di più uffici elettorali il presidente trasmette copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio avente sede nel capoluogo del distretto. Questi procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni lista e da ogni candidato negli uffici elettorali istituiti nel distretto (art. 5).
- Entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati può esser presentato il reclamo in merito alla validità delle liste, alla eleggibilità dei candidati ed alle operazioni elettorali. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione della Corte di appello competente per gli affari civili con ordinanza motivata non impugnabile adottata entro otto giorni. Decorsi i termini le schede sono distrutte (art. 6).
3. La tormentata epoca delle nuove elezioni: parte seconda (13 dicembre 2023-25 novembre 2024)
13 dicembre 2023. Il Plenum, come visto, decide il ritorno in Sesta Commissione della pratica di risposta al quesito sulla data prevista per le elezioni.
30 dicembre 2023. A dicembre, oltre al Natale e all’ultimo giorno dell’anno, puntualmente giunge il c.d. “Decreto milleproroghe”. Arriva quindi il decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 che con l’art. 11.6, “al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari”, differisce le elezioni dal mese di aprile 2024 al mese di ottobre 2024.
23 febbraio 2024. La legge n. 18 di conversione del “milleproroghe” modifica il comma 6 dell’art. 11 disponendo che per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre 2024. Le ragioni giuridiche del differimento non sono evidenti e in ogni caso il risultato ottenuto è stato quello di un ulteriore slittamento delle elezioni di soli due mesi.
L’art. 1 del d. lgs. n. 35/2008, in tutta questa storia legislativa, non è mai interessato dalle modifiche e continua a prevede che le elezioni avvengano ad aprile: il problema quindi dovrebbe riproporsi, tale e quale, alle prossime elezioni del 2028 dei Consigli.
Settembre 2024. Il Ministero non invia nei termini di legge le schede elettorali.
Autunno 2024. Tra i corridoi inizia a serpeggiare la notizia di un rinvio delle elezioni ad aprile 2025. Rinvio che interessa a molti, per diverse ragioni, e che normativamente consente di arrivare al ricongiungimento normativo con l’art. 1 del d. lgs. n. 35/2008 e a porre così fine all’effetto farfalla, innescato dall’art. 83.19 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e alimentato dallo stesso legislatore. Le voci continuano a rincorrersi, la data del 1 e 2 dicembre prevista per le elezioni si avvicina. Tutti, o quasi, confidano nel rinvio: le attività amministrative preparatorie procedono senza fretta, la campagna elettorale latita.
25 novembre 2024. “Il Consiglio dei ministri è convocato lunedì 25 novembre 2024, alle ore 17.45 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: schema di decreto-legge: misure urgenti in materia di giustizia (Presidenza - Giustizia)” così recita l’ordine del giorno del C.D.M. La norma del rinvio dovrebbe esser contenuta in un difficile decreto-legge contenente anche un nuovo e pericoloso illecito disciplinare (“la consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi in cui è espressamente previsto dalla legge l’obbligo di astenersi o quando sussistono gravi ragioni di convenienza”) e delicate norme in materia di cybersicurezza.
Ore 17:12. Dalla stampa giunge la notizia del rinvio dell’esame del decreto sulla giustizia ad altra seduta su richiesta di una delle forze di governo.
4. Quale partecipazione, quale democrazia ordinamentale
1 e 2 dicembre 2024 resta, ad oggi e in modo ancora incerto, la data delle elezioni.
Lo strano caso, o forse no, delle elezioni pone la questione del senso della partecipazione e della democrazia ordinamentale in relazione al primo e immediato organo di autogoverno, il Consiglio giudiziario, le cui origini sono più antiche di quelle del C.S.M.
Il processo democratico di formazione dei Consigli è in difficoltà per tante ragioni. E la storia di queste elezioni ne è un chiaro sintomo. Difficoltà che è la premessa della annunciata tecnicizzazione e regressione democratica, da attuare mediante sorteggio, del C.S.M.
Si indicano almeno quattro di queste ragioni.
Il Consiglio giudiziario è spesso degradato ad organo esclusivamente “tecnico-giuridico” (sempre che questa espressione abbia un reale significato). E tuttavia resta un organo democratico che esprime ed assume frequentemente indirizzi di “politica giudiziaria” o “ordinamentale” che dir si voglia. Basti pensare alle diverse scelte in merito alla trasparenza dei lavori dei consigli, al diverso atteggiamento da assumere sul vaglio delle regole organizzative degli uffici, al differente modo di affrontare le spinte gerarchiche presenti, e così via. Le norme e la realtà non saranno mai così cristalline da elidere la necessità della scelta valoriale. Per tale ragione la maggioranza dei suoi componenti è - e si auspica resti - elettiva. Se il Consiglio non è un ufficio meramente tecnico-amministrativo allora la sua elezione non deve esser svilita a mero passaggio burocratico.
La disaffezione nei confronti della vita associativa e ordinamentale si accompagna, da tempo, alla trasformazione in senso dispregiativo della espressione “politica giudiziaria” o “politica ordinamentale”. Resta così un affare di pochi. E diventa di conseguenza difficile coinvolgere sia l’elettorato attivo, sia quello passivo, anche nel processo democratico di prossimità.
La struttura normativa delle elezioni del Consiglio e la lettura data spesso dai gruppi associativi alle elezioni hanno poi contribuito ad alimentare il circolo della disaffezione politico-giudiziaria e la visione apolitica (intesa come assenza di idee e valori) dei Consigli. La disaffezione muove anche e forse soprattutto dal basso e si congiunge con precise aspirazioni politico-partitiche di riduzione della giustizia a mera tecnica.
Le norme elettorali non favoriscono la partecipazione, soprattutto nei distretti medio-piccoli. Basti considerare, ad esempio, che l’art. 12 d. lgs. n. 25/2006 prevede la raccolta di 25 firme di elettori per la presentazione della lista e tanto sia per il distretto di Roma che per quello di Campobasso. L’art. 3 d. lgs. n. 35/2008 consente invece ai Presidenti di Corte di stabilire discrezionalmente il numero degli uffici elettorali da costituire nel distretto. L’assenza di un termine iniziale delle operazioni elettorali - in particolare della raccolta firme – spinge poi a condotte di accaparramento delle sottoscrizioni che possono soffocare, sin dall’inizio, nuove iniziative democratiche.
I gruppi associativi e i distretti - anche in ragione delle difficoltà normative riportate e della disaffezione sottolineata - hanno ceduto spesso alla prassi del c.d. “listino unico bloccato” (unica lista con tanti candidati quanti sono i posti da eleggere, come previsto dall’art. 12 del d.lgs. 25 del 2006, suddivisi tendenzialmente per appartenenza territoriale) alimentando il circolo vizioso e l’idea distorta del consigliere giudiziario quale rappresentante di un territorio o di un ufficio, invece che portatore di idee e valori.
La tormentata vicenda delle nuove elezioni - l’andirivieni di date e ipotesi - ha certamente ingenerato un diffuso e colpevole affidamento nel rinvio che ha addormentato il confronto elettorale rendendolo ad oggi, di fatto, quasi impossibile. L’ipotizzato rinvio delle elezioni nei prossimi giorni - favorito dalla latitanza delle schede elettorali in ragione delle scelte del Ministero e come tale formalmente impeccabile - sarebbe comunque un ulteriore svilimento della democrazia ordinamentale (anche considerando i termini previsti dal procedimento elettorale: martedì 26 per la costituzione degli uffici e giovedì 28 per la presentazione delle liste).
L’assenza di confronto elettorale ed essersi affidati ad una manovrabile norma di rinvio per le elezioni è democratico? Il rinvio delle elezioni democratiche a pochi giorni dalla data prevista è democratico? Quale partecipazione, quale democrazia ordinamentale?
Democrazia. Parola di uso comune, anche nella sua declinazione come aggettivo. È ampiamente diffusa. Suggerisce un valore… Non è fuor di luogo, allora, chiedersi se vi sia, e quale, un’anima della democrazia. O questa si traduce soltanto in un metodo? Cosa la ispira? Cosa ne fa l’ossatura che sorregge il corpo delle nostre Istituzioni e la vita civile della nostra comunità? È un interrogativo che ha accompagnato e accompagna il progresso dell’Italia, dell’Europa. Alexis de Tocqueville affermava che una democrazia senz’anima è destinata a implodere, non per gli aspetti formali, naturalmente, bensì per i contenuti valoriali venuti meno (Discorso del Presidente della Repubblica e, si ricorda, Presidente del C.S.M. Sergio Mattarella, Trieste 3 luglio 2024).
Approfondimenti
Sul tema dei Consigli giudiziari, su questa rivista, si segnala:
Il Consiglio giudiziario, questo sconosciuto di Marcello Basilico
Direttivi e semidirettivi, nomine e conferme. La parola al Consiglio giudiziario. Intervista di Federica Salvatore e Riccardo Ionta a Riccardo Ferrante, Cataldo Intrieri e Giuseppe Sepe.
Sette anni al Consiglio Giudiziario di Brescia. Un bilancio che va oltre l'esperienza locale di Claudio Castelli
Immagine: Karma di Do-Ho Suh, 2003.
Sulla natura giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L‘Adunanza Plenaria si pronuncia sulla violazione del principio di alternatività (nota a Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 maggio 2024, n. 11).
di Silvia Casilli
Sommario: 1. Premessa: i fatti di causa e il thema decidendum. – 2. La pronuncia dell’Adunanza Plenaria. – 3. Sulla natura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: tra funzione giustiziale e forma provvedimentale. –– 4. Lo statuto della nullità dei provvedimenti amministrativi.
1. Premessa: i fatti di causa e il thema decidendum.
Con la sentenza n. 11 del 2024, l’Adunanza Plenaria si è pronunciata in ordine alla natura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e al regime del decreto decisorio del Presidente della Repubblica reso erroneamente su ricorso straordinario ormai trasposto in sede giurisdizionale.
La vicenda da cui trae origine la questione sorge da un mancato coordinamento tra la decisione resa in sede giurisdizionale, a seguito di rituale trasposizione, ed il parallelo procedimento proseguito ai sensi degli artt. 8 ss. d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e culminato con l’erronea emanazione del decreto decisorio.
In particolare, la vicenda contenziosa nasce dalla realizzazione, senza alcun previo titolo abilitativo, di un manufatto abusivo per il quale veniva poi presentata istanza di condono, cui il Comune rispondeva con un diniego; il diniego di condono veniva impugnato con un primo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria pronunciatosi con sentenza di rigetto, confermata in appello dal Consiglio di Stato.
Nel frattempo, il Comune adottava una prima ordinanza di demolizione dell’opera realizzata in assenza di titolo autorizzativo. Avverso tale ordinanza (n. 754/2006) il privato cittadino artefice del manufatto abusivo proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale dinnanzi al medesimo Tar[1].
Nelle more del giudizio da ultimo indicato, il Comune ingiungeva nuovamente la demolizione con una nuova ordinanza (n. 43/2008, ripetitiva della precedente n. 754/2006) impugnata innanzi al Tar[2], che respingeva la domanda[3].
Nonostante la rituale trasposizione in sede giurisdizionale del giudizio avente ad oggetto la prima ordinanza di demolizione, il 18 novembre 2020 veniva erroneamente emesso il decreto del Presidente della Repubblica con il quale veniva accolto il ricorso straordinario proposto avverso l’ingiunzione n. 754/2006.
Successivamente, in senso opposto interveniva la sentenza a definizione del giudizio (n.r.g. 1240 del 2006) relativo allo stesso ordine di demolizione n. 754/2006 con la quale il Tar, respingendo il ricorso, rilevava che “il decreto presidenziale […] è intervenuto dopo la rituale trasposizione del contenzioso innanzi a questo giudice, in cui si era radicata definitivamente la giurisdizione e, pertanto, esso non preclude una decisione sul merito nel presente giudizio”.
I giudici amministrativi, dunque, precisavano immediatamente come il radicamento della propria giurisdizione non potesse essere intaccato dall’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, essendo questo intervenuto solo dopo la rituale trasposizione del contenzioso in sede giurisdizionale.
Ciò nonostante, il privato cittadino appellava la predetta sentenza sulla scorta di tre motivi, tra cui l’asserita elusione del decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2010. L’appellante, muovendo dall’assunto della “natura sostanzialmente giurisdizionale” del ricorso straordinario “e dell’atto terminale della relativa procedura”, sosteneva l’impossibilità per il giudice di disattendere il parere recepito nel decreto presidenziale, pena la violazione della regola dell’alternatività tra i due mezzi di gravame espressa dall’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971, sulla base di un’asserita lapalissiana influenza del decreto sul processo di convincimento del giudice.
In altri termini, la decisione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica viene tratteggiata dal ricorrente come cosa giudicata.
A fronte del ricorso presentatole, la Sezione VI del Consiglio di Stato osservava come la controversia ponesse la questione inedita del rapporto esistente tra la decisione resa su un ricorso straordinario, nonostante il giudizio fosse stato ritualmente trasposto, e la sentenza adottata in sede giurisdizionale, nel caso in cui le due pronunce abbiano avuto esiti contrastanti.
La soluzione che l’Adunanza Plenaria è chiamata a fornire attiene, sì, al regime del decreto decisorio reso all’esito del ricorso straordinario, ma prima ancora alla natura stessa di tale strumento, questione strettamente funzionale alla risoluzione del quesito se la pronuncia resa sul ricorso straordinario sia idonea a passare in giudicato in una maniera assimilabile alla sentenza pronunciata dal giudice amministrativo.
La Sezione rimettente, infatti, ritiene sussistenti ancora profili di incertezza circa la natura del ricorso straordinario e la portata del principio di alternatività enunciati dall’art 8 d.P.R. n. 1199/1971, pertanto – affermando di propendere per la tesi della nullità sul rilievo della natura soggettivamente amministrativa della decisione che definisce il ricorso straordinario, con conseguente applicabilità delle norme che regolano le invalidità del provvedimento amministrativo – ha rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria il quesito volto a chiarire quale sia “il regime giuridico del decreto decisorio del Presidente della Repubblica reso erroneamente su ricorso straordinario ormai trasposto, ossia: se ad esso sia o non sia riferibile l’insegnamento consolidatosi che considera la decisione di un ricorso straordinario non trasposto avente valore di cosa giudicata e, nel caso in cui tale decreto decisorio del Presidente della Repubblica non abbia valore di cosa giudicata, se debba essere considerato nullo ai sensi dell’art. 21 septies della legge 241 del 1990 perché reso in astratta e totale carenza di potere per violazione del principio di alternatività dei rimedi”
2. La pronuncia dell’Adunanza Plenaria.
L’Adunanza Plenaria, con la sentenza in commento, ha preso posizione netta sulla natura del ricorso straordinario, ponendosi in aperto contrasto con la tendenza, sempre maggiormente consolidata in seno a una parte della giurisprudenza[4], a riconoscere una sorta di progressiva “giurisdizionalizzazione”[5] del ricorso straordinario, che avrebbe una natura “formalmente amministrativa, ma sostanzialmente giurisdizionale”[6] .
I principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria[7] sono, infatti, i seguenti: “Il ricorso straordinario è un rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale, di cui condivide soltanto alcuni profili strutturali e funzionali. La decisione resa su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sebbene il giudizio fosse stato ritualmente trasposto in sede giurisdizionale, è nulla ai sensi dell’art. 21 septies del c.p.a., in quanto emanata in difetto assoluto di attribuzione”.
Per giustificare tali conclusioni, i giudici affermano come l’individuazione della regola atta a dirimere il contrasto pratico loro sottoposto sia dipesa dalla qualificazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e dal regime giuridico conseguentemente applicabile al decreto decisorio.
Attraverso un ineccepibile percorso argomentativo, di cui si dirà diffusamente a breve, volto a ribadire la tesi tradizionale della natura amministrativa, o meglio, giustiziale del rimedio, l’Adunanza Plenaria, avendo dato atto dei due orientamenti contrapposti sulla natura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e delle relative conseguenze del regime giuridico applicabile al decreto decisorio reso all’esito del procedimento, attraversa la storia dell’istituto ripercorrendo l’accidentato percorso normativo e giurisprudenziale che lo ha caratterizzato, per poi approdare al dibattito più recente, raffrontando la compatibilità dei diversi orientamenti contrapposti con il quadro normativo esistente.
Svolta tale approfondita ricostruzione, il Supremo Consesso Amministrativo ha ravvisato la necessità di affinare ulteriormente il quadro concettuale e ricostruttivo, a partire da un’imprescindibile indagine sulla portata della nozione di giurisdizione (e non sovrapponibilità della stessa con la nozione di giudice) e di cosa giudicata, senza tralasciare la ratio della regola dell’alternatività di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 per poi tracciare, una volta data adesione alla teoria giustiziale, il regime giuridico dell’atto conclusivo che rappresenta un provvedimento amministrativo a tutti gli effetti e come tale trova la propria disciplina, nelle norme sull’invalidità amministrativa.
3. Sulla natura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: tra funzione giustiziale e forma provvedimentale.
Il punto di partenza da cui muove l’Adunanza Plenaria, su cui si spende gran parte della pronuncia, attiene alla qualificazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Vengono immediatamente prospettate, in apertura della parte in diritto, le due letture[8] attorno alle quali si è polarizzato il dibattito sulla natura del rimedio in esame.
Da una parte la tesi tradizionale[9] – fondata originariamente sulla natura amministrativa dell’organo promanante la decisione, sulla natura obbligatoria ma non vincolante del parere del Consiglio di Stato[10], sull’inidoneità delle decisioni del Presidente della Repubblica a passare in giudicato, e sull’impossibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale e di effettuare rinvio pregiudiziale[11], nonché sul principio di alternatività – vede nel ricorso straordinario un rimedio di natura amministrativa[12].
Dall’altra, la tesi della natura “sostanzialmente giurisdizionale”[13] trova sostegno negli indici della presenza del parere del Consiglio di Stato, nello stesso principio di alternatività che starebbe a dimostrare l’equiordinazione rispetto al rimedio giurisdizionale, nella tendenziale immutabilità delle decisioni rese su ricorso straordinario, nella possibilità di esperire il rimedio della revocazione[14] e nel principio del contraddittorio, accentuato nell’ambito del ricorso straordinario.
Diverse sono le conseguenze che discendono sul piano pratico, per la questione sottoposta al vaglio dell’Adunanza, a seconda che si sposi l’una o l’altra teoria.
Seguendo l’impostazione tradizionale, la fattispecie andrebbe sussunta sotto le norme che disciplinano l’invalidità dell’atto amministrativo (segnatamente, la nullità per difetto di attribuzione) che in quanto tale sarebbe privo della forza e del valore giuridico per imporsi o condizionare l’accertamento giurisdizionale.
La tesi che invece configura il ricorso straordinario come sostanzialmente giurisdizionale dovrebbe comportare una soluzione diametralmente opposta: la pronuncia sul ricorso straordinario, in maniera non dissimile alla sentenza del giudice amministrativo, sarebbe idonea a passare in giudicato con una serie di conseguenze: la violazione della norma sull’alternatività tra sede straordinaria e giurisdizionale si tradurrebbe in un vizio del decreto che, in applicazione del principio generale della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, andrebbe fatto valere tramite il mezzo di impugnazione previsto dalla legge (nel caso di specie quello di cui all’art. 10 comma 3 del d.P.R. n. 1199/1971), risultando altrimenti sanato; il mezzo attraverso il quale dovrebbe essere rilevata l’esistenza di un precedente decreto decisorio (equiparato alla sentenza) ormai “stabile”, sarebbe l’eccezione di cosa giudicata; solo ove non fosse rilevata l’eccezione di cosa giudicata o proposta revocazione avverso la seconda sentenza[15] si determinerebbe, in caso di difformità tra le due pronunce, un contrasto tra giudicati in cui sarebbe l’ultimo giudicato a prevalere sul precedente.
Al fine di dimostrare la fondatezza della tesi tradizionale, la sentenza in commento, tralasciando la trattazione sull’origine storica dell’istituto[16], ripercorre il dibattito che lo ha caratterizzato.
Sino al 2009, l’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza amministrativa intendeva il ricorso straordinario come un rimedio contenzioso di natura amministrativa. In quest’ottica non vi era spazio per il riconoscimento, in capo alle sezioni consultive del Consiglio di Stato, della legittimazione a sollevare l’incidente di costituzionalità né della proponibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle decisioni rese su ricorso straordinario o della loro ricorribilità per motivi di giurisdizione.
La discussione sulla natura del rimedio venne rivitalizzata dall’entrata in vigore della l. 69/2009 che, all’art. 69, ha modificato l’art. 13 d.P.R. n. 1199/1971 prevedendo che la Sezione consultiva “se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale” nonché l’art. 14 del medesimo d.P.R., eliminando la potestà del Governo di deliberare in senso difforme rispetto al parere espresso dal Consiglio di Stato. A fronte anche delle ulteriori innovazioni introdotte dal codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104[17], a seguito del riconoscimento da parte della Corte di Cassazione di una serie di rimedi che spostavano l’asse del rimedio verso la natura giurisdizionale, quali l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione dei decreti resi su ricorsi straordinari[18], nonché la loro impugnabilità per motivi inerenti alla giurisdizione[19], la giurisprudenza di legittimità ha sempre più mostrato la propria propensione a riconoscere nel decreto presidenziale un’estrinsecazione sostanziale della funzione giudiziaria.
Diverso è, invece, il tenore delle pronunce della Corte Costituzionale[20] e del Consiglio di Stato che hanno, seppur quest’ultimo in maniera altalenante, negato la piena coincidenza dei due rimedi, per quanto possano dirsi assimilabili sotto taluni profili[21], senza che però ne venga mutata la natura amministrativa.
Da tale ricostruzione emerge innegabilmente un quadro complesso. In più, ragionevolmente, i giudici della Plenaria evidenziano come le formule linguistiche che, prudentemente e con diverse sfumature, alludono ad un’assimilazione del rimedio straordinario a quello giurisdizionale non appaiono, tuttavia, esaustive sul piano definitorio; in altri termini, non viene mai chiarito come “l’asserita antinomia – o ambivalenza – tra forma (di atto amministrativo) e sostanza (di atto decisorio) possa incidere sulla collocazione sistematica e sul regime giuridico dell’istituto”[22]; l’interprete, in altre parole, si mostra spesso restio ad abbandonare quella prudenza che lo trattiene in una costante incertezza definitoria.
Il progressivo riconoscimento della natura giustiziale del ricorso straordinario ha spinto, pertanto, a ingenerare quasi un equivoco lessicale fondato sull’arbitraria sovrapposizione dei concetti di giustiziale e giurisdizionale. Tale equivoco è particolarmente evidente a fronte di un istituto giuridico quale quello del ricorso straordinario, residuato invero di un’altra epoca del nostro diritto, ma pervenuto sino a noi, ove la natura amministrativa del rimedio giustiziale si colloca oggi in evidente contrasto col sentimento di tutela del diritto di difesa ormai imprescindibile nelle ipotesi di tutela giurisdizionale. Da ciò l’esigenza degli interpreti di piegare il lessico normativo e, di conseguenza, la sostanza del rimedio, per il perseguimento di questo obiettivo[23].
Proprio a fronte di tale incertezza lessicale e inconcludenza sul piano definitorio, il Supremo Consesso ravvisa l’esigenza di affinare ulteriormente il quadro concettuale e ricostruttivo, a partire dalla nozione di “giurisdizione” che, sin da subito, viene differenziata dalla rappresentazione ideale della funzione di rendere giustizia, dovendosi invece definire come attributo di specifica e concreta attività statale da disciplinare. Vanno scartati i tentativi dottrinali di definizione della giurisdizione sulla base di aspetti di tipo contenutistico o sulla base del dato strutturale – ossia quello di essere l’accertamento dei giudici contrassegnato dal particolare regime di cosa giudicata – dovendosi optare per l’unica definizione attendibile, basata non sul dato ontologico quanto sull’aspetto soggettivo: “la giurisdizione è l’attività di accertamento e decisoria che l’ordinamento imputa ai giudici, come individuati dalle norme costituzionali sulla competenza (artt. 101, 102 e 103 Cost.)”[24].
Partendo da tale concetto di attività giurisdizionale, demandata all’autorità giudiziaria ordinaria e agli altri organi di giurisdizione contemplati dalla Costituzione, tra cui i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato, l’Adunanza Plenaria dimostra, a partire dalla qualificazione normativa dell’istituto, come gli indici normativi depongano tutti nel senso della natura amministrativa del rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il d.P.R. n. 1199/1971 configura espressamente il ricorso come rimedio amministrativo, anche il procedimento[25]illumina la natura non giurisdizionale del rimedio. Difettano, infatti, tutti gli elementi propri dell’attività giurisdizionale in quanto: normalmente non viene garantito il contraddittorio e il parere è espresso in seduta non pubblica nella quale non è ammessa discussione orale; il parere del Consiglio di Stato è un atto endoprocedimentale, che acquista valore fino a quando non viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica; il decreto conclusivo è un atto ministeriale perché controfirmato dal Ministro, che ne assume responsabilità politica e giuridica; la decisione finale viene imputata allora allo Stato come persona giuridica e non all’organo giurisdizionale; emerge, infine, un’autonomia strutturale della decisione del Presidente della Repubblica e Ministro rispetto a quella del Consiglio di Stato in quanto gli eventuali vizi propri del segmento successivo al parere possono essere fatti valere ai sensi dell’10 comma 3 d.P.R. 1199/1971 e il fatto che il Presidente della Repubblica abbia la facoltà di richiedere il riesame del parere restituendo gli atti al Ministro competente, sostiene la teoria che la decisione finale non sia meramente dichiarativa di una pronuncia dell’organo giurisdizionale.
Significativa, in questa ricostruzione, è la caratteristica – richiamata a fondamento di entrambe le teorie sulla natura del ricorso straordinario – dell’alternatività del rimedio rispetto a quello giurisdizionale. In quest’ottica, l’argomento è richiamato a sostegno dell’eterogeneità dei due rimedi, che, pur presentando punti di contatto, hanno natura diversa; non a caso è prevista la possibilità di trasporre il ricorso in sede giurisdizionale, evidenziandosi in tal modo la diversità e complementarietà dei due, che danno vita ad un sistema integrato di tutela. L’art. 8 d.P.R. n. 1199/1971 subordina, infatti, l’ammissibilità del ricorso straordinario alla condizione che lo stesso interessato non abbia impugnato il medesimo atto con ricorso giurisdizionale; il ricorso straordinario diviene improcedibile qualora l’amministrazione o il controinteressato abbiano trasposto il giudizio in sede giurisdizionale (art. 10).
Lo stesso c.p.a. prende allora in considerazione il ricorso straordinario al solo fine di disciplinare gli effetti processuali della predetta trasposizione. La generalizzazione della facoltà di opposizione estesa a tutte le parti art. 48 comma 1 c.p.a.) si spiega per salvaguardarne il diritto di azione in sede giurisdizionale: la locuzione di cui all’art. 48 c.p.a. (secondo cui se l’opposizione è dichiarata inammissibile il tribunale dispone la restituzione del fascicolo “per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria”) è semplicemente un meccanismo di raccordo con il rimedio amministrativo conseguente all’accertata inidoneità dell’opposizione a comportare la trasposizione.
A spiegare la natura giustiziale del ricorso straordinario è la stessa ratio dell’opposizione, volta a garantire ai controinteressati e alle parti resistenti la piena libertà di adire la tutela giurisdizionale e non quella di scegliere tra due rimedi entrambi giurisdizionali[26]: la trasposizione esprime allora “un rapporto di complementarietà tra il mezzo giustiziale e quello giurisdizionale, entrambi parti di un sistema comunicante e integrato di tutela”[27].
Non può poi ignorarsi lo stesso art. 69 della legge n. 69/2009 che, rubricato “Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione”, sottolinea esplicitamente l’intenzione legislativa di incrementare le garanzie di un rimedio giustiziale e non di certo di trasformarlo in mezzo di impugnazione giurisdizionale.
Il dato positivo è allora inequivoco e, poiché le norme processuali rinviano a una nozione formale di giurisdizione, le relative disposizioni non possono estendersi ad attività poste in essere da soggetti diversi dai giudici. Pur a fronte dell’indeterminatezza dei termini del linguaggio naturale, l’interpretazione non è mai un atto libero da vincoli e deve pur sempre muoversi, nell’attribuzione del significato, nel perimetro della volontà del legislatore. La nozione di rimedio “formalmente amministrativo, ma sostanzialmente giurisdizionale” non trova alcun riscontro nel dato normativo ed è priva di un effettivo significato.
Perciò l’Adunanza Plenaria nega la possibilità di riqualificare in via pretoria un intero istituto, ricollocando una classe di ipotesi da una sede normativa ad un’altra, in quanto tale operazione trascende il testo ed è destinata a creare ulteriori antinomie: affidare agli interpreti una tale discrezionalità significa esporsi ad esiti imprevedibili, fondati su criteri ondivaghi ed evanescenti[28].
Né si può dal contesto sovranazionale estrapolare una definizione autonoma di giurisdizione, distorcendo una definizione funzionale che, nell’elaborazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Strasburgo, ha semplicemente lo scopo di assicurare allo strumento del rinvio pregiudiziale la garanzia dell’“effettività” del diritto europeo, e certamente non di ampliare la nozione, inglobando un rimedio amministrativo nel sistema giurisdizionale[29].
La possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale o di effettuare il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia non può essere assunta quale indice della natura giurisdizionale del rimedio in quanto le nozioni di giurisdizione, e ancor più quella di giudice[30], adottate a tal fine sono, dunque, più ampie rispetto a quelle delineate dal diritto interno e rispondono ad un diverso fine che ne giustifica la connotazione in senso sostanziale.
Su queste basi, l’Adunanza Plenaria, tira le fila della digressione, dettando[31] le proprie conclusioni:
Proprio alla luce dell’impossibilità di qualificare la decisione amministrativa come cosa giudicata in senso tecnico, la Plenaria fa un ultimo passaggio mettendo in discussione anche quell’orientamento[33] che la ritiene impugnabile ai sensi dell’art. 111 comma 8 Cost.: la posizione favorevole al ricorso di cui all’art. 362 c.p.c., infatti, sembrerebbe collidere con l’art. 10 comma 3 d.P.R. n. 1199/1971, ove si prevede la possibilità di impugnare la decisione resa su ricorso straordinario davanti al giudice amministrativo: per le parti del giudizio, unicamente per vizi di forma o di procedimento; per il soggetto pregiudicato dalla decisione straordinaria, ma non evocato in sede straordinaria, anche per tutti altri possibili errori di giudizio della decisione[34].
Sicché sembrerebbe quantomeno asistematico fare discendere dalla (asserita) “ambivalenza” del ricorso straordinario finanche una divaricazione del regime delle impugnazioni: il giudizio amministrativo di legittimità con riguardo alla “forma amministrativa”; il ricorso per cassazione in ragione della “sostanza giurisdizionale”. Impugnazioni che, per giunta, sarebbero concorrenti tra di loro, mancando una qualsivoglia norma di coordinamento.
Ad opinione della Plenaria appare, quindi, preferibile ritenere che l’art. 7, comma 8, del c.p.a. – il quale ammette il ricorso straordinario “unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa” – contenga una norma che delimita l’ambito di applicazione del ricorso giustiziale, la cui violazione è censurabile in sede giurisdizionale (e nei vari gradi di giudizio) tramite l’impugnazione di cui al predetto art. 10, comma 3..
4. Lo statuto della nullità dei provvedimenti amministrativi.
Una volta sposata la teoria giustiziale, può finalmente completarsi il quadro delineando il regime giuridico dell’atto finale: inquadrata la decisione del Presidente della Repubblica come provvedimento amministrativo a tutti gli effetti, il regime giuridico non può che essere quello delineato dalla legge n. 241/1990.
Viene, dunque, scartata l’ipotesi del contrasto tra giudicati – corollario della tesi della natura giurisdizionale del ricorso straordinario – e affermato che il regime della decisione resa, per tutto quanto non previsto dal d.P.R. n. 1199/1971 e dalle pertinenti norme del c.p.a., è quello dettato dalle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, segnatamente dalle norme sull’invalidità amministrativa.
I giudici di Palazzo Spada tracciano il regime del provvedimento nullo, evidenziandone tutta la distanza rispetto alla disciplina dell’invalidità in ambito negoziale.
L’art. 21 septies l. n. 241/1990, si legge, ha confermato le precedenti acquisizioni giurisprudenziali circa l’inserimento a pieno titolo della nullità nell’ambito dell’invalidità del provvedimento amministrativo, che diviene così una categoria composita e idonea a ricomprendere i diversi stati vizianti entro una cornice sistematica unitaria.
Tra i vizi che determinano la nullità, la norma contempla il difetto assoluto di attribuzione, il quale è il portato del principio di tipicità del potere amministrativo, a sua volta corollario del principio di legalità cui è soggetta l’attività amministrativa di diritto pubblico. Il difetto assoluto di attribuzione è ravvisabile nell’ipotesi in cui venga esercitato un potere non previsto né attribuito dall’ordinamento (cd. carenza di potere in astratto), nonché come conseguenza del divieto, da parte di un’Amministrazione, di esercitare un potere che, ancorché definito dall’ordinamento, sia attribuito ad una diversa Amministrazione (incompetenza assoluta) ovvero per il quale sussista un impedimento legale assoluto al suo esercizio (la categoria pretoria della carenza di potere in concreto, invece, rientra oramai nell’area dell’annullabilità).
La fattispecie de qua, ad opinione della Plenaria, ricade senza dubbio nell’ipotesi del difetto assoluto di attribuzione. L’intervenuta opposizione e la rituale riassunzione del giudizio in sede giurisdizionale spogliano, infatti, l’amministrazione del potere di definire la controversia (l’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, inibisce qualsiasi pronuncia, di rito e nel merito, sul ricorso straordinario che sia stato trasposto in sede giurisdizionale). Se ne desume che l’istruzione dell’affare da parte del Ministero competente, il parere del Consiglio di Stato ed il decreto stesso di definizione del ricorso, sono assolutamente preclusi dall’atto con il quale si opera la trasposizione del ricorso dalla sede straordinaria a quella giurisdizionale (salva l’ipotesi dettata dall’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971).
L’Adunanza si spende poi in una ricostruzione, anche storica, del regime dell’invalidità del provvedimento, valorizzando le innovazioni apportate dal c.p.a.
Nell’assetto anteriore all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, annullabilità e nullità rappresentavano il precipitato di tecniche normative marcatamente diverse: l’atto nullo (nel solco della teoria generale del negozio giuridico) veniva considerato giuridicamente rilevante (in quanto sussumibile in una fattispecie normativa, in primis quella che contempla le diverse ipotesi di nullità), ma improduttivo di effetti; il regime dell’annullabilità, rispondendo all’esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, consentiva, a differenza della nullità, che il provvedimento illegittimo si consolidasse rapidamente in caso di mancata impugnazione e comunque producesse i suoi effetti fino all’eventuale caducazione.
L’entrata in vigore del c.p.a., ha tuttavia consacrato una disciplina dell’azione di nullità del tutto difforme rispetto alla tradizione civilistica.
Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del c.p.a. “la domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni”. L’azione di nullità, dunque, non può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.) e senza essere soggetta a prescrizione (art. 1422 c.c.), ma solo da coloro che sono legittimati a far valere ogni altra illegittimità del provvedimento ed entro un breve termine di decadenza (sia pure più lungo di quello previsto per l’azione di annullamento). Essendo configurata come vizio la cui contestazione è soggetta a termine decadenziale, la nullità si atteggia in termini di illegittimità “forte”, suscettibile anch’essa di consolidamento per coloro che ne subiscono gli effetti pregiudizievoli.
Le principali differenze tra le due forme di invalidità si manifestano nelle tecniche di sindacato: il giudizio sulla nullità si misura in termini “parametrici” di difformità dell’atto rispetto allo schema legale; il giudizio di l’annullabilità consente, invece, di sanzionare anche la devianza “funzionale” dell’atto rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico assegnato alla cura dell’Amministrazione, ovvero di controllarne la ragionevolezza e proporzionalità (sia pure con il divieto di procedere a valutazioni sostitutive di merito).
La pronuncia si sofferma, infine, sui quesiti interpretativi sollevati con riguardo al secondo periodo del comma 4 dell’art. 31 c.p.a., il quale precisa che “la nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
Con riguardo a tale aspetto, viene precisato che il potere del giudice di rilevare in via officiosa l’esistenza di una causa di nullità va contemperato e coordinato con il principio dispositivo della domanda e con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo.
Il rilievo d’ufficio della nullità – possibile solo ex actis, sulla base cioè dei fatti ritualmente introdotti o comunque acquisiti in causa – non trova ostacoli se volto a paralizzare la domanda di annullamento del ricorrente (com’è per l’ipotesi oggetto dell’ordinanza di rimessione). Il rilievo della nullità da parte del giudice non può invece sopperire alla carenza di allegazioni del ricorrente, introducendo un tema decisorio che non era stato dedotto nell’atto di impugnazione: l’esercizio del potere officioso, in tale caso, renderebbe vana la previsione stessa del termine decadenziale per la deduzione del vizio da parte del ricorrente[35]; sussistendone i presupposti e in ossequio al principio di legalità e di parità delle armi, non può riconoscersi alcuna discrezionalità in capo al giudice nel rilevare la nullità.
[1] Con ricorso iscritto al n.r.g. 1240 del 2006.
[2] Con ricorso iscritto al n.r.g. 528 del 2008.
[3] Con sentenza n. 584 del 5 giugno 2009, confermata poi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2906 del 2020.
[4] Si segnala, in particolare, Cass. SS.UU., 28 gennaio 2011, n. 2065 che, fungendo da modello per le successive pronunce che hanno spostato l’asse del rimedio verso la natura giurisdizionale, ha chiarito come le modifiche apportate alla disciplina del ricorso straordinario dalla legge 69 del 2009 sono tali da eliminare alcune determinanti differenze del procedimento per il ricorso straordinario rispetto a quello giurisdizionale: l’eliminazione del potere della PA di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato confermerebbe che il provvedimento finale, che conclude il procedimento, è meramente dichiarativo di un giudizio, per cui che questo sia vincolante, se non trasforma il decreto presidenziale in atto giurisdizionale (in ragione della natura dell’organo emittente e della forma dell’atto), lo assimila a questo nei contenuti (si legge che “il provvedimento è amministrativo nella forma, ma assimilato a quello giurisdizionale nei contenuti”).
Sempre la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con una serie di sentenze successive (Cass. SSUU., 19 dicembre 2012, n. 23464; 8 settembre 2013, n. 20659; 5 ottobre 2015, n. 19786) sembrava aver superato la natura amministrativa del rimedio, riconoscendo l’idoneità del decreto stesso a formare il giudicato.
Tale tesi, sostenuta dalle Sezioni Unite, è stata successivamente avallata dal Consiglio di Stato che, con Ad. Plen. 5 giugno 2012, n. 18, pur avendo chiarito che il ricorso straordinario al Capo dello Stato costituisce un rimedio giustiziale che si colloca in simmetrica alternativa con quello giurisdizionale, ancorché di più ristretta praticabilità quanto al novero delle azioni esperibili, testualmente afferma come non sia dubitabile che il petitum proposto in sede di ricorso straordinario sia perfettamente equiparabile (e produca lo stesso effetto) ad una “domanda giurisdizionale”.
Nello stesso solco si colloca poi anche Cons. Stato, Ad. Plen., 6 maggio 2013, n. 9 che ha riconosciuto “la natura sostanzialmente giurisdizionale del rimedio in parola e dell’atto terminale della relativa procedura”.
Gli stessi argomenti sono stati poi ripresi, da ultimo, da Cons. stato, Ad. Plen, 2015, n. 7 per la quale la decisione resa all’esito di un ricorso straordinario è da ricondurre all’apporto consultivo del Consiglio di Stato, connotato da una suitas giurisdizionale tale da trasformare il provvedimento reso dal Presidente della Repubblica in meramente dichiarativo: secondo tale ricostruzione, il decreto presidenziale che recepisce il parere, pur non essendo, in ragione della natura dell’organo e della forma dell’atto, un atto formalmente e soggettivamente giurisdizionale, è comunque “estrinsecazione sostanziale di funzione giurisdizionale” che culmina in una decisione caratterizzata dal crisma dell’intangibilità, propria del giudicato, all’esito di una procedura in unico grado incardinata sulla base del consenso delle parti (la sentenza, che di fatto ha riconosciuto la portata innovativa e non meramente interpretativa della modifica legislativa del 2009, nel precisare come tali modifiche debbano considerarsi “inidonee ad incidere sulla natura giuridica” di decreti presidenziali adottati prima della loro entrata in vigore, ha sostanzialmente ravvisato, al contrario, un mutamento della natura giuridica dei decreti presidenziali adottati all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009..
[5] Sul punto si segnalano: per un’ampia trattazione critica sulla natura del rimedio e sulla sua attualità, C. Volpe, Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in www.giustizia-amministrativa.it; per una ricostruzione sulla natura del rimedio alla luce della sua “giurisdizionalizzazione” e sulla compatibilità con l’ottemperanza, S. Casilli, La tutela esecutiva per la decisione resa in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: gli ultimi sviluppi, tra evoluzione e arresti giurisprudenziali (nota a Consiglio di Stato, Sezione Prima, 28 febbraio 2022, n. 475), in questa Rivista, 1 febbraio 2023.
[6] Definizione, questa, affermatasi in via pretoria, ma che non trova alcun riscontro effettivo nel dato normativo (non si dimentichi la fondamentale incidenza del principio di legalità nella materia amministrativa), come evidenziato dalla stessa sentenza in commento al punto 3.1 ove si legge che “la creazione pretoria di una nuova categoria di atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente giurisdizionali contrasta anche con la qualificazione scolpita nella legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) che, nel tipizzare gli «atti amministrativi» (non previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali) da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio o del ministro competente, all’art. 1, comma 1 lettera bb), vi include espressamente la «[…] decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica».
[7] Al punto 8 della sentenza in commento.
[8] Il fulcro di detto contrasto giurisprudenziale, afferendo all’estensione delle forme di tutela disponibili sulla base del dato formale dello strumento di tutela attivato, pur a fronte della medesima situazione giuridica soggettiva (e, segnatamente, al riconoscimento della possibilità di accedere alla tutela esecutiva), ricorda, per certi versi, la tensione sottesa al concetto di Rechtsschutzbedürfnis nel pensiero di Schönke (cfr. P.L. Portaluri, La cambiale di Forsthoff. Creazionismo giurisprudenziale e diritto al giudice amministrativo, Napoli, 2021, 107 ss.).
[9] Cass. SSUU, 2 ottobre 1953, n. 3141; Cons. Stato, sez. V, 9 luglio 1954, n. 724.
[10] Natura poi mutata dalla legge n. 69/2009 che ha modificato gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 1199/1971 rendendo obbligatorio e vincolante nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il parere del Consiglio di Stato e prevedendo la possibilità, per quest’ultimo, di sollevare, anche in sede consultiva, questioni di legittimità costituzionale.
Il mutato carattere vincolante del parere ha costituito, per taluni, argomento a sostegno della tesi della natura giurisdizionale.
In senso contrario, tuttavia, è stato escluso che possa essere significativo il fatto che la riforma del 2009 abbia reso vincolante il parere del Consiglio di Stato, in quanto la vincolatività di tale provvedimento non ne muterebbe la natura, che rimarrebbe amministrativa ed ancorata ad una funzione giustiziale: in questo senso deporrebbe anche la rubrica dell’art. 69 l. 69/2009. Così G. D’Angelo, La «giurisdizionalizzazione» del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: profili critici di un orientamento che non convince, in www.giustamm.it, 2013, 6, secondo cui semmai la vincolatività muta i termini del rapporto con il decreto del Presidente della Repubblica. Del resto, è stato evidenziato che nel procedimento del ricorso straordinario la natura decisoria è riconoscibile, con maggiore evidenza oggi in ragione del carattere vincolato, al parere del Consiglio di Stato, il quale avrebbe carattere formale di atto consultivo ma dal punto di vista sostanziale sarebbe caratterizzato dagli stessi contenuti di una decisione amministrativa (cfr. A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2013, 165).
[11] Anche in relazione all’esperibilità del rinvio pregiudiziale lo scenario è oggi mutato alla luce della spinta favorevole operata dalla Corte di Giustizia già con sentenza del 16 ottobre 1997, cause riunite da C-69/96 a C-79/96. In quell’occasione la Corte, infatti, giunse ad ammettere la possibilità per il Consiglio di Stato, in sede di emissione del parere su ricorso straordinario, di effettuare il rinvio pregiudiziale. A tale conclusione la Corte di Giustizia pervenne sulla base della considerazione per cui anche in tale sede al Consiglio di Stato va riconosciuta la qualifica di “giurisdizione nazionale” ai sensi dell’art. 177 (ora 234) del Trattato CE.
Sulla scia della sentenza della Corte di Giustizia si pose poi lo stesso Consiglio di Stato, sez. I, 19 maggio 1999, n. 850, giungendo ad ulteriori conseguenze e ritenendosi legittimato, anche in sede di parere reso su ricorso straordinario, a sollevare questione di legittimità costituzionale.
Deve però rilevarsi come a più riprese, prima dell’entrata in vigore della modifica legislativa del 2009, si fossero espresse la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 21/1975, n. 148/1982, n. 254/2004) al fine di negare alle Sezioni consultive del Consiglio di Stato la legittimazione a sollevare incidente di costituzionalità e le Sezioni Unite (con sentenza del 18 dicembre 2001, n. 15978) al fine di confinare la portata del precedente offerto dalla Corte di Giustizia, osservando come la nozione di “organo giurisdizionale – rilevante al fine dell’individuazione delle autorità legittimate a rimettere in via pregiudiziale all’esame della Corte di Giustizia questioni relative all’interpretazione del Trattato – dovesse essere ricavata esclusivamente dalle norme di diritto comunitario, mentre nel caso di specie essa avrebbe dovuto essere desunta dalle disposizioni di diritto interno” per cui tra le due nozioni non doveva esservi, dunque, necessaria coincidenza.
[12] In tal senso pronunce fondamentali sono le già citate Cass. SS.UU. n. 15978/2001 e Corte Cost. n. 254/2004.
[13] Si rinvia, a fondamento dell’orientamento sostanzialmente giurisdizionale, supra, alla nota 4.
[14] Come previsto dall’art. 12 d.P.R. n. 119/1971, ma anche ribadito da TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 30 settembre 2022, n. 2582 in cui si legge che “Per giurisprudenza consolidata, la decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione può essere impugnata per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c., nonché davanti al giudice amministrativo solo per i vizi formali e procedurali successivi al vincolante parere di rito del Consiglio di Stato. Tali limitazioni all'impugnativa della decisone sono opponibili solo al ricorrente e alle controparti del procedimento giustiziale, le quali non avendo chiesto la trasposizione alla sede giurisdizionale hanno così accettato tutte le peculiarità e conseguenze di tale procedimento.
In particolare, la rinuncia del ricorrente straordinario successiva alla trasmissione del parere dell'organo consultivo, ma anteriore al decreto presidenziale, non può essere utilmente presentata e, ove prodotta, non può essere considerata e dispiegare i pretesi effetti estintivi.
L'espressione del parere obbligatorio esaurisce la fase decisionale del ricorso straordinario; la sua rivalutazione in sede giurisdizionale è inammissibile stante il principio di alternatività fra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, che non consente che vengano rimesse in discussione questioni, di forma e/o di sostanza, afferenti gli atti ed i provvedimenti opposti in via straordinaria, onde evitare che l'impugnazione in sede giurisdizionale porti ad un riesame del medesimo giudizio espresso in sede consultiva, per effetto della sovrapposizione della decisione giurisdizionale a quella del ricorso straordinario”.
[15] Ai sensi dell’art. 395 n. 5 c.p.c.
[16] Il più lontano antenato del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è rinvenibile nel sistema di “giustizia ritenuta”, tipico delle monarchie assolute. La prima codificazione di questo rimedio risale al 1739, nel 1975 fu poi istituito il Consiglio del Re e si stabilì che il sovrano potesse ascoltarne il parere, anche se non vincolante, prima di decidere sui ricorsi a lui indirizzati; fu poi Carlo Alberto nel 1831, a modificarne la denominazione in “Consiglio di Stato” il cui parere venne reso obbligatorio in tutti i casi di ricorso al Re dalla Legge del Regno di Sardegna n. 3707/1859.
Con l’istituzione nel 1889 della IV Sezione del Consiglio di Stato venne meno la funzione del ricorso straordinario di rimedio generale per l’impugnazione, per motivi di legittimità, dei provvedimenti amministrativi definitivi. La legge n. 5992/1889, infatti, attribuiva definitivo sbocco giurisdizionale anche agli interessi legittimi, fino ad allora tutelabili solo attraverso lo strumento dei ricorsi amministrativi.
Pur ritenendo alcuni che il rimedio avesse esaurito la sua utilità, l’istituto venne mantenuto in vita e disciplinato dal d.P.R. n. 1199/1971 e, per evitare che vi fossero problematiche duplicazioni, in ossequio al principio del ne bis in idem, si fece ricorso al principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario di modo da evitare da un lato che sullo stesso atto intervenissero due pronunce giustiziali diverse e dall’altro che il Consiglio di Stato si pronunciasse due volte sulla medesima questione.
[17] Il quale: ha stabilito che il ricorso straordinario è ammissibile unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa (art. 7 comma 8); ha, sia pur non espressamente, definitivamente riconosciuto la possibilità di azionare il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del decreto presidenziale (art. 112); ha generalizzato la facoltà di opposizione di cui all’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 in favore di tutte le parti nei cui confronti sia stato proposto il ricorso straordinario (art. 48 comma 1); ha previsto che “qualora l’opposizione sia inammissibile, il Tribunale amministrativo regionale dispone la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria”, delineando, secondo alcuni, una particolare ipotesi di translatio iudicii (art. 48 comma 3 c.p.a.)
[18] In tal senso le già citate SS.UU. n. 2065/2011.
[19] Cass. SS.UU. n. 23464/2012, n. 20596/2013, n. 10414/2014.
[20] Corte Cost. n. 73/2014, n. 24/2018, n. 63/2023.
[21] Recentemente il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez. I, 22 novembre 2019, n. 2935), pur riconoscendo che il ricorso straordinario “ha perso la sua connotazione, tipicamente ed esclusivamente, di rimedio amministrativo”, ha concluso che “non vi è coincidenza tout court con gli altri rimedi giurisdizionali sul piano dei principi applicabili” e che l’atto conclusivo della procedura va qualificato come provvedimento amministrativo, “solo per certi aspetti equiparato” ad una sentenza (proprio su queste basi è stata giustificata la non perfetta operatività delle garanzie della pubblicità e oralità).
[22] Punto 2.4 della sentenza in commento.
[23] La questione della corretta lettura lessicale dei termini di diritto è peraltro non frutto solo della recente ipertrofia interpretativa, ma era noto già alla dottrina ottocentesca ove si poneva il problema di coordinare un testo normativo ritenuto vago e incompleto con la sentita necessità di garantire adeguata tutela. Così, “l’appello al sentimento giuridico del giudice è il segno che non ci sono altre parole: il sentimento giuridico è la reazione sociale alla frustrazione del desiderio del testo. Sussiste una correlazione necessaria tra afasia normativa e senso giuridico. Una società è in afasia normativa quando non riesce a verbalizzare norme per l’insuperabilità di contrasti sugli oggetti da regolare. Giunta al limite del linguaggio regolativo, mediante le formule di autotrascendenza la società scopre quanto possa esserle provvidenziale l’afasia” (P. Femia, Sentimento e moltitudine. Rudolf von Jhering tra interessi ideali e beni comuni, Il Mulino, 2024, 225 ss).
[24] Si legge al punto 3 della sentenza.
[25] Il legislatore, in ordine al procedimento che conduce alla decisione, prevede che: il ricorso venga notificato all’organo che ha emanato l’atto o al Ministero competente, il quale ordina, se del caso, l’integrazione del procedimento (art. 9): l’Amministrazione competente per materia svolge l’istruttoria (art. 11); l’affare già istruito viene trasmesso alle Sezioni Consultive del Consiglio di Stato (art. 12) per l’adozione del parere vincolante (art. 13).
[26] È stato autorevolmente rilevato che, se si optasse, al contrario, per la natura “sostanzialmente giurisdizionale” del rimedio in esame, il significato dell’opposizione dei controinteressati (e delle parti resistenti) non sarebbe più quello di scegliere tra un rimedio giurisdizionale e uno amministrativo, ma quello di scegliere tra due rimedi giurisdizionali (l’uno semplificato e l’altro ordinario), con una conseguente notevole limitazione dell’oggetto del consenso di tutte le parti: l’espressione “sostanzialmente giurisdizionale” da un lato lascerebbe intendere l’impossibilità di sostenere la tesi della natura effettivamente giurisdizionale, dall’altro lato introdurrebbe una distinzione tra giurisdizione in senso sostanziale e giurisdizione in senso formale, che è giustificabile in altri sistemi giuridici ma non nel nostro, in considerazione della disciplina costituzionale della funzione giurisdizionale (in tal senso F.G. Scoca, Osservazioni sulla natura del ricorso straordinario al Capo dello Stato; Cons. Stato, Ad. Plen., 5 giugno 2012, n. 18, in Foro it., 2012, III, 2378).
[27] Punto 3.1 della sentenza in commento.
[28] Le conseguenze rischiose sono presto dette: il diritto giurisprudenziale “diviene un diritto di lotta combattuta con le armi dell’interpretazione, cioè delle norme modellate dall’attività interpretativa: lotta ermeneutica contro fenomeni che non si ritengono adeguatamente tutelati dalla legge” (P.L. Portaluri, Immagini da un futuro possibile: il paradigma della legittimazione ad agire, in CERIDAP. Rivista Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche, fasc. 2/2023, 227 ss).
[29] In tal senso deve essere ridimensionata la portata della pronuncia – che per taluni avrebbe segnato la conclusione del processo di giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario – della Corte Edu, Sez. I, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia, che ha affermato che le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l'art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario.
[30] Nel diritto interno, infatti, già le due nozioni si differenziano in quanto quella di “giudice”, ai fini dell’applicazione dell’art. 1 legge costituzionale n. 1/1948 e dell’art. 23 l. n. 87/1953, è più ampia di quella di “giurisdizione”.
[31] Al punto 5 ss.
[32] Come è stato osservato da Cons. Stato, Ad. Plen. 14 luglio 2015, n. 7, l’ottemperabilità di una decisione è una qualitas non sovrapponibile a quella diversa della sussistenza di un giudicato resistente al potere della legge. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’esecuzione delle decisioni definitive e vincolante che le ha pronunciate, è parte integrante del “diritto a un tribunale” nell’ampia accezione ‘convenzionale’ (inclusiva cioè anche di organi non inseriti nell’apparato giudiziario). Che la decisione resa su ricorso straordinario non configuri un giudicato in senso tecnico non comporta, tuttavia, alcuna modifica dell’orientamento espresso dalla medesima Adunanza Plenaria, nelle sentenze n. 9 e 10 del 2013, secondo cui il ricorso per l’ottemperanza deve essere proposto dinanzi allo stesso Consiglio di Stato, nel quale si identifica il giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta.
[33] Sul punto si segnala nuovamente Cass. SS.UU. n. 10414/2014, sentenza che, con un’opera di equilibrismo giuridico, ha segnato un’apertura verso l’impugnabilità delle decisioni rese all’esito del ricorso straordinario per motivi inerenti alla giurisdizione, ma non con la medesima ampiezza prevista dall’art. 9 c.p.a.; la Corte estrae una regola processuale assente nell’ordinamento, conformata alla specialità del procedimento (che si svolge in unico grado) che preclude l’impugnazione delle pronunce laddove non sia stata contestata nel corso del procedimento la giurisdizione, fondatasi, così, per accordo delle parti (potendosi diversamente impugnare la decisione per motivi di giurisdizione ove una delle parti l’abbia contestata durante il procedimento).
Le Sezioni Unite consentono tuttavia il ricorso per motivi di giurisdizione ai sensi dell’art. 111 comma 8 Cost. sotto un diverso profilo, ossia quello dell’eccesso di potere giurisdizionale, in quanto in tal caso la questione di giurisdizione non attiene alla giurisdizione come presupposto che deve sussistere, ma riguarda un momento successivo, quello della decisione, che astrattamente potrebbe eccedere dai limiti del potere giurisdizionale, come quando il giudice amministrativo esercita una prerogativa spettante alla PA; evenienza questa (eccezionale), che legittimerebbe le parti, che sul punto non possono dirsi soccombenti, a proporre ricorso ex art. 111 comma 8 Cost. e art. 362 c.p.c.
[34] Cons. Stato, Ad. Plen., 27 giugno 2006, n. 9.
[35] Così come osservato da Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 2019, n. 4566.
Contenzioso climatico e giurisdizione
di Giuliano Scarselli
“Si chiama perciò politica quell’aspetto della realtà che concerne il complesso degli interessi collettivi”.
F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma, 1951, 12.
Sommario: 1. Il contenzioso climatico in Italia e la questione della giurisdizione del giudice ordinario. 2. Si deve distinguere le controversie intentate contro lo Stato, nelle quali la giurisdizione è esclusa dal principio di separazione dei poteri. 3. Segue: e dall’impossibilità di sostituire il giudice all’amministrazione. 4. Segue: da quelle intentate contro le grandi imprese, nelle quali la sussistenza (o meno) della giurisdizione va valutata secondo le regole procedurali generali. 5. Il difetto assoluto di giurisdizione tra doveri dello Stato (e/o delle imprese) e diritti dei cittadini. 6. I doveri dello Stato. 7. Segue: quelli delle imprese. 8. Segue: e i diritti dei cittadini. 9. Ai doveri degli Stati (e/o delle imprese) non corrispondono automaticamente dei diritti per i cittadini. Quando ciò si verifica e quando no. Analisi della normativa interna e comunitaria sul punto. 10. Ed inoltre: del difetto di giurisdizione delle azioni che fuoriescono dal crisma della pretesa giudiziaria. 11. Se questi argomenti possono tenere a fronte del diritto dell’Unione europea. 12. Brevissima conclusione.
1. Il contenzioso climatico in Italia e la questione della giurisdizione del giudice ordinario. Intervengo su una questione di grande attualità, che è quella della giurisdizione (o meno) del giudice ordinario a fronte di azioni giudiziarie fatte valere da associazioni, oppure da semplici cittadini, per la condanna dello Stato, o di grandi realtà economico/industriali, ad adeguarsi ai doveri della riduzione nell’emissione di gas serra per ottemperare al raggiungimento degli obiettivi nazionali e internazionali a fronte dei cambiamenti climatici in corso[1].
Al riguardo, dobbiamo soprattutto far riferimento a due controversie in Italia:
a) la prima si è chiusa in primo grado con una sentenza del Tribunale di Roma, 26 febbraio 2024, sezione seconda, n. 3552[2].
Esattamente, una associazione e dei privati adivano il Tribunale di Roma contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere la condanna dello Stato, ai sensi degli artt. 2043 e 2058 c.c.: “all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni artificiali di CO2-ed nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell’altra, maggiore o minore, in corso di causa accertanda” (così la domanda delle parti attrici).
Costituitasi in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, il Tribunale di Roma, con la sentenza sopra menzionata, dichiarava inammissibile la domanda per difetto assoluto di giurisdizione.
Osservava il Tribunale di Roma che: “Gli attori, nel contestare l’inadeguatezza e l’insufficienza della condotta dello Stato nel contrastare i cambiamenti climatici lamentano una responsabilità dello Stato-legislatore, non predicabile fuori dai casi di violazione del diritto dell’Unione europea”; e quindi gli attori, secondo il Tribunale di Roma, chiedevano al giudice di intervenire su “valutazioni discrezionali di ordine socio-economico e in termini di costi-benefici nei più vari settori della vita della collettività umana che rientrano nella sfera di attribuzione degli organi politici e non sono sanzionabili nell’odierno giudizio”.
Una pronuncia di merito su simile domanda, per il Tribunale di Roma, si sarebbe posta: “in violazione di un principio cardine dell’ordinamento rappresentato dal principio di separazione dei poteri” (così Trib. Roma, pag. 12 della sentenza).
b) Parallelamente a questa iniziativa ve n’è stata un’altra, con la quale due associazioni, unitamente sempre a dei soggetti privati, si sono rivolte, di nuovo al Tribunale di Roma, questa volta però non contro lo Stato ma contro ENI s.p.a., perché il Tribunale dichiarasse che “ENI s.p.a., Ministero dell’Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti s.p.a., a seguito delle emissioni in atmosfera di gas serra, e in particolare CO2, provenienti dalle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da ENI, non hanno ottemperato e non stanno ottemperando al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionali riconosciuti di cui ENI s.p.a. si sarebbe dovuta dotare in linea con l’Accordo di Parigi, con l’art. 2 l. 240/2016 e con gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi, in violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU, così come previsto dagli artt. 2 e 7 della Carta di Nizza. Per l’effetto accertare e dichiarare che ENI s.p.a., Ministero dell’Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti s.p.a., sono solidamente responsabili, per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della CEDU, 2 e 7 della Carta di Nizza, e degli artt. 2043 (o in alternativa art. 2050 0 2051 c.c.) e art. 2059, per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dagli attori per l’effetto delle conseguenze del cambiamento climatico che essi hanno concorso a cagionare”[3].
In questa occasione, probabilmente per la sussistenza della pronuncia del Tribunale di Roma sopra menzionata, le parti attrici promuovevano regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. per far dichiarare la giurisdizione del giudice adito circa il contenzioso promosso[4].
Il regolamento preventivo di giurisdizione porta la data del 10 giugno 2024, e la questione è pertanto al vaglio della Sezioni Unite della Corte di Cassazione[5].
2. Si deve distinguere le controversie intentate contro lo Stato, nelle quali la giurisdizione è esclusa dal principio di separazione dei poteri. Orbene, io credo che in primo luogo sia necessario distinguere il contenzioso climatico che veda quale convenuto lo Stato, da altro contenzioso climatico che veda quale convenuto una società commerciale/industriale.
La differenza è evidente, poiché lo Stato, a differenze di una società industriale, non inquina e non produce direttamente gas serra; ciò possono farlo solo i singoli cittadini, oppure le imprese.
Dal che, se io chiedo che lo Stato venga condannato “all’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni artificiali di CO2-ed nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990”, in realtà io non chiedo che detto abbattimento sia posto in essere dallo Stato, ma chiedo, più precisamente, che lo Stato si attivi perché tale comportamento sia tenuto dai cittadini e dall’imprese.
In questi casi la domanda giudiziaria è quindi indiretta, e non a caso le stesse conclusioni dell’atto di citazione precisano che lo Stato sia condannato più esattamente “all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento”, ecc…….
Dunque, non si pretende che il giudice condanni lo Stato all’abbattimento delle emissioni artificiali di CO2-ed, bensì che lo condanni a tenere un comportamento che imponga agli altri di abbattere le emissioni artificiali di CO2-ed.
Ma questa imposizione, ovvero queste “necessarie iniziative” delle quali si chiede la condanna, non potrebbero che avere ad oggetto leggi, o atti aventi forza di legge, con i quali, appunto, imporre il rispetto degli obiettivi.
E poiché è pacifico che il giudice, in uno Stato democratico basato sul principio della separazione dei poteri, non ha alcuna possibilità di ordinare agli organi competenti di fare leggi, o atti aventi forza di legge, di qualunque tipo o natura, (ma direi che la regola valga anche negli Stati totalitari), va da sé che una simile domanda rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non può che scontrarsi con il difetto di giurisdizione[6].
In questi termini la decisione del Tribunale di Roma, 26 febbraio 2024, che ha dichiarato inammissibili le domande per difetto assoluto di giurisdizione in quanto volte a condannare lo Stato-legislatore, non può che trovare piena condivisione, pena altrimenti il venir meno di ogni regola ordinamentale e processuale.
Il potere di imporre le leggi non è riconosciuto nemmeno alla Corte Costituzionale, relativamente alla quale, al più, si parla di “sentenze monito”, ovvero di sentenze che semplicemente indicano, senza alcun obbligo per il legislatore e fuori da meccanismi di condanna giudiziale, quale possa o debba essere la disciplina costituzionalmente legittima di una determinata materia[7].
E se tale potere non spetta alla Corte Costituzionale, certamente non può spettare al giudice ordinario di merito.
Né un potere del genere può essere immaginato presso il giudice amministrativo: e ciò non solo perché il difetto assoluto di giurisdizione è, appunto, un difetto assoluto, nel senso che nessun giudice, nemmeno quello amministrativo, può avere giurisdizione su detta materia, ma anche perché comunque ciò è escluso dallo stesso art. 7, 1° comma del codice del processo amministrativo, in base al quale: “Non son impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”.
3. Segue: e dall’impossibilità di sostituire il giudice all’amministrazione.
A completamento di ciò aggiungerei che il difetto assoluto di giurisdizione vi è altresì quando una parte chieda al giudice lo svolgimento di una funzione che fuoriesca dai canoni della giurisdizione a fronte di quelli dell’amministrazione.
È quanto, peraltro, emerge dallo stesso art. 41, 2° comma c.p.c. per il quale non v’è giurisdizione del giudice ordinario “a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa”.
Al riguardo, alla luce di infiniti scritti dottrinali che sussistono sui rapporti tra giurisdizione e amministrazione, direi che la giurisdizione è il potere di applicare la legge al singolo caso controverso attenendosi al dettato normativo[8], o, per usare le parole di un processualista quale Antonio Segni: “La giurisdizione può definirsi come la funzione statale destinata all’attuazione della norma concreta di legge, attuazione che ha carattere sostitutivo o surrogatorio”[9].
Nessuno, poi, esclude che nel far ciò il giudice goda di un certo potere discrezionale, ma parimenti tutti ammettono che la discrezionalità del giudice è ben diversa dalla discrezionalità della pubblica amministrazione, poiché nel primo caso il potere discrezionale del giudice è circoscritto all’interpretazione della legge, mentre nel secondo caso il potere discrezionale della pubblica amministrazione è riferito alle scelte concrete da compiere e alle decisioni da prendere[10].
Ed anzi, il tratto maggiore che separa la giurisdizione dall’amministrazione sta proprio nel grado di discrezionalità che è riconosciuto nello svolgere la funzione: interpretazione della legge da una parte, scelta e bilanciamento degli interessi generali dall’altra[11].
Si tratta di un dato già presente nella nostra dottrina classica[12], riterrei non venuto meno nel tempo presente, e che continua ancor oggi a contrappone la funzione giurisdizionale a quella amministrativa[13].
Di nuovo, se la domanda giudiziale ha ad oggetto la condanna dello Stato: “all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni artificiali di CO2”, è evidente che con essa non si chiede al giudice di svolgere una funzione giurisdizionale in senso proprio, quanto piuttosto di sostituirsi all’amministrazione nel prendere decisioni che questa non assume.
Né si chiede al giudice di applicare la legge, poiché anzi le controversie sui mutamenti climatici partono dal presupposto della assenza di leggi che attuino gli impegni internazionali presi dall’Italia sul clima; e, stante anche la circostanza che le norme comunitarie non contengono le determinazioni in concreto delle attività che lo Stato, le imprese o i singoli cittadini devono tenere a fronte dei cambiamenti climatici, è impensabile, a mio parere, che la discrezionalità del giudice possa spingersi fino a consentirgli di porre in essere un’attività amministrativo/legislativa quale è quella di stabilire quali siano le cose da fare in concreto per giungere ad una riduzione della produzione entro il 2030, delle emissioni artificiali di CO2-ed nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990[14].
Ove il giudice facesse una cosa del genere, egli si sostituirebbe all’amministrazione, e quindi porrebbe in essere una funzione che esorbita dalla giurisdizione[15].
4. Segue: da quelle intentate contro le grandi imprese, nelle quali la sussistenza (o meno) della giurisdizione va valutata secondo le regole procedurali generali.
Il discorso, però, può essere diverso se il convenuto del contenzioso climatico non è più lo Stato bensì una società industriale come ENI[16].
Nei confronti di ENI, o più in generale di società commerciali e/o industriali, diversamente dallo Stato, è astrattamente possibile chiedere, direttamente e in concreto, di limitare: “le emissioni in atmosfera di gas serra, e in particolare CO2, provenienti dalle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da ENI”, o comunque chiedere di accertare che ENI ha tenuto un comportamento non conforme all’Accordo di Parigi e/o al diritto comunitario (così le conclusioni della seconda citazione).
È evidente che a fronte di una controversia di questo genere, il principio della separazione dei poteri non c’entra più niente, e solo qui, secondo i criteri generali, si tratta di valutare se il giudice ordinario abbia o meno giurisdizione a provvedere.
Direi, però, che se la controversia vede come parti solo dei privati e non anche la pubblica amministrazione (e ciò al di là del caso specifico, perché ENI ha un’anima ibrida tra pubblico e privato, e in quella lite è convenuto anche il Ministero dell’Economia), v’è da porsi il problema ulteriore dell’ammissibilità o meno dello stesso istituto del difetto assoluto di giurisdizione,
V’è da chiedersi, infatti, se nei casi in cui il contenzioso è solo tra privati, un difetto assoluto di giurisdizione sia ammissibile[17], visto che il nostro sistema processuale sembra configurarlo esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione (artt. 37 e 41 c.p.c.), mentre la giurisprudenza, almeno per quanto io sappia, non ha dato a questo quesito risposte univoche nel tempo, in quanto in un primo momento ha ritenuto che la improponibilità assoluta della domanda tra privati per mancanza di una norma che tuteli la situazione dedotta in giudizio fosse questione di merito e non di giurisdizione[18], e poi ha cambiato orientamento, asserendo che “Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in un giudizio che si svolga tra privati, in quanto la mera qualità soggettiva delle parti non è più criterio discriminante assoluto al fine di stabilire se il ricorso per regolamento preventivo sia ammissibile”[19].
Ad ogni modo direi:
a) tutto ciò che qui cerco di razionalizzare vale in ogni caso con riferimento alle controversie contro la pubblica amministrazione;
b) e vale parimenti anche con riguardo alle controversie contro le società commerciali/industriali, in quanto, senza troppa differenza, la mancanza di una norma che tuteli la situazione dedotta in giudizio può valere o come difetto di giurisdizione, ove si ritenga ammissibile l’istituto (anche) in questi casi, oppure come inammissibilità della domanda; senza mutamento del risultato sostanziale di rigetto.
5. Il difetto assoluto di giurisdizione tra doveri dello Stato (e/o delle imprese) e diritti dei cittadini.
Il difetto assoluto di giurisdizione è contemplato nel nostro ordinamento dagli artt. 37 e 41 c.p.c.
Per circoscrivere il fenomeno credo si possa semplicemente richiamare la nozione che ne dà la dottrina: “Il difetto assoluto di giurisdizione (o improponibilità assoluta della domanda) nei confronti della pubblica amministrazione, si ha ogni qual volta sia dedotto in giudizio un interesse di fatto, cioè giuridicamente non protetto dal nostro ordinamento né come diritto soggettivo né come interesse legittimo.”[20].
Si tratta, dunque, di ipotesi nelle quali la posizione dedotta in giudizio non trova tutela nell’ordinamento[21], o, detto in modo analogo, “si tratta in definitiva di ipotesi in cui vengono dedotte dinanzi al giudice situazioni soggettive (interessi semplici) che non sono tutelabili in via giurisdizionale, non avendo la consistenza né di diritti né di interessi legittimi”[22].
Questa posizione è anche quella della giurisprudenza, sia meno recente[23] che più recente[24]; dal che, ai fini della giurisdizione, si tratta di verificare se la pretesa fatta valere in giudizio abbia natura di interesse semplice oppure la consistenza di un diritto tutelato dall’ordinamento; e, nel nostro caso concreto, si tratta di valutare se i privati abbiano un diritto proprio contro lo Stato (e/o contro le imprese) con riferimento ai problemi climatici del pianeta imputabili al surriscaldamento globale.
Posta la questione in questi termini, due però sono le precisazioni da dare:
a) la prima è che, evidentemente, la valutazione dell’esistenza o meno di questo diritto va fatta in astratto e non in concreto, ovvero si tratta solo di valutare se vi sono, o non vi sono, nell’ordinamento interno e comunitario, norme di protezione in grado di fissare dei veri e propri diritti soggettivi;
b) e la seconda è che, nel far ciò, non si tratta di valutare solo se, e quali siano, i doveri dello Stato (e/o delle imprese) a fronte dei mutamenti climatici, ma anche di chiedersi se ai doveri dello Stato (e/o delle imprese) possano corrispondere contrapposti diritti soggettivi dei cittadini.
V’è la tendenza a ritenere che la sussistenza di un presupposto abbia come conseguenza necessaria la sussistenza dell’altro[25].
Al contrario, si tratta di due momenti distinti, e che distintamente vanno analizzati, in quanto entrambi debbano esserci affinché il giudice abbia giurisdizione, e l’esistenza (eventuale) dell’uno non necessariamente comporta la sussistenza dell’altro[26].
6. I doveri dello Stato.
Circa il dovere dello Stato, si debbono in primo luogo ricordare le norme.
Le fonti normative possono essere indicate nella Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 9 maggio 1992 (UNFCCC), reso esecutivo in Italia dalla legge 15 gennaio 1994 n. 65, e poi soprattutto nell’Accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 2015, ratificato in Italia con la legge 4 novembre 2016 n. 204,
A livello comunitario vi sono inoltre le Direttive del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 aprile 2009, 2009/29/CE, il Regolamento europeo sul clima 2021/1119 del 30 giugno 2021[27], e la Decisione, sempre del Parlamento e del Consiglio europeo, 406/2009/CE.
A ciò poi si aggiungono disposizioni di carattere più generale quali gli artt. 2 e 8 CEDU, gli artt. 2 e 7 della Carta di Nizza e art. 9 Cost.
A fronte di tutte queste fonti normative, io credo non vi possa essere dubbio dell’esistenza di un dovere dello Stato a provvedere per il contenimento dell’emissione in atmosfera di gas serra.
Tuttavia, poiché par evidente che per ottenere questo obiettivo, ovvero: “l’abbattimento, entro il 2030, delle emissioni artificiali di CO2-ed nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990” si debbano “fare delle cose”, e queste “cose da fare” non sono precisate negli atti normativi sopra richiamati, è parimenti indiscutibile che questo dovere si concretizzi con l’esercizio di un potere discrezionale/valutativo da parte dello Stato.
Ed infatti l’Accordo di Parigi, fonte sempre richiamata dalle normative successive, e in particolar modo dal Regolamento europeo sul clima 30 giugno 2021 n. 1119, non solo non contiene l’elenco delle cose da fare, ma nemmeno contiene precetti giuridici in senso stretto, quanto piuttosto affermazioni di programma.
A titolo di esempio, per l’art. 2: “I cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell’umanità”, cosicché l’accordo “mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici mantenendo l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C …; per l’art. 4: “Le parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida”; ed ancora per l’art. 6 gli obiettivi sono quelli di: “Promuovere la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra…..Incentivare e facilitare la partecipazione alla mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra”; ed infine per l’art. 10: “Le parti condividono una visione a lungo termine sull’importanza di realizzare appieno lo sviluppo e il trasferimento delle tecnologie al fine di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici” [28].
Direi, in estrema sintesi, che così come non può essere messo in discussione che vi sia un dovere dello Stato di difesa dell’ambiente a fronte dei cambiamenti climatici, allo stesso modo non può nemmeno essere messo in discussione che questo dovere lo Stato lo adempie con atti non specificamente determinati dalle norme e rimessi al suo potere discrezionale.
Inoltre è chiaro che, poiché l’avanzare di nuovi diritti comporta inevitabilmente una contrazione di quelli già esistenti, va da sé che lo Stato deve procedere con prudenza e bilanciamento di situazione che potrebbero porsi tra loro in contrasto.
Direi che questa è stata anche la posizione dell’Avvocatura dello Stato nella misura in cui ha sostenuto che non può non sussistere: “un bilanciamento da effettuare tra tutela ambientale e perseguimento di altri rilevanti interessi sociali”[29].
7. Segue: quelli delle imprese.
La questione, di nuovo, si presenta diversamente quando dal dovere dello Stato si passi al dovere delle grandi imprese industriali e/o commerciali come ENI.
Le imprese, evidentemente, agiscono nel rispetto delle norme, e per loro tale rispetto non potrà che essere sufficiente.
Non possono avere le imprese dei doveri oltre quelli che risultino dalle leggi esistenti; né alle imprese può immaginarsi rimproveri da carenza normativa; né, ancora, alle imprese può essere rimproverata la mancata collaborazione agli obiettivi di cui agli accordi internazionali se non nella misura in cui questi obiettivi si siano tradotti in obblighi specifici a loro rivolti.
L’espressione contenuta in citazione, pertanto, e secondo la quale vi sarebbe responsabilità delle imprese che: “non hanno ottemperato e non stanno ottemperando al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionali riconosciuti di cui ENI s.p.a. si sarebbe dovuta dotare in linea con l’Accordo di Parigi, con l’art. 2 l. 240/2016” non sembra, a mio sommesso parere, affermazione corretta poiché: a) o si indicano quali sono specificamente le norme che obbligano ENI o altre imprese a mettersi in linea con l’Accordo di Parigi; b) oppure va da sé che ENI e le altre imprese non hanno l’obbligo di adeguarsi all’Accordo di Parigi, in quanto è un Accordo che coinvolge gli Stati, e non le imprese[30].
In questo modo, mentre questo dovere sembra sussistere per lo Stato, se pur nella elastica forma di un dovere rimesso alla discrezionalità di individuazione delle modalità possibili anche in bilanciamento con altri diritti, egual dovere non sembra potersi predicare per le imprese, che nient’altro sono tenute a fare se non rispettare le leggi esistenti che direttamente le chiamino in causa; e tutto il resto può loro essere rimproverato solo dal punto di vista morale; e ciò, evidentemente, anche ai fini della valutazione della giurisdizione.
8. Segue: e i diritti dei cittadini.
È arriviamo al tema principale, che è quello di valutare se al dovere dello Stato segua automaticamente un corrispondente diritto del cittadino.
E qui vale ricordare che, anche ammessa l’esistenza del dovere dello Stato, questo dovere non sembra proprio né riversarsi sulle imprese, né attribuire automaticamente ai cittadini un diritto generale di agire in giudizio.
Prima ancora che con elaborazioni teoriche, penso che l’insussistenza di una correlazione necessaria tra dovere/diritto si possa dimostrare semplicemente con degli esempi.
È fuori da ogni discussione, ad esempio, che lo Stato abbia il dovere di tenere ad elevati livelli di qualità gli ospedali e la sanità pubblica a tutela del diritto alla salute dei cittadini nel rispetto dell’art. 32 Cost.
Però, parimenti, ritengo che nessuno si sentirebbe di affermare che, allora, un qualunque cittadino possa adire il giudice per chiedergli di condannare lo Stato a rispettare questo suo dovere.
Così, se un cittadino si lamenta di una specifica malasanità, che gli ha prodotto un danno ingiusto, lì è ovvio che la domanda può essere solo (se del caso) respinta nel merito, e nessuna questione di giurisdizione può porsi. Ma se al contrario il cittadino, fuori da ogni fatto specifico, semplicemente lamenti l’inattività dello Stato nella corretta e adeguata tenuta e gestione degli ospedali, chiedendone al giudice la condanna a provvedere entro una certa data, lì diversamente credo che ai più apparerebbe evidente l’esistenza del difetto assoluto di giurisdizione[31].
Lo stesso, sempre a titolo di esempio, potrebbe valere per la scuola a fronte del diritto costituzionale di cui agli art. 33 e 34 Cost.
Se un cittadino si rivolgesse al giudice asserendo che lo Stato mantiene la scuola e l’istruzione in uno stato del tutto scadente per un paese democratico ed evoluto quale l’Italia e chiedesse la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’adeguamento della scuola ad un livello accettabile di qualità per un tempo futuro da determinare, oppure la condanna ad adeguare gli stipendi del personale del Ministero dell’istruzione ai parametri dell’art. 36 Cost., di nuovo queste domande, con tutta probabilità, verrebbero rigettate per difetto assoluto di giurisdizione, senza scandalo o discussione di alcuno; e, direi, anche se proposte da una associazione, e non solo da un soggetto privato.
Ma potremmo dare un terzo esempio tratto dall’art. 31 Cost. in materia di famiglia.
Al riguardo, infatti, la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei relativi compiti, con particolare riguardo alle famiglie numerose, nonché protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Se qualcuno si dovesse rivolgere al giudice semplicemente asserendo che lo Stato è inadempiente con riguardo a questi compiti, e ne chiedesse la condanna giudiziale della protezione in modo più incisivo e concreto, beh, riteniamo, di nuovo, che la domanda verrebbe ancora una volta considerata del tutto priva di giurisdizione, e ciò senza meraviglia di alcuno.
9. Ai doveri degli Stati (e/o delle imprese) non corrispondono automaticamente dei diritti per i cittadini. Quando ciò si verifica e quando no. Analisi della normativa interna e comunitaria sul punto.
Ed infatti, stando ai principi, ai doveri dello Stato non corrispondono diritti dei cittadini, se non nella misura in cui la legge li configuri come tali in modo diretto ed esplicito.
I cittadini hanno una miriade di interessi all’interno di un contesto sociale, ma questi interessi si trasformano in diritti soggettivi solo quando la legge li prende direttamente in considerazione e assegna loro una tutela differenziata e individuale.
Conviene, in proposito, tornare alla teoria generale dei diritti[32], e ricordare che non ogni fonte normativa è in grado di creare diritti soggettivi, ma solo quella che dia vita a ciò che Giuseppe Chiovenda chiamava volontà concreta di legge[33].
Se vi è una volontà concreta di legge di attribuire ad un soggetto portatore di un interesse semplice una tutela diretta e differenziata di quell’interesse, allora lì, e solo lì, quell’interesse si trasforma in diritto soggettivo; altrimenti, la mera esistenza di un interesse di fatto dovuto ad un dovere generale dello Stato non attribuisce al cittadino un diritto soggettivo; ciò avviene solo nei casi nei quali la legge in modo espresso operi questa trasformazione.
Né è sufficiente che le fonti normative, anche di primo piano, disegnino una “situazione giuridica protetta”[34], perché si possa rinvenire in ciò diritti soggettivi giustiziabili, in quanto ogni c.d. “situazione giuridica protetta” emerge pur sempre dal rovesciamento della medaglia del dovere dello Stato: se lo Stato ha dei doveri da una parte, allora, in relazione ad essi, da altra parte, i cittadini hanno una situazione giuridica protetta.
Ma questa situazione, come detto, non configura ancora diritti soggettivi che possano essere fatti valere in giudizio se la legge non li considera tali prendendo a riferimento direttamente i privati quali destinatari della norma, e così consentendo a questi di invadere ed incidere sullo Stato[35].
Altrimenti, come già esplicitato, è chiaro che la salute per i cittadini è una situazione giuridica protetta, e tuttavia è parimenti chiaro che questa situazione giuridica protetta non consente un’azione giudiziaria per pretendere una diversa e più attenta gestione e manutenzione degli ospedali pubblici.
Dunque, se queste premesse sono corrette, e torniamo alle fonti normative dei cambiamenti climatici sopra richiamati, vediamo come in nessuna di questa fonti vi sia una volontà concreta di legge che possa, anche solo lontanamente, far ritenere esistenti dei diritti soggettivi dei privati.
Al riguardo si deve ricordare che la legge 15 gennaio 1994 n. 65 costituisce semplice ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 9 maggio 1992 (UNFCCC); successivamente tale convenzione si trasferiva nell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, oggetto a sua volta di ratifica ed esecuzione in Italia con la legge 4 novembre 2016 n. 204; quest’ultima, infatti, dispone ciò con gli artt. 1 e 2, e poi regola le coperture finanziarie con gli artt. 3, 4 e 5; nient’altro vi si trova.
L’Accordo di Parigi, a sua volta, e come sopra abbiamo sintetizzato, contiene una serie di impegni programmatici degli Stati a fronte dei cambiamenti climatici, ed in particolar modo, con l’art. 2, ogni Stato “mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici… mantenendo l’aumento della temperatura media mondiale bel al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali”; ma nessuno dei 29 articoli, di cui è composto l’Accordo, attribuisce in modo esplicito e diretto ai cittadini diritti soggettivi, nel senso sopra chiarito, di alcuna sorte.
Lo stesso vale per le fonti comunitarie, ed in particolare:
a) la Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 aprile 2009, 2009/29/CE, che consta di 52 premesse e di 29 articoli, disciplina “l’attuazione di un impegno più rigoroso della Comunità in materia di riduzioni…che conduca a riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra superiori a quelle previste all’articolo 9”, ed ogni disposizione è sempre rivolta a Gli Stati membri oppure a la Commissione, ecc….
b) La Decisione, sempre del Parlamento e del Consiglio europeo, 406/2009/CE e sempre del 23 aprile 2009, ha ad oggetto “gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020”, e nelle 34 premesse e 16 articoli non si disciplinano ipotetici diritti soggettivi dei privati.
Lo stesso art. 16, rubricato Destinatari, espressamente asserisce che “Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione”; inoltre gli impegni sono tutti degli Stati membri: così l’art. 3: “Ciascun Stato membro è tenuto………” “Ogni Stato membro garantisce………” “Ogni Stato membro limita………”, ecc…
c) Infine, il Regolamento europeo sul clima 2021/1119 del 30 giugno 2021, 40 premesse e 14 articoli, ha contenuto non dissimile ai precedenti: l’art. 1 richiama espressamente l’Accordo di Parigi e “stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050” e “istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell’obiettivo globale di adattamento di cui all’articolo 7 dell’accordo di Parigi”; inoltre l’art. 3 è dedicato alla Consulenza scientifica sui cambiamenti climatici, l’art. 4 ai Traguardi climatici intermedi dell’Unione, l’art. 6 alle Valutazioni dei progressi compiuti e delle misure dell’Unione, ed ancora l’art. 7 alle Valutazioni delle misure nazionali.
Non v’è, anche in questo Regolamento, alcuna norma che possa avere il crisma dell’attribuzione di specifici diritti soggettivi ai privati.
In sintesi, è necessario non mettere sullo stesso piano quelli che sono i diritti soggettivi dagli interessi e/o dai desideri dei cittadini: i primi giustiziabili, i secondi rimessi alla discrezionalità del potere legislativo e amministrativo, ovvero alla politica.
10. Ed inoltre: del difetto di giurisdizione delle azioni che fuoriescono dal crisma della pretesa giudiziaria.
A completamento di queste osservazioni credo possa poi aggiungersi che le domande fatte valere in questi giudizi appaiono altresì fuoriuscire completamente dal crisma della giurisdizione.
Si consideri al riguardo quanto segue:
a) In primo luogo le domande proposte appaiono di contenuto generico a fronte del dovere di specificità che una domanda giudiziale deve avere per essere ammissibile.
Esattamente, chiedere al giudice di condannare lo Stato: “all’adozione di ogni necessaria iniziativa”, ecc…… costituisce domanda priva di determinazione, poiché non in grado di individuare con la dovuta specificità qual è, o quali sono, gli obblighi di fare al quale, o ai quali, la parte condannata è tenuta.
Si tratta, pertanto, di una domanda che si pone in contrasto con lo stesso art. 163 n. 3 c.p.c., per il quale la citazione introduttiva del processo deve contenere: “la determinazione della cosa oggetto della domanda”.
La giurisprudenza considera infatti nulla la citazione quando l’oggetto del giudizio sia “assolutamente incerto”[36].
b) Conseguentemente, la sentenza che, paradossalmente, dovesse accogliere una simile domanda, condannando così lo Stato allo abbattimento, entro il 2030, delle emissioni artificiali di CO2-ed, sarebbe poi sentenza priva delle condizioni del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., visto che il titolo esecutivo ha sempre ad oggetto “un diritto certo, liquido ed esigibile”[37], e visto che per certezza del titolo “deve intendersi la precisa individuazione del bene oggetto dell'esecuzione per consegna e rilascio e della prestazione di fare o non fare nell'esecuzione”[38].
In ogni caso detta sentenza sarebbe priva della possibilità di essere attuata in sede esecutiva.
Ed infatti, stante l’assoluta genericità degli obblighi di fare prospettati con la domanda, sarebbe poi impossibile dare una valutazione oggettiva del suo (o meno) adempimento, né il terzo libro del codice di procedura civile dedicato al processo di esecuzione appare in grado, nelle sue articolazioni, di consentire l’attuazione forzata di una sentenza a contenuto così indeterminato[39].
c) Inoltre, la domanda non sembra corrispondere nemmeno ai principi della legittimazione ad agire ex art. 81 c.p.c.
La legittimazione ad agire è infatti strettamente connessa alla titolarità individuale del diritto fatto valere in giudizio, e solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, che si denominano di legittimazione straordinaria, è consentito a terzi la deduzione in giudizio di diritti che siano da riconoscere in capo a soggetti diversi da quelli presenti nel processo[40].
Qualcosa di analogo sta nel Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), che nell’art. 263, 4° comma espressamente statuisce in punto di legittimazione ad agire: “Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente”.
Poiché l’azione esercitata in questi processi non attiene, al contrario, né ad atti adottati nei confronti delle parti attrici, né ad atti che li riguardino direttamente e individualmente, ma solo ad interesse generici, che toccano l’intera comunità in egual misura, le parti attrici sono carenti di legittimazione ad agire nel senso in cui essa è giudizialmente riconosciuta[41].
Conferma di ciò si ha anche con la decisione dalla Corte Giustizia unione europea 26 settembre 2024 n. 340/23, per la quale: “Riconoscere ad alcuno la legittimazione ad agire fondata unicamente sulla violazione dei suoi diritti fondamentali mediante atti di portata generale, come il regolamento impugnato, equivarrebbe a svuotare di sostanza le prescrizioni dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.”.
E conferma di questa posizione si ha anche in forza della sentenza CEDU 9 aprile 2024 (GC) 53600/20, la quale, nel giudizio per la responsabilità da cambiamento climatico della Svizzera, ha escluso la legittimazione ad agire dei privati, e ammessa la legittimazione delle associazioni solo in presenza di tre criteri, tra i qual quella di “essere legalmente stabilita nella giurisdizione interessata o avere la legittimazione ad agire in tale giurisdizione”[42].
E poiché tale legittimazione nella giurisdizione interessata non sembra proprio sussistere, o sussiste solo in presenza di "una lesione diretta, concreta ed attuale dalla violazione di termini"[43], va da sé che le domande giudiziali qui ad analisi non sono state proposte da parti aventi la legittimazione ad agire[44].
d) Le domande giudiziali, inoltre, nella misura in cui hanno ad oggetto la condanna dello Stato a tenere un comportamento futuro, (per l’abbattimento, entro il 2030, ecc…), hanno parimenti ad oggetto quella che viene definita condanna in futuro.
In questi termini la domanda contrasta altresì con il principio secondo il quale la giurisdizione non può essere utilizzata se non per fatti passati[45], mentre la condanna in futuro è ammissibile solo in via del tutto eccezionale, e nelle sole ipotesi specificamente previste dalla legge (ed in questi casi nessuna legge autorizza l’utilizzo della condanna in futuro).
Ciò perché, par evidente: “la sentenza di condanna presuppone una lesione attuale del diritto, e dunque che si sia già verificato l’inadempimento”, cosicché: “la condanna in futuro costituisce uno strumento eccezionale, circoscritto alle ipotesi espressamente previste dalla legge[46].
e) Soprattutto, una sentenza del genere, la quale dovrebbe individuare “l’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento”, ecc… avrebbe carattere c.d. costitutivo/determinativo, ovvero darebbe al giudice il potere di determinare in concreto il contenuto dell’obbligazione[47].
Ma una simile determinazione, a parte il fatto che non sembra possibile per le ragioni già illustrate, si porrebbe in ogni caso in contrasto con il principio secondo il quale il giudice può pronunciare sentenze costitutive/determinative solo nei casi tipici individuati dalla legge e nella stretta misura ivi prevista, e ciò ai sensi dell’art. 2908 c.c.[48] E qui siamo fuori da questo ambito, non solo perché non v’è legge che legittimi il giudice a pronunciare in questi casi sentenze costitutivi/determinative, ma anche perché ciò è possibile solo quando il contenuto dell’obbligo non è determinato, ma tuttavia esiste sul piano del diritto sostanziale, mentre in questi casi, per quanto sopra detto, non esiste nemmeno un diritto soggettivo in relazione alle pretese giudiziali avanzate.
f) Infine, una sentenza del genere non rispetterebbe i criteri del giudicato giurisdizionale civile, e ciò, direi, né da un punto di vista oggettivo che soggettivo.
In senso oggettivo poiché esso non riesce ad avere la forza tipica del giudicato sostanziale, in quanto privo di un comando che possa ritenersi giudizialmente individuato a carico della parte obbligata soccombente.
E in senso soggettivo, poiché il dovere di abbattimento, entro il 2030, delle emissioni artificiali di CO2-ed non potrebbe considerarsi posto a vantaggio delle sole parti attrici vittoriose in giudizio, ma andrebbe considerato a vantaggio di tutti, così di nuovo confondendo il piano giudiziale della legittimazione processuale con quello politico della soddisfazione di un interesse, e finendo altresì per attribuire alla giurisdizione una funzione di tipo oggettivo che non esiste nel nostro sistema[49].
11. Se questi argomenti possono tenere a fronte del diritto dell’Unione europea.
In estrema sintesi, noi avremmo più ragioni di difetto di giurisdizione a fronte del c.d. contenzioso climatico: a) v’è difetto assoluto di giurisdizione perché il giudice non può ordinare allo Stato di fare leggi o atti aventi forza di legge o di invadere la sfera riservata all’amministrazione; b) v’è difetto assoluto di giurisdizione perché il giudice non può decidere questioni relativamente alle quali le parti attrici non hanno situazioni soggettive di diritto; c) e v’è infine difetto assoluto di giurisdizione perché il giudice non può decidere una questione che fuoriesce completamente dai crismi della pretesa giudiziaria.
Questo è quanto mi sembra di poter sostenere.
Ma poi, da vecchio giurista di civil law, mi sopraggiungono dei dubbi, e mi chiedo se tutti questi ragionamenti non siano superati dai tempi, e non siano travolti dal nuovo diritto comunitario, che guarda più alla sostanza delle cose, fino a considerare inutili cavilli, o sterili sforzi logici, le dissertazioni che impediscano o limitino ai cittadini l’accesso al giudice.
Sinceramente, però, non credo sia questa la conclusione da dare, ed anche rianalizzando il diritto comunitario concernente le questioni trattate, io non riesco a trovare niente (forse per mia inadeguatezza) che possa rovesciare i punti esaminati.
Precisamente, rilevo ancora quanto segue.
11.1. Vi sono le norme comunitarie sopra richiamate, ovvero, oltre all’Accordo di Parigi, le Direttive del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 aprile 2009, 2009/29/CE, il Regolamento europeo sul clima 2021/1119 del 30 giugno 2021, e la Decisione, sempre del Parlamento e del Consiglio europeo, 406/2009/CE, oltre alle disposizioni di carattere più generale quali gli artt. 2 e 8 CEDU, gli artt. 2 e 7 della Carta di Nizza.
Per le ragioni già esposte, non mi sembra che queste fonti normative si pongano in contrasto con i rilievi svolti.
11.2. V’è, poi, la vicenda Urgenda, sempre menzionata in ogni scritto di Climate change litigation e anche richiamata dalla sentenza del Tribunale di Roma 26 febbraio 2024 n. 3552: “dove lo Stato olandese (considerato tra i paesi maggiormente emissivi in Europa) è stato condannato definitivamente dalla corte Suprema nel dicembre 2019”[50].
Ma, a parte la circostanza che, nel caso, non si tratta di una Corte europea bensì di una Corte olandese[51], ma, a parte ciò, la situazione non sembra affatto cristallizzata con tale pronuncia, se si considera che proprio in questi giorni è uscita la notizia dell’accoglimento di un appello della società Shell dinanzi alla Corte dell’Aja, che ha annullato il giudizio di primo grado emesso dopo una causa intentata da gruppi di ambientalisti olandesi, che imponeva alla multinazionale britannica di ridurre le emissioni di CO2 del 45% entro il 2030.
Per la Corte dell’Aja non si può imporre una soglia precisa a una singola azienda[52].
11.3. V’è, soprattutto, la sentenza già menzionata CEDU 9 aprile 2024 (GC) 53600/20 nel giudizio di responsabilità da cambiamento climatico della Svizzera[53].
Sia consentito stigmatizzare che si tratta di una sentenza lunga 288 pagine.
Comprendo che una decisione della CEDU debba trovare compromessi tra diverse, e a volte contrapposte, sensibilità, ma trovo davvero riprovevole che non si riesca a produrre provvedimenti giudiziari più precisi e più brevi, soprattutto alla luce dei tempi moderni, che impongono alla giustizia di essere sintetica e specifica.
Ciò premesso, si tratta di una decisione che fissa molti principi generali, per poi concludere, con riferimento alla Svizzera, che: “La Corte ha riscontrato alcune lacune critiche nel processo di creazione del quadro normativo nazionale da parte delle autorità svizzere, tra cui la mancata quantificazione, attraverso un bilancio del carbonio o in altro modo, delle limitazioni delle emissioni nazionali di gas serra. Di conseguenza, lo Stato convenuto aveva superato il suo margine di apprezzamento ed era venuto meno ai suoi obblighi positivi ai sensi dell’articolo 8 del presente contesto”.
Qualcuno potrebbe argomentare che se la CEDU, con questa sentenza, ha provveduto nel merito, allora il tema preliminare della giurisdizione è contenuto e implicitamente riconosciuto.
Da un punto di vista logico, la deduzione tiene.
Da un punto di vista più strettamente giuridico, però, il tema della giurisdizione non appare affatto trattato nella lunga sentenza in questione, e tutto semplicemente viene ricondotto alla questione della legittimazione ad agire dinanzi alla Corte.
Peraltro, una cosa sembrano le azioni di condanna presenti nel contenzioso italiano, altra cosa il mero accertamento che la Corte europea ha posto in essere nei confronti dello Stato svizzero.
E parimenti, una cosa è la legittimazione ad agire, altra cosa la giurisdizione: si dovesse tornare agli esempi fatti, se una associazione a tutela della salute promovesse in Italia una controversia per la buona tenuta degli ospedali, forse qualcuno potrebbe arrivare a riconoscere a questa associazione la legittimazione ad agire, ma difficilmente riconoscerebbe la giurisdizione di una simile domanda.
Ad ogni modo la stessa sentenza precisa che l’accesso al giudice è consentito solo “allo status di vittima ai sensi della Convenzione”, e che al riguardo: “la Corte non ha ritenuto di poter applicare in questo contesto la giurisprudenza relativa alle vittime potenziali, ciò potrebbe coprire praticamente chiunque e non funzionerebbe quindi come criterio limitativo”.
Ed infatti, anche nel rispetto dell’art. 263, 4° comma del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), la legittimazione ad agire può infatti essere riconosciuta a: “Qualsiasi persona fisica o giuridica” relativamente a questioni: “che la riguardano direttamente e individualmente”.
Poi, però, la sentenza esclude la legittimazione delle parti private ma la riconosce all’associazione, con criteri, a mio sommesso parere, non solo dubbi, ma nemmeno esplicitamente indicati, visto che la Corte motiva sul punto: “Nelle circostanze del caso di specie e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, la Corte ha ritenuto che l’associazione ricorrente soddisfacesse i criteri pertinenti e avesse quindi la necessaria legittimazione ad agire”.
I criteri pertinenti sono: “Scopo dell’associazione…..essere senza scopo di lucro…la natura e l’estensione delle sue attività…….i suoi membri e la sua rappresentatività…i suoi principi e la trasparenza della sua governance….circostanze particolari del caso”, ecc…., per cui: “la concessione di tale legittimazione è nell’interesse della corretta amministrazione”; senza, salvo che non cada in errore, una analisi specifica di rispondenza di detti criteri ai requisiti della associazione attrice del giudizio.
11.4. Ora, io credo che nessuno si sentirebbe di negare che la soluzione adottata da questa sentenza appare di dubbia conformità all’art. 263, 4° comma del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), e che nessun giudice italiano potrebbe concedere o negare la legittimazione ad agire con una simile motivazione.
Ed inoltre questa sentenza non appare (almeno a me) in linea con altre decisioni comunitarie su temi analoghi.
Faccio riferimento non solo a quelle già richiamate dall’Avvocatura dello Stato nella difesa al contenzioso denominato del “giudizio universale”[54], bensì anche ad altre, che non sembrano proprio coordinarsi con essa[55]; e, come che sia, si ripete, una cosa è la legittimazione ad agire, altra la giurisdizione.
11.5. In ogni caso ricordo altresì che le sentenze CEDU vincolano l’Italia solo se riferibili ad un orientamento consolidato, e la materia non sembra al momento essere circoscritta da un orientamento consolidato, visto che la sentenza CEDU 9 aprile 2024 (GC) 53600/20 è la sola che al momento si ha.
Ricordo la pronuncia della nostra Corte costituzionale al riguardo:
“La questione è, altresì, inammissibile per l'erroneità del presupposto interpretativo secondo cui il giudice nazionale sarebbe vincolato all'osservanza di qualsivoglia sentenza della Corte di Strasburgo e non, invece, alle sole sentenze costituenti "diritto consolidato" o delle "sentenze pilota" in senso stretto. Infatti, se è vero che alla Corte di Strasburgo spetta pronunciare la «parola ultima» in ordine a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, resta fermo che l'applicazione e l'interpretazione del sistema generale di norme è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri. Il ruolo di ultima istanza riconosciuto alla Corte di Strasburgo, poggiando sull'art. 117, primo comma, Cost. deve quindi coordinarsi con l'art. 101, secondo comma, Cost. nel punto di sintesi tra autonomia interpretativa del giudice comune e dovere di quest'ultimo di prestare collaborazione, affinché il significato del diritto fondamentale cessi di essere controverso.”[56].
Dunque, le questioni di giurisdizioni si inseriscono, direi indiscutibilmente, nell’ambito della “applicazione e l'interpretazione del sistema generale di norme che è attribuito in prima battuta ai giudici degli Stati membri”, e l’assenza di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea sul punto esclude che i giudici interni non possano, in tema di giurisdizione, continuare ad applicare le regole proprie di tale istituto processuale.
11.6. Altri precedenti degni di rilievo, non mi sembrano sussistere.
12. Brevissima conclusione.
In conclusione, la sensazione è quella che si sia voluto utilizzare la giurisdizione per ottenere da essa un monito allo Stato affinché sia più efficiente e più determinato nel provvedere all’adempimento degli obblighi comunitari e internazionali con riferimento ai mutamenti del clima.
Ma la giurisdizione non può essere utilizzata per questi scopi, e
nella misura in cui invece lo scopo ultimo di queste iniziative è proprio quello di ottenere ciò, esse non appaiono condivisibili, poiché la politica non può rendersi oggetto di giudizio, e perché, come diceva Francesco Carnelutti è politica, e non giurisdizione: “quell’aspetto della realtà che concerne il complesso degli interessi collettivi”.
Per citare un altro classico, sembra proprio che i tempi di oggi rispondano alle sue previsioni: “Progressivo affievolimento del diritto soggettivo fino a ridursi a un interesse occasionalmente protetto; allargamento del diritto amministrativo a scapito del diritto civile; assorbimento del processo civile nella giurisdizione volontaria e nella giustizia amministrativa; aumento dei poteri discrezionali del giudice; annebbiamento dei confini non solo tra diritto privato e diritto pubblico, ma anche tra diritto sostanziale e diritto processuale; aspirazione sempre più viva del diritto caso per caso. – Tutti questi sono gli aspetti di una crisi che il processualista segue con ansietà nel suo specchio, nel quale si riflette, tradotto in forma di teoria, il vasto travaglio del mondo”[57].
[1] Sul contenzioso climatico v. ad esempio E. BENVENUTI, Climate change litigation e diritto internazionale privato dell’unione europea: quale spazio per la tutela collettiva? in Riv. dir. intern. priv. proc., 2023, 848 e ss.; F. VANETTI – L. UGOLINI, Contenzioso climatico: recenti sviluppi e riflessioni, in Ambiente e Sviluppo, 2024, 403 e ss.; M., DELSIGNORE, Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi, Giornale di diritto amministrativo, 2022, 265 e ss.; S. NESPOR, I principi di Oslo, Giornale dir. amm. 2015, 750 e ss.; F.Z. GIUSTINIANI, Contezioso climatico e diritti umani: il ruolo delle Corti europee sovranazionali, in Federalismi.it., 2023, 271 e ss.; N. DE SADELEER, Il contenzioso climatico dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, Riv. giur. dell’Ambiente, 2024, n. 57.
[2] Vedi la sentenza anche in Nuova giur. civ. comm., 2024, 309 e ss., con nota di C.M. MASIERI, La causa “giudizio universale” e il destino della Climate change litigation, con ampie indicazioni bibliografiche e di precedenti giudiziari.
La sentenza ha già ricevuto numerose critiche. V. per tutti A. MOLFETTA, La sentenza giudizio universale in Italia: un’occasione mancata di fare giustizia climatica, in Osservatorio costituzionale, Associazione italiana dei costituzionalisti, Fasc. 5/2024. Altri commenti critici sono contenuti nel sito www.contenziosoclimaticoitaliano.it.
[3] Vedila nel sito www.contenziosoclimaticoitaliano.it
[4] Sempre in www.contenziosoclimaticoitaliano.it
[5] Si veda VINCRE – HENKE, Il contenzioso climatico: problemi e prospettive, Rivista di Biodiritto, 2023, 137 e ss.
[6] Riterrei che questa regola valga pacificamente anche per la Corte europea dei diritti dell’uomo. V. al riguardo N. DE SADELEER, Il contenzioso climatico dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, Riv. giur. dell’Ambiente, n. 57, 2024: “La Corte EDU ha ricordato i limiti del principio della separazione dei poteri, sottolineando che «un intervento giurisdizionale, ..., non può prendere il posto delle misure che devono essere adottate dal potere legislativo e da quello esecutivo, o sostituire tali misure»”; seppur: “il controllo giurisdizionale è complementare ai processi democratici (§ 412)”.
[7] Per tutti si veda CORTE COSTITUZIONALE, Servizio Studi, Il dialogo con il legislatore: moniti auspici e richiami nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2022, Roma, 2023, 7 e ss.; R. PINARDI, Moniti al legislatore e poteri della Corte costituzione, Quaderni costituzionali, 2022, 3, www.forumcostituzionale.it; A. SPADARO, Del rapporto tra giudice costituzionale e legislatore, in Riv. AIC, 2023, 103 e ss.; E COCCHIARA, L’evoluzione dei moniti della Corte costituzionale al legislatore: un bilancio a settant’anni dalla legge 87 del 1953, Gruppo di Pisa, 2023, 3, 1 e ss.
[8] Ricordo in questo senso studi classici quali GALLI, Il concetto di giurisdizione, in Studi in onore di M. D’Amelio, Roma, 1933, II, 171; e soprattutto MORTARA, Commentario al codice e alle leggi di procedura civile, Milano, 1923, I, 20, per il quale: “Risulta abbastanza chiaro che la funzione giurisdizionale costituisce quella difesa del diritto obiettivo per virtù della quale ottengono protezione le facoltà soggettive al medesimo conformi”; CALAMANDREI, Limiti fra giurisdizione e amministrazione nella sentenza civile, in Opere, Napoli, 1965, I, 65, per il quale la giurisdizione è “un’attività secondaria di natura dichiarativa”; SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1966, I, 16, per il quale la giurisdizione è: “attuazione del diritto oggettivo, o del diritto soggettivo garantito dalla norma”; CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile, Padova, 1936, I, 230, per il quale la giurisdizione è la precisa “composizione della lite”; ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1973, I, 29.
[9] v. SEGNI, Giurisdizione (in generale), voce del Nov.mo Digesto, Torino, 1961, X, 987.
[10] V. infatti RASELLI, Il potere discrezionale del giudice civile, Padova, II, 1935; ID., Alcune note intorno ai concetti di giurisdizione ed amministrazione, Roma, 1926, 4; FABBRINI, Potere del giudice, voce dell’Enc. del Diritto, Milano, 1985, XXXIV, 721; SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Studi in onore di Segni, Milano, 1966, IV, 243; DE MARINI, Considerazioni sulla natura della giurisdizione volontaria, Riv. dir. proc., 1954, 270.
[11] Mi permetto di ricordare in argomento un mio vecchio studio, SCARSELLI, La tutela dei diritti dinanzi alle autorità garanti. Giurisdizione e amministrazione, Milano, 2000, 202 e ss.
[12] Ricordo ancora F. FERRARA, Potere del legislatore e funzione del giudice, Riv. dir. civ., 1911, 510; PACCHIONI, Dei poteri creativi della giurisprudenza, Riv. dir. comm., 1912, 41; COVIELLO, Dei moderni metodi d’interpretazione della legge, S. Maria Capua Vetere, 1908, 18; LIPARI, Il problema dell’interpretazione giuridica, Il diritto privato nella società moderna, a cura di S. Rodotà, Bologna, 1970, 118.
[13] Aggiungerei, poi, che il divieto posto al giudice di non invadere la sfera dell’amministrazione, ovvero la sfera del potere discrezionale e politico degli organi dello Stato a ciò preposti, non vale solo per il giudice civile, ma costituisce una regola generale, applicabile anche al giudice penale e al giudice amministrativo.
Esattamente: a) per il processo penale si ricorda l’art. 606 c.p.p. per il quale: “Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri”; b) e per il processo amministrativo si ricorda l’art. 31, 3° comma c.p.a.: “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità”; e l’art. 7, che richiama l’art. 134 c.p.a., i quali statuiscono che il giudice amministrativo può pronunciare con cognizione estesa anche al merito nelle sole controversie espressamente indicate nella legge.
[14] Il discorso non muterebbe se il giudice, nel pronunciare la sentenza domandata, invece di determinare le cose da fare in concreto, si limitasse ad accogliere la domanda nella sua generalità per come presentata, ovvero condannasse semplicemente lo Stato: “all’adozione di ogni necessaria iniziativa per l’abbattimento”, ecc…,
Saremmo egualmente in una ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per quanto esposto nel paragrafo n. 10.
[15] Si consideri anche Corte cost. 18 gennaio 2018 n. 6, la quale al punto 15 della motivazione asserisce che: “L’eccesso di potere giudiziario denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come sempre è stato inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosidetta invasione o sconfinamento)”.
[16] V. in argomento F. GOISIS, CEDU e contenzioso climatico nei confronti delle grandi imprese: quale impatto?, in NT+Diritto.il sole24ore, 20 novembre 2024.
[17] In argomento v. Iannicelli, Il c.d. difetto assoluto di giurisdizione fra privati per mancanza di posizione giuridica astrattamente tutelabile, Foro it., 1988, I, 3394; tra i classici LIEBMAN, Domanda infondata e regolamento di giurisdizione, Riv. dir. proc., 1953, II, 35; GARBAGNATI, Improponibilità della domanda e regolamento di giurisdizione, Giust. Civ., 1987, I, 2849.
[18] V., ad esempio, Cass. 15 giugno 1987 n. 5256; e Cass. sez. un. 30 giugno 1999 n. 368; Cass. 7 marzo 2001 n. 90.
[19] Così invece Cass. 13 giugno 2008 n. 15196; Cass. 21 febbraio 2018 n. 4235; e Cass. 9 marzo 2020 n. 6690.
[20] PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2023, 241.
Tra i classici, sul punto, ricordo, ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1957, I, 127: “La così detta improponibilità della domanda ha luogo quando la pretesa del privato è sì intensamente assoggettata ai poteri attribuiti alla amministrazione attiva da essere sfornita di tutela nel processo contro quest’ultima (CARNELUTTI, Istituzioni, II, n. 423); P. D’ONOFRIO, Commento al codice di procedura civile, Torino, 1957, I, 82: “Il difetto di giurisdizione si verifica allorquando si sottoponga alla autorità giudiziaria ordinaria una pretesa la quale non è azionabile in modo assoluto, ovvero quando la pretesa non ha rilevanza giuridica...Un interesse meramente religioso, estetico o morale, ad esempio, non è tutelabile”;
[21] V. A. MASSARI, Regolamento di giurisdizione e competenza, in Nov.Dig.it., Torino, XV, 1968, 283, citato da G. GIOIA, La decisione sulla questione di giurisdizione, Torino, 2009, 67.
[22] Così BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2019, I, 116.
[23] Cass. sez. un. 30 marzo 2005 n. 6635: “Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio”
[24] Cass. sez. un. 1° giugno 2023 n. 15601: “Il difetto assoluto di giurisdizione è configurabile quando manca nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio”. Si veda anche Cass. sez. un. 29 maggio 2023 n. 15058: “Sulla domanda proposta nei confronti dello Stato italiano per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancanza di una disciplina normativa per la tutela della maternità delle donne avvocato vi è difetto assoluto di giurisdizione, poiché essa comporta non già la delibazione di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla sfera riservata dalla Costituzione allo Stato legislatore”.
[25] V. fin d’ora, per tutti BELLOMO, Nuovo sistema del diritto amministrativo, IQ, Diritto e scienza, 2023, I, 43, per il quale: “Non sempre al dovere – diversamente dall’obbligo – in capo a un soggetto corrisponde un diritto in capo ad altro soggetto, potendo sussistere interessi non qualificati che spetta all’amministrazione valutare discrezionalmente. In tale accezione, dunque, l’interesse di fatto consiste nell’interesse dei cittadini ad essere ben amministrati”. Si veda anche CHIEPPA-GIOVAGNOLI, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2024, 163.
[26] È questa, direi, anche la posizione dell’Avvocatura dello Stato nel giudizio sfociato nella sentenza del Tribunale di Roma 26 febbraio 2024; v. la comparsa di risposta nel sito www.contenziosoclimaticoitaliano.it, pag. 26: “Occorre a tal proposito rilevare che l’adesione degli Stati agli accordi sul clima non è idonea di per sé a fondare la base legale da cui evincere un obbligo di natura vincolante la cui (eventuale) violazione vale a fondare un’azione di responsabilità nei confronti delle istituzioni degli Stati stessi”.
[27] D. BEVILACQUA, La normativa europea sul clima: una regolazione strategica o un passo troppo timido, Riv. giur. dell’ambiente, 2022, n. 29.
[28] È questa anche la posizione dell’Avvocatura dello Stato, comparsa di risposta, pag. 27: “L’accordo di Parigi si basa sulla definizione di contributi nazionali non vincolanti di mitigazione, che devono essere stabiliti autonomamente da ciascuna delle parti contraenti (sistema bottom-up…..e soggetti a periodica revisione sulla base delle indicazioni che verranno elaborate dalle istituzioni e dagli organismi previsti dal sistema della Convenzione quadro dell’Accordo stesso…..Per assicurare l’attuazione degli impegni non sono stati, comunque, previsti meccanismi sanzionatori, essendosi privilegiata la diversa strategia di affidare il successo dell’accordo a piani contenenti contribuzioni alla riduzione globale delle emissioni volontariamente e ambiziosamente assunte dagli Stati”.
[29] Avvocatura dello Stato, comparsa di risposta, pag. 15.
[30] Al riguardo v. anche la recentissima Cass. sez. un. 19 giugno 2024 n. 16837: “Il difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile quando il giudice speciale ha applicato una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete”.
[31] In senso, direi, del tutto conforme, BELLOMO, Nuovo sistema del diritto amministrativo, cit., 43, il quale fa degli esempi analoghi a quelli sviluppati nel testo. Si legge: “Esempi di interessi di fatto aderenti a tale nozione (ovvero alla circostanza che non attribuiscono corrispondenti diritti ai cittadini) possono indicarsi nell’interesse ad una buona e funzionante illuminazione pubblica, alla manutenzione delle pubbliche strade, alla funzionalità e qualità dei servizi pubblici”.
Di nuovo appare chiaro che nessun cittadino può adire il giudice per pretendere dallo Stato, genericamente, l’adempimento di questi doveri.
[32] V., senza alcuna pretesa di completezza, LENER, Potere (dir. priv.), voce dell’Enc. del Diritto, Milano, 1985, XXXIV, 610; CESARINI SFORZA, Diritto soggettivo, voce dell’Enc. del Diritto, Milano, 1964, XII, 659; FALZEA, Efficacia giuridica, voce dell’Enc. del Diritto, Milano, 1965, XIV, 432 e ss.; SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, 70 e ss.; BETTI, Dovere giuridico (teoria gen.), voce dell’Enc. del Diritto, Milano, 1965, XIV,53 e ss.
[33] CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1923, I, 2: “Analizzando l’idea del diritto soggettivo, si trova che questo si risolve in una volontà concreta di legge. Ogni norma contenuta nella legge è una volontà generale, astratta, ipotetica, subordinata cioè al verificarsi di determinati fatti. Ogni volta si verifica il fatto o il gruppo di fatti previsti dalla norma, si forma una volontà concreta della legge, in quanto dalla volontà generale e astratta nasce una volontà particolare che tende ad attuarsi nel caso singolo”.
[34] In questo senso, ancora, VINCRE – HENKE, Il contenzioso climatico: problemi e prospettive, Rivista di Biodiritto, 2023, 143 per i quali le fonti normative di protezione dell’ambiente raffigurano situazioni giuridiche protette “tanto al singolo soggetto quanto alla collettività”.
[35] Per tutti v. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, Roma, 1951, 161, il quale, seppur con diverse parole, ritengo manifestasse la stessa idea: “La differenza tra diritto soggettivo e facoltà è facile da tracciare sul filo della differenza tra l’agere e il iubere: la facoltà non esce dalla sfera dell’interesse proprio mentre il diritto soggettivo invade la sfera dell’interesse altrui”.
[36] V. Cass. 28 agosto 2009 n. 18783; Cass. 3 marzo 2008 n. 5743; Cass. 9 settembre 2004 n. 18184; Cass. 1° giugno 2001 n. 7448;
[37] CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1923, I, 169; L. MONTESANO, Condanna civile e tutela esecutiva, Napoli, 1965, 185, e ID., La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, 175.
[38] Così LUISO, Diritto processuale, Il processo esecutivo, Milano, 2009, 23, secondo la tradizione della dottrina, tra la quale ricordo: REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1957, II, 121; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1957, 12; GRASSO, Titolo esecutivo, voce dell’Enc. del Diritto, Milano, 1992, XLIV, 692, per il quale il diritto certo è quello che “deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti dal relativo provvedimento giurisdizionale o atto negoziale”. In giurisprudenza Cass. 25 febbraio 1983 n. 1455: “Requisito essenziale dei titoli esecutivi, giudiziali e stragiudiziali, menzionati dall' c. p. c. è la certezza del diritto risultante dal titolo stesso, intesa nel senso che la situazione giuridica accertata in favore di un soggetto deve emergere esattamente e compiutamente, nel suo contenuto e nei suoi limiti dal relativo provvedimento giurisdizionale”. Scriveva altresì Giuseppe Chiovenda che: “La sentenza di condanna presuppone la convinzione del giudice che in base alla sentenza si possa senz’altro, o immediatamente dopo un certo tempo, procedere dagli organi dello Stato agli atti ulteriori necessari per l’effetto del conseguimento del bene garantito dalla legge (v. infatti CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1923, I, 169).
[39] VINCRE – HENKE, Il contenzioso climatico: problemi e prospettive, Rivista di Biodiritto, 2023, 149, ritengono che potrebbe risolvere il problema, in questi casi, l’esecuzione indiretta di cui all’art. 614 bis c.p.c.; il tutto, comunque, in una prospettiva “difficile da pronosticare”.
Io non credo, tutto al contrario, che in questi casi la strada dell’art. 614 bis c.p.c. sia percorribile, poiché nella misura in cui gli obblighi di fare oggetto di questi contenziosi consisterebbero in interventi normativi dello Stato, rimessi peraltro al suo potere amministrativo/discrezionale, e da realizzarsi nel bilanciamento con tutti gli altri diritti e interessi pubblici coinvolti, trovo del tutto inammissibile che a fronte di ciò il giudice possa condannare lo Stato ad una somma di denaro quale sanzione per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure.
Se poi si aggiunge che questi obblighi di fare sui quali l’art. 614 bis c.p.c. dovrebbe operare sarebbero contenute in un dispositivo della sentenza a contenuto del tutto generico, e tale da rendere praticamente impossibile una verifica oggettiva dell’adempimento o meno della sentenza,
[40] Sulla legittimazione processuale v. ora L. GALATI, Processo senza soggetti, Milano, 2021, 156 e ss.
[41] In questo senso anche l’Avvocatura generale dello Stato, comparsa di risposta, pag. 22: “Gli odierni attori non appaiono legittimati ad agire in giudizio per lamentare forme di alterazione indiretta dell’ambiente, quali potrebbero essere le conseguenze del cambiamento climatico dovuto ad emissioni di gas serra, in quanto titolari di una posizione indifferenziata rispetto a quella di qualunque altro soggetto”.
A conferma di questa posizione l’Avvocatura dello Stato richiamava i precedenti comunitari di: a) caso Armando Carvalho e a.v. Consiglio e Parlamento europeo (causa T-330/18); b) Corte di Giustizia, 15 luglio 1963, causa C-25/62, Plaumann, punto 199; c) CEDU Lopez Ostra v. Spagna 1994; d) CEDU Guerra v. Italia, 1998; e) CEDU Oneryildiz v. Turchia, 2004; f) CEDU Cordella v. Italia, sentenza 24 gennaio 2019, sul caso “Ilva”.
[42] N. DE SADELEER, Il contenzioso climatico dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, Riv. giur. dell’Ambiente, n. 57, 2024, ricorda che per la menzionata sentenza CEDU, la legittimazione ad agire spetta solo quando v’è: “il «rischio reale» di un «impatto personale e diretto» sul ricorrente”, che: “debba essere «particolarmente elevato» (§§ 486 - 488), il che esclude un semplice pregiudizio superficiale. Quindi, la vittima dovrebbe essere «esposta in modo intenso agli effetti del cambiamento climatico», il che implica “un bisogno imperioso di garantire la sua protezione individuale” (§ 487)”.
[43] V. Cons. Stato, 20 settembre 2024, III, n. 7704.
[44] Per una critica alla legittimità generalizzata delle associazioni a far valere in giudizio interessi diffusi v. ora anche PROTO PISANI – VERDE, Verso una giurisdizione di tipo oggettivo, nota critica a Cass. sez. un. 23 novembre 2023 n. 32559, in Riv. dir. proc., 2024, 1031, per i quali: “Il nostro sistema di giustizia – ricordiamolo – è di tipo soggettivo, in quanto il giudice può intervenire se è chiamato in causa da chi è titolare del rapporto giuridico contestato o è diretto destinatario del provvedimento impugnato”.
[45] Si veda anche, al riguardo, l’art. 34, 2° comma c.p.a., per il quale: “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
[46] Così, espressamente, BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Bari, 2019, I, 47/48.
Si veda anche in argomento PAOLINI, Note sulla condanna in futuro, Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, 507; PROTO PISANI, Appunti sulla tutela di condanna, in Appunti sulla giustizia civile, Bari, 1982, 182.
[47] v. in argomento PAGNI, Le azioni di impugnativa negoziale, Milano, 1998, 1 e ss.; MONTESANO, Obbligo a contrarre, voce dell’Enc. del Diritto, Milano, 1979, XXIX, 508 e ss.; PROTO PISANI, Appunti sulla tutela c.d. costitutiva, Riv. dir. proc. 1991, 60 e ss.
[48] V. al riguardo PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 2023, 161, per il quale: “L’art. 2908 c.c. vale ad imporre il marchio della tassatività alle ipotesi riconducibili nello schema dommatico della tutela costitutiva”. V. anche DI MAIO, La tutela civile dei diritti, Milano, 1987, 307; E MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, 155: “l’inquadramento della tutela giurisdizionale dei diritti in via determinativa sotto la categoria descritta nell’art. 2908 c.c. non è senza concrete conseguenze, giacché comporta la tipicità della tutela in esame”.
[49] V. infatti ancora PROTO PISANI – VERDE, Verso una giurisdizione di tipo oggettivo, cit., 1031 e ss.
[50] Così, espressamente, la sentenza del Tribunale di Roma 26 febbraio 2024 n. 3552, pag. 7.
[51] In questo contesto possono ricordarsi anche le pronunce del Tribunale amministrativo di Parigi del 3 febbraio 2021, con la quale è stata riconosciuta una responsabilità omissiva in relazione agli obiettivi e agli impegni comunitari e nazionali, e la sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 29 aprile 2021, che si è pronunciata sulla parziale incostituzionalità della legge federale sui cambiamenti climatici del 2019.
[52] V. al riguardo, M. PIGNATELLI, Il sole24 ore, 12 novembre 2024.
[53] Vedila in https://hudoc.echr.coe.int/it#
[54] Rinvio alla nota n. 41.
L’avvocatura dello Stato, comparsa di risposta, pag. 16 e ss., indica poi numerose sentenze internazionali in senso conforme all’inammissibilità dei ricorsi.
[55] Corte europea dei diritti dell’uomo, Gran Camera 9 aprile 2024: “La Corte, all'unanimità, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da sei cittadini portoghesi relativamente alle ricadute, odierne e future, del cambiamento climatico”; F.Z. GIUSTINIANI, Contezioso climatico e diritti umani: il ruolo delle Corti europee sovranazionali, in Federalismi.it., 2023, 271 e ss.
[56] Così espressamente Corte Cost. 26 marzo 2015 n. 49; conforme Corte Cost. 4 dicembre 2009 n. 317: “Con riferimento ad un diritto fondamentale garantito anche dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa. In particolare, la Corte non può ammettere che una tutela superiore, che sia possibile introdurre per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., rimanga sottratta ai titolari di un diritto fondamentale. L'obiettivo di massima espansione delle garanzie deve essere conseguito attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che tutelano i medesimi diritti protetti a livello convenzionale e nel necessario bilanciamento con altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, suscettibili di essere incisi dall'espansione di una singola tutela. La protezione dei diritti fondamentali deve, dunque, essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, e la realizzazione di un equilibrato sistema di tutela è demandata, per gli ambiti di rispettiva competenza, al legislatore, al giudice comune e al giudice delle leggi. Il risultato complessivo dell'integrazione delle garanzie dell'ordinamento deve essere di segno positivo, nel senso che dall'incidenza della singola norma Cedu sulla legislazione italiana deve derivare un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali. Resta fermo che la Corte costituzionale non può sostituire la propria interpretazione di una disposizione della Cedu a quella della Corte di Strasburgo, con ciò uscendo dai confini delle proprie competenze, in violazione di un preciso impegno assunto dallo Stato italiano con la sottoscrizione e la ratifica, senza l'apposizione di riserve, della Convenzione, ma può valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma Cedu, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni compiute dalla Corte in tutti i giudizi di sua competenza”. V. anche in senso analogo Corte Cost. 11 marzo 2011 n. 80.
[57] P. CALAMANDREI, La relatività del concetto di azione, Studi sul processo civile, Padova, 1947, V, 26.
Immagine: Chmee2/Valtameri, CC BY 3.0

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
