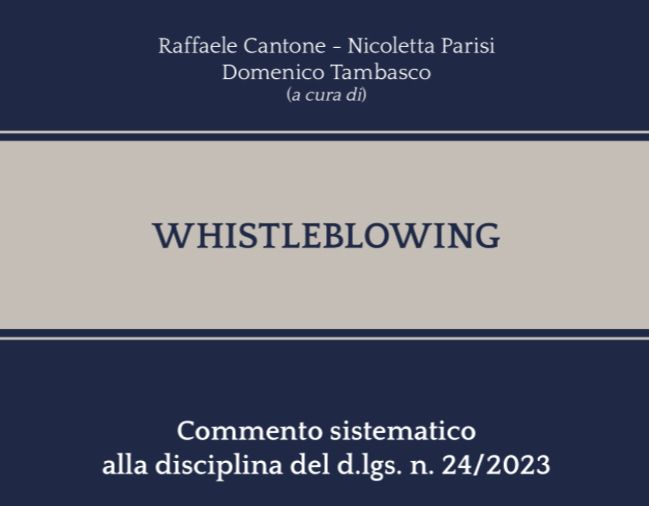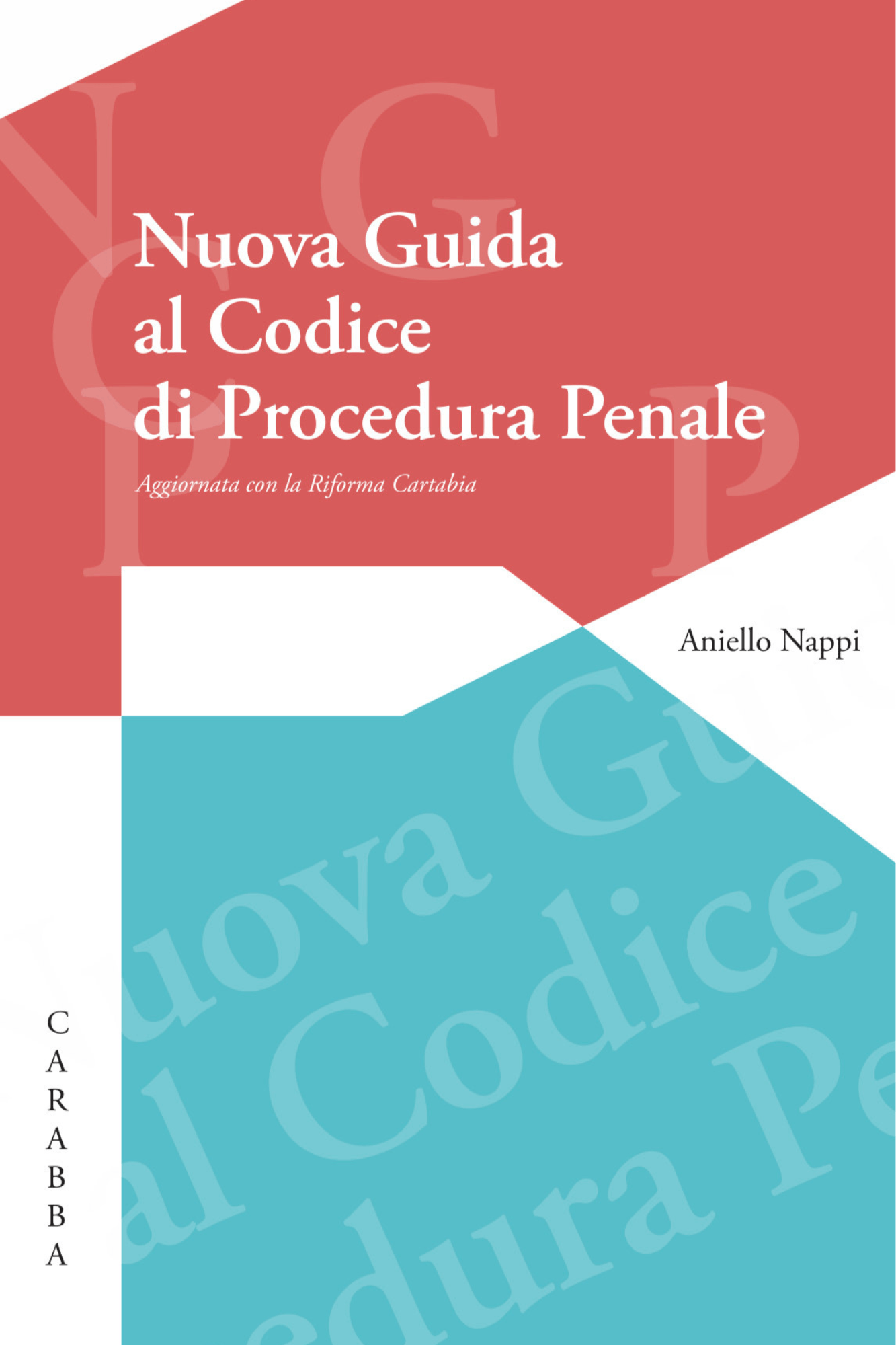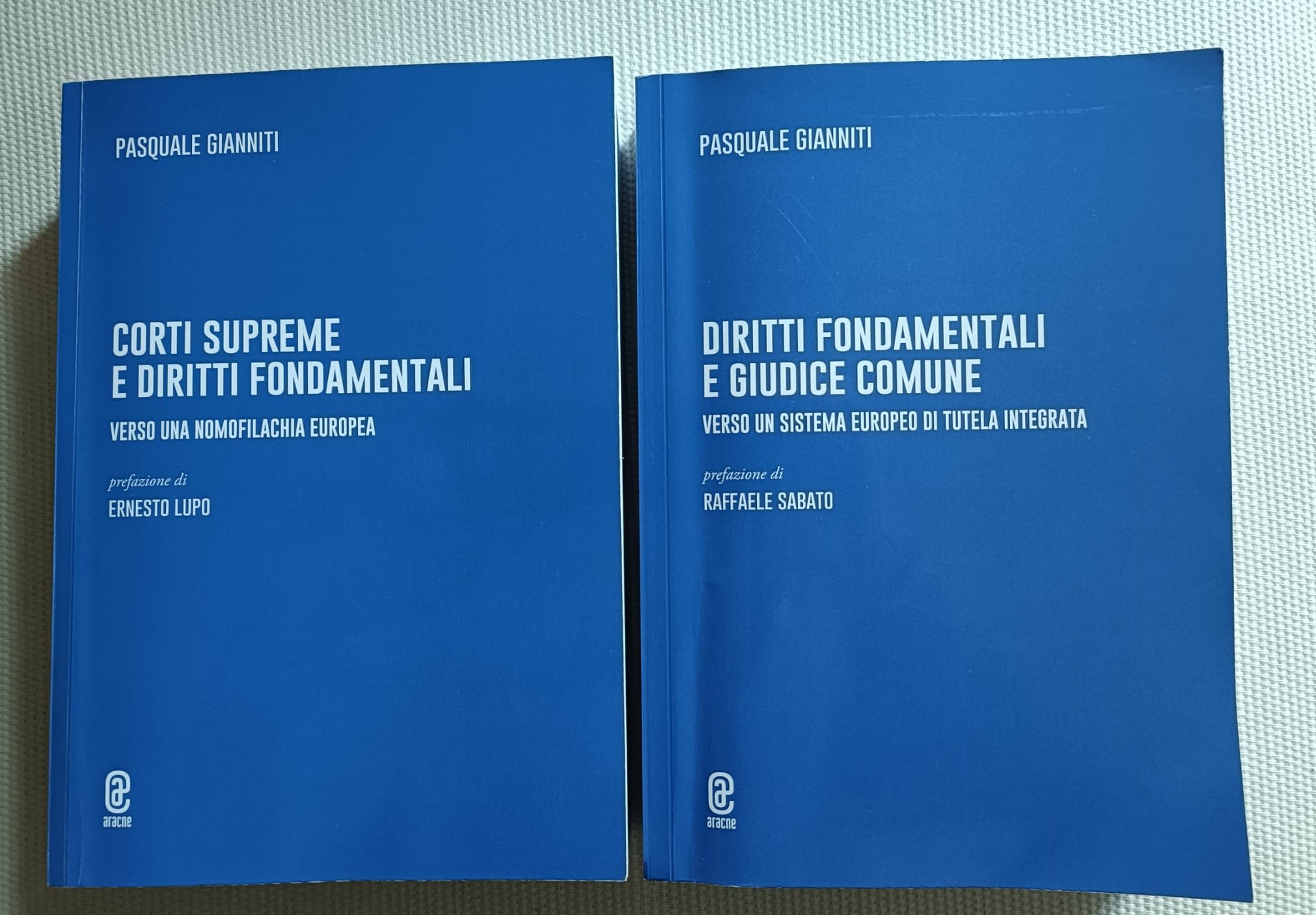Prima di occuparsi del ruolo, della posizione della Corte di cassazione e della necessità di un dialogo virtuoso con i giudici di merito è opportuno un chiarimento sulla nozione di “diritto vivente”, frequentemente evocata proprio con riguardo all’attività interpretativa della Corte di legittimità.
L’espressione è spesso usata in senso polemico, per significare la crescita incontrollata del diritto giurisprudenziale, per censurare quella che viene denunciata come indebita invasione di campo del giudiziario rispetto al legislativo, ovvero per evidenziare il distacco della Corte dai giudici del merito e dalle loro esigenze.
In realtà, in modo assolutamente approssimato, l’espressione diritto vivente, così come compare in numerose sentenze della nostra Corte costituzionale, non significa affatto “diritto libero” o “libera creazione del diritto”, bensì, più modestamente, “attuale stato dell’interpretazione giurisprudenziale di una norma suscettibile di diverse letture”.
In quanto “vivente” il diritto è mutevole e la sua cifra caratteristica è l’incertezza; una incertezza che il processo dovrebbe essere in grado di sciogliere.
Molto si parla di “prevedibilità della decisione”, ravvisando nella stessa il tratto che dovrebbe caratterizzare le moderne giurisdizioni, ma non si può pensare che la giurisprudenza sia immutabile, che la prevedibilità coincida con la immutabilità di ciò che è consolidato.
A ben vedere, l’esito di ogni processo ha sempre una componente di imprevedibilità e tante previsioni più o meno azzardate su “come andrà a finire” sono destinate ad essere smentite.
Ciò appartiene alla fisiologia, non alla patologia del giudiziario. Si possono fare pronostici su come il giudice interpreterà una norma (sostanziale o processuale), ma non si potrà mai dar per scontata l’opzione interpretativa che alla fine sarà preferita.
2. Le condizioni in cui opera la Corte di cassazione
All’indomani dell’unificazione della Corte di cassazione penale (1889), un giurista dei primi del novecento offriva una descrizione piuttosto sconfortante della situazione in cui versava la “nuova” Cassazione con sede nella Capitale, evidenziando i contrasti interni alle Sezioni, le oscillazioni interpretative mai risolte, le sentenze iperboliche, l’esasperante individualismo tra i giudici di legittimità.
È sorprendente constatare che gli stessi problemi che oggi riguardano la Corte di cassazione erano già presenti in anni così lontani e in contesti profondamente diversi.
Naturalmente, l’attuale difficoltà della Corte di legittimità, percepita spesso come distante dai giudici di merito, a “fare nomofilachia”, dipende da numerosi fattori, cui non è estranea, è opportuno ricordarlo, la stessa natura “ambigua” di questo giudice, che deriva dall’impianto delle norme fondamentali che regolano le sue funzioni: da un lato, l’art. 65 ord. giud. che stabilisce che la Corte di cassazione assicura l’esatta osservanza e l’uniformità dell’interpretazione della legge; dall’altro, l’art. 111, comma 7, Cost., che prevede che contro le sentenze è sempre ammesso ricorso per cassazione, per violazione di legge.
Si tratta di due disposizioni che disegnano il DNA della Corte di cassazione e che giustificano pienamente la fortunata definizione di questo giudice come di un “vertice ambiguo”, per sottolineare che, allo stesso tempo, svolge funzioni di corte suprema (ius constitutionis) e di corte di terza istanza che assicura una tutela dei diritti delle parti (ius litigatoris), ponendosi nel sistema costituzionale come strumento di tutela contro le “decisioni ingiuste” e insostituibile baluardo per le garanzie dell’imputato.
Proprio l’essere baluardo contro le decisioni ingiuste ha contribuito all’aumento esponenziale dei ricorsi con il conseguente ridimensionamento del ruolo di Corte suprema, svolto in maniera prevalente dalle Sezioni unite.
Le Sezioni semplici finiscono infatti per svolgere prevalentemente funzioni di giudice dello ius litigatoris, pronunciando un numero elevatissimo di decisioni, con il rischio conseguente di un aumento esponenziale dei contrasti giurisprudenziali tra Sezioni, ma anche all’interno della stessa Sezione, di contrasti consapevoli ed inconsapevoli, di obiettive difficoltà di individuare con chiarezza gli orientamenti consolidati.
Detto rischio è accentuato dall’attività di massimazione e, più in generale, dalle funzioni delle banche dati, in cui i giudici finiscono sempre per trovare quel che cercano, con conseguente difficoltà per la Corte di apparire coerente e stabile.
Ciò produce difficoltà nell’assicurare uniformità interpretativa e complica le possibilità di instaurare un corretto rapporto tra giudice di legittimità e giudice di merito.
3. Le norme e i fenomeni criminali: le sollecitazioni e la compressione dei diritti.
In questo contesto problematico la Corte di cassazione rende la propria giurisprudenza e dialoga con i giudici di merito.
Si sono registrate frequenti spinte, forti sollecitazioni alla Corte da parte dei giudici di merito – per lo più derivanti dalla esigenza di limitare manifestazioni criminali sempre più allarmanti - a guardare al “fenomeno” e non alle norme e alla corretta applicazione del diritto, ad assecondare e privilegiare, di fatto, una libertà interpretativa, anziché la certezza giuridica, a “trasformare” il ruolo e la funzione propri della Corte, intesa come invalicabile presidio di legittimità e luogo di garanzia dei diritti fondamentali delle persone.
Sollecitazioni finalizzate a privilegiare una lettura delle disposizioni penali “di tipo estensivo additivo”, in un’ottica volta a valorizzare le esigenze di difesa sociale, a ritenere erroneamente che la necessita di stabilità e la prevedibilità delle decisioni, garantita dalle Sezioni unite, sia assicurata dalla immutabilità di ciò che è consolidato.
Non vi è solo la nota vicenda del concorso esterno nell’associazione mafiosa (di cui tanto si parla), ma ci si può riferire anche al tema della c.d. corruzione funzionale, cioè del funzionario a libro paga (prima della modifica dell’art. 318 c.p. dovuto alla legge Severino); a certe applicazioni dell’abuso d’ufficio; alla lettura che la Corte di cassazione, per anni, ha fatto del reato di maltrattamenti in famiglia, estendendo la tutela anche al non più convivente, soluzione che, da ultimo, è stata significativamente criticata dalla Corte costituzionale (sent. n. 98 del 2021); ancora, alla giurisprudenza sul disastro innominato oppure all’applicazione del reato di getto pericoloso di cose esteso alle emissioni di onde elettromagnetiche o, ancora, alle malattie professionali e all’estensione della lottizzazione abusiva, fino alle confische senza condanna.
4. Il virtuoso dialogo tra giudice di legittimità e giudice di merito.
Si tratta di operazioni interpretative che, sotto diversi profili, sono state compensate da altri modelli di intervento, caratterizzati da una linea di proficuo dialogo con i giudici di merito, dalla comune scelta di innalzare qualitativamente e stabilizzare i livelli di garanzia, di respingere l’idea che il processo penale sia un inutile orpello volto sostanzialmente a garantire l’impunità, dalla considerazione per cui la necessità di “dare risposte” non può piegare le norme, limitare la legalità penale, conformare la funzione di accertamento con le regole del giusto processo.
Un innalzamento delle garanzie derivato dal progressivo e costante recepimento degli spunti offerti dalle decisioni di Strasburgo: si pensi, ad esempio, all’interpretazione evolutiva dell’art. 7 CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo, che ha offerto un fondamento molto più solido al principio di retroattività della lex mitior e che ha portato poi le Sezioni unite Gatto ed Ercolano ad estenderne l’operatività anche in executivis; ai tentativi di ampliare la sfera operativa dell’istituto del ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis c.p.p. per dare esecuzione a sentenze della Corte EDU (caso Drassich); alla valorizzazione dell’istituto della restituzione in termini per porre rimedio alla disciplina del processo contumaciale (caso Somogyi); alla sostanziale abrogazione per indeterminatezza del reato previsto dall’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che puniva il soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale per non aver rispettato l’obbligo di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, operata dalle Sezioni unite Paternò nel 2017; alle Sezioni unite Caruso del 2019 sulla coltivazione di stupefacenti (ancora un intervento sulla tipicità del reato).
Non diversamente, sotto altro profilo, è necessario dialogare con la migliore dottrina, che ormai da tempo ha indicato come il diritto giurisprudenziale determini effetti, quali la retroattività dei mutamenti giurisprudenziali e la interpretazione estensiva (che, pur essendo riconducibile alla lettera dell’enunciato normativo, può non apparire ragionevolmente prevedibile), rispetto ai quali occorre riempire i vuoti di tutela che si aprono con soluzioni adeguate alla complessità delle questioni: la continua elaborazione della giurisprudenza di merito, per sua natura vicina alla percezione dei mutamenti e del novum dell’evoluzione sociale, e l’opera “uniformatrice” svolta dalla Corte di cassazione hanno il dovere di misurarsi seriamente con tali problemi nell’ottica della progressiva espansione della tutela dei diritti fondamentali.
Entro questa prospettiva assume un particolare rilievo l’esigenza di promuovere ed assicurare una maggiore uniformità interpretativa all’interno delle sezioni semplici della Corte di cassazione, attraverso l’organizzazione di apposite riunioni sezionali e intersezionali.
Una maggiore attenzione va riservata alla valutazione, sin dalle prime fasi del giudizio di merito, delle questioni oggetto di un possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ovvero di un eventuale ricorso alla Corte EDU, ponendosi in una più ampia dimensione ordinamentale di tutela diffusa dei diritti della persona, la cui protezione “convenzionale” è in via primaria riservata alla sensibilità del giudice comune.
Si avverte, inoltre, l’esigenza di innalzare i livelli di formazione professionale dei magistrati e di potenziare il ruolo della Scuola superiore, orientando l’attività formativa anche sull’esperienza di dialoghi tematici volti ad approfondite la comune messa a fuoco delle questioni che più di frequente costituiscono oggetto di ricorsi proposti alla Corte di cassazione.
Potrebbe rivelarsi opportuna, infine, sulla base dell’esperienza ricavabile dall’esame di altri modelli ordinamentali vicino al nostro (ad es., il sistema francese), la possibilità di istituire conferenze permanenti dei presidenti delle Corti di appello e dei procuratori generali, che rispettivamente individuino e raccolgano sul territorio le comuni questioni problematiche da sottoporre all’attenzione della Corte, al fine di elaborare proposte virtuose e l’instaurazione di buone prassi in materia organizzativa, anche nella prospettiva di una più rapida fissazione e trattazione dei giudizi di impugnazione.
Approfondimenti sul tema:
Il ruolo del giudice ai fini della effettività dei precetti posti dalla legge di Giacomo Fumu
Un cambiamento del volto della giustizia Italiana di Antonella Di Florio
Appunti sui numeri della Cassazione di Pierpaolo Gori
Il passaggio dalla requisitoria orale a quella scritta di Pasquale Serrao D'Aquino