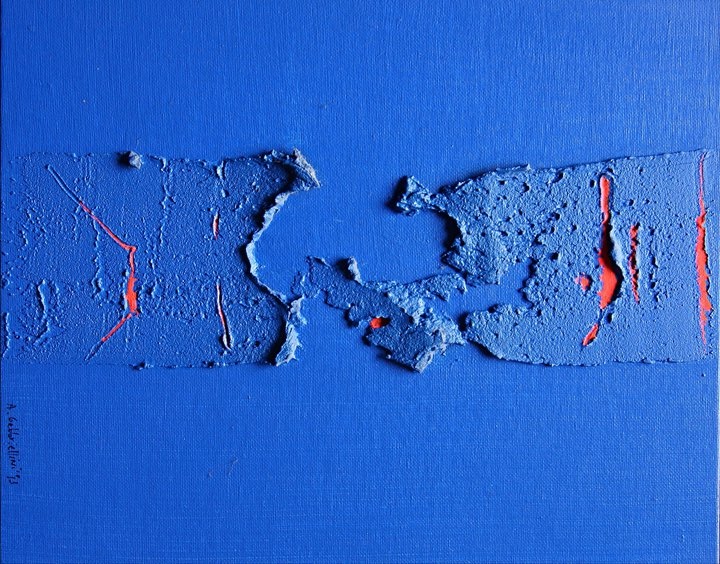Memoria, testimonianze e ritratti di giuristi italiani del Novecento - a cura di Vincenzo Antonio Poso
Franco Cordero intellettuale del dissenso*
Sommario: 1. Prologo – 2. La Procedura penale secondo Franco Cordero – 3. Cordero filosofo del diritto: l’incidente della Cattolica – 4. Segue: Il caso Cordero davanti alla Corte costituzionale e nelle reazioni dei commentatori – 5. Narratore e storico – 6. Polemista negli anni 2000 – 7. Lascito intellettuale.
1. Prologo
Franco Cordero (Cuneo, 6 agosto 1928 – Roma, 8 Maggio 2020) è stato, più che un giurista, un intellettuale di straordinaria erudizione, con interessi in ogni anfratto dello scibile umanistico. L’attitudine alla critica e al dissenso rispetto alle tendenze dominanti del pensiero, politico, teologico, giuridico lo ha esposto a frequenti polemiche, affrontate sempre con atteggiamento laico e razionale. Come giurista, ha avuto un’influenza enorme nello sviluppo della dottrina processualpenalistica. Ha offerto importanti approfondimenti nel campo della filosofia del diritto, della teologia oltre che minuziosi affreschi storia della giustizia penale. Si è prodigato come romanziere, segnalandosi per l’originalità dello stile letterario e vincendo il premio Viareggio (miglior opera prima) con il libro Genus (1969). Nella veste di pubblicista, ha animato vivaci polemiche, prendendo di mira principalmente le ortodossie del pensiero religioso e talune arroganze della politica.
Già gli inizi del Cordero studioso sono stati accidentati. Desideroso di dedicarsi all’arte medica, decide di iscriversi alla facoltà giuridica torinese dopo una singolare esperienza vissuta da diciottenne nell’ultimo anno di liceo (1946). Come lui stesso racconta, viene invitato da Gino Giugni (genovese, che aveva frequentato Cuneo come sfollato durante il secondo conflitto mondiale) a tenere una conferenza su “Socialismo e cristianesimo” in un circolo cittadino. Assiste all’incontro Aldo Viglione (cuneese, partigiano, avvocato e poi politico). «Hanno influsso plagiario i suoi complimenti» ricorderà Cordero. A sentir lui «ho l’avvocatura nei cromosomi, con sicure prospettive fra foro e politica. Tramonta così la vocazione medica» (così in Morbo italico, Roma-Bari, Laterza 2013, 235).
Si laurea nel 1950 in Diritto romano, sotto la guida di Giuseppe Grosso, discutendo una tesi dal titolo Pactum de non petendo nell’obbligazione solidale di diritto romano. Vorrebbe crescere nell’ambiente del prof. Grosso, ma capisce subito che le prospettive di carriera in quel settore sono pressoché inesistenti. Frequenta per qualche anno la cattedra retta da Francesco Antolisei: con rammarico, costretto a deviare «dalla via seria (il diritto romano) alla fiera penalistica» (cfr. Premessa a Gli osservanti, edizione rieditata da Nave di Teseo, Milano, 2024, p. 1). Ma nemmeno quell’ambiente lo accoglie con favore: «arriverai alla cattedra dall’avvocatura», cantava l’affabile maestro (loc. ult. cit.). Nel 1954 si sposta a Milano, nello studio di Enrico Allorio, che lo consiglia di dedicarsi alla Procedura penale, disciplina nuova, da rifondare. Ed è da questo punto che conviene muovere per ripercorrere le principali tappe di una straordinaria figura di giurista e intellettuale.
2. La Procedura penale secondo Franco Cordero
Anche qui conviene lasciar la parola all’autore. In un convegno del 2008, organizzato per celebrare i sessant’anni della Costituzione repubblicana, Cordero rievoca il suo primo approccio con questa disciplina. «Sessant’anni fa non godeva buona fama. Forse posso concedermi un aneddoto autobiografico. Ho 19 anni, iscritto al secondo anno della Facoltà torinese: luogo serio; imparo comme il faut varie cose; questa coda dello scibile penalistico viene al quarto anno; da 10 (vale a dire dal 1938) costituisce materia autonoma nella ratio studiorum, prima era un capitolo trascurabile dei “Criminalia”, enucleati dallo ius civile anno Domini 1509, quando Bologna chiama Ippolito Marsili, vecchio praticone, “ad lecturam quotidianam criminalium”. Il professore, chiaro penalista (Francesco Antolisei), la ignora; non teneva nemmeno lezione. Quart’ultimo dei miei esami, vi spendo quattro o cinque giorni: 30 e lode. La cosa peggiore è che li meriti, avendo racimolato qualche idea nel deserto intellettuale». (cfr. Miserie della procedura penale, in Marco Ruotolo – a cura di – La costituzione ha sessant’anni. La qualità della vita sessant’anni dopo, Ed. scientifica, Napoli, 2008, p. 149).
Negli anni Cinquanta, la Procedura penale era dunque una disciplina abbandonata a sé stessa: un “deserto intellettuale”. All’autonomia accademica, formalmente riconosciuta da un decreto ministeriale del settembre 1938, non era seguita (se non in qualche rarissimo caso) un’assegnazione esclusiva del relativo corso a docenti di ruolo. Quasi ovunque essa era insegnata per affidamento al docente di Diritto penale, il quale finiva spesso col trascurarla. Di conseguenza, anche la manualistica e la dottrina erano di modesta levatura, prive di originalità, sempre comunque debitrici del ben più evoluto Diritto processuale civile.
Il primo studio (Le situazioni soggettive nel processo penale, Torino, Giappichelli, 1956) è un impegnativo esercizio di teoria generale del processo: un’opera di pura teoria, come musica astratta nei ballabili, confesserà decenni dopo (Premessa a Gli osservanti, loc. cit.). In realtà, muove da un’adesione convinta alle teorie di Hans Kelsen, lasciandosi andare a qualche spunto di ammirata polemica per il grande processualista tedesco James Goldschmidt, la cui visione realistica dell’agone processuale apprezzerà e valorizzerà negli anni successivi.
Arriva alla cattedra quasi da autodidatta, vista l’assenza di maestri processualpenalisti. Nel 1958 lo chiama l’Università di Trieste, che lascerà nel 1960, per trasferirsi a Milano, chiamato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel 1963 gli sarà affidato anche l’insegnamento di Filosofia del diritto: ciò che lo porterà a scontrarsi con l’ortodossia cattolica. E qui conviene che il racconto segua distintamente ciascuna delle due esperienze didattiche vissute dal nostro Autore, se non altro, per una questione di ordine espositivo e per evitare sovrapposizioni che rischierebbero di confondere il lettore.
Cominciamo con lo studioso del processo penale. All’inizio degli anni Sessanta, Cordero ha occasione di cimentarsi con le questioni più controverse che animavano la dottrina processualpenalistica impegnata nel progettare una riforma del processo adeguata alla realtà politico-costituzionale dell’epoca. Francesco Carnelutti lo chiama a far parte della commissione ministeriale da lui presieduta e istituita proprio col compito di ripensare ab imis la riforma del processo penale: non più una revisione del c.p.p. 1930, ma la riscrittura di un nuovo codice, con l’abbandono del modello cosiddetto misto, di derivazione napoleonica adottato in Italia sin dal 1865. L’incontro con il vecchio professore (ultraottantenne), avvocato celebratissimo, dev’essere stato galvanizzante per il giovane docente appena approdato alla Cattolica, poco più che trentenne e all’epoca pressoché sconosciuto. Lo si capisce dalla convinzione con la quale egli difenderà il “progetto Carnelutti” in due dibattiti rimasti celebri e tuttora molto citati nella letteratura processualpenalistica: alludo ai convegni svoltisi nel 1964, uno nel Sud Italia (Lecce) e l’altro al Nord (Bellagio). In quelle due occasioni, in perfetta sintonia con la radicalità della proposta carneluttiana, Cordero diede davvero il meglio di sé, sostenendo con ottimi argomenti la necessità di superare il processo di impronta inquisitoria allora vigente in Italia, con un modello adversary fondato sull’inchiesta di parte vagheggiata nel progetto Carnelutti (gli interventi sono pubblicati nel volume Criteri direttivi per una riforma del processo penale, Milano, Giuffrè, 1965, poi confluiti nel volume Ideologie del processo penale, Milano, Giuffrè, 1966, 151 ss.).
Cordero immagina e analizza minuziosamente tutti i problemi che l’attuazione di quel rivoluzionario progetto avrebbe comportato. Constatiamo oggi, a molti anni dalla riforma processuale del 1988, quanto fossero azzeccate quelle previsioni. Vi troviamo lucidamente espressi, ad esempio, il timore che il pubblico ministero incaricato dell’inchiesta di parte assuma funzioni istruttorie simili a quelle del giudice istruttore; il timore che l’uso di dichiarazioni verbalizzate dalla polizia o dal pubblico ministero possano trasformarsi in prove, se utilizzate a fini di contestazione nell’esame testimoniale; la proposta di introdurre l’incidente probatorio (una “oasi giurisdizionale”) per superare il problema delle prove che rischiano di andar disperse nel corso della fase investigativa; e ancora, la proposta di contrastare le possibili inerzie del pubblico ministero, attribuendo alla persona offesa la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione (a imitazione di analogo istituto presente nella Strafprozessordnung germanica). Chi ha una conoscenza anche approssimativa delle vicende che nel corso dei decenni hanno accompagnato l’applicazione del codice vigente è in grado di apprezzare la fondatezza di quei timori e la sensatezza di quelle proposte espresse con un quarto di secolo d’anticipo sulla riforma processuale.
Grande impatto sulla dottrina processuale penale italiana hanno avuto le riflessioni di Franco Cordero in tema di diritto probatorio. Alludo in particolare ad alcuni scritti comparsi su varie riviste fra il 1961 e il 1963 e raccolti nel volume dal titolo Tre studi sulle prove penali (Milano, Giuffrè, 1963) oltre che nel già citato Ideologie del processo penale (Milano, Giuffré, 1966). Nel primo dei due volumi, la prova è analizzata come atto complesso (procedimento) scomposto nei tre tempi della ammissione/acquisizione, formazione e valutazione. Ispirandosi al noto saggio di Carnelutti sulla Prova civile (Roma, Athenaeum, 1915, rieditato nel 1947, nonché in Diritto e processo, Napoli, Morano, 1958, p. 125 ss.), Cordero offre in quel corposo saggio una breve trattazione generale della prova penale.
Si avverte anche qui l’influsso di Goldschmidt. Cordero accetta la tesi del processualista tedesco che postula l’autonomia del diritto processuale rispetto al diritto sostanziale. I fenomeni del processo animano un mondo chiuso, con regole proprie (ammissibilità, fondatezza, rilevanza, validità etc.) insensibili alle vicende del diritto sostanziale e ai rispettivi criteri di valutazione (lecito/illecito). Ne segue che il diritto processuale esige un approccio suo proprio da parte dello studioso. Sulla base di simili premesse è impostato il controverso problema della prova illecitamente acquisita. L’illiceità della provenienza non comporta di per sé l’inammissibilità o inutilizzabilità del corpo del reato o della cosa pertinente al reato: solo la legge processuale può abbinare una sanzione di invalidità a quella provenienza illecita. Se la legge processuale tace, la prova può essere utilizzata, benché frutto di un illecito. Come noto, il problema è stato a lungo dibattuto con riferimento al rapporto fra perquisizione e sequestro. L’illegittimità della perquisizione non comporta l’esclusione della cosa sequestrata dal novero delle prove valide, salvo che la legge vieti esplicitamente il sequestro, come accade, ad esempio, con i documenti coperti da segreto (art. 200 c.p.p.); quelli depositati nello studio del difensore (art. 103, comma 6, c.p.p.) o con le attività di “dossieraggio” (art. 240, comma 2, c.p.p.). Al riguardo, risulta decisiva la latitudine che la legge processuale assegna al potere istruttorio del magistrato impegnato nell’indagine, non i più limitati poteri assegnati alla polizia. La perquisizione si qualifica come semplice antecedente storico (non giuridico) del sequestro; la sua illegittimità comporterà la mancata convalida giudiziale dell’operazione effettuata dalla polizia, oltre alla possibile sanzione (penale o disciplinare di chi ha agito illecitamente), ma non la restituzione della cosa sequestrata che il giudice potrà quindi utilizzare. Male captum, bene retentum è la formula che sintetizza un orientamento seguito (ancor oggi) dalla giurisprudenza della Corte di cassazione italiana.
La maturazione del pensiero processualistico di Cordero trova la sua compiuta realizzazione nel manuale di Procedura penale pubblicato per la prima volta nel 1966. Un’opera che – si può dire – apre una nuova stagione nella cultura processuale penale italiana. Cordero stesso definirà quel manuale un’opera “atipica”: «la novità sta nell’esservi disegnata una sintassi» (così in Rutulia, Roma, Quodlibet, p. 237).
Va detto che i manuali in circolazione all’epoca erano redatti con stile piatto e acritico: orientati al metodo tecnico-giuridico, avevano un’impostazione prevalentemente esegetica, con una sistematica incentrata su principi dottrinali elaborati secondo categorie pandettistiche di fine Ottocento. Pensati per un apprendimento nozionistico; non inducevano riflessioni sui nodi politici e sui conflitti ideologici implicati nelle pratiche giudiziarie e nei relativi istituti.
Ben diverso appariva il manuale di Cordero. Lo si capiva già dalla copertina. Anche la quarta edizione (1977 quella sulla quale ho preparato l’esame di Procedura penale nel lontano 1978) raffigurava in sovracopertina il frontespizio della Practica causarum criminalium (Averolda nuncupata) di Ippolito Marsili. In quella stampa cinquecentesca si scorgono, in centro, strumenti e scene di tortura; in basso, scene di vita accademica con il professore in cattedra e gli studenti in diligente ascolto. In alto, sui lati, simboli del potere politico, sfilate di alti prelati, scene di guerre navali e campali.
In effetti, una volta aperto, quel manuale apriva un mondo che nessuno – fra i processualisti italiani del tempo – aveva mai prima esplorato con tale sapienza e acume. Gli istituti processuali erano analizzati in prospettiva storica; studiati con l’occhio critico del filosofo del linguaggio; rimeditati in chiave politica; criticati per il substrato ideologico che nella pratica li reggeva. Siamo distanti anche dalla visione formalistica che caratterizzava la monografia giovanile sulle Situazioni soggettive.
All’inizio, quell’opera “atipica” desta reazioni poco favorevoli nei paludati ambienti accademici: «l’establishment l’accoglie a denti stretti – confessa Cordero – ma pratici colti l’adoperano». Proprio così. I magistrati e gli avvocati più sensibili agli sfondi culturali della giustizia penale notano ben presto la straordinaria qualità di quelle pagine. Alcuni docenti lo adottano come libro di testo nei loro corsi. Migliaia di studenti sono attratti dalla prosa colta, dai riferimenti storici e filosofici, dall’uso impeccabile dell’arnese interpretativo. In pochi anni, diventerà una lettura obbligata per tutti coloro che intendono occuparsi di procedura penale.
Il vero valore dell’opera sta nel taglio critico che caratterizza ogni sua pagina. L’autore non si limita a descrivere gli istituti e le pratiche della procedura. Ne esamina l’origine, la ragion d’essere, la pratica applicazione alla luce di quelle che lui stesso definisce «leggi naturali del processo» (Procedura penale, Milano, Giuffrè, 1966, p. 21). Niente a che vedere con premesse giusnaturaliste. Ogni strumento – sostiene l’Autore – ha sue proprie leggi. Nel caso del processo giudiziario, occorre individuare quelle adatte a produrre decisioni giuste, senza ledere, oltre il necessario, la dignità delle persone che vi sono coinvolte. I postulati sono pochi e semplici: giudice indipendente e imparziale; struttura triadica dell’agone giudiziario. Da questi, discendono, a mo’ di corollario, le regole adatte a regolare lo svolgimento procedurale. I “principi naturali” appartengono all’essenza logica del processo (giusto) e sono anteposti agli stessi principi costituzionali.
Si avverte anche qui l’eco di James Goldschmidt e della opzione politico-culturale ben evidenziata nella prefazione al suo Prozess als Rechtslage: il diritto processuale può prosperare solo sul terreno del liberalismo democratico, dove l’agone sia regolato garantendo in concreto la possibilità che ciascuna delle parti in contesa esca vincente. Trattandosi di un dispositivo atto a produrre norme (singolari e concrete) sulla scorta delle norme (generali ed astratte) confezionate dal legislatore, il processo va strutturato in modo da assicurare il contraddittorio fra le parti, affinché queste possano accettarne l’esito. I contesti politici (autoritari o dispotici) che negano il contraddittorio non favoriscono un autentico diritto processuale, ma semmai una Kabinettsjustiz, vale a dire una giustizia penale dispoticamente influenzata dal potente di turno: una penalità “amministrativizzata” che non meriterebbe l’appellativo di ‘giurisdizionale’, anche se ad amministrarla vi fosse chi pretende di essere chiamato ‘giudice’. Di qui le battaglie che – specialmente nella prima metà degli anni Sessanta – Cordero si impegna a combattere contro le incrostazioni autoritarie e inquisitorie del processo penale italiano, contro l’ambigua figura del giudice istruttore (giudice-accusatore) e contro l’ancora più compromettente figura dell’accusatore giudice (pubblico ministero-istruttore).
Il manuale è impregnato dalla prima all’ultima pagina di questo spirito militante. Esso avrà una diffusione ampia e prolungata nel tempo. L’edizione del 1966 sarà seguita da altre 8 edizioni nei venti anni successivi. Dopo la riforma processuale del 1988 l’autore riscriverà il suo manuale, del quale usciranno ben 9 edizioni nei venticinque anni successivi. In totale, 18 edizioni sulle quali si sono formate almeno quattro generazioni di studiosi del processo penale. Bastano questi numeri a dare un’idea dell’influsso davvero notevole che Franco Cordero ha avuto sulla dottrina processualpenalistica italiana nella seconda metà del secolo scorso.
Dal punto di vista, per così dire, dogmatico, credo che il culmine del pensiero processualistico di Cordero sia tutto racchiuso nella prima edizione del suo manuale. Le edizioni successive, così come i rari interventi su temi processualistici pubblicati in seguito, tengono conto delle evoluzioni normative e giurisprudenziali, sviluppando tuttavia idee, intuizioni, posizioni, già maturate nel proficuo decennio inaugurato dalla monografia sulle Situazioni soggettive (1956).
3. Cordero filosofo del diritto: l’incidente della Cattolica
Come già detto, nel 1962 Cordero ottiene dalle autorità religiose dell’Università Cattolica il nulla osta per insegnare anche la Filosofia del diritto. Insegnamento importante e delicato per una Università confessionale, a lungo affidato negli anni precedenti a un prelato di sicura ortodossia, mons. Francesco Olgiati (cofondatore, con Agostino Gemelli, della stessa Università). La discontinuità è evidente. Cordero si professa cattolico, ma intende indagare il mondo teologale con il bisturi della ragione, insofferente ai dogmi religiosi calati dall’alto e sottratti alla discussione. Ai padri della Chiesa e alle encicliche papali associa letture di Freud, Nietzsche, Carnap, spesso anzi preferendoli per le provocatorie sollecitazioni che ne scaturiscono. Gli attriti con le gerarchie dell’ateneo milanese sono nell’aria, benché si versi in un periodo di accese discussioni interne al mondo cattolico, incoraggiate dalle aperture dialoganti del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962 – 8 dicembre 1965) e da coevi movimenti di dissenso all’interno della stessa Chiesa cattolica: si pensi all’esperienza delle comunità cristiane di base sorte a Roma (Dom Franzoni) e all’isolotto di Firenze (don Mazzi).
Il casus belli è rappresentato dalla pubblicazione del libro Gli Osservanti. Fenomenologia delle norme (Giuffrè, 1967), un manuale lungo quasi 700 pagine, nel quale l’autore analizza la genesi delle norme amputando le premesse religiose o giusnaturalistiche care all’ortodossia cattolica. Basta leggere le prime tre righe per capirne il taglio: «Questo libro studia i fenomeni normativi ossia l’uomo come tessitore di norme, che impone a sé, agli altri, a Dio: le produce e le consuma, legislatore e animale osservante».
Due anni dopo pubblica un altro libro “eretico”: Il sistema negato. Lutero contro Erasmo (Bari, De Donato, 1969), dove mostra di preferire il “negatore” Lutero all’ “integrato” Erasmo: negatore del “sistema” il primo; integrato (per astuta convenienza) il secondo. Nello stesso anno esce il romanzo autobiografico Genus, nel quale egli ricostruisce con toni cupi l’ambiente accademico nel quale opera, spingendosi a prevedere la sventura che stava per subire.
Questa produzione accademico-letteraria non sfugge all’occhio dell’autorità ecclesiastica.
L’assistente spirituale dell’Università Cattolica (Mons. Carlo Colombo, “teologo del Papa” come Cordero lo definirà), scrive una lettera per indurre “l’eretico sulla retta via”, anticipandogli la possibile revoca dell’incarico. Il destinatario della lettera non piega il capo. L’urto è inevitabile. Il 1° dicembre 1969 (dopo varie tergiversazioni) il consiglio di Facoltà toglie a Cordero l’incarico di Filosofia del diritto, lasciandoli, per il momento, l’insegnamento di Procedura penale.
La reazione non si fa attendere. A inizio gennaio 1970 Cordero pubblica il violento pamphlet Risposta a Monsignore (De Donato, 1970) col quale risponde punto per punto alla lettera di Colombo. Il libriccino avrà ampia divulgazione: quattro edizioni nello stesso anno, con l’aggiunta di una traduzione in lingua inglese. Questo successo finirà col peggiorare la sua situazione interna alla Cattolica e contribuirà a far deflagrare il caso sul piano nazionale. Si muove la curia romana. Il prefetto della Sacra Congregatio pro institutione catholica (card. Gabriele Garrone) scrive a Cordero minacciando la revoca del nulla osta all’insegnamento in Cattolica, se entro il 31 ottobre (1970) non scenderà a Roma per recedere dal suo marcato laicismo. Anche qui la risposta non si fa attendere e sarà la risposta di un intellettuale fermo nell’affermare la propria indipendenza di pensiero, senza compromessi con postulati confessionali (la lettera fu pubblicata integralmente dal settimanale l’Espresso del 1° novembre 1970 col titolo Nostra madre ghigliottina). Andò a finire che il consiglio di Facoltà revocò il nulla osta all’insegnamento della Procedura penale e di qualsiasi altra disciplina nell’Università cattolica. Le parole contenute in una lettera inviatagli dal rettore Lazzati (13 novembre 1970) non lasciavano dubbi: «non potrà più svolgere, nell’Università del Sacro Cuore, nessuna attività inerente allo stato giuridico di professore». Situazione paradossale: uno dei più qualificati studiosi del processo penale era privato della venia legendi in una disciplina che – si può dire – aveva contribuito in misura decisiva a modernizzare. Cordero aveva chiusa la citata lettera al card. Garrone con queste parole: «Reagirò se qualcuno tenterà di togliermi la cattedra: in Italia c’è una legge e ci sono dei giudici; nessuna migliore occasione per vedere se il paese nel quale viviamo è un principato ecclesiastico o una repubblica democratica».
In quello stesso periodo, Emanuele Severino aveva subito analoga sorte. Docente di Filosofia morale nella stessa Università, gli era stato revocato il nulla osta all’insegnamento per l’asserita inconciliabilità di sue teorizzazioni con l’ortodossia cattolica. Pur con rammarico, egli accettò l’esclusione e si trasferì all’Università veneziana Ca’ Foscari, proseguendo lì il suo insegnamento. Poteva essere un precedente da imitare.
Cordero, invece, mantiene la promessa fatta per iscritto al card. Garrone e sceglie la via del conflitto, convinto di avere buone ragioni da far valere davanti ai giudici.
4. Segue: Il caso Cordero davanti alla Corte costituzionale e nelle reazioni dei commentatori
La revoca del nulla osta fu impugnato davanti al Consiglio di Stato (ancora non esistevano i TAR) che rinvia gli atti alla Corte costituzionale, ravvisando un possibile contrasto fra la norma concordataria sulla revoca del nulla osta (art. 38 dei Patti lateranensi) con gli artt. 7 e 33 Cost. (ordinanza del 26 novembre 1971). La Corte costituzionale si pronuncerà più di un anno dopo (sent. del 14 dicembre 1972, n. 195) dando sostanzialmente ragione all’autorità ecclesiastica. Si afferma l’idea che una “Università ideologicamente qualificata” vada lasciata libera di limitare la libertà di insegnamento, senza però violarla, anche perché «libero è il docente di aderire, con il consenso alla chiamata, alle particolari finalità della scuola; libero è egli di recedere, a sua scelta, dal rapporto con essa quando tali finalità più non condivida».
La sentenza lascia l’amaro in bocca ai pensatori laici, e solleva accese discussioni a destra e a sinistra. Molti accademici prendono posizione pro o contro. La rilevanza anche attuale del tema (se si considera l’analogo incidente occorso al filosofo del diritto Luigi Lombardi Vallauri in epoca relativamente recente) consiglia di dar brevemente conto almeno di alcuni commenti suscitati dal “caso Cordero”.
Particolare risalto ebbe la polemica che oppose Vezio Crisafulli a Paolo Barile, entrambi direttamente coinvolti nella vicenda: il primo come membro della Corte che emanò la sentenza, il secondo come difensore di Cordero (assieme a Giuseppe Guarino) davanti alla stessa Corte. A pochi giorni dal deposito della motivazione, Crisafulli inviò una lettera al Corriere della sera (18 gennaio 1973), non per difendere la sentenza, ma per spiegarne il senso ed evitare fraintendimenti su una questione di massima importanza per le istituzioni culturali. Egli negava che la Corte avesse fatto prevalere la norma concordataria sulla normativa costituzionale; si è invece tratto dall’art. 33 cost. la libertà della scuola prevale sulla libertà (del singolo docente) nella scuola. E questo accadrebbe – soggiungeva Crisafulli – anche se la libera università fosse ideologicamente orientata in senso marxista o islamico: in altre parole, per far sopravvivere i postulati ideologici sui quali si fonda, l’istituzione universitaria orientata in senso confessionale o ideologico può limitare la libertà del singolo docente. Barile replicava che l’Università non può essere messa sullo stesso piano di una scuola (inferiore o superiore). Il comma 6° dell’art. 33 assegna uno status speciale all’istituzione accademica, riconoscendole ampia autonomia ordinamentale. Tutti le Università, anche quelle libere, in quanto sovvenzionate con danaro pubblico, sono soggette alle leggi dello Stato e non possono revocare l’autorizzazione ad insegnare, sovrapponendo una propria valutazione ideologica al giudizio della commissione statale di concorso che abbia assegnato il titolo di professore in una determinata disciplina.
Vero che Cordero poteva essere chiamato da altro ateneo, ma questo comportava una lesione del diritto alla inamovibilità, a sua volta garantito da una legge dello Stato. Oltretutto, scriveva Paolo Barile nella citata lettera a Crisafulli, «non sono molte le Università che oggi chiamerebbero Cordero: quasi ovunque ci sono rigide maggioranze di cattolici». Va detto, a questo proposito, che durante la contesa giudiziaria con la Cattolica, Franco Cordero manteneva lo status giuridico di professore ordinario principalmente sotto il profilo economico), ma senza poter tenere lezione. Il suo trasferimento ad altra sede si imponeva, dopo che la Corte costituzionale aveva praticamente chiuso la vicenda in favore della Cattolica; ma restava problematico, perché era necessario trovare un ateneo disposto a chiamarlo. Di questo problema si fece carico Arturo Carlo Jemolo, che in una nota alla decisione della Corte costituzionale qui considerata (Perplessità su una sentenza, in Foro. it., 1973, I, c. 12) auspicava il varo di una legge ad hoc con la quale si stabilisse che «ove la Santa sede revochi il suo nulla osta, il ministro dell’istruzione trasferisca il professore ad Università statale, anche in soprannumero, tenendo il possibile conto dei suoi desideri». Il principio di inamovibilità sarebbe stato comunque sacrificato, ma la carriera del docente in altra sede sarebbe stata assicurata, anche tenendo conto delle sue preferenze nella scelta della sede.
Non ci fu comunque bisogno di una legge per far approdare il prof. Cordero all’ateneo torinese nel 1974: una chiamata nient’affatto scontata, che ebbe qualche avversario. Due anni dopo (1976) sarebbe stato chiamato dall’Università di Roma-La Sapienza, dove rimase fino al congedo.
5. Narratore e storico
Quattro anni di forzata assenza dalle aule di lezione hanno lasciato un segno nella vita di questo eccellente studioso. Quando gli fu negato l’insegnamento di Procedura penale aveva 42 anni. Ne aveva compiuti già 46 quando riprese la vita di docente a Torino. Se guardiamo alla produzione scientifica e letteraria di quel quadriennio, notiamo la pressoché totale assenza di contributi riguardanti la Procedura penale e un intensificarsi dell’interesse per la narrativa, la filosofia, la storia, il giornalismo.
Pubblica in rapida sequenza quattro romanzi a sfondo marcatamente autobiografico: Le masche, Rizzoli, Milano, 1971; Opus, Einaudi, Torino, 1972; Pavana, Einaudi, Torino, 1973; Viene il re, Bompiani, Milano, 1974; tutti di grande interesse per chi desidera sondare il suo stato d’animo in quel periodo buio.
Nel 1972 ritorna alla sua passione per la riflessione teologico-filosofica, pubblicando il voluminoso saggio L'Epistola ai Romani. Antropologia del cristianesimo paolino, Collana Saggi, Torino, Einaudi, 1972.
Dal 1970 al 1972 è molto attivo sulle pagine del settimanale l’Espresso, dove interviene dissertando di varia umanità, per prendere posizione su controversi casi giudiziari dell’epoca (es. caso Valpreda, caso Vajont), per affrontare temi d’attualità (amnistia, divorzio, tossicodipendenza), senza trascurare i suoi personali conflitti con le gerarchie cattoliche. Fra i vari scritti di codesto periodo merita segnalare quello apparso sull’Espresso del 20 febbraio 1972 dove ripercorre la drammatica degradazione accademica di Ernesto Bonaiuti, nella quale – si capisce – egli trova motivi di inquietante rispecchiamento: sembra davvero che parli di sé stesso, in un momento in cui la vicenda con la Cattolica è ancora in corso, aperta a esiti che Cordero presagisce già come negativi.
Come detto, il suo interesse per la Procedura penale cala. A parte il manuale, periodicamente aggiornato e sempre molto letto da un gruppo crescente di seguaci, si registrano rari saggi su riviste o interventi a convegni accademici, come quello svolto nel 1975 a Trieste (sua prima sede universitaria) in tema Connessione e giudice naturale, nell’ambito del convegno su Connessione e conflitti di competenza Milano, Giuffrè 1975, p. 41 ss.); o la relazione dal titolo Stilus curiae. (analisi della sentenza penale) svolta nel convegno ferrarese su La sentenza in Europa: metodo, tecnica e stile (10-12 ottobre 1985) pubblicata con gli atti del convegno Padova, CEDAM, 1988, nonché in Riv. it. dir. e proc. pen. 1986, p. 19 ss.).
Nell’ottobre del 1985 figura fra i fondatori della neo-costituita Associazione tra gli studiosi del processo penale, ma non vi dedicherà tante energie.
Chiamato a far parte della Commissione Pisapia (istituita dal Ministro della Giustizia con D.M. 18 settembre 1974) per la redazione di un nuovo codice di procedura penale, non vi spende energie; il suo ruolo resta marginale, benché dieci anni prima (nei già citati convegni di Lecce e Bellagio) proprio lui si fosse battuto con passione per una radicale riforma del processo.
Negli anni successivi, la sua attenzione è attratta dalla filosofia del diritto (vedi la voce Diritto, in Enciclopedia Einaudi, 1978, vol. IV, p. 895-1003) oltre che dalla storia del diritto (Riti e sapienza del diritto, Roma-Bari, Laterza, 1981; La fabbrica della peste, Laterza, Laterza, Roma-Bari 1983; Criminalia. Nascita dei sistemi penali, Laterza, Roma-Bari, 1986 e dai quattro volumi dedicati alla biografia del grande eretico Savonarola, Laterza, Roma-Bari,1986-1988).
Né si è sopita la vena narrativa: nel 1975 pubblica L’Opera (Milano, Bompiani), dove affiorano altri scorci autobiografici del giovane liceale in una piccola città, satura di simboli e riti religiosi, sul finir della seconda guerra mondiale. Nel 1976 esce Passi d’arme (Milano, Giuffrè), romanzo di ambientazione militare (paragonato al buzzatiano Deserto dei Tartari), che fornisce occasione per dialoghi e riflessioni interiori imperniati sulla figura di un giovane studente in legge.
Sei romanzi in sei anni, nei quali l’autore riversa sentimenti di inquietudine connessi con la sua ancora recente vicenda accademica, ma anche esplosioni di vitalità e curiosità viste da un uomo maturo che rimedita il passato adolescenziale.
I romanzi di questi anni sono ricchi di tracce per ricostruire la personalità ricca e provocatoria di un intellettuale nemico delle convenzioni sociali, degli stereotipi, dei servilismi interessati e delle arroganze dei potenti.
Successivamente, darà alle stampe altre quattro opere narrative: Cronaca d'una stregoneria moderna (Laterza, Roma-Bari, 1985), dove narra, in prima persona e con ambientazione di fantasia, un caso indiziario, relativo a un problematico suicidio dietro il quale potrebbe celarsi un omicidio o una condotta istigatoria. Segue L'armatura. Un'inconsueta traversata del mondo raccontata con strabiliante maestria (Garzanti, Milano, 2007), di ambientazione settecentesca, con personaggi e località fantasiose, nel quale esibisce la sua vastissima erudizione (non solo umanistica). Poi il Toson d’oro (Leima, Palermo, 2014), dove si raccontano avventure argonautiche e dove compare un personaggio di nome Iulius (che in Genus era l’alter ego dello stesso Cordero). E ancora, Bellum civile (Quodlibet, Macerata, 2017), una riscrittura di Passi d’arme, pubblicato circa quarant’anni prima. Infine, La tredicesima cattedra (La nave di Teseo, Milano, 2020), pubblicato postumo, subito dopo la sua scomparsa, anch’esso con evidenti richiami autobiografici, in parte già narrati nel suo primo romanzo.
6. Polemista negli anni 2000
Dopo il congedo dall’insegnamento (1998), Cordero torna sorprendentemente in campo come polemista con un articolo pubblicato sul giornale La Repubblica (19 dicembre 2001) dal titolo Lezione impolitica sulla nostra giustizia.
L’occasione è data da quel colpo di mano legislativo che introdusse nel codice di rito un discutibile divieto probatorio nella disciplina delle rogatorie internazionali (Legge 5 ottobre 2001, n. 367). Su quel divieto gravava il sospetto di essere stato voluto per favorire – in extremis – un amico dell’allora presidente del Consiglio imputato di corruzione giudiziaria. Cordero vi intravvede un segno di arroganza del potere e non esita a schierarsi al fianco dei magistrati milanesi, inflessibili nell’acquisire comunque le prove che la novella legislativa intendeva vietare.
Sarà questo il primo di una numerosa serie di scritti giornalistici e interventi in pubblico disseminati in un quindicennio e raccolti in diversi volumi (Le strane regole del signor B., Milano, Garzanti, 2003; Nere lune d’Italia: segnali da un anno difficile, Milano, Garzanti, 2004; Fiabe d’entropia: l’uomo, Dio, il diavolo, Milano, Garzanti, 2005; Aspettando la cometa: notizie e ipotesi sul climaterio d’Italia, Torino, Bollati Boringhieri, 2008; Il brodo delle undici: l’Italia nel nodo scorsoio, Torino, Bollati Boringhieri, 2010; L’opera italiana da due soldi: regnava Berlusconi, Torino, Bollati Boringhieri, 2012).
Con questo genere letterario Cordero si era già cimentato – come detto in precedenza – all’inizio degli anni Settanta, all’epoca della collaborazione con l’Espresso, quando infuriava la polemica con l’autorità accademico-ecclesiastica. Ora se la prende con la classe politica, ammorbata dal vizio di ostacolare con iniziative pseudo-garantiste il lavoro della magistratura penale, particolarmente attiva sul fronte della corruzione politica. I suoi interventi sono animati da un forte sentimento di intransigenza morale. Con linguaggio schietto e con arditi paralleli storici denuncia l’uso disinvolto e arrogante dell’uomo di potere, incline all’uso aggressivo e pretestuoso di argomenti “liberali” per assicurarsi l’impunità.
A prima vista si ha l’impressione che il Cordero pamphlettista, difensore delle inchieste giudiziarie, implacabile censore dei vizi pubblici e delle intemperanze di una classe politica corrotta, sia in contraddizione con lo studioso che, negli anni Sessanta del secolo scorso, denunciava, sibilando parole altrettanto schiette, le tare inquisitorie della giustizia penale italiana. In realtà, c’è una grande coerenza nella sua lunga avventura intellettuale. Al centro delle sue battaglie c’è sempre stata una manifesta insofferenza per l’uso impunito e dispotico del potere: non importa che si tratti di potere giudiziario, fondato su pratiche inquisitorie; di potere religioso, fondato sulla difesa ad oltranza di indiscutibili ortodossie; di potere politico, fondato su un malinteso senso dell’investitura popolare; di potere economico, che accentua le diseguaglianze sociali, assoggettando ai propri interessi anche l’amministrazione della cosa pubblica.
Ogni potere, non solo quello giudiziario, rischia derive personalistiche e tiranniche, nella misura in cui chi lo esercita si lascia sopraffare da impulsi primordiali. Insegna Sigmund Freud – più volte evocato a questo riguardo da Cordero (ad esempio, in Morbo italico, cit., 67 e 169) – che nel territorio dell’ES, «bestia extra tempora indifferente al trascorrere del tempo», regno di pulsioni individuali dominate dal principio del piacere, sono all’opera istinti primitivi insensibili a principi razionali o a freni morali. Uomini fra gli uomini, anche i potenti di ogni risma (non solo i magistrati) mal sopportano il “disagio della civiltà”. Franco Cordero “umanista eterodosso”, “giurista militante” si è assunto il faticoso compito di censurare ogni uso smodato del potere, accettando di pagare alti prezzi personali per difendere la sua libertà di coscienza e di critica. E possiamo già immaginare cosa direbbe oggi, con le sconcertanti manifestazioni di arroganza muscolare che vediamo attive anche sul piano della politica internazionale.
7. Lascito intellettuale
Le molteplicità delle opere (giuridiche, filosofiche, teologiche, letterarie) nelle quali si è concretizzata la sua attività intellettuale rende difficoltoso un bilancio. Nessuno, nemmeno i suoi detrattori all’epoca del conflitto con l’Università del Sacro Cuore, mettevano in dubbio la sua straordinaria cultura e l’eccellente abilità espositiva. “Non discuto il metodo da Lei scelto e soprattutto ammiro la Sua cultura, veramente immensa” scriveva mons. Colombo, nella lettera alla quale Cordero replicò con il suo noto pamphlet (frammento riportato in Risposta a Monsignore, cit., p. 43). E qualche giorno dopo la sua scomparsa, il filosofo cattolico Francesco D’Agostino, nel ricordarne la figura scriveva: «sicuramente è stato un giurista fuori dal comune, che ha nobilitato la sua disciplina (il diritto processuale penale) oltre ogni aspettativa», ma poi concludeva che la sua non era intelligenza «né giuridica, né filosofica, ma polemica e, in quanto tale, sterile» (Franco Cordero, il più scomodo di tutti gli eclettici, L’Avvenire, 10 maggio 2020.
Non essendo un filosofo, né uno storico, né un critico letterario, mi astengo dal formulare un giudizio complessivo su un autore eccezionalmente poliedrico. In quanto processualpenalista, condivido con D’Agostino l’affermazione che Cordero ha impresso al diritto processuale penale italiano uno sviluppo “oltre ogni aspettativa”. Proprio così. Egli lascia agli studiosi del processo penale un’eredità importante, che non va dissipata. Certo, bisogna riconoscere che il suo saggio giovanile sulle Situazioni soggettive (risalente ormai settant’anni fa, lui appena ventottenne, ripubblicato da Giappichelli nel 2022, con una bella prefazione di Paolo Ferrua) appare oggi difficilmente accessibile perché scritto in un linguaggio ricco di astrazioni, frasi lunghe e complicate che sfidano le capacità di comprensione specie delle generazioni di studiosi ora in attività. Si tratta tuttavia di un’opera seminale, che contiene in embrione il nucleo vivo della dottrina processuale coltivata negli anni successivi: l’analisi delle figure soggettive (l’onere, il dovere, il potere, la discrezionalità) sono analizzate sia nella loro realtà statica, sia nel dinamismo dell’agone processuale (anche qui, Goldschmidt docet). Occorre essere consapevoli che – per la dottrina processualpenalistica – quel testo ha reso possibile l’emancipazione dalla tradizionale (e inadeguata) teorica del “rapporto giuridico processuale”. Impostazione di ascendenza processualcivilistica (chiovendiana), cara agli esponenti del tecnicismo giuridico, che impediva di analizzare il fenomeno processuale come campo di forze dove si scontrano interessi terribilmente concreti.
Quanto le riflessioni teoriche contenute in quel primo sforzo monografico siano risultate proficue per la scienza processualistica lo si comprende dagli studi successivi del nostro Autore.
Gli scritti sulle prove risalenti ai primi anni Sessanta sono quanto di meglio si possa ancor oggi trovare su un tema centralissimo per l’accertamento giudiziario. La distinzione fra prova storica e prova critica (ereditata da Carnelutti) è stata approfondita e ben adattata da Cordero alla realtà del processo penale in studi che tuttora forniscono una base teorica per analizzare il fenomeno probatorio, anche con riferimento all’affermarsi di quelle specie di prova critica rappresentate dalla “prova digitale” e dalla cosiddetta “prova scientifica”.
Gli interventi sulla riforma processuale penale svolti nei convegni di Lecce e Bellagio (1964) ai quali si è in precedenza accennato, offrono anche al giovane studioso odierno una quantità di spunti e osservazioni di straordinario acume per la sorprendente lungimiranza che li caratterizza.
La “lettura” delle invalidità processuali e, in particolare, delle invalidità probatorie resta attuale a più di sessant’anni dalla sua formulazione.
Il manuale (a partire dalla edizione del 1966) costituisce un modello tuttora insuperato di esposizione critica delle norme processuali penali, con un sapiente uso della comparazione storica messa al servizio della comprensione degli istituti volta a volta esaminati. Un’opera ormai appartenente al novero dei “classici”: destinata a durare nel tempo e a fornire illuminanti indicazioni (anche di metodo), benché le norme delle quali si parla non siano più in vigore.
L’impostazione rigorosamente sistematica per cui nell’interpretare le norme conta principalmente la coerenza complessiva con l’insieme dell’ordinamento, mentre vale poco o niente la volontà del legislatore (le norme non vanno lette come testamenti, amava ripetere), ha segnato un netto avanzamento rispetto all’atteggiamento piattamente esegetico (e quasi sempre ideologicamente orientato) dei seguaci del tecnicismo giuridico.
Dotato di fertile immaginazione, ha saputo vedere in anticipo le conseguenze a lungo termine di certe scelte legislative (come, ad esempio, quelle riguardanti la lettura a fini di contestazione nell’esame testimoniale), cogliendo connessioni problematiche inaccessibili a chi, per fretta o superficialità, non è abituato a rimuovere le croste verbali delle singole norme. Ha sempre guardato al fenomeno normativo come espressione della cultura e della ideologia di un data epoca, trasmettendo a molti giovani la passione per la storia delle idee e per la scoperta delle radici di istituti antichi utili a coglierne il senso nel tempo presente.
Un cenno merita lo stile espositivo. Chi legge i suoi saggi (ma il rilievo vale anche per i romanzi) noterà la singolare efficacia che si sprigiona da frasi secche ed essenziali. Sono frasi ad alto potenziale contenutistico. Non è stile barocco, come qualcuno può pensare. Al contrario. Cordero elimina il superfluo, assegnando a ogni parola un preciso “compito” concettuale nell’economia del discorso. Abile nell’uso dell’ellisse e del linguaggio allusivo, lascia spesso sottinteso quanto il lettore attento deve saper completare mentalmente per proprio conto. Discorsi saturi di pensiero, prosciugati da aggettivazioni sovrabbondanti. esigono un ruolo attivo, talvolta faticoso, ma sempre redditizio e istruttivo per chi legge. Copiare il suo stile è impossibile e comunque sconsigliato, tanto esso è compenetrato con la personalità e il patrimonio di conoscenze posseduto di chi lo ha messo a punto: chi si illudesse di imitarlo farebbe inevitabilmente figura meschina. Se ne possono però trarre utilissimi insegnamenti, considerata l’indiscutibile efficacia che lo contrassegna: prima di licenziare uno scritto, verificare l’esatta corrispondenza fra pensieri e parole, a condizione che vi sia un pensiero da trasmetter; astenersi da frasi fatte, assunti stereotipati o espressioni trombonesche; arrendersi di fronte all’indicibile senza tentare spericolati irrazionalismi e senza lasciarsi andare a petizioni di principio; sciogliere concetti complessi nei loro elementi essenziali; puntare alla ricchezza concettuale del periodo con massima economia di parole; eliminare ogni sovrabbondanza che affaticherebbe inutilmente la mente del povero lettore.
Infine, un cenno al coraggio intellettuale. La vicenda sofferta nella prima metà degli anni Settanta dimostra quanto gli fosse cara la libertà di pensiero e di coscienza. Qualcuno può aver pensato che quella sua tenace lotta per riavere la cattedra negata fosse motivata da ragioni egoistiche. In realtà Cordero sapeva che avrebbe pagato a caro prezzo talune scelte “eretiche”. Ha cercato di combattere con l’arma della ragione i veti dell’ambiente accademico nel quale era inserito e ha denunciato i soprusi che vedeva affiorare nella realtà politico-sociale, come i veri intellettuali del dissenso, critici con i potenti di ogni risma, intolleranti delle ingiustizie, refrattari al compromesso anche a costo di essere degradati o marginalizzati. Figure – bisogna ammetterlo – divenute rare nel tempo presente.
* Con una iniziativa davvero encomiabile, la biblioteca civica di Cuneo ha catalogato e messo a disposizione del pubblico la bibliografia pressoché completa di Franco Cordero. Ha inoltre digitalizzato gli articoli non giuridici da lui scritti, e gli articoli scritti su di lui, comparsi sulle maggiori testate nel corso degli anni, ora liberamente consultabili al seguente link https://www.comune.cuneo.it/cultura/biblioteca/cataloghi/fondo-franco-cordero.html. Questa ricca fonte informativa si è rivelata particolarmente utile per ricostruire la tormentata “lite” fra Cordero e l’Università del Sacro Cuore (par. 3 e 4).