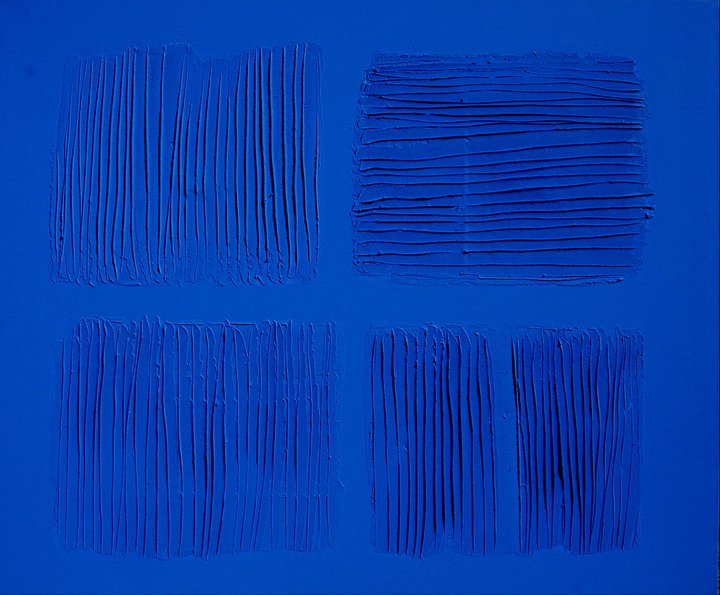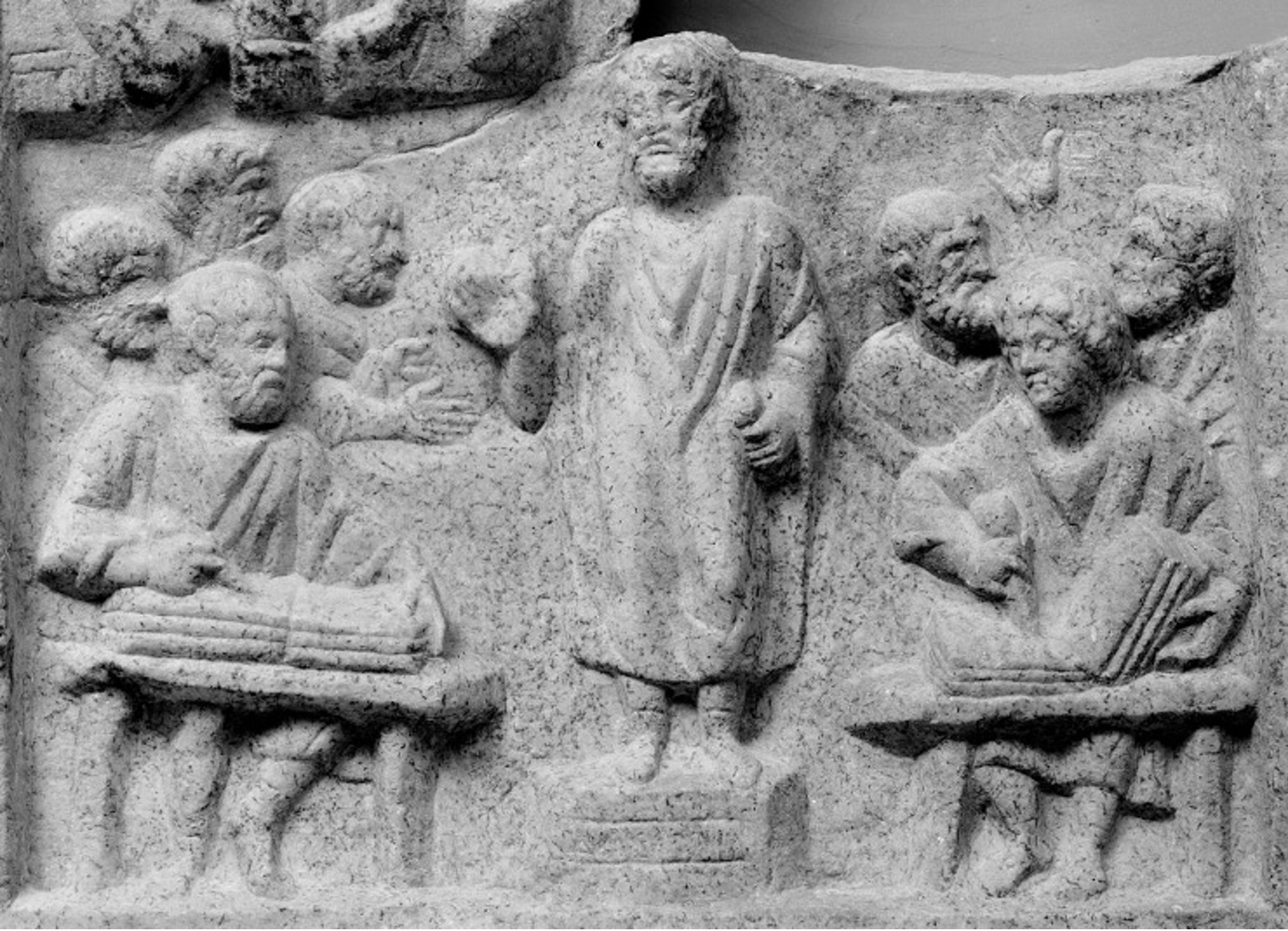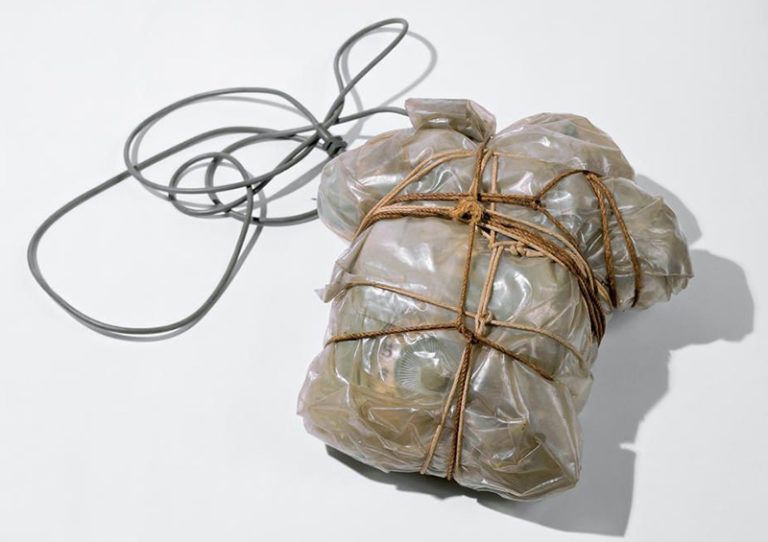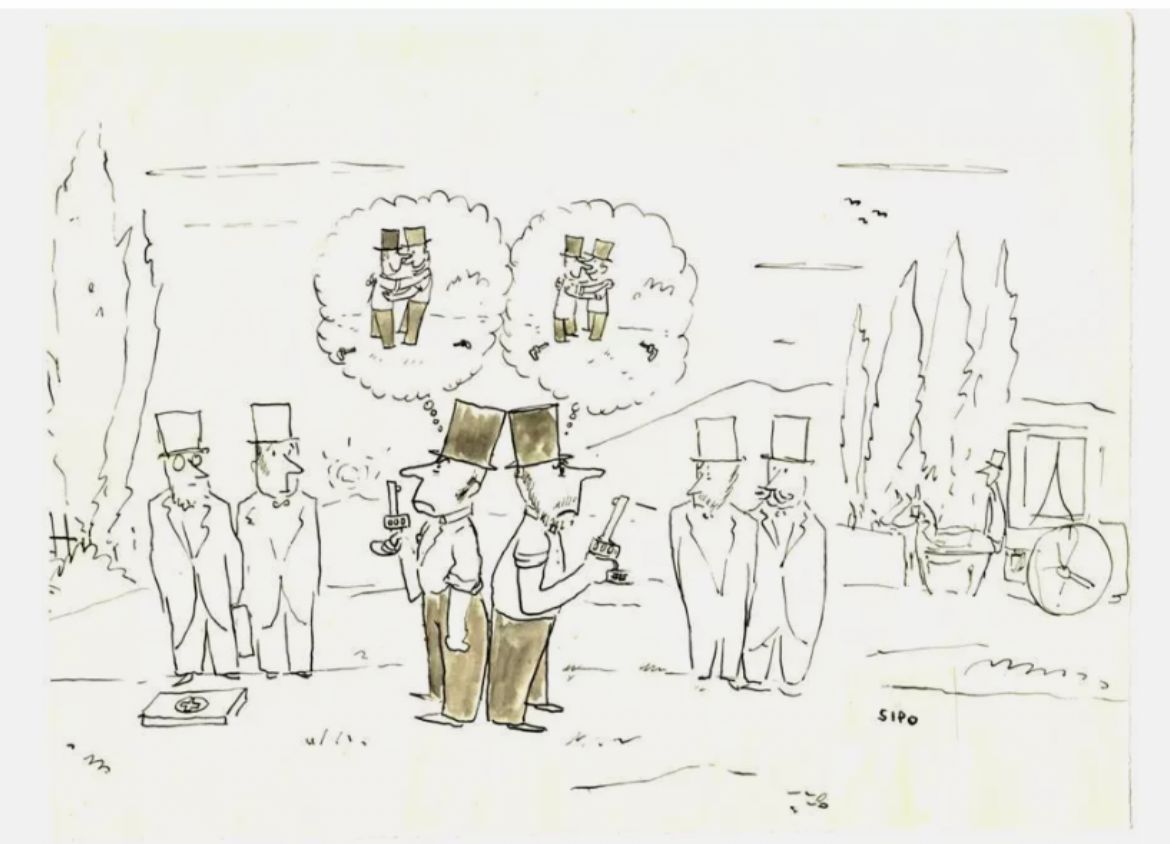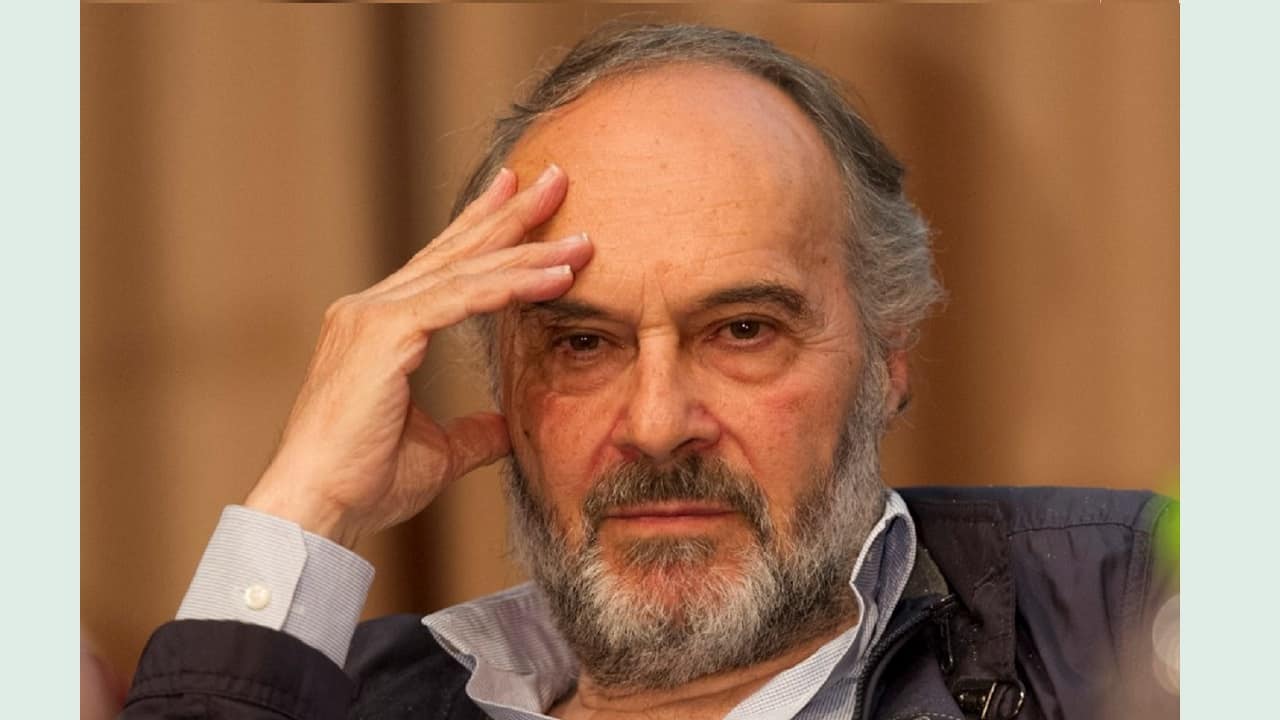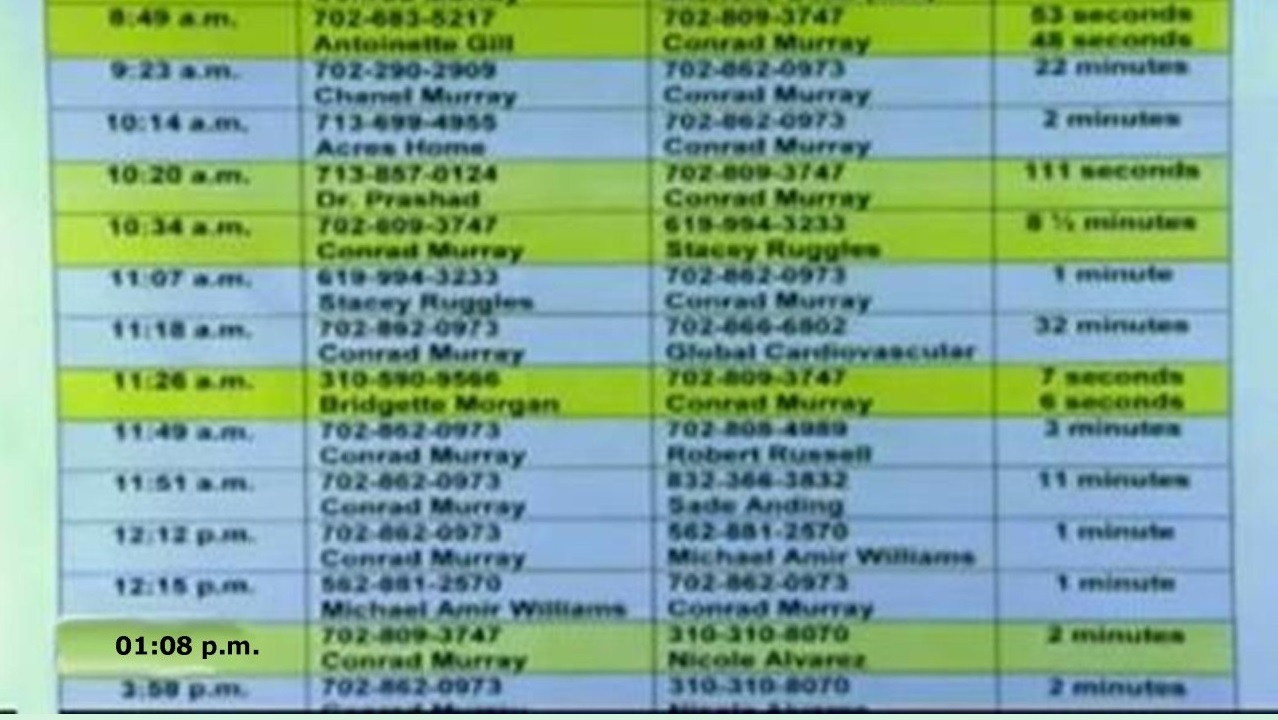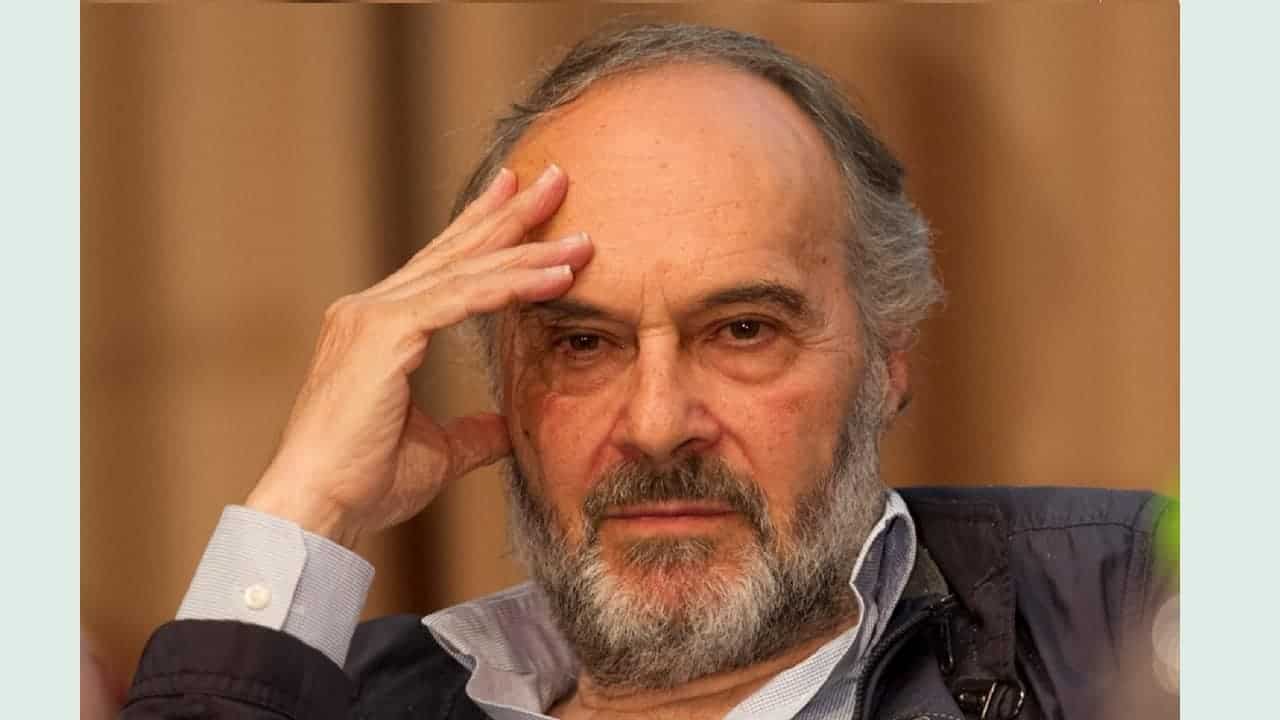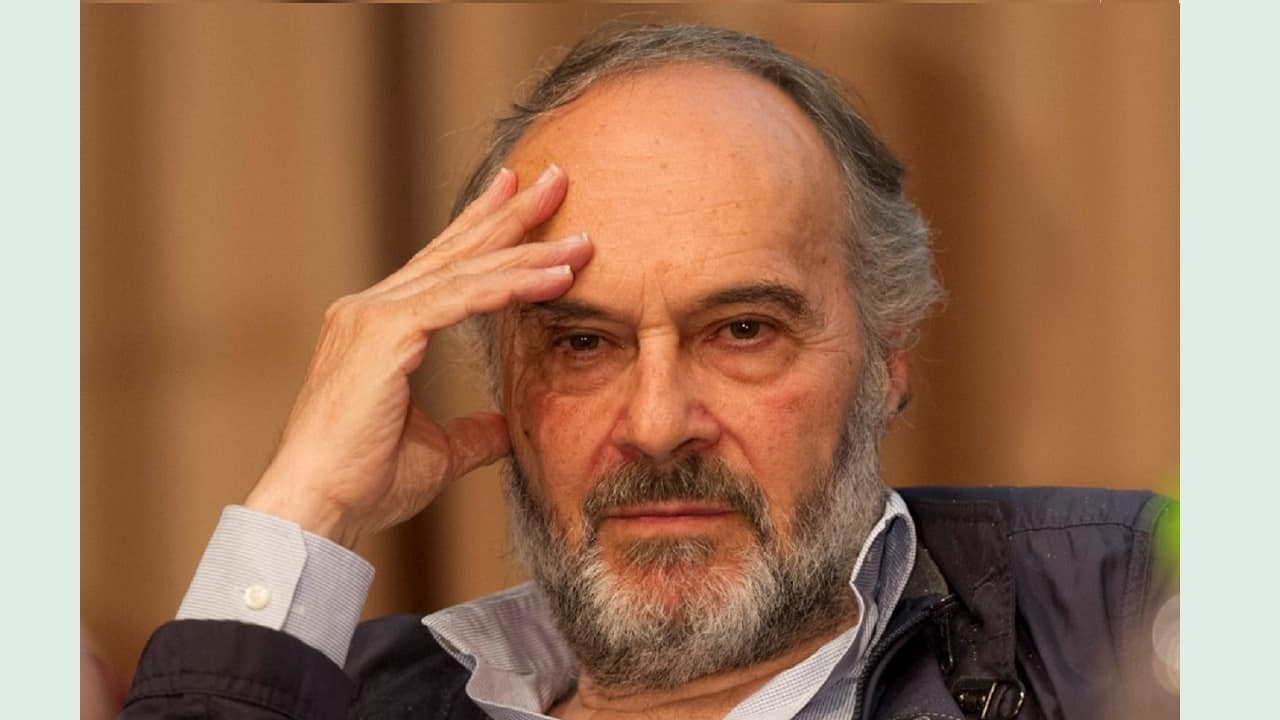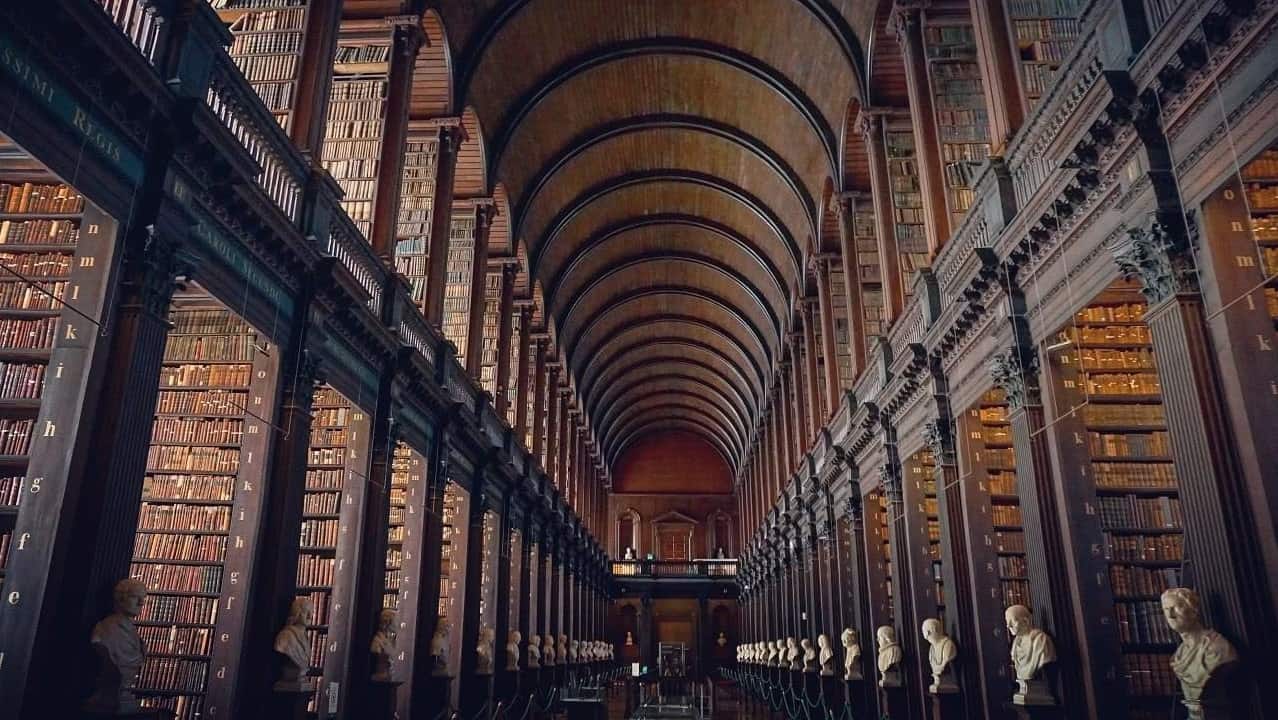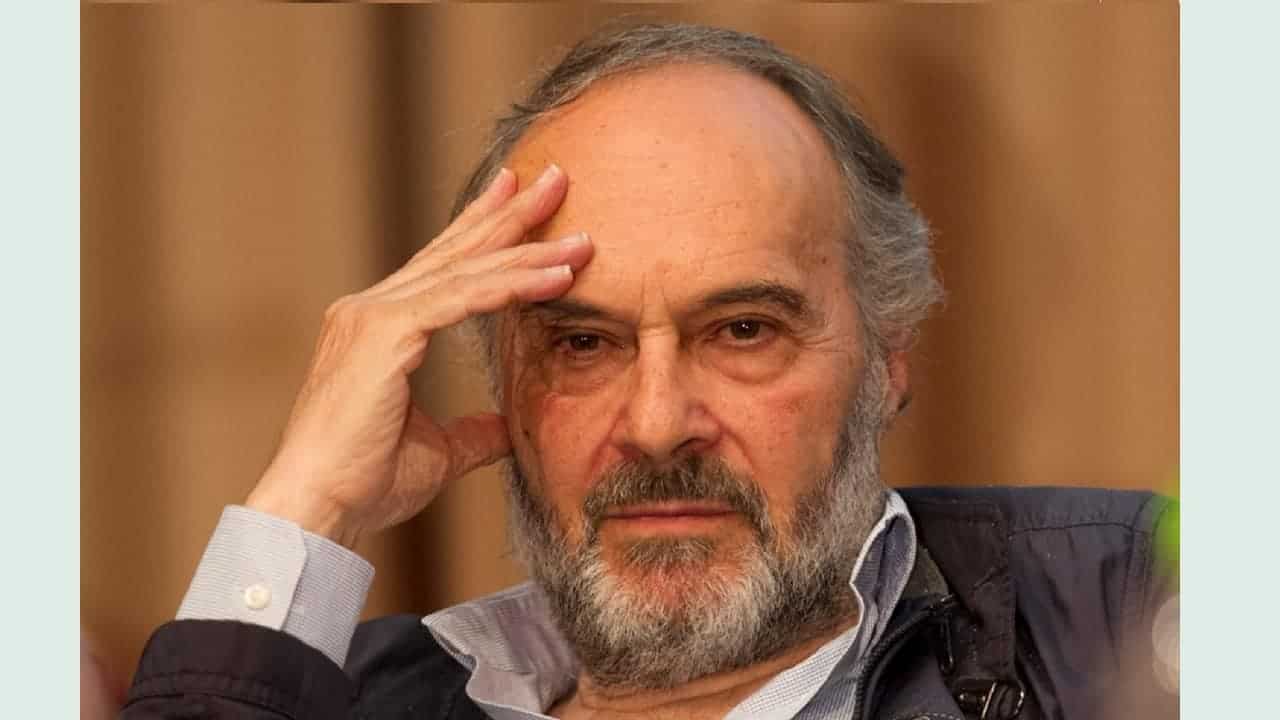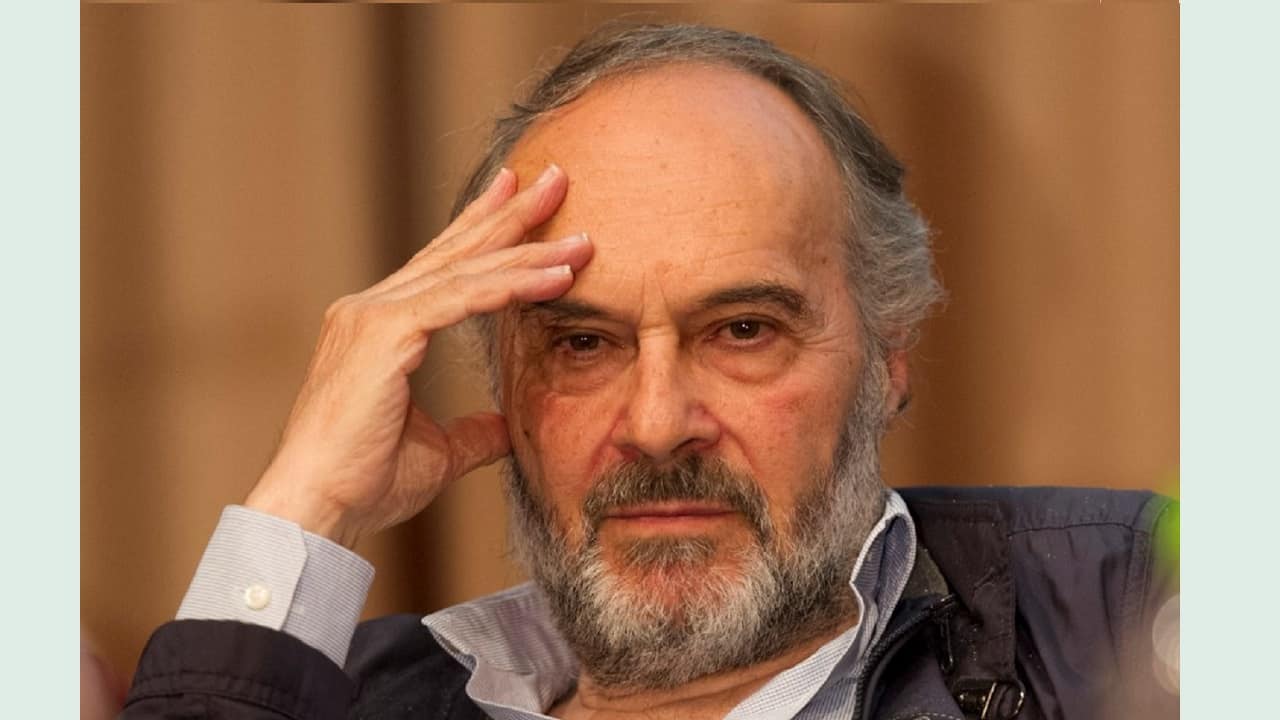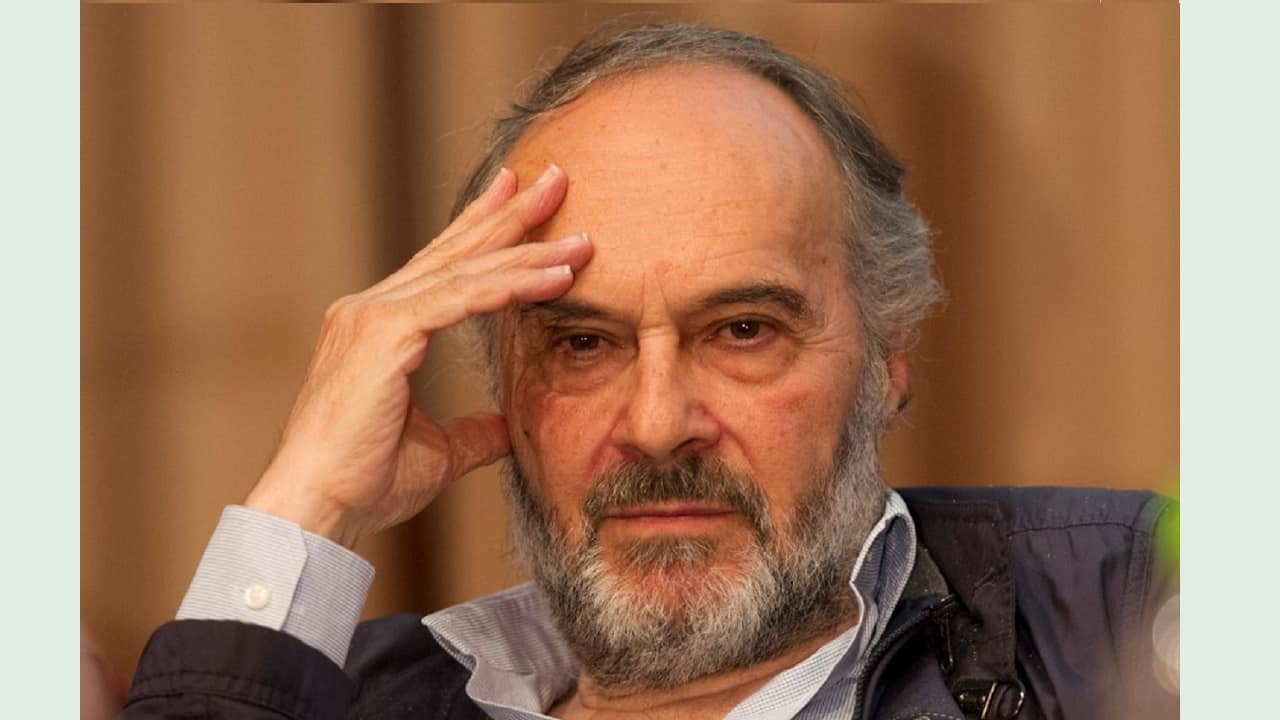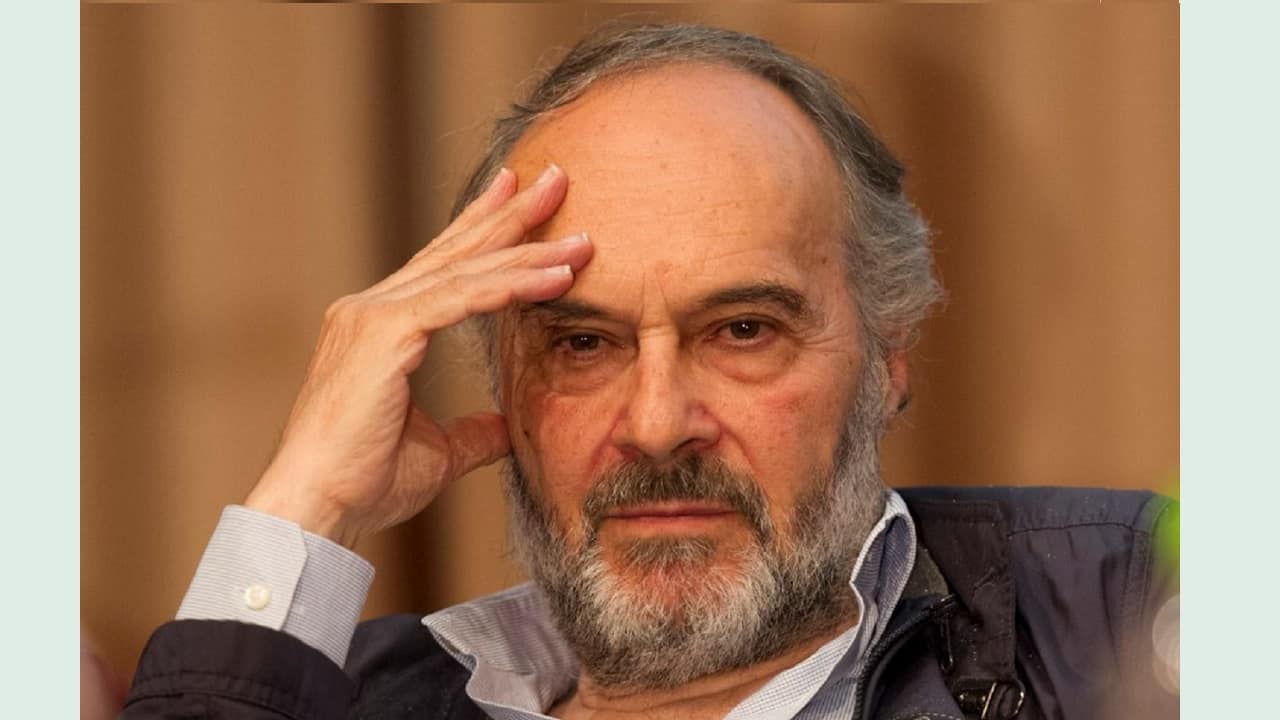FORUM I MALI DEL CSM E LA LORO SCOMPARSA: L’INVADENZA DELLE CORRENTI O LA LORO SCOMPARSA?
I mali del CSM di Giorgio Spangher*
*Testo della relazione presentata al Convegno Migliorare il Csm nella cornice istituzionale, Roma, 11 ottobre 2019 pubblicato in Migliorare il CSM nella cornice costituzionale editore CEDAM, collana: Dialoghi di giustizia insieme.
Il Consiglio Superiore della Magistratura è un luogo dove si esercita una funzione e/o un potere. Come ogni luogo dove si esercita una funzione e/o un potere sottostà alle regole della funzione e/o del potere: chi è chiamato a svolgerle cerca di esercitarle nella “visione” personale o del gruppo di appartenenza cercando di prevalere sull’altro o sugli altri che anch’essi vogliono svolgere personalmente o nel gruppo di appartenenza la loro funzione e/o il potere.
È possibile che singoli o gruppi trovino dei compromessi, dei componimenti, delle mediazioni, ma tendenzialmente l’uno o l’altro, un gruppo o un altro cercherà di prevalere.
Come detto il Consiglio Superiore della Magistratura non si sottrae, forse non può sottrarsi a questa logica delle funzioni e del potere, non costituendo un ostacolo – in termini assoluti – la materia sulla quale la funzione e/o il potere si esercita (l’autorevolezza della Magistratura, la sua indipendenza).
Poiché il potere del singolo, inevitabilmente, è debole nascono i gruppi e nel contesto del Consiglio Superiore, le correnti che, certamente, hanno come substrato un elemento culturale ideologico, legato alla visione ed alla missione della giurisdizione, ma che da questo elemento di fondo, che permane, si strutturano anche come centro di “potere” con cui esercitare la funzione e/o il potere.
Peraltro, l’aggregazione che senza voler assumere connotazioni spregiative, continueremo a chiamare correnti, sono il volano per ulteriori manifestazioni di potere: le elezioni dell’Associazione Nazionale Magistrati, le nomine al direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, gli incarichi direttivi, le nomine agli organismi europei, le varie designazioni del c.d. fuori ruolo, e via a seguire.
Del resto, in caso di nomine a grappolo o a pacchetto, si assiste ad una distribuzione delle stesse secondo la logica della proporzione della rappresentanza consiliare.
Si peccherebbe di onestà intellettuale ove si mancasse di sottolineare che anche le componenti laiche – i membri di nomina parlamentare – si strutturano ai gruppi, come del resto emerge dalla stessa distribuzione degli otto seggi che effettua il Parlamento (cinque alla maggioranza, tre all’opposizione) seppure i loro obiettivi siano diversi, ancorché tesi a favorire le opzioni culturali e politiche della magistratura, ritenute in qualche modo più contigue: il c.d. collateralismo.
Le componenti laiche, se sono coinvolte nelle scelte ideologiche e di distribuzione degli incarichi, restano estranee alla distribuzione delle posizioni di supporto del Consiglio (magistrati, segretari) e molto spesso alle logiche della sezione disciplinare e di quella definibile paradisciplinare.
Per cogliere il senso dell’organizzazione correntizia basta sottolineare come l’operazione di “reclutamento” inizi dalla formazione iniziale, dai gruppi di lavoro ed il proselitismo continui nelle sedi di assegnazione.
Per capire ancora meglio quanto si è detto basterà sottolineare come qualsiasi magistrato che abbia una pratica di un certo rilievo, per sé, davanti il Consiglio Superiore della Magistratura, sarà inevitabilmente portato ad interrogarsi sulla composizione della Commissione competente e sugli eventuali appoggi del suo competitor.
Il senso del proselitismo si alimenta attraverso i dibattiti nel plenum dove la loro prolissità è giustificata dall’esigenza di trasmettere ai magistrati l’impegno profuso dal gruppo di appartenenza (o che si vuole avvicinare) a testimonianza dell’impegno a tutela del candidato. Lo stesso discorso vale per il gruppo che si opponga alla decisione maggioritaria.
Il dato trova ulteriori conferme nella proliferazione, da parte di ogni gruppo, delle mailing-list, con le quali si cerca di spostare gli equilibri del potere a proprio vantaggio.
A conferma della logica dei gruppi, si sottolinea che i voti in dissenso sono rari, in quanto le questioni conflittuali vengono affrontate all’interno delle correnti, spesso con ritardi e paralisi dell’attività consiliare, che riprenderà quando un punto di equilibrio sarà stato raggiunto.
Ancora, posso riportare per esperienza personale, come il Consiglio usi con elasticità i criteri che stanno alla base delle scelte soggettive: la prima pratica che ho affrontato riguardava la nomina di un giudice minorile: doveva prevalere il criterio della specializzazione o quello della rotazione delle esperienze? Prevalse il primo criterio. Ho chiuso l’esperienza consiliare sempre su un caso di nomina di un giudice minorile; è prevalso l’altro criterio. Prevaleva la scelta della maggioranza legata al nome del candidato.
Quanto ai rapporti con la politica, questi si collocano su piani diversi. Il laico cerca la legittimazione da parte dei suoi referenti per il successivo sviluppo di carriera nelle istituzioni.
A volte il magistrato interessato ad una pratica cerca l’interlocuzione mediata con il politico del territorio, ma a volte non ha difficoltà a ricercare la condivisione con il componente laico.
I magistrati cercano e intrattengono interlocuzioni soprattutto in relazione a possibile posizioni istituzionali fuori ruolo.
Fermo restando che ogni consiliatura fa storia, a sé, non potendosi escludere che i laici agiscano in ordine sparso, ovvero come gruppo, superando le differenze e divergenze politiche, in modo più o meno compatto, cioè, scomponibile, le ultime vicende evidenziano, per un verso, l’emergere di figure individuali di magistrati connotate da una forte visibilità mediatica e, per un altro, la frantumazione delle correnti, di gruppi correntizi soggettivamente riconducibili ad una leadership personale.
A parte vanno considerate le frammentazioni interne, spesso prodromiche di scissione, e di protagonismi più o meno isolati e contingenti.
Resta consolidato che stante un corpus di magistrati numericamente non elevato, la capacità di controllo delle appartenenze, anche in sede distrettuale, non presenta particolari difficoltà di controllo, con conseguente scarsa incidenza sui sistemi elettorali che si volessero introdurre.
* Sul Forum si rinvia alla lettura dei precedenti contributi :Introduzione di Alfonso Amatucci al forum I MALI DEL CSM E LA LORO SCOMPARSA: L’INVADENZA DELLE CORRENTI O LA LORO SCOMPARSA? e FORUM I MALI DEL CSM E LA LORO SCOMPARSA: L’INVADENZA DELLE CORRENTI O LA LORO SCOMPARSA? Le correnti: un male necessario? di Carlo Guarnieri
Seguirà I mali del CSM: invadenza delle correnti o la loro scomparsa? di Eugenio Albamonte