
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Cass. S.U., 25 marzo 2021, n. 8500 e fattispecie reddituali a efficacia pluriennale. Sulla rilevanza del valore della stabilità dei rapporti e del consolidamento delle fattispecie impositive in materia tributaria
di Laura Castaldi
Sommario: 1. Premessa - 2. La posizione assunta dalle SS.UU. - 3. Premesse metodologiche - 4. Alcuni contributi al dibattito - 5. Le connesse problematiche alla valenza attribuita al principio di autonomia dei periodi impositivi - 5.1. Disquisizioni intorno all’“inerzia” e alla “non contestazione” con riferimento ad annualità pregresse definitive: a latere fisci - 5.2. (Segue) a latere contribuente - 5.3. Sulla dilatazione temporale degli obblighi di conservazione documentale - 5.4. Un caso di prospective overruling procedurale? - 6. Considerazioni conclusive - 6.2. (Segue).
1. Premessa
Ormai da tempo si registravano divergenze di vedute tra gli addetti ai lavori in ordine all’individuazione dei limiti temporali – in chiave necessariamente preclusivo-decadenziale – alla contestabilità nell’an da parte degli Uffici finanziari di quelle che, da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Cass. S.U. 25 marzo 2021 n. 8500 - hanno ritenuto identificare con l’espressione “fattispecie reddituali a efficacia pluriennale” ovvero – anche se giuridicamente non è affatto la stessa cosa – “elementi reddituali ad efficacia pluriennale” : volendo con ciò indicare omnicomprensivamente (ma, come vedremo poi, impropriamente) quei fatti ed eventi al verificarsi dei quali il legislatore tributario ricollega effetti – fiscalmente rilevanti e conformanti il modo di essere sostanziale della fattispecie impositiva – destinati però a spiegarsi temporalmente in una pluralità (talvolta indefinita e indeterminabile ex ante)[1] di periodi d’imposta successivi a quello in cui il fatto ha integrato gli estremi di sua rilevanza fiscale.
In un panorama dagli incerti contorni, il recente profilarsi nella giurisprudenza di legittimità di un orientamento interpretativo che, a nostro parere, scandiva rigorosamente la scansione temporale dei contenuti accertativi degli Uffici in stretta osservanza dei termini decadenziali posti dal legislatore a presidio della loro elevazione, ha suscitato inaspettate reazioni ansiogene. Indotte forse da timori su possibili inefficienze o inadeguatezze della macchina amministrativa nel garantire un’efficace azione di contrasto all’evasione fiscale: e così, alla fine, è scattato l’altolà.
Talché – pur in assenza di un reale contrasto giurisprudenziale - all’indomani delle sent. 9993/2018 e 2899/19, con ben quattro ordinanze interlocutorie[2] le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi su di una questione di massima della “particolare importanza”: consistente, appunto e come già detto, nello stabilire se la contestabilità nell’an di un componente redditualmente rilevante ad efficacia pluriennale venga meno per gli Uffici finanziari con il maturarsi del termine decadenziale di rettificabilità in accertamento della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui siffatto componente reddituale pluriennale ha visto integrarsi la sua fattispecie costitutiva, ovvero se tale profilo di sua contestabilità in accertamento si conservi con riferimento a tutti,indiscriminatamente, i successivi periodi impositivi in cui esso è destinato, talvolta per volontà del contribuente talaltra per disposizione di legge, a spiegare i suoi effetti in chiave conformativa della fattispecie impositiva.
2. La posizione assunta dalle SS.UU.
La pronuncia che ne è scaturita – si tratta come è noto della sent. 25 marzo 2021 n. 8500 – ha visto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sposare quest’ultima opzione interpretativa: con un percorso argomentativo che, al di là dell’incedere un po’ farraginoso del ragionamento, si riassume a guardar bene in un paio di decisivi passaggi che possono qui agevolmente sintetizzarsi.
La dichiarazione dei redditi è un atto, recettizio, dichiarativo di scienza: come tale, esso è deputato a riportare ed esporre – in chiave doverosamente partecipativa rispetto agli Uffici finanziari– fatti che assumono rilevanza giuridica in ragione degli effetti (fiscalmente rilevanti) che vi ricollega il legislatore ai fini della determinazione/rilevazione, con cadenza annuale, del reddito imponibile riferibile ad un determinato contribuente.
Alcuni fatti sono, per legge o per volontà del contribuente, destinati a rilevare giuridicamente, in chiave di loro incidenza quanto alla determinazione del risultato reddituale imponibile del contribuente, con riferimento ad una pluralità di periodi d’imposta[3]; con ciò trovando (o dovendo trovare) reiterata esposizione in tutte le corrispondenti dichiarazioni dei redditi interessate da tale loro, temporalmente pluriennale, rilevanza giuridica.
Poiché l’attività ricognitiva in accertamento degli Uffici finanziari ha ad oggetto la verifica di correttezza, fedeltà e compiutezza del risultato reddituale complessivo e unitario annualmente riferibile al contribuente, così come emergente dall’articolato e composito iter di sua rilevazione da costui operato (o che avrebbe dovuto essere operato) in sede dichiarativa, ogni fatto che è destinato a incidere su tale risultato è suscettibile di essere sottoposto a verifica e ad eventuale sindacato da parte degli organi accertatori fino allo spirare del corrispondente termine decadenziale di accertamento, senza limiti contenutistici di sorta: con la conseguenza che rispetto a “fatti” aventi valenza reddituale pluriennale, nessun effetto preclusivo quanto alla loro contestabilità in accertamento potrebbe farsi discendere per effetto della loro eventuale mancata contestazione – e intervenuta incontestabilità per compiuto maturarsi dei relativi termini decadenziali di accertamento – da parte degli Uffici finanziari con riguardo alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo impositivo nel quale si è verificata quella che la Corte chiama (tradendo un certo imbarazzo concettuale) la loro “genesi causale sostanziale”, e che noi riterremmo invece più corretto chiamare la loro fattispecie costitutiva sostanziale.
3. Premesse metodologiche
Ci permettiamo, rispettosamente, di dissentire dalla posizione espressa dalla Suprema Corte.
E la ragione del nostro dissenso si riassume e si sintetizza in una constatazione magistralmente espressa, per l’appunto, proprio dalla Suprema Corte laddove questa – con un ricorso all’utilizzo grammaticale del modo condizionale che si disvela davvero ricco di significato quando calato nel contesto - rileva come “nella soluzione prospettata, l’amministrazione finanziaria potrebbe contestare il fatto generatore ed il presupposto costitutivo dell’elemento pluriennale anche a molti anni di distanza dal suo insorgere”.
Non si poteva dire meglio per evidenziare il risultato ultimo cui conduce il pronunciamento in rassegna e l’incidenza vanificatoria che esso è destinata a spiegare sul senso e sulla funzione da ascrivere alla natura decadenziale dei termini temporali di accertamento nella logica di sistema che impronta la nostra materia, e sul loro impatto rispetto ad un settore – quello delle imposte sui redditi – dove la disciplina sostanziale e – necessariamente di riflesso – quella procedurale e processuale sono impegnate a coniugare il continuum di venuta ad esistenza dell’indice di espressività di capacità contributiva con la necessità di una sua frazionata rilevazione, a sua volta funzionale alla periodicità di suo assoggettamento a prelievo.
Del resto, come la pensiamo in argomento abbiamo già avuto modo di dirlo altrove, in tempi non sospetti e con dovizia di elementi a corredo[4].
Anche per rispetto dell’economia di una nota quale vuol essere la presente, non ci soffermeremo, dunque, in questa sede a disquisire sui diversi passaggi argomentativi che la Suprema Corte dispiega a sostegno della posizione interpretativa adottata: posto che ciò, fra l’altro, comporterebbe il dover scomodare e mettere in ballo una serie di questioni e problematiche assai complesse che finirebbero per essere trattate necessariamente in superficie e, dunque, senza costrutto alcuno. Quando, per contro, la presa di posizione della Suprema Corte, anche se non certo inaspettata quanto al suo contenuto, ha subito sollevato reazioni di segno vario e diverso: talché già si profila un certo fenomeno inflazionistico di commenti che non è nostra intenzione ulteriormente implementare.
4. Alcuni contributi al dibattito
Ci sia però consentito avanzare qualche breve spunto di riflessione, a titolo di mero contributo, al vivace confronto dottrinale e giurisprudenziale già in corso.
In primo luogo, riteniamo che la delicatezza e il polimorfismo della questione in discussione[5] avrebbe dovuto consigliare una maggiore cautela nell’affrontarla nei termini assolutamente generali e oggettivamente indiscriminati prescelti invece dalla Suprema Corte, pur nella dichiarata consapevolezza della sua complessità[6].
La decisione ci sembra sia stata un po’ precipitosa e, tutto sommato, non una buona idea.
Problemi complessi spesso richiedono soluzioni complesse e opportuni distinguo. L’operata scelta per la generalità e univocità di risposta ha finito invece – a nostro parere – per ripercuotersi e andare a discapito della linearità (ma soprattutto della coerenza intrinseca anche solo lessicale) del pensiero dei Supremi Giudici: che infatti prende le mosse da un orizzonte amplissimo – dove sono richiamate a descrivere il quadro di riferimento, senza distinzioni di sorta, perdite e ammortamenti, sopravvenienze attive, detrazioni e crediti d’imposta - prosegue altalenando pericolosamente tra “fattispecie reddituali pluriennali”, “componenti economici e patrimoniali con rilevanza pluriennale”, elementi con “genesi causale sostanziale” in un determinato periodo d’imposta ma “efficacia poliennale”, per infine approdare a circoscrivere l’attenzione e calibrare il discorso – giusta, probabilmente, l’oggetto del contendere rimesso alla cognizione della Suprema Corte – sulle sole categorie reddituali a rilevazione analitico-contabile dove la disciplina di rilevazione della redditività imponibile, per il reddito d’impresa anche in ragione del principio di derivazione, vede una continuità di rilevanza fiscale di molti componenti positivi e/o negativi di reddito in proiezione ultrannuale.
In questo panorama assai composito, il punto di criticità a nostro parere sta nel ridurre il tutto ad una questione di “fatti” o meglio ad una questione di “narrazione di fatti” concorrenti al risultato reddituale imponibile[7] : rispettivamente da parte del contribuente nella dichiarazione e, in termini necessariamente simmetrici, da parte dell’Ufficio nell’atto di accertamento in rettifica (non a caso, quest’ultimo, denominato tale dal legislatore).
Abbiamo l’impressione che la questione non stia esattamente in questi termini. Né in senso assoluto né in senso relativo.
Che né la dichiarazione né l’accertamento siano, o siano solo, una semplice narrazione reciprocamente partecipativa di meri fatti lo dimostra proprio la latitudine del giudicato tributario: che copre con il crisma della definitività l’accertamento/cognizione che il giudice compie non solo della posizione di debito/credito rispettivamente del contribuente e dell’Amministrazione finanziaria, ma anche del modo di essere della fattispecie impositiva, nei suoi elementi costitutivi da cui si estrinseca il rapporto obbligatorio d’imposta intercorrente tra le parti in causa, coltivando la propria attività cognitiva entro il recinto non solo fattuale, ma anche valutativo, che gli viene riportato dalle parti, e nella dichiarazione e nell’atto di accertamento che tale dichiarazione rettifica, nei limiti di ciò che costituisce il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio sotto il profilo oggettivo e motivazionale.
Il contribuente non si limita ad esporre fatti, ma ne offre una declinazione/rappresentazione fiscalmente rilevante proprio attraverso il veicolo della dichiarazione (anche, se del caso, per il tramite di propri comportamenti concludenti a carattere omissivo): lo spirare dei termini decadenziali di rettifica in accertamento della dichiarazione (e, corrispondentemente per il contribuente, di sua emendabilità ex art. 2, co. 8, lg. 322/1998) comporta la cristallizzazione della rappresentazione della fattispecie impositiva che ne scaturisce e che ne è contenuta con quel valore di immutabilità anche pro futuro che è cifra proprio di quell’esigenza di stabilità dei rapporti tributari e presidio alla coerente rilevazione del loro sviluppo temporale che la sentenza della Suprema Corte mette ora pericolosamente in crisi, e sui cui risvolti ci soffermeremo più oltre.
Ma il discorso vale, a maggior ragione, in senso relativo: è sufficiente concentrare l’attenzione sulle cd. “fattispecie ad efficacia pluriennali” che la Corte elenca a titolo esemplificativo nella sentenza per convincersene. Posto che vi si trovano annoverate le perdite pregresse e i crediti d’imposta riportati a nuovo la cui contestabilità, nei termini riconosciuti come ammessi dalla sentenza, non può che comportare necessariamente la rimessa in discussione dell’intero modo di essere dell’imponibile, ovvero addirittura del risultato finale liquidatorio d’imposta, con prospettica riferibilità a periodi impositivi ormai definitivi.
Senza contare che non tutto ciò che la Corte elenca come ricompreso nella sfera d’interesse della sua pronuncia è destinato in realtà a spiegare rilievo in chiave pluriennale sul versante della determinazione del risultato reddituale: com’è invece sicuramente per ammortamenti, sopravvenienze attive, rateizzi di plusvalenze, accantonamenti. Così non è per le detrazioni che incidono ex post sulla liquidazione dell’imposta netta, come pure, e a maggior ragione, per i crediti d’imposta riportati a nuovo che rilevano ai fini della determinazione dell’imposta da versare e fermo restando che anche sul versante dei componenti con rilevanza reddituale pluriennale si potrebbero/dovrebbero operare opportuni distinguo considerando che presentano tale caratteristica anche taluni oneri deducibili (com’è nel caso di cui all’art. 10, lett. e-bis, del T.U.I.R.) che però solo impropriamente possono dirsi concorrere alla determinazione del risultato reddituale complessivo del contribuente.
Ci sembra che una simile multiforme varietà di situazioni meriterebbe un’adeguata considerazione prima di essere pacificamente ricondotta ad un’unica disciplina: per giunta sotto un aspetto di così rilevante importanza qual è quello dell’accertamento.
5. Le connesse problematiche alla valenza attribuita al principio di autonomia dei periodi impositivi
Ci sono poi alcuni, chiamiamoli così, profili di dettaglio (o meglio, di contorno) che rimangono sullo sfondo nell’economia della sentenza ma che – sulla scorta della declinazione interpretativa offerta in ordine al principio di autonomia dei periodi d’imposta, quando sviluppata coerentemente – non paiono di facile risoluzione e aprono prospettive d’indagine tanto complesse quanto inaspettate.
5.1. Disquisizioni intorno all’“inerzia” e alla “non contestazione” con riferimento ad annualità pregresse definitive: a latere fisci
In primo luogo c’è da chiedersi se, ed eventualmente quale, significato debba attribuirsi pro futuro all’eventuale omessa contestazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un cd. “componente reddituale pluriennale” nel contesto e all’esito di un’attività di controllo e verifica che abbia interessato una annualità rispetto alla quale essa (non contestazione) abbia assunto i crismi della definitività: e ciò nella duplice prospettiva che l’attività istruttoria sia sfociata, alternativamente, in una chiusura delle operazioni senza elevazioni di sorta (e il relativo termine decadenziale di accertamento sia medio tempore maturato) ovvero abbia condotto, sì, alla notificazione di un avviso di accertamento, ma riportante rilievi e contestazioni altri e diversi rispetto al suddetto componente reddituale pluriennale (irrilevante risultando poi a questo riguardo il fatto che l’atto di accertamento sia o meno stato oggetto di ricorso da parte del contribuente).
In questo caso, infatti, la tesi della Suprema Corte – secondo la quale all’(intervenuta definitività per maturazione dei termini di espletamento dell’) inerzia dell’amministrazione all’accertamento – stante la mera eventualità di quest’ultimo – non potrebbe mai attribuirsi alcun significato concludente, men che mai ingenerante un legittimo affidamento nel contribuente quanto alla corrispondente correttezza della propria condotta fiscale nel trattamento di un componente reddituale pluriennale valevole anche pro futuro – si rivelerebbe assai poco pertinente e forse addirittura impropriamente invocata: posto che, nell’ipotesi prospettata, l’inerzia si atteggerebbe a relativa (riguardando il singolo componente reddituale pluriennale) ma non assoluta, inserendosi piuttosto in un’attività di verifica e accertamento positivamente espletata dall’Ufficio: e anzi, solo impropriamente in un contesto siffatto potrebbe parlarsi di inerzia[8], dovendosi invece più opportunamente parlare di mancata contestazione e, dunque, di positiva condivisione, ad opera degli organi accertatori, delle valutazioni fiscali operate dal contribuente in sede dichiarativa quanto al regime applicabile al componente reddituale pluriennale.
Ci lascia davvero perplessi, in un simile orizzonte, sostenere che il principio di autonomia dei periodi d’imposta osti al riconoscimento di un qualsivoglia effetto preclusivo a future contestazioni da parte dell’Ufficio finanziario circa il trattamento fiscale riservato al componente reddituale pluriennale dal contribuente nelle successive dichiarazioni d’imposta.
5.2. (Segue) a latere contribuente
In ogni caso, la posizione assunta dalla Suprema Corte – con conseguenze ancor più complesse a seconda di come risolviamo la questione appena sopra tratteggiata – non può non ribaltarsi e investire specularmente anche la parte contribuente: la quale dunque, simmetricamente, si ritiene alcuna preclusione di sorta dovrebbe incontrare nell’adempimento dei propri obblighi dichiarativi pro futuro, non solo dall’intervenuta definitività (per maturato termine di loro rettificabilità) di precedenti dichiarazioni quanto all’an, quomodo e quantum di rilevanza fiscale assegnato ad un determinato componente reddituale pluriennale dalle stesse emergenti,[9] ma addirittura dalla mancata impugnazione in toto o in parte qua di un avviso di accertamento dell’Ufficio finanziario che tali profili, nei loro diversi profili di espressione, fosse venuto precedentemente a contestare.
Ed invero, posto che il principio di autonomia dei periodi d’imposta – a maggior ragione nella logica seguita dalle Sezioni Unite – spiega rilievo sul piano sostanziale, esso non ha coloriture di parte e, dunque, la sua lettura dovrebbe necessariamente declinarsi a doppio senso e valere tanto per l’amministrazione finanziaria in sede di verifica in accertamento quanto per il contribuente in sede dichiarativa. Insomma, se la definitività non è preclusiva non lo può che essere a doppio senso. Con buona pace della coerenza e continuità di rilevazione della materia imponibile e/o di conformazione della fattispecie impositiva – pur nella periodizzazione della sua rilevazione ai fini della sua, del pari periodica, soggezione al prelievo – che impronta tutta la disciplina sostanziale in materia di imposte sui redditi.
Con l’ulteriore complicazione – ma di questo facciamo solo rapido cenno perché l’argomento, nella sua complessità, richiederebbe ben altri spazi di approfondimento – che un simile scenario potrebbe risultare suscettibile di comportare conseguenze di non poco conto, laddove il cd. componente reddituale pluriennale sia destinato a rilevare fiscalmente non solo direttamente (e dunque in sé e per sé quale elemento concorrente in positivo o negativo alla determinazione del risultato reddituale imponibile di una pluralità di periodi impositivi), ma altresì ad incidere indirettamente nella determinazione di altre componenti reddituali non pluriennali: com’è segnatamente nel caso degli ammortamenti, per quanto attiene poi alla determinazione delle plusvalenze/minusvalenze dei beni cui essi afferiscono nel contesto del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
La prospettiva d’indagine richiede un po’ di sforzo di immaginazione per essere adeguatamente sviluppata ed esplorata, forse non conduce da nessuna parte ma la nostra sensazione è che qualche opportuna verifica in argomento andrebbe fatta, se non altro per capire se la rigorosa logica delle simmetrie fiscali (oggettive e/o soggettive) che impronta in generale tutto il sistema di imposizione sui redditi, ed in particolare la disciplina di rilevazione analitica del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, regge comunque in questo diverso scenario e conserva la sua intrinseca coerenza.
La fantasia poi potrebbe portarci lontano e, allargando l’angolo di visuale, farci chiedere se la lettura dell’art. 7 del T.U.I.R. in punto di “autonomia ed annualità dei periodi d’imposta” – ritenuti dalla Suprema Corte i “fattori interpretativi chiave per la risoluzione del problema” – sia destinata a spiegare qualche significativo impatto sul versante della disciplina degli interpelli e, in particolare, quanto al requisito della preventività della loro proposizione rispetto alla posizione in essere della fattispecie concreta, relativamente alla quale si predica l’obiettiva incertezza applicativa di una determinata disposizione normativa. Condizione, quella della preventività, la cui richiesta ricorrenza tanto limita l’accessibilità a siffatto strumento e l’utilità del medesimo nel consolidare il rapporto di cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti di cui è istituzionalmente auspicato veicolo di attuazione[10].
Non è detto che la pronuncia in rassegna sia destinata ad aprire interessanti prospettive di non lieve momento sotto questo profilo.
5.3. Sulla dilatazione temporale degli obblighi di conservazione documentale
Ma senza divagare troppo e tornando strettamente in medias res, particolarmente stringenti ci sembrano invece i problemi che, neppure troppo sullo sfondo, emergono dalla sentenza per quanto attiene alla dilatazione dei termini temporali relativi agli obblighi di conservazione della documentazione dimostrativa dell’elemento pluriennale: che, se abbiamo compreso bene il ragionamento della Corte, dovrebbero andare di pari passo, adeguandosi e calibrandosi consequenzialmente – quanto al loro dies a quo e relativo loro dies ad quem – con riferimento ai termini decadenziali di accertamento della dichiarazione relativa all’ultimo periodo impositivo di rilevanza fiscale dell’elemento reddituale pluriennale: permanendo inalterata, lungo tutto il corrispondente arco temporale dichiarativo, e a prescindere da medio tempore intervenute definitività di singole annualità per sopravvenuta maturazione dei termini decadenziali di rettifica delle relative dichiarazioni, la verificabilità in accertamento ed eventuale contestabilità, ad opera dell’Ufficio finanziario, dei suoi fatti generatori e dei suoi presupposti costitutivi, a prescindere dal periodo d’imposta cui sarebbe riconducibile la loro insorgenza.
5.4. Un caso di prospective overruling procedurale?
Ora, a noi sembra che qui il problema non sia solo – in via di principio – di pratica applicabilità sul piano operativo, oltreché di resistenza in chiave giustificativa secondo i canoni della proporzionalità e della ragionevolezza, di un simile costrutto.
E che già, sotto questo profilo, molto si potrebbe dire: quando solo si consideri che – stante la varietà e vastità delle fattispecie annoverate dalla Corte (e annoverabili) nell’orbita delle cd. componenti reddituali pluriennali, come tali soggette ai principi enunciati nel suo pronunciamento – l’obbligo di conservazione documentale nei termini declinati dalla Corte può investire sia imprese che lavoratori autonomi, ma anche semplici contribuenti non tenuti alla contabilità[11], può concernere singoli specifici componenti reddituali, ma anche componenti pluriennali che generano e traggono loro fondamento costitutivo nella stessa complessiva fattispecie impositiva relativa ad un determinato periodo impositivo[12], può abbracciare archi temporali ragionevolmente contenuti, ma anche potenzialmente illimitati o straordinariamente ampi[13]. Il tutto, in evidente attrito rispetto alle evocate semplificazioni e all’alleggerimento dagli incombenti formali che sembra andare per la maggiore in questo frangente storico.
C’è, in verità, qualcosa di più.
Non soltanto le espressioni lessicali utilizzate[14], ma proprio la manifesta difficoltà della scansione argomentativa spesa a supporto in parte qua del ragionamento, sembrano tradire la consapevolezza della Corte circa l’intrinseca novità (potremmo chiamarla, forse più correttamente, ragionevole imprevedibilità) che la propria posizione interpretativa in merito ai termini decadenziali di contestabilità in accertamento dei cd. componenti reddituali pluriennali è destinata a spiegare, come ricaduta procedurale[15], sulla parallela prospettica dilatazione temporale degli obblighi di conservazione documentale a carico dei contribuenti. La fatica di far quadrare il cerchio è evidente: come emerge laddove si richiama (a onor del vero con grande onestà intellettuale) il proprio precedente in termini, che però purtroppo suona di tenore esattamente opposto a quanto si pretenderebbe sostenere[16], tentando di dargli un senso coerente con gli assunti predicati; come pure laddove si cerca malamente di sminuire la portata dell’art. 8, co. 5, dello Statuto dei diritti del contribuente per un verso scomodando (fra l’altro discutibilmente) la gerarchia delle fonti, per l’altro sottolineando la connotazione di disposizione di principio da attribuire alla disposizione per contrabbandarne la non applicabilità ai casi di specie, descritti come “ipotesi del tutto caratteristiche”: quando solo poche pagine prima la Corte si è dilungata a constatare la frequenza sempre maggiore che il fenomeno del “differimento pluriennale” registra nel sistema impositivo reddituale per ciò che strumento di equo contemperamento dell’esigenza di preservare il gettito erariale e, al contempo, di ricorrere alla leva tributaria in chiave incentivante per l’attuazione di politiche di modernizzazione e rilancio anche economico (come nel settore edile), ovvero per il perseguimento di obiettivi virtuosi (la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del territorio ecc.).
Con un problema di non poco conto che nel frattempo si pone: che sta nell’ esigenza di tutelare, sotto questo versante, il legittimo affidamento medio tempore riposto dai contribuenti nel quadro normativo vigente e nella lettura giurisprudenziale fino ad oggi offertane: esigenza di tutela cui non sembra soddisfacentemente rispondere il richiamo della Corte – quasi alla stregua di una valvola di chiusura – al dovere di ammettere, in sede contenziosa, il contribuente a fornire in altro modo la prova posta a suo carico, in tutti quei casi nei quali vi siano in concreto elementi per ritenere che egli si sia legittimamente privato oltre il termine decennale della documentazione fiscale. Se non altro perché il problema qui è a monte rispetto al diritto di difesa e della prova in giudizio: e riguarda, appunto e prima ancora, la fase endoprocedimentale istruttoria dell’accertamento. Il cui compiuto e soddisfacente svolgimento – secondo un principio di parità delle parti che è il riflesso della buona fede reciproca – - è spesso la miglior profilassi al proliferare del contenzioso: come dimostra di ritenere il legislatore tributario per effetto del combinato disposto dell’art. 5-ter del D.L.vo n. 218/1997 e dell’art. 12 della lg. n. 212/2000.
Insomma, la pronuncia in rassegna profila un problema di possibile lesione del diritto di difesa per tutti quei contribuenti che alla sua stregua si troveranno in difetto rispetto all’adempimento degli obblighi di conservazione documentale così come da essa conformati, per aver riposto affidamento nel disposto dell’art. 2220 c.c. e nell’art. 8, co. 5, della lg. 212/2000, anche alla luce dell’interpretazione datane dalla stessa Corte con la pregressa sent. 9834/2016: problema che però la Corte non affronta né tanto meno risolve e che pare anche di difficile e complessa risoluzione.
Per quanto ci riguarda, dunque, sono molti i punti d’ombra che la sentenza in commento lascia aperti e che potrebbero forse – lo auspichiamo – condurre a qualche ulteriore approfondimento e opportuna puntualizzazione da parte della Suprema Corte: come del resto è già successo con riferimento ad altre questioni, anch’esse particolarmente complesse e di massimo rilievo.[17]
6. Considerazioni conclusive
Ma il punto più interessante per noi è un altro: ed esorbita dalla stretta presa di posizione in ordine alla condivisibilità o meno, dal punto di vista squisitamente giuridico, della soluzione interpretativa adottata dalla Suprema Corte. Su cui abbiamo appena manifestato brevemente alcune nostre riserve. Esso riguardando piuttosto le ripercussioni a più vasto raggio che la sentenza in rassegna, con i suoi assunti di principio, è destinata a spiegare:
- e sul versante dell’agire amministrativo, in particolare quanto all’efficienza e al suo buon andamento costituzionalmente pretesi;
- e sulle scelte e sulle condotte del contribuente: sia come tale, che nel suo essere, a monte, homo oeconomicus in tale veste del pari tutelato dalla Costituzione nel valore della sua libertà appunto di iniziativa economica;
- e, più in generale, sul buon funzionamento del sistema.
Partiamo da quest’ultimo profilo.
Apparentemente, la posizione della Suprema Corte sembrerebbe rappresentare un ottimo punto di approdo nella ricerca di un difficile e precario equilibrio tra due opposte esigenze:
- per un verso quella, diciamo, di tutela del cd. “interesse fiscale” a che sia garantita la massima ampiezza di controllo/verifica/contestabililità e rettificabilità di tutto ciò che, a vario titolo, emerge dalla singola, specifica, dichiarazione d’imposta del contribuente come concorrente alla determinazione del risultato imponibile e/o alla liquidazione del tributo da versare con riferimento al relativo periodo d’imposta: in un’ottica di salvaguardia del gettito tributario e di efficace contrasto all’evasione, e quasi come contrappeso alla mera eventualità dell’accertamento e all’asimmetria conoscitiva che in tal sede caratterizza la posizione dell’Amministrazione finanziaria rispetto al contribuente quanto alle vicende fiscalmente rilevanti che lo riguardano;[18]
- per l’altro verso, quella del contribuente (ma che la Corte correttamente ascrive a interesse generale ed espressione di civiltà giuridica) a che si pervenga, entro un termine ragionevole, alla stabilizzazione del rapporto giuridico tributario che gli fa carico: così da non trovarsi sine die “in balìa” di quelle che la Suprema Corte chiama iniziative recuperatorie – ma che noi riterremmo più corretto indicare come iniziative contestatorie (e solo conseguentemente recuperatorie) – del Fisco.
È vero sì, infatti, che l’Amministrazione può sempre mettere in discussione i fatti presupposti e gli elementi costitutivi del componente reddituale pluriennale con riferimento a qualunque delle dichiarazioni nelle quali esso componente rileva fiscalmente, a prescindere dalla mancata rettifica (in parte qua?) della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui essi (fatti presupposti ed elementi costitutivi) sono venuti ad esistenza o di altre successive, ma – ecco la chiave di volta – ciò nessuna incidenza spiegherà sull’eventuale intervenuta definitività, per medio tempore compiuta maturazione dei rispettivi termini decadenziali di accertamento, delle precedenti dichiarazioni in cui tale elemento abbia comunque spiegato rilievo nella conformazione della fattispecie impositiva.
Talché – ecco la chiosa della Suprema Corte – niente può eccepirsi quanto al risultato: per ogni singolo periodo impositivo i termini di rettificabilità della relativa dichiarazione e, correlativamente, di accertamento della relativa obbligazione d’imposta rimangono sempre e costantemente quelli di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
A noi sembra però che, così argomentando, la Suprema Corte non colga che proprio qui sta il punto di criticità sistematica della soluzione interpretativa sposata: il pegno da pagare per non riconoscere l’allungamento dei termini di accertamento in danno dei contribuenti e, nello stesso tempo, per non prefigurare preclusioni accertative in danno degli Uffici finanziari, sta nel riconoscere come strutturalmente possibile la disomogeneità e non coerente continuità di rilevazione del modo di essere della fattispecie reddituale imponibile in quel suo divenire temporale che trova espressione proprio (anche se non solo) nei cd. elementi reddituali pluriennali.
In evidente contrasto con quella che è la conformazione del rapporto alla stregua della sua disciplina sostanziale.
Quanto ciò sia sostenibile a livello sistematico e costituzionale abbisognerebbe di essere adeguatamente approfondito: considerato che la disciplina procedurale (così come quella processuale) è servente rispetto quella sostanziale e non viceversa.
Si tratta di un campo di riflessione molto complesso, già emerso ed emergente sotto altri e diversi profili nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale[19], che richiede probabilmente un intervento organico a più vasto raggio rispetto al quale non può adeguatamente supplire solo l’elucubrazione giurisprudenziale della Suprema Corte.
6.2. (Segue)
Per quanto attiene poi agli altri due precedenti aspetti, ci permettiamo solo alcune brevi divagazioni senza alcuna pretesa di approfondimento.
Quanto al primo profilo, abbiamo l’impressione che varie siano le questioni su cui meriterebbe riflettere.
Già di per sé, oggi, i termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi sono, nella loro oggettività, estremamente dilatati. Anche volendoci limitare all’attività di accertamento in rettifica, lo spirare del relativo termine decadenziale è attualmente fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: termine, già considerevolmente ampio, che immancabilmente si sospende, si proroga e ulteriormente si estende per ragioni le più diverse e anche sempre più variegate e numerose (calamità naturali, emergenze pandemiche, manovre condonistiche, interventi di emendatio dell’originaria dichiarazione ad opera dello stesso contribuente, necessità di assicurare il compiuto espletamento di forme varie di contradditorio endoprocedimentale senza che gli uffici patiscano medio tempore il maturarsi di decadenze a proprio danno, e via discorrendo).
A questa già significativa estensione temporale dei termini di accertamento, la posizione interpretativa della Suprema Corte – comunque la si pensi – finisce per certificare anche una altrettanto significativa dilatazione, anche in proiezione temporale, di ciò che ha da formare oggetto di controllo e verifica (ai fini di una eventuale futura contestabilità) a carico degli Uffici. Insomma, ad una (confermata) maggiore latitudine di potere di contestabilità si accompagnerà però una altrettanto simmetrica maggiore latitudine[20] dei compiti di controllo e dei riconnessi oneri istruttori di cui è investita l’amministrazione finanziaria: tanto più gravosi e di difficile espletamento quanto più concernenti, prospetticamente, vicende remote nel tempo, come tali suscettibili di patire approcci ricostruttivi distorti in ragione di fenomeni di decontestualizzazione normativa ma anche, mi si passi il termine, “ambientale”[21]: a loro volta potenziali fattori moltiplicatori di res litigiosa.
Il quadro che ne scaturisce potrebbe porre non pereghini interrogativi non solo sul grado di adeguatezza di risposta dell’apparato burocratico-amministrativo in termini di efficienza, ma anche sulle garanzie di incisività dell’azione accertativa[22]: oltre a profilare pericolosi (e non certo auspicabili) fenomeni di ulteriore parcellizzazione e inflazionamento del contenzioso tributario le cui – notoriamente rallentate – tempistiche di espletamento potrebbero, peraltro, andare ad ulteriore detrimento, incidendo negativamente, per quanto qui interessa, sulla già potenzialmente grave decontestualizzazione cronologica tra attività di accertamento e oggetto accertato.
Quanto al secondo profilo, ci sembra che i problemi siano gli stessi di cui sopra, seppur visti dalla diversa angolazione del contribuente: rispetto al quale essi però assumono una diversa coloritura che potremmo sintetizzare e riassumere nella percezione di una immanente e permanente instabilità (per potenzialmente illimitata contestabilità) del modo di essere del proprio rapporto impositivo reddituale nel suo costante divenire nel tempo: il tutto a discapito di quel valore di certezza che, nel nostro settore al pari di quello penale, si traduce essenzialmente in termini di ragionevole prevedibilità (anche, e talvolta soprattutto, in chiave prospettica) per il contribuente delle conseguenze fiscali delle proprie condotte. Aspettativa che, per costui, non attiene soltanto all’esigenza di essere salvaguardato da possibili oscurità, polivalenza e ambiguità oltre che mutevolezza nel tempo dei dati normativi ma anche dai margini di possibile (e di per sé imperscrutabile nella fondatezza) contestabilità ex post della correttezza fiscale dei propri comportamenti, stanti le significative conseguenze destabilizzanti che ne conseguono[23]: come l’istituzione e la disciplina degli interpelli e dei rulings dimostrano.
Tant’è non è da escludere si registri – come effetto di rimbalzo nell’immediato futuro del pronunciamento in rassegna - un accorciamento, laddove possibile per il contribuente, dei limiti temporali di spendita dei componenti reddituali pluriennali per conseguire il prima possibile il consolidamento della relativa fattispecie. Che non significa affatto mirare conseguire definitivamente il frutto dell’evasione bensì più banalmente archiviare il rischio o l’evenienza della contestazione: fattore di incertezza non solo psicologico ma prima ancora economico e strategico, soprattutto sul piano imprenditoriale.[24]
Il tema è vastissimo e, stanti le sue implicazioni, non può neppure essere accennato in queste brevi note. Viene però da pensare se la sentenza della Suprema Corte non possa essere una buona occasione per soffermarvici adeguatamente l’attenzione.
[1] Come riconosce la stessa Corte facendo riferimento al regime di spendibilità delle perdite pregresse.
[2] Si tratta, nell’ordine, dell’ord. 10701/2020, dell’ord. 15525/2020, dell’ord. 16752/2020 e, infine, dell’ord. 20842/2020.
[3] La Corte parla di “componenti reddituali a rilevanza pluriennale” definendoli come “elementi economici e patrimoniali che, per quanto emersi e consolidatisi nella loro genesi causale sostanziale in una determinata annualità d’imposta sono tuttavia dalla legge fiscale ammessi a produrre effetti sulla formazione della base imponibile di annualità successive eventualmente anche molto lontane da quella di origine”.
[4] Mi permetto di rinviare alla mia nota a commento di Cass. 9993/2018 (CASTALDI, Intorno al principio di autonomia dei periodi impositivi e ai termini decadenziali di accertamento, in Riv. trim. dir. trib. 2019, 194 ss.).
[5]Consistente nello stabilire la latitudine, non solo contenutistico/sostanziale ma anche argomentativo/motivazionale, dell’attività di accertamento degli Uffici finanziari in relazione ai termini decadenziali di suo espletamento.
[6] Secondo quanto è dato leggere nella sentenza in commento, infatti, “non sembra che la complessità ed eterogeneità delle fattispecie siano tali da impedire o sconsigliare una soluzione unitaria al problema giuridico posto dall’ordinanza di remissione” per ciò che – questa la considerazione della Suprema Corte (sulla condivisibilità della quale nutriamo forti riserve) – la materia dell’accertamento e dei termini di suo esperimento “più di ogni altra richiede regole operative il più possibile stabili e uniformi”.
[7] Che poi la Corte sente comunque il bisogno di declinare in termini di “elementi”, di “dati” o “informazioni” e, più oltre – con l’occhiale specificamente concentrato sul reddito d’impresa – come “voci” e dopo ancora come “componenti” con una polisemia che disvela la consapevolezza da parte dei Giudici della difficoltà di ricondurre ad unicum la tematica da trattare.
[8] Che è termine di coloritura volutamente anodina.
[9] E così alla valutazione di un bene relativo all’impresa come fiscalmente non ammortizzabile (ovvero ammortizzabile solo parzialmente nel quantum) operata dal contribuente nella dichiarazione relativa all’esercizio di suo inserimento nel ciclo produttivo e nei successivi, potrebbe seguire, nonostante il sopravvenuto crisma di definitività per maturazione dei termini decadenziali di accertamento/rettifica di siffatta dichiarazione e di altre successive, una diversa valutazione del contribuente medesimo quanto al trattamento fiscale da riservare a siffatto bene negli esercizi successivi di sua incidenza pluriennale.
[10] Concordiamo pertanto con le riflessioni da ultimo svolte in proposito da FARRI, Le incertezze nel diritto tributario, in Dir. prat. trib. 2021, 720 ss.
[11] Com’è nel caso – fra l’altro richiamato proprio dalla Suprema Corte – in cui si discuta dello scomputo in chiave di detrazione decennale pro quota in rate costanti dei costi per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, per la ripulitura e ritinteggiatura delle facciate degli edifici ecc..
[12] Com’è laddove si discuta di spendita di perdite pregresse, ovvero addirittura di crediti d’imposta del pari riportati a nuovo da esercizi e dichiarazioni pregresse.
[13] È quanto accade per alcune tipologie di beni – fabbricati destinati all’industria, in genere, ma anche infrastrutture destinate ai servizi pubblici essenziali come porti, aeroporti, autostrade, opere idrauliche fisse ecc. – dalla vita utile particolarmente durevole che, in base ai coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988, hanno periodi di ammortamento che abbracciano anche qualche decina di anni.
[14] Non vogliamo scendere nell’esegesi spicciola della sentenza, però ci sembra significativo che la Corte, dopo aver richiamato il proprio precedente (Cass. 9834/16) – meglio descritto alla nt. 18 – ricorra a formule quasi dubitative nel prendere posizione, distaccandosene, rispetto ad esso: in buona sostanza sostenendo come, alla luce del proprio costrutto interpretativo, “non pare inesigibile” che il contribuente sia onerato della diligente conservazione delle scritture “fino allo spirare del termine di rettifica (anche ultradecennale) dell’ultima dichiarazione accertabile”.
[15] La Corte parla di “correlazione servente” che intercorre tra il regime di conservazione documentale e la disciplina dell’accertamento e della sua tempistica.
[16] Il richiamo è a Cass. 9834/2016, nella quale la Suprema Corte, pronunciandosi con riferimento ad un caso di ammortamenti ultradecennali, ha limitato l’ultrattività dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre il termine decennale di cui all’art. 2220 c.c. al solo caso in cui l’accertamento – iniziato prima del decimo anno – non sia ancora stato definito a tale scadenza: osservando come, altrimenti, “l’obbligo di conservazione si protrarrebbe per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’Ufficio, rispetto al quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die”.
[17] È chiaro il richiamo, nel testo, all’evoluzione giurisprudenziale registratasi in tema di efficacia esterna del giudicato tributario all’indomani del pronunciamento della SS.UU. della Cassazione con sent. 13916/2006: per una cui meditata analisi facciamo richiamo, ex multis, a FRANSONI-RUSSO, I limiti oggettivi del giudicato nel processo tributario, in Rass. trib. 2012, 858 ss. Vd. anche, più di recente, seppur con un’impostazioneche ci trova su posizioni distanti, CORRARO, L’efficacia ultra litem del giudicato tributario tra vecchi modelli e nuove teorizzazioni: il lungo cammino della Corte di Cassazione nel segno di una costante incertezza sistematica, in Dir. prat. trib. 2020, 2547 ss..
[18] Come traspare, neppure troppo nascostamente, nell’argomentare della Corte laddove questa – seppur ad altro fine – ricorda che il sistema impositivo, “soprattutto in campo reddituale, trova il proprio fulcro non nell’accertamento (evento che resta pur sempre secondario nella dinamica complessiva delle entrate tributarie) ma nella fisiologia della dichiarazione quale vero e proprio atto di responsabilità autoimpositiva e autoliquidativa”.
[19] Ci limitiamo a solo alcune recentissime note di significativo rilievo in argomento. Con sent. 11 maggio 2021 n. 12372, la Suprema Corte di Cassazione ha disposto che in caso di perfezionamento dell’accertamento con adesione in relazione ad un anno, a situazione immutata, non è legittima la condotta dell'Agenzia delle Entrate che, per gli anni successivi, aumenti la pretesa rispetto ai pregressi accertamenti poi definiti in adesione. In una tale evenienza, gli accertamenti sono parzialmente nulli e la pretesa va ricondotta nell'entità derivante dall'accordo di adesione perfezionatosi per gli anni pregressi. Con sent. 30 marzo 2021 n. 8740, la Suprema Corte ha stabilito che l’efficacia vincolante della risposta dell’Amministrazione finanziaria ad un interpello, limitata alla questione oggetto di quest’ultimo e al contribuente istante, pur non trovando applicazione, in via generale, in relazione a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall’interpellante, può estendersi anche a soggetti diversi che, in relazione all’atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, “nonché all’allocazione dei relativi obblighi”, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall’interpello.
[20] Peraltro, declinata in chiave di doverosità: pena la negligenza suscettibile di conseguenze sanzionatorie anche in punto di responsabilità contabile a carico dei verificatori.
[21] Non possiamo infatti dimenticare che tutte le disposizioni di legge (anche quelle tributarie) nel loro risvolto applicativo risentono del contesto storico, politico, economico, sociale e giurisprudenziale in cui sono calate: tanto maggiore è lo iato temporale che intercorre tra ciò che è oggetto della verifica e la verifica stessa, tanto maggiore sarà il pericolo di un disallineamento di approcci valutativi dovuti, appunto, a “decontestualizzazioni”.
[22] Volendo essere più chiari: non siamo sicuri che consentire (ma altresì imporre) agli Uffici finanziari di controllare sempre tutto non finisca per andare a discapito della qualità, tempestività ed efficacia dell’azione amministrativa di accertamento. Non ci dimentichiamo che interrogativi molto simili a quelli di cui al testo condussero alcuni decenni fa ad attenuare la rigorosità del principio di unicità e globalità dell’accertamento, portando all’introduzione dell’accertamento parziale. La situazione, se vogliamo, è perfettamente speculare, ma proprio per questo ci sembra meritevole di attenzione per l’insegnamento che può offrire.
Aggiungiamo anche che molte delle scelte di conformazione della disciplina sostanziale dei tributi sono frutto di una pragmatica scelta compromissoria tra l’esigenza di rispetto del principio di effettività nella rilevazione della manifestazione di attitudine alla contribuzione da assoggettare a prelievo e, da un lato, l’esigenza di snellezza, semplicità e non economicamente gravosa applicabilità della disciplina da parte del contribuente, dall’altro, fattibile, efficace ed efficiente controllabilità ex post da parte degli Uffici finanziari. Insomma, il meglio talvolta è nemico del bene.
[23] Si pensi – tanto per enumerarne solo alcune - agli aggravi sanzionatori, ai possibili risvolti penali, alle misure confiscatorie, ai recuperi in pendenza di causa, ai costi e all’alea del contenzioso.
[24] Ne è indiretta conferma la stretta connessione che intercorre tra gli indici di affidabilità fiscale e la valenza premiale che, in tale contesto, essi spiegano in chiave riduttiva dei termini di accertamento.
Giustizia e comunicazione
2. Fare cronaca giudiziaria
Intervista di Maria Cristina Amoroso a Rosaria Capacchione
Nel contributo sul tema del linguaggio giudiziario e la comunicazione istituzionale,Gianni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte di Cassazione, ha evidenziato i pericoli insiti nella comunicazione dei media.
Oggi Giustizia Insieme affronta quest’argomento con la giornalista Rosaria Capacchione, firma eccellente di una sapiente cronaca giudiziaria che ha raccontato senza remore i fenomeni camorristici, dal 1985 al 31 marzo 2018 per Il Mattino di Napoli a Caserta e Napoli, ed oggi per la testata Fanpage.it.
Senatrice della Repubblica, Segretario della Commissione permanente della Giustizia e Componente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali; autrice di libri di successo che hanno valicato i confini del paese; destinataria dei più preziosi riconoscimenti per il suo straordinario impegno civico, oggi, da intervistata, regala a Giustizia Insieme il suo interessante punto di vista sull’etica della cronaca giudiziaria.
Cosa dobbiamo intendere per cronaca giudiziaria?
La mia carriera è iniziata in un momento in cui nel mondo della comunicazione vi era una separazione organizzativa tra la cronaca nera e la cronaca giudiziaria. La prima era costituita dalla narrazione del fatto, spesso concentrata sul lato più morboso dello stesso, la seconda dal reportage meramente tecnico di quanto emergeva dal processo e, pertanto, non particolarmente ricca di contenuti, essendo spesso limitata al riferimento ad avvenuti arresti, all’esistenza di misure cautelari e, soprattutto, alle pene di volta in volta irrogate.
In questo peculiare contesto, cercai di fare in modo che i miei primi passi nel mondo del giornalismo, per quanto novizi e quindi poco incisivi a confronto di colleghi più noti, presentassero un tratto distintivo.
Decisi, quindi, di affiancare alla narrazione tecnica quella del fatto, fondendo le due forme di comunicazione e, di fatto, attribuendo al concetto di cronaca giudiziaria un diverso contenuto raccontando non solo il processo ma anche la narrazione di ciò che avveniva “oltre”, sia all’interno dello stesso, nel “backstage” dell’aula di tribunale, sia al di fuori, nella società civile, particolarmente ricca di ricordi diretti e parole riferite.
La cronaca giudiziaria per così dire tradizionale è stata, a suo avviso, totalmente superata?
Io ho deciso di non far coincidere il contenuto della cronaca giudiziaria solo con il contenuto del processo, che è solo un frammento della narrazione del fatto che, tra l’altro, non necessariamente coincide con la realtà storica.
È molto interessante la prospettiva del processo come narrazione non meramente tecnica, ci approfondisce questo concetto?
Il processo è il rituale ma non solo. È la celebrazione solenne, ma è anche il testimone che prima di entrare in aula ti racconta qualcosa d’interesse, o la vittima che piange, o qualcuno che viene accompagnato da chi, in maniera assillante, gli ripete cosa deve dire, è l’avvocato che guarda in un certo modo il cliente che sta per dare una risposta cruciale. Tutte queste cose, che chiaramente il giudice non vede, unitamente al racconto raccolto da e tra il popolo, sono preziose tessere di un puzzle che solo l’occhio esterno del giornalista può compiutamente comporre.
Ma questa è la mia posizione, per altri la cronaca giudiziaria è ancora intesa in senso meno esteso per una serie di ragioni molto complesse.
Approfondiamo queste ragioni…
Dovendo limitarmi per evidenti ragioni, in questa sede, a selezionare solo alcune delle molteplici cause, soprattutto due fattori, uno nuovo ed uno vecchio, hanno, a mio avviso, snaturato e snaturano ancora la cronaca giudiziaria. Iniziando dal fattore “nuovo”, molto limitante, è stato, a mio avviso, l’eccessivo ed acritico interesse per le intercettazioni. Per anni non ho avuto alcuna necessità di andare in procura; i miei contatti erano limitati alla polizia giudiziaria e al giudice, evidenti e utili centri di conoscenza ove transitavano misure cautelari e altre informazioni.
Dopo Tangentopoli la caccia ai verbali ha decretato la fine del nostro mestiere, perché affidando al “bianco e nero” il racconto abbiamo barattato il nostro ricco punto di vista con quello che è per definizione solo un frammento della storia il cui contenuto, quando non assolutamente inutile, è comunque difficile da cogliere perché decontestualizzato. Questo è stato, a mio avviso il primo fattore che ha determinato anche una crisi del nostro mestiere chiaramente inteso nell'accezione a me più cara.
In questa prospettiva la riforma delle intercettazioni le è sembrata una giusta soluzione?
A me è sembrata una sconfitta, la necessità di ricorrere ad una legge per far sì che i magistrati non inseriscano nei provvedimenti verbali di intercettazioni non utili e per evitarne la pubblicazione da parte di noi giornalisti, rivela con drammatica chiarezza quanto ci siamo allontanati dal senso dei nostri rispettivi mestieri e dal rispetto dei relativi codici deontologici.
Così come sa di sconfitta l’aver dovuto prevedere delle sanzioni per reprimere comportamenti che non ci dovrebbero appartenere.
Ha parlato di due fattori, uno che Lei ha definito “nuovo” costituito dalle intercettazioni, e il “vecchio” qual è?
Più che vecchio è un fattore senza tempo, una vera e propria costante della cronaca giudiziaria ed è il costo della verità. Andare “oltre” il processo costa, costa in termini economici, soprattutto nelle inchieste in cui ci si scontra con il potere. Solo la gestione economica di una difesa in giudizio rischia di divenire un prezzo insostenibile anche in caso di vittoria giudiziale, un costo che proprio le testate medio piccole, che dovrebbero svolgere il compito di raccontare le realtà locali, non possono sostenere.
La cronaca giudiziaria “difensiva” quindi si autocensura e si rinchiude in una tutelante coincidenza con il processo, quando va bene.
Tutto questo condiziona fortemente l'effettività di una democrazia che si fonda sulla libertà di espressione, poiché è evidente che in un sistema così strutturato, più cresce la possibilità che il giornalista sia responsabile di danni economici, più la sua autonomia è legata, non più e non tanto al colore ma alla ricchezza dell’editore.
Come può influire, a suo avviso, il legislatore sulla modalità di fare cronaca giudiziaria?
Può farlo direttamente prevedendo disposizioni che, di fatto, costituiscono le forme velate di dissuasione cui ho già fatto cenno: prevedendo norme sulla responsabilità dei giornalisti, attribuendo ad alcune condotte rilievo penale, e può farlo anche indirettamente, dando al processo una struttura che impedisce la narrazione di una verità più ampia.
Si pensi ad esempio a quanto è accaduto durante la pandemia. Lo svolgimento dei processi per via telematica senza la previsione di una facoltà per la stampa di collegarsi, sia pur da remoto, per assistervi ha determinato la celebrazione “occulta” di moltissime cause di rilevante interesse pubblico e ha impedito quella narrazione che io sento come necessaria. Noi giornalisti ci siamo dovuti confrontare con questa formula che, di fatto, ci ha estromesso silenziosamente consegnandoci un processo inaccessibile ed ibrido - perché né cartolare né pubblico - che non ci ha consentito, con lo strumento del racconto, di adempiere alla funzione di controllo dell’esercizio del potere giudiziario.
Quanto i tempi di durata del processo influiscono sul modo di fare cronaca giudiziaria?
Un processo che dura tanto non può essere narrato e quindi, per questo verso, controllato. Si può controllare l’estrinseco, ovvero riferire dei lunghi rinvii, della mancata e ripetuta trattazione, ma si perde il controllo sul fatto, sulla gravità dello stesso perché se il suo accertamento vien diluito troppo nel tempo fisiologicamente l’attenzione giornalistica cala e soprattutto per vicende che invece meriterebbero sempre i riflettori accesi, il buio non giova, a tutti i livelli.
Quali processi vengono narrati dalla cronaca giudiziaria?
Per come la intendo io, la scelta su cosa raccontare è totalmente svincolata dalle categorie giuridiche. Non è detto che la cronaca giudiziaria racconti solo di reati.
La prospettiva giornalistica è, a mio avviso, differente da quella degli operatori della giustizia perché non deve tenere conto degli effetti penali della condotta, ma dell’interesse pubblico alla narrazione di un fatto.
Da questo punto di vista ci sono fatti di reato inenarrabili: un processo avente ad oggetto una grande evasione fiscale, a meno che non sia stata commessa da un personaggio pubblico, solitamente non si racconta perché si tradurrebbe in una mera elencazione di numeri. Si racconta il fatto di sangue, il crimine efferato, ma si racconta soprattutto il non reato, che tuttavia riveste interesse perché consente all’opinione pubblica di comprender persone e sistemi, a prescindere dalla loro responsabilità penale. Spesso una delle rettifiche che pubblichiamo consiste nel chiarimento del soggetto coinvolto di non essere indagato, quando l’editore mi consente due righe di replica, in maniera standardizzata, evidenzio che il dato non toglie interesse alla comunicazione che lo riguarda.
Da esperta di comunicazione come giudica la comunicazione istituzionale del mondo giustizia?
Distinguerei due livelli. La comunicazione che avviene tramite i provvedimenti e la comunicazione istituzionale.
Sovente la comunicazione effettuata “in nome del popolo italiano” è ostica e difficilmente comprensibile. In questo caso, il ruolo del giornalista è di fare da medium per restituire al lettore una coincidenza intellegibile tra significante e significato. E in presenza di una decisione non chiara è possibile avere quale medium un giornalista che si informa sul contenuto in maniera approfondita o uno che, al contrario, non cogliendo il senso del provvedimento offre una informazione non del tutto corretta.
Quanto alla comunicazione istituzionale io vorrei chiarire che per quanto chiara nella forma e completa nella sostanza non è la comunicazione che a me serve per fare cronaca giudiziaria, o meglio, non è la comunicazione che mi consente, da sola, di fare una buona cronaca giudiziaria.
Scendendo nel concreto, il comunicato stampa, ad esempio, può essere considerato una forma idonea di informazione dal punto dell’ufficio perché un punto di vista parziale sul quale il giornalista non deve assolutamente appiattirsi, in primo luogo perché la verità può coincidere o meno con la verità processuale del comunicato stampa, e poi perché non è detto che l’interesse pubblico coincida con il contenuto della voce ufficiale dell’ufficio, perché potrebbe invece riguardare fatti e persone non menzionate nel comunicato.
Quale tra le comunicazioni provenienti dalla giustizia non Le piace?
Non mi piace la comunicazione di potere, la conferenza stampa indetta per affermare la superiorità di un ufficio su un altro o sulla polizia giudiziaria.
E quale narrazione della giustizia non le piace?
Non mi piace quando noi giornalisti diventiamo uno strumento e ci prestiamo a raccontare solo una parte del tutto, presentandola come la verità assoluta. Perché ciò non accada bisogna mantenere integra la tensione ad offrire al lettore tutte le notizie, tutte le versioni fornite, in maniera ufficiale o ufficiosa, e sottoporre prima a verifica e poi a critica ciò che viene veicolato. Il mio monito per i colleghi più giovani è di chiedere, informarsi, verificare in maniera ossessiva e solo dopo chiedersi se vi è un interesse pubblico a diffondere una notizia data da una sola delle parti ed interrogarsi sul se e su come farlo.
Le è capitato di essere stata strumento di qualcuno?
Consapevolmente no, perché in maniera caparbia ho sempre valutato in maniera autonoma tutto ciò che mi è stato consegnato dalle fonti.
Le fonti dell’informazione giudiziaria non sono mai cambiate, la notizia la dà chi ce l’ha. Ed allora ciò che conta è mantenere autorevolezza con le fonti, così che sia già chiaro, prima di ogni tentativo, che io, per stile, modo di fare, scelte, non sarò certo lo strumento che cercano. E questo discorso vale nei confronti di tutti. Non bisogna divenire la voce della Procura così come non bisogna divenire il megafono della difesa. E per fare ciò bisogna non valicare i limiti di ciò che è possibile fare, per non dover essere “costretti a ricambiare il favore” e bisogna mantenere quale fede incrollabile l’obiettivo di raccontare il tutto e non solo un frammento dell’accaduto.
Come vive i limiti stabiliti per la comunicazione da parte dei magistrati? Come influenzano il suo lavoro?
Su questo bisogna intenderci e non essere ipocriti. Se è vero, ad esempio, che negli uffici di procura la comunicazione ufficiale è del Procuratore, è altrettanto vero che per piccoli chiarimenti o dettagli su cose di interesse pubblico nessun pubblico ministero mi ha mai invitato a lasciare il suo ufficio.
Quanto è stato difficile essere una cronista giudiziaria, nel senso che le è proprio in terra di camorra?
Fare la cronaca giudiziaria è stato facilissimo. Mi sono concentrata sull’aspetto umano di personaggi anche molto malvagi. La mia naturale vocazione a capire e verificare mi ha portato ad approfondire aspetti che per gli altri giornalisti non meritavano attenzione e così piano piano i miei racconti erano più dettagliati e completi, e offrivano anche a chi indagava spunti inediti. Voler conoscere anche al di là di ciò che accadeva nelle aule di giustizia per me è stato naturale, subire le conseguenze di questa narrazione inedita, e proprio per questo scomoda, è stato chiaramente la parte più complicata.
Lei vive sotto scorta ormai da molti anni, cosa significa per Lei?
Significa rinunciare a fare molte cose. Leggerezze che non mi apparterranno mai più, e non è facile.
Significa però anche sicurezza e rapporti e relazioni umane molto importanti.
Carta stampata e giornalismo televisivo, come cambia la cronaca giudiziaria?
La carta stampata è stata sempre il mio mondo e sempre lo sarà.
La cronaca giudiziaria, come la intendo io, è lontana dalla comunicazione televisiva, salvo la narrazione fatta di telecamera fissa e qualche commento tecnico finale di “un giorno in pretura” non apprezzo altro.
I programmi spesso diventano l’atecnico luogo di celebrazione di un processo alternativo privato della sua storia, e pertanto una narrazione monca che, inaccettabilmente, spesso non ha alcun contatto con le carte.
Lei è stata Senatrice della Repubblica, come questa esperienza ha influito sulla sua comunicazione dei meccanismi del potere legislativo?
Sicuramente dall'interno si capiscono meglio gli schemi di funzionamento di una macchina burocratica estremamente complessa altrimenti davvero difficile da raccontare. Stando in Senato ho visto le cause degli effetti di cui discorrevo nella mia vita antecedente l’esperienza politica.
Quanto al contatto con il potere posso dire che il potere che ho raccontato era più definito del potere che ho visto, dall’interno si percepisce soprattutto un magma indefinito, il potere si sente ma non si vede, nei miei racconti era sicuramente molto più delineato di come l’ho percepito nelle sedi che gli sono proprie.
Un’ultima domanda: Lei che per lavoro ascolta la gente ci dica, come la collettività percepisce la magistratura?
Secondo me la stima è bassissima, non c'è fiducia nella magistratura e la principale causa di questa disistima deriva dall’osservazione dei comportamenti della vita quotidiana dei magistrati, dal loro venir meno ai valori che sono chiamati a far rispettare.
A questo vanno aggiunte la lentezza della giustizia e gli errori giudiziari, fattori che oltre a gettare discredito e dubbi sul funzionamento della macchina giudiziaria consegnano i cittadini in mano a giustizie parallele illecite più funzionali, o percepite come tali. La crisi che investe la magistratura è la stessa che travolge il giornalismo, finché siamo in tempo dovremmo fare, ognuno per ciò che lo riguarda, un ritorno serio a comportamenti che siano d’esempio in quanto traducenti nei fatti un solido sistema valoriale.
La Corte di cassazione sulla sindrome di alienazione parentale: è colpa d’autore?
Nota a Corte di cassazione 17 maggio 2021 n. 13217, Pres. Genovese, est. Caiazzo
di Rita Russo
Sommario: 1. Il caso della madre malevola - 2. L’affidamento super esclusivo - 3. La sindrome di alienazione parentale.
1. Il caso della madre malevola
Una lunga battaglia legale per l’affidamento di una bambina, con alterne vicende nei giudizi di merito, approda in Cassazione.
I processi di affidamento dei minori sono difficili da gestire in sede di legittimità, perché le valutazioni di fatto, notoriamente incensurabili in cassazione, hanno sempre ampio spazio nelle motivazioni dei giudici di primo e secondo grado e talora prevalgono sulle valutazioni in diritto. La materia è regolata da principi e clausole generali quali la primaria considerazione del miglior interesse del minore e la tutela della relazione familiare, la cui concreta attuazione si lega inevitabilmente alle specifiche del caso concreto, a fatti accertati e inquadrati nel tempo e nello spazio e quindi, in definitiva, al giudizio di merito. Ciononostante, anche la valutazione di merito è censurabile in cassazione, se il giudice non segue i criteri legali procedimentali che devono presiedere alle decisioni.
Arriva dunque in cassazione la storia di un rapporto conflittuale tra genitori; la bambina, in età scolare, è stata affidata al padre (affido super-esclusivo), sulla base di quanto emerso in due consulenze tecniche d’ufficio, in primo ed in secondo grado, con risultati sostanzialmente conformi.
È stata diagnosticata la “sindrome della madre malevola” rilevando un elevato grado di conflittualità tra i genitori, con difficoltà comunicative e gravi carenze delle capacità genitoriali della madre, la quale non accetta il ripristino delle relazioni tra padre e figlia, e vorrebbe esclude il padre dal rapporto con la stessa; a ciò si aggiunge l'influenza della famiglia materna (in particolare della nonna), con prospettive dannose e rischiose. Alla madre si addebitano comportamenti “scellerati” quali il procurarsi falsi certificati di malattia per far assentare la bambina da scuola e così impedire al padre di portarla con sé.
La madre reagisce al provvedimento che modifica in termini così rigorosi l’affidamento della figlia, ricorrendo per cassazione e contestando la validità scientifica della diagnosi di “sindrome della madre malevola”, deducendo che si tratta nella sostanza di una diagnosi di sindrome di alienazione parentale (PAS), sia pure non esplicitata, cui la Corte d'appello ha aderito acriticamente.
La Corte di cassazione accoglie questa censura e osserva, richiamando precedente giurisprudenza della stessa Corte, che al fine di modificare l’affidamento del minore non è sufficiente la diagnosi di una patologia; il giudice è tenuto ad accertare la veridicità comportamenti pregiudizievoli per la minore, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia diagnosticata.
La Corte di legittimità ricorda inoltre che qualora venga esperita una consulenza tecnica d’ufficio le relative conclusioni non possono essere acriticamente recepite dal giudice, specie se all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure.
Fin qui l’enunciazione di principi di diritto. La Corte passa poi ad un esame più penetrante, ritenendo non convincenti le conclusioni della consulenza, il cui contenuto è considerato in molti punti generico e non chiaro in ordine alla carenza delle capacità genitoriali della ricorrente; anche le condotte pregiudizievoli sono state solo genericamente enunciate. Si rileva quindi che la Corte d'appello, nel disporre l'affidamento esclusivo della minore al padre, ha escluso l'affidamento condiviso su una astratta prognosi circa le capacità genitoriali della ricorrente, fondata, in sostanza, su qualche episodio, attraverso cui la madre avrebbe tentato di impedire che il padre incontrasse la bambina, senza però effettuare una valutazione più ampia, e senza considerare la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali della madre. E, pur non entrando nel merito della validità scientifica della diagnosi, la Corte conclude nel senso che i fatti ascritti dalla Corte territoriale alla ricorrente non presentano la gravità legittimante la pronuncia impugnata, in mancanza di accertate, irrecuperabili carenze d'espressione delle capacità genitoriali.
Si tratta di considerazioni molto incisive, in cui il giudice di legittimità sembra diminuire considerevolmente il suo tradizionale distacco dal fatto ed esprimere valutazioni di merito, pur non avendo avuto un accesso diretto agli atti, ma solo sulla base dell’esame motivazione e cioè di una sintesi delle emergenze processuali e delle ragioni della decisione, e nell’implicita considerazione che la rigorosa giurisprudenza della Corte Edu in tema di interruzione dei rapporti tra il minore ed uno dei due genitori impone grande cautela[1].
La Corte, però, rese queste considerazioni che servono ad individuare gli errori cui dovrà porre rimedio il giudice di rinvio, la cui decisione è già fortemente indirizzata dalla valutazione di non gravità dei fatti a carico della madre, esprime anche un'altra considerazione di carattere più generale, osservando che la decisione impugnata appare “espressione di una inammissibile valutazione di tatertyp, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di "colpa d'autore" connessa alla postulata sindrome” .
Forse, ancora più della sensibilità ai richiami della Corte di Strasburgo[2], è questa la vera ragione ed il fulcro centrale della decisione, e cioè l’esigenza di negare, anche nell’ambito del diritto di famiglia, che nel processo si giudichi (e se il caso si sanzioni) non tanto il fatto commesso, quanto piuttosto il modo d’essere dell’agente. In altre parole, non è ammissibile far discendere dalla diagnosi di una patologia, anche se scientificamente indiscussa e a maggior ragione se dubbia, una presunzione di colpevolezza o di inadeguatezza al ruolo di genitore, scissa dalla valutazione in fatto dei comportamenti. Nel processo si giudica questi ultimi e non la persona, e pertanto è dall’osservazione e dall’analisi dei comportamenti che occorre muovere; la diagnosi può aiutare a comprenderli e soprattutto a valutare se sono emendabili, ma non può da sola giustificare un giudizio -o pregiudizio- di pericolosità a carico del soggetto.
2. L’affidamento super-esclusivo
L’affidamento esclusivo, nel nostro sistema normativo, è ipotesi residuale ma non di scarsa importanza, perché trova applicazione quando il giudice ritenga dimostrata la violazione dei doveri o abuso dei poteri connessi alla responsabilità genitoriale ovvero la sussistenza di una condotta pregiudizievole per la prole.
Di conseguenza, se ne valuta l’applicabilità nei casi di genitori fragili, patologici, disinteressati, inadempienti, aggressivi. Non è però sufficiente accertare la fragilità o la inadeguatezza del genitore, perché il provvedimento di affidamento deve essere modellato dal giudice caso per caso, e pertanto è necessario indagare in concreto sulle cause della inadeguatezza del genitore e sulla emendabilità, totale o parziale, delle carenze riscontrate perché l’art. 337 quater c.c. consente invero di derogare alla regola, ma al tempo stesso impone di fare salvi, nei limiti del possibile, i diritti del minore [3].
Lo schema legale dell’affidamento esclusivo come descritto dall’art. 337 quater c.c. comma secondo, con decisioni di maggior interesse attribuite ad entrambi, non è sensibilmente differente dall’affidamento condiviso con poteri disgiunti sulle questioni di ordinaria amministrazione. Si vuole con ciò mantenere inalterato, nei limiti del possibile, quel doveroso compito genitoriale di collaborare nell’interesse del minore e di consultarsi prima di assumere decisioni che ne orientano la cura, educazione ed istruzione.
La differenza si avverte invece se il giudice dispone limitazioni della responsabilità genitoriale, ove ciò sia funzionale ad evitare pregiudizio per il minore.
L’affidamento super esclusivo è un assetto in cui queste limitazioni si estendono fino ad estromettere il genitore ritenuto inadeguato dalla funzione decisoria insita nella responsabilità genitoriale, e in cui si consente al genitore affidatario di adottare tutte le decisioni riguardanti il minore, anche senza il consenso dell'altro genitore, cui resta però il potere dovere di vigilare sulle scelte compiute dall’altro e se il caso di ricorrere al giudice, qualora le ritenga pregiudizievoli per il minore stesso.
Dette limitazioni si pongono come deroghe alla regola generale della pariteticità dei compiti parentali e quindi devono essere giustificate da una ragione forte e specificamente individuata.
Inoltre, si deve ricordare che affidamento, collocamento e diritto di visita costituiscono aree di intervento diverse e quindi è possibile che l’affidamento sia modellato secondo un regime decisorio fortemente limitativo della partecipazione di un genitore, ma al tempo stesso quel genitore, pur se escluso dalle decisioni che riguardano la vita del minore, possa continuare a frequentarlo ed anche in taluni casi a prendersi cura di lui, ove le capacità di accudimento siano intatte.
Nel disporre l’affidamento si valuta non soltanto con chi deve andare a vivere il bambino, ma anche chi, come e con quali eventuali limitazioni deve esercitare la responsabilità genitoriale. Affidare un minore significa infatti attribuire una responsabilità riguardo le funzioni di cura, educazione ed istruzione del minore e lo strumento per esercitare tali funzioni non può che individuarsi nell’esercizio della responsabilità genitoriale. È netta, nel nostro ordinamento la differenza tra la physical custody e cioè il collocamento e la ripartizione dei tempi di vita del minore, uguale o diseguale, tra i genitori, e la legal custody, vale a dire il potere-dovere di assumere le decisioni che riguardano la vita del minore.
La interruzione dei rapporti non è quindi necessariamente connessa ad un affidamento super esclusivo; inoltre occorre tenere presente che la stessa Corte Costituzionale ha affermato che la interruzione della relazione tra genitori e figli sul piano giuridico, ma anche naturalistico, si giustifica solo in funzione di tutela degli interessi del minore[4].
Non è tuttavia facile definire, in concreto, che cosa debba intendersi per best interests of the child, cioè il miglior interesse del minore, o, come taluni traducono dalla versione in lingua francese, interesse superiore del minore.
In un noto caso di sottrazione internazionale, la Corte Edu ha affermato che l’interesse del minore comprende tanto l’interesse a mantenere regolari rapporti con i genitori quanto l’interesse a crescere in un ambiente sano, stabile e affidabile (sound enviroment). Il contatto con la famiglia si può recidere solo se essa è “particularly unfit”[5]. In questa come in altre decisioni, la Corte di Strasburgo sembra adottare una sorta di presunzione, secondo la quale il miglior interesse dei figli è mantenere rapporti con entrambi i genitori, salvo che siano particolarmente inadatti, rapporto che lo Stato ha il dovere di garantire, con una adeguato “arsenale” di misure positive e salvo ricorrano circostanze di particolare gravità[6].
3. La Sindrome di alienazione parentale
La PAS (Parental Alienation Syndrome), nella descrizione offerta dallo psicologo forense nordamericano Richard Gardner, è un disturbo provocato da un comportamento genitoriale di progressiva svalutazione agli occhi del figlio dell'altro genitore, al fine di rendere difficili i rapporti tra i due. Il minore si trasforma in un veicolo dei sentimenti e delle idee del genitore alienante, che opera il brainwashing (indottrinamento) sul minore, creando una relazione singolare in cui il genitore alienante porta il minore a percepire come propri i sentimenti di odio e rivalsa nei confronti dell’(ex) partner, così determinando il c.d. allineamento o schieramento del bambino con il genitore manipolante.
Diversi specialisti non riconoscono la validità della diagnosi; la teoria non avrebbe basi scientifiche e si fonderebbe soltanto sul pregiudizio indimostrato che, ogniqualvolta viene presentata una denuncia di abuso, vi sarebbe un comportamento patologico della madre, nonché su particolari idee sull’abuso sessuale attribuite a Gardner.
Gli specialisti che condividono e recepiscono la tesi di Gardner o talune sue varianti come ad esempio la P.A.D. (Parental Alienation Desorder) ovvero quelle relative ai "conflitti di lealtà", spesso suggeriscono di allontanare il minore dal genitore che opera il brainwashing, come si farebbe nel caso del genitore abusante o maltrattante. In altri casi si è parlato di “sindrome di Medea” prendendo mosse dal mito greco che vede Medea uccidere i figli per punire il tradimento di Giasone, oppure utilizzate altre definizioni più o meno suggestive. In qualche caso l’accento è sul profilo personologico della madre, in altre sul comportamento di strumentalizzazione di un rapporto privilegiato con i figli, usati come arma nel conflitto con l’ex partner.
Il contatto tra il bambino e il genitore patologico sarebbe dunque da interrompere, allontanando il minore dal genitore “malato”.
Questo suggerimento “terapeutico” talvolta ben si addice alle caratteristiche del caso, ma non può assumersi a regola fissa, perché non è detto che il comportamento manipolativo dipenda da una patologia e non è detto che interrompendo il contatto la questione si avvii a risoluzione: si pensi ad esempio al caso del genitore che cerca di sostenere le proprie rivendicazioni economiche rendendone partecipe i figli che così iniziano a percepire il padre come soggetto inadempiente; è un comportamento censurabile, ma non necessariamente frutto di una patologia, anzi potrebbe affondare la proprie radici in una “colpa” dell’altro genitore; quanto questo comportamento sia indicativo di scarsa capacità genitoriale è una valutazione da rendere nel contesto dell’intera vicenda, raffrontandolo anche con il comportamento dell’altro.
Inoltre, mentre è (relativamente) facile allontanare il bambino dal genitore abusante, è difficilissimo allontanare un minore da un genitore manipolante. Questi genitori hanno di solito altissime performance di accudimento e cura e il minore, se è schierato con il genitore manipolante, è a lui (più spesso a lei) fortemente legato e si oppone con tutte le sue forze ad esserne allontanato. Questo non significa che il miglior interesse del minore si persegua soltanto prendendosene cura materiale, perché anche l’aspetto educativo ha la sua importanza e la rescissione del legame affettivo con l’altro genitore può avere conseguenze, più evidenti nel lungo periodo, sulla sua armonica crescita.
La Corte di cassazione si è già occupata in passato della PAS affermando che il giudice del merito deve verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale[7], ma anche che non è solo attraverso la consulenza tecnica che si possono accertare questi comportamenti pregiudizievoli perché il giudice ha a disposizione tutti i mezzi di prova propri del processo civile ed anche uno strumento specifico, quale è l'ascolto del minore, che però non è un mezzo di prova bensì la modalità attraverso la quale il minore esercita il suo diritto di partecipare al processo e di esprimere la sua opinione sulle scelte di vita che lo riguardano[8].
La sentenza in esame, con il suo forte richiamo all’accertamento dei fatti, completa il quadro. La sentenza contiene inoltre un importante riferimento (e qui si avverte forte l’eco della giurisprudenza della Corte Edu) al dovere del giudice di approntare misure per il recupero di una relazione familiare sana.
In questo delicato settore però non è consigliabile usare la coercizione, ma è necessaria la collaborazione di tutte le parti interessate, temendo presente che il decorso del tempo senza che sia stabilito un contatto tra genitore ed il figlio può pregiudicare irrimediabilmente la relazione familiare[9]. Il giudice non può limitarsi a delegare ai servizi sociali un generico controllo e monitoraggio della situazione, ma deve, anche d'ufficio, ricorrere a tutti i mezzi possibili per tutelare la relazione familiare, e tra questi l'affidamento a terzi, le sanzioni aventi finalità dissuasive e la mediazione[10].
Da ricordare, tuttavia, che se pure è compito del giudice informare i genitori sui benefici della mediazione familiare e sottoporre loro l'opportunità di intraprendere un simile percorso, ovvero un percorso di sostegno psicologico e di miglioramento della genitorialità, né la mediazione né la psicoterapia possono essere imposte dal giudice agli adulti, ma sono scelte rimesse alla autodeterminazione delle parti[11].
[1] V. DE MARZO: Sindrome di alienazione parentale e salvaguardia del rapporto familiare: i doveri motivazionali del giudice di merito, in Foronews www.foroitaliano.it 20 maggio 2021
[2] Corte Edu: Piazzi c. Italia, 2.11.2010 n. 36168/09 Lombardo c. Italia 29.1.2013 n.25704/11; Santilli c. Italia, 7.12. 2013, n. 51930/10, tutte in www.giustizia.it (sito del Ministero della Giustizia); v. anche A.I. c. Italia1.4. 2021.
[3] Sia consentito il rinvio a R. Russo Affidamento esclusivo e super esclusivo: l’interesse del minore richiede flessibilità, in Fam. e dir. 2019, 10, 891
[4] V. Corte Cost. 23.1.2013 n. 7 in www.cortecostituzionale.it
[5] Corte Edu Neulinger e Shuruk c. Svizzera, 6.7.2010; in dottrina: LONG Il principio dei best interests e la tutela dei minori, in Questione Giustizia, speciale Corte Strasburgo, aprile 2019.
[6] V. nota n.2
[7] Cass. civ. sez. I 20.3.2013 n. 7401, in Dejure
[8] Cass. civ. sez. I 09.6.2015 n. 11890; Cass. civ. sez. un. 21.10. 2009 n. 22238, in Dejure
[9] Corte Edu, sez. IV, 17.11.2015, B. c. Italia
[10] Cass. civ. sez. I 22.5. 2014 n. 11412; Trib. Reggio Emilia, sez. I, 11.06.2015;Trib. Roma 10.5.2013; Trib. Messina 8.10.2012; Trib. Varese 3.2.2011, tutte in Dejure
[11] Cass. civ., sez. I, 01.07.2015, n. 13506, in Dejure
Osservazioni al maxi-emendamento 1662/S/XVIII di riforma del processo civile
di Giuliano Scarselli
Sommario: 1. Le proposte condivisibili - 2. Le proposte non condivisibili - 3. Una precisazione sui nuovi provvedimenti di condanna o di rigetto in via breve - 4. Una seconda precisazione sulla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda - 5. La riforma e l’obiettivo di ridurre i tempi dei processi - 6. Segue: il correttivo da porre.
“È chiaro che la nomina di un numero di magistrati corrispondenti, nei singoli gradi gerarchici, al bisogno del pubblico servizio, è una delle condizioni per cui lo Stato adempie il suo obbligo di organizzare l’amministrazione della giustizia”
MORTARA, Istituzioni di ordinamento giudiziario, Firenze, 1919, 85.
1. Le proposte condivisibili.
È stato diffuso in questi giorni l’articolato relativo al maxi-emendamento 1662 di riforma del processo civile.
Si tratta di un emendamento molto ampio, che certamente contiene delle proposte positive.
Senza preamboli, mi accingo a sottolinearle:
a) seppur non sia un amante della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, devo riconoscere che molte delle scelte fatte in punto di mediazione appaiono di buon senso.
Condivisibili gli incentivi fiscali che si prevedono per le parti che riescano a mediare; condivisibile che la legge precisi in modo chiaro chi debba attivare la mediazione in caso di opposizione a DI; condivisibile, ancora, che si preveda in modo espresso che la condizione di procedibilità della domanda è assolta quando le parti non raggiugano l’accordo al primo incontro e non manifestino intenzione di proseguire con l’attività di mediazione; condivisibile la previsione di farsi rappresentare in sede di mediazione, in presenza di giustificasti motivi, da un terzo: ancora, condivisibile la scelta di favorire la mediazione anche con i soggetti pubblici, prevendendo che non vi sia responsabilità contabile in tutte le ipotesi nelle quali il contenuto dell’accordo rientri nei limiti del potere decisionale; condivisibile, di nuovo, che in casi di nomina dell’esperto la relazione possa poi esser prodotta in giudizio e sia rimessa alla libera valutazione del giudice; certamente condivisibile, inoltre, che si proceda ad una verifica statistica circa l’opportunità di mantenere la condizione di procedibilità dell’azione; ed infine, ripeto, seppur con i dubbi che possa avere chi come me non ami l’istituto della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, ragionevole è da ritenere che questa sia stata estesa ai rapporti giuridici contrattuali di durata, ovvero a quei rapporti dove trovare una soluzione dei contrasti è maggiormente necessario.
b) Per quanto concerne il processo di cognizione, trovo corretto voler salvare quelle novità che abbiamo sperimentato a seguito dell’emergenza Covid 19, se queste, effettivamente, possono agevolare il lavoro degli avvocati e dei giudici senza pregiudicare il diritto alla difesa.
E così, mi pare ragionevole che si preveda che, fatta salva la possibilità per le parti di opporsi, il giudice disponga che le udienze civili, che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si svolgano con collegamenti a distanza, e che addirittura il giudice debba disporre che le udienze siano sostituite con il deposito telematico di note scritte se vi è richiesta congiunta di tutte le parti costituite.
c) Trovo altresì condivisibile l’aver mantenuto l’atto di citazione, che molti avevano già dato per morto, e ciò, se non altro, per rispetto ad una tradizione antichissima, si dice risalente addirittura alle 12 tavole.
d) Trovo poi condivisibile che non si sia fatto del procedimento sommario di cui all’art. 702 bis e ss. c.p.c. il rito principale, se non addirittura unico, del giudizio di cognizione di primo grado, e che lo stesso si chiuda con sentenza e non con ordinanza, al fine di superare quelle problematiche che in questi anni abbiamo avuto con riferimento all’interpretazione dell’art. 702 quater c.p.c.
d) Trovo, ancora, condivisibile che si preveda, seppur in forme che al momento restano generiche, un aumento delle competenze del giudice di pace, in modo da lasciare al Tribunale le controversie più complesse e di maggiore rilevanza, anche economica.
e) Condivido inoltre che non si siano introdotte rilevanti novità con riferimento ai mezzi di impugnazione, martorizzati da mille riforme negli anni passati, ed in particolare condivido che non siano stati introdotti ulteriori, significativi filtri, che avrebbero costituito nuovi discutibili limiti ai diritti processuali garantiti dalla carta costituzionale. Condivisibile, poi, in questo contesto, l’unificazione del procedimento camerale in cassazione con l’eliminazione delle differenze di cui agli artt. 380 bis e 380 bis 1 c.p.c.
f) Ed infine, è condivisibile che non sia provveduto, secondo voci che invece da tempo circolavano, a creare ipotesi di decisioni arbitrali fissate ex lege, perché, tutto al contrario, si deve ricordare che l’intervento degli arbitri, se non richiesto congiuntamente da tutte le parti, è incostituzionale per violazione (almeno) dell’art. 102 Cost.
2. Le proposte non condivisibili.
Altri punti non mi sembrano invece convincenti.
In particolare:
aa) non condivido che una pronuncia di inammissibilità dell’appello possa esser data anche a seguito di trattazione orale, poiché credo che la difesa scritta sia invece coessenziale al diritto al contraddittorio in un processo civile.
bb) Non trovo poi condivisibile il nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione da parte del giudice di merito per la decisione di una questione di diritto previsto dall’art. 6 bis del progetto, poiché mi sembra strumento che contrasti con più di un principio giuridico, tra i quali quello che ogni giudice è giudice della sua competenza, e quindi che una decisione che spetta ad un giudice deve essere decisa da quel giudice, secondo scienza e coscienza, e non da altri, e quello del diritto dei cittadini di ricorrere in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che potrebbe evidentemente essere limitato da questo strumento preventivo. E ciò, oltre al fatto che questa novità potrebbe essere usata in senso dilatorio dai giudici di merito, e costituire grave ritardo nell’andamento del processo, con pari inutile aggravio del lavoro della Corte di cassazione; né ancora penso possa attribuirsi alla Corte di cassazione un ruolo simile a quello della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell’Unione europea, alle quali, effettivamente, si rimettono le questioni pregiudiziali.
cc) Non condivido, inoltre, la scelta fatta sub art. 3 in base al quale tanto l’atto di citazione quanto la comparsa di risposta debbono, a pena di decadenza, contenere l’indicazione specifica dei mezzi di prova.
Non condivido detto avanzamento delle preclusioni istruttorie perché il processo civile non può essere assimilato a quello del lavoro, e perché, nei limiti del possibile, è sempre preferibile optare per soluzioni di libertà, che meglio consentono agli avvocati di poter recuperare possibili errori, e quindi alla giustizia di poter decidere nel merito piuttosto che su errori o carenze processuali.
dd) Soprattutto, non condivido la nuova disposizione dell’art. 14, secondo la quale il soccombente può esser condannato, anche d’ufficio, a pagare in favore della controparte una somma equitativamente determinata, e in favore della cassa delle ammende una somma non superiore a cinque volte il contributo unificato.
Si tratta di una disposizione a mio parere del tutto incostituzionale, sia perché non può essere rimessa alla mera discrezione del giudice la determinazione di una sanzione (che, nel caso sia in favore della controparte, non conosce infatti limiti indicativi nemmeno di massima), e sia soprattutto perché non può essere sanzionato l’esercizio del diritto di azione e/o di difesa, visto che, indiscutibilmente, l’art. 24 Cost. comprende nel suo seno anche l’esercizio dell’azione infondata, e nessun’altra conseguenza può avere così il soccombente se non il pagamento delle spese processuali.
L’esperienza concreta ci insegna poi che i giudici non separano le domande infondate da quelle promosse con mala fede o colpa grave, e fanno di tutta l’erba un fascio (abbiamo sperimentato ciò sia con riferimento al pagamento del raddoppio del contributo unificato, sia con riferimento all’applicazione del 2° comma dell’art. 283 c.p.c.); dal che non è pensabile che il soccombente debba sopportare simili sanzioni, e che l’esercizio del diritto di azione sia sottoposto al ricatto permanente di minacce economiche.
A questo fine mi solleva ricordare ancora una volta il pensiero di due grandi statisti del passato quali Pasquale Stanislao Mancini e Luigi Einaudi.
Mancini scriveva che “l’amministrazione giudiziale e la garanzia dei diritti è il primo e più sacro debito dell’autorità sociale” e che, se si introducono ostacoli, costi o sanzioni all’esercizio dell’azione in giudizio, allora “una comune prudenza determinerà sovente il cittadino a sopportare in pace torti anche gravi piuttosto che ricorrere a mezzi cotanto onerosi di riparazione. Allora le liti diverranno il lusso dei ricchi, la giustizia un loro privilegio e non un bene ed un diritto egualmente garentito a tutti” (in Mancini – Pisanelli – Scialoja, Commentario del codice di procedura civile per gli stati sardi, Torino, 1855, II, 9).
Luigi Einaudi sosteneva il principio della gratuita della giustizia quale momento fondamentale delle funzioni dello Stato, al pari della difesa nazionale e della sicurezza, e affermava senza mezzi termini che “Al litigante non è logico far pagare qualcosa (tassa, in qualunque modo congegnata, di bollo o di registro o altra) in aggiunta alle imposte che egli già pagò, come cittadino, per mettere in grado lo Stato di esercitare l’ufficio suo” (così Einaudi, Imposte e tasse giudiziarie, Riv. Dir. fin. 1937, I, 359).
Oggi, affermare un principio, che pure sarebbe evidente e logico, quale quello della gratuità del servizio giurisdizionale, non è possibile, e ragioni di cassa fanno sì che appaia invece legittima la pretesa fiscale dello Stato a fronte dell’iniziativa delle parti di far valere un diritto in giudizio.
Ma usare i tributi e le sanzioni quali mezzi per indurre il cittadino a non chiedere giustizia, fino a terrorizzarlo per le conseguenze economiche che l’aver adito il giudice potrebbe avere (quintuplo del contributo unificato e triplo delle spese liquidate), non è solo del tutto incostituzionale perché in violazione dell’art. 24 Cost., e non è solo qualcosa che, come già diceva Mancini nel secolo XIX, danneggia i ceti più deboli in deroga al nostro odierno art. 3 Cost., ma è il segno, evidente, di un cedimento culturale al quale dobbiamo opporre resistenza.
3. Una precisazione sui nuovi provvedimenti di condanna o di rigetto in via breve.
Ciò premesso, alcune precisazioni.
L’art. 3 e-decies 1 recita: “prevedere che il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate”.
Orbene, di questa riforma non posso lamentarmi, poiché essa assomiglia molto alla condanna con riserva che io propongo fin dalla fine degli anni ’80, e che recentemente ho riformulato con un breve scritto (ID, Sul principio secondo il quale i tempi del processo devono andare a danno della parte che ha bisogno della trattazione della causa, ovvero su una proposta di riforma per l’efficienza del processo civile a costo zero, Judicium, ottobre 2020).
Tuttavia sia consentito rilevare che la cosa andrebbe a mio parere formulata in termini un po’ diversi.
La proposta di riforma, direi in gran parte, è collegata alla novità delle preclusioni istruttorie fin dagli atti introduttivi del giudizio, cosicché il giudice può pronunciare in questo modo un provvedimento sommario di condanna, o di rigetto della domanda, anche a seguito della prima udienza. Ed in tal contesto, poiché la creazione di questi nuovi provvedimenti da pronunciare in via breve è sembrata al riformatore evidentemente audace, si è previsto, quasi a compensazione, che questi non formino comunque cosa giudicata ai sensi dell’art. 2909 c.c. (così l’art. 3 e-decies).
Orbene, alcune osservazioni.
In primo luogo, se il giudice può pronunciare una condanna in limine litis nelle ipotesi in cui la posizione di un litigante sia completa e soddisfacente e l’altra no, allora lì direi, in verità, noi non abbiamo più bisogno della preclusione agli atti introduttivi del giudizio fissata ex lege, perché la preclusione, anche senza espressa previsione, sorge egualmente quale necessità delle parti di presentarsi al giudice fin dalla prima udienza in modo completo ed esaustivo sotto tutti i punti di vista.
Dunque, l’esistenza di questi provvedimenti già di per sé induce le parti a essere complete fin con gli atti introduttivi; e così, se possiamo ottenere quel risultato senza imposizione, il legislatore non deve allora porre l’obbligo, poiché al contrario è preferibile attenersi ad un principio di libertà, se questo è possibile.
Oltre a questo, sottolineo:
a) che la fattispecie che consente l’emanazione della condanna in via breve in favore dell’attore che ha già fornito al giudice la prova dei fatti costitutivi non può completarsi con l’esistenza di difese del convenuto che “appaiono manifestamente infondate”, poiché non può introdursi una differenza tra “difese infondate” e “difese manifestamente infondate”, ove solo quest’ultime consentirebbero l’emanazione del provvedimento di condanna. Si tratta infatti di una distinzione troppo labile che, come tale, potrebbe generare confusione, oppure attribuire al giudice poteri discrezionali troppo ampi. Dal che, insisto, il provvedimento deve esser concesso non quando, a fronte della prova dei fatti costitutivi, le difese del convenuto sono “manifestamente infondate” ma quando il convenuto non sia riuscito a fornire la prova di almeno un fatto impeditivo, modificativo o estintivo dei fatti costitutivi già provati in giudizio dall’attore.
b) Inoltre, questo provvedimento funge da sé, ed evidentemente, quale deterrente alla prosecuzione del giudizio, ma esso non può darsi come provvedimento che necessariamente lo chiude; e la soluzione di compromesso di chiudere il processo senza al contempo attribuire al provvedimento autorità di cosa giudicata non sembra convincente, poiché l’assenza della forza del giudicato, anche in una ottica di economia processuale, aumenta, e non diminuisce, il contenzioso, visto che il convenuto ha così la possibilità di proporre una nuova lite alla quale seguirebbero almeno due nuovi processi: quello in accertamento negativo rispetto alla condanna pronunciata, e quella in opposizione all’esecuzione avverso la condanna che è stata concessa.
Credo, allora, che la soluzione ideale sia semplicemente quella di consentire al giudice, in limine litis, di valutare tanto la sussistenza della prova dei fatti costitutivi quanto quella dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi fatti valere da chi si difende, e quindi di pronunciare la condanna quando a fronte della prova dei fatti costitutivi nessuna prova sia fornita dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi, oppure di rigettarla quando la prova dei fatti costitutivi non si abbia, o, pur essendoci, vi sia per contro la prova di almeno un fatto estintivo, impeditivo o modificativo.
Questi provvedimenti, poi, indirettamente, come detto, a monte sono in grado di creare di fatto un regime rigido di preclusioni (e senza la necessità che questo sia categoricamente fissato dalla legge) e a valle portano alla tendenziale chiusura del processo, che però non va disposta per legge, poiché, al contrario, tanto in ipotesi di provvedimento di accoglimento quanto di rigetto, deve essere consentito al soccombente, se lo vuole, di poter proseguire le attività processuali e completare quelle difese che in limine litis non son sembrate al giudice adeguate.
Dunque, a fronte della parte dell’art. 3 e-decies, io semplicemente proporrei, previa eliminazione delle preclusioni istruttorie fin dagli atti introduttivi del giudizio, una norma del seguente tenore: “Su domanda di parte, e quando il processo abbia ad oggetto diritti disponibili, il giudice concede ordinanza anticipatoria della sentenza sui diritti dei quali l’attore abbia già fornito prova dei fatti costitutivi, e sempreché al processo non sussista pari prova dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi. Il provvedimento vale come titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione ipotecaria, sopravvive all’estinzione del processo e contiene la liquidazione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 91 e ss. c.p.c.”.
4. Una seconda precisazione sulla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
Una seconda precisazione ritengo debba farsi con riferimento alla mediazione quale condizione di proponibilità della domanda.
Ho premesso che le novità che si propongono appaiono ragionevoli una volta data questa condizione; solo dubito che debba continuare a prevedersi che la mediazione possa costituire, in taluni casi, condizione di esercizio dell’azione giudiziale.
La mediazione fonda le sue radici, infatti, in un negozio, e un negozio giuridico non può non basarsi sulla libertà delle parti.
Dal che, immaginare che le parti, per andare dinanzi al giudice, debbano previamente presentarsi ad un mediatore per affermare, assai spesso, che, proprio in forza del loro diritto di libertà negoziale, non intendono mediare, appare meccanismo del tutto inutile, che costituisce solo perdita di tempo e di denaro.
Giuseppe Chiovenda diceva che il processo deve dare a chi ha un diritto, tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire, e la mediazione, al contrario, presupponendo la definizione della lite attraverso la concessione di una qualche cosa, non è mai in grado di dare a chi ha un diritto, tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire, e quindi non è mai in grado di assolvere pienamente il compito di rendere giustizia; semplicemente opera attraverso un negozio, che come tale deve essere, però, rimesso alla libertà delle parti, senza costituire condizione di accesso al giudice.
Di questo avviso era tutta la dottrina classica, con posizioni che forse giova ricordare:
a) Giuseppe Pisanelli: “La conciliazione delle parti è un’idea che ha molte attrattive, ma conviene di non esagerarla, e molto più ancora di non forzarla. Quando lo sperimento della conciliazione si volle rendere obbligatorio, come preliminare necessario al giudizio, non corrispose alle aspettative e degenerò in una vana formalità” (PISANELLI, Procedura civile, Palermo, 1868, VII, 2);
b) Luigi Mattirolo: “Il sistema che impone lo sperimento della conciliazione, prima di iniziare la causa, sebbene annoveri tuttora qualche partigiano, è respinto dalla maggiore parte degli scrittori. In verità l’idea di conciliazione ripugna al concetto di coazione. La legge non deve farsi indiscreta tutrice dei cittadini; essa deve permettere, agevolare anche in ogni miglior modo lo sperimento della conciliazione; non imporlo. Il tentativo forzato, appunto perché forzato, degenera, siccome l’esperienza ha luminosamente dimostrato, in una vana formalità, spesso inutile, talvolta dannosa” (MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, Torino, 1892, I, 145);
c) Ludovico Mortara: “Questo istituto teoricamente ottenne un certo plauso ma in pratica non diede notevoli vantaggi. È necessario che la sua interposizione sia domandata, giacché non saprebbe rispondere al decoro della giustizia un’intromissione volontaria, per quanto officiosa, nelle questioni private. Il giudice non si ha interporre in discussioni, ufficio questo di mediatore e non di magistrato” (MORTARA, Manuale della procedura civile, Torino, 1921, I, 576);
d) Giuseppe Chiovenda: “Il conciliatore interpone il suo ufficio solo se richiesto” (CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1934, II, 22).
e) Piero Calamandrei: “In altri paesi la simpatia con la quale si guarda alla conciliazione è fondata su un senso di crescente scetticismo contro la legalità; così può avvenire che il favore con cui si guarda alla funzione conciliativa vada di pari passo col discredito della legalità e sia indice di un ritorno alla concezione della giustizia come mera pacificazione sociale” (CALAMANDREI, Istituzioni di diritto processuale civile, Padova, 1941, 87).
E se oggi, poi, correttamente e senza mezzi termini, si afferma che “quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, la condizione si considera avverata se le parti si presentano al primo incontro dinanzi al mediatore e detto incontro si conclude senza accordo”, a maggior ragione la necessità della condizione di procedibilità della domanda viene meno e andrebbe soppressa, poiché l’obbligo che ne discende si riduce solo alla recita con la quale le parti, pagato un piccolo obolo, affermano semplicemente al mediatore che non intendono mediare.
5. La riforma e l’obiettivo di ridurre i tempi dei processi.
Questi, a mio parere, i punti principali della riforma.
Dopo di che, date le note positive e negative sopra evidenziate, non vedo però che pertinenza possa avere questo progetto con l’obiettivo di ridurre i tempi del contenzioso civile (si dice, del 40%), se non addirittura, si sente dire altresì da qualche altra parte, con quello di ridurre la stessa mole del contenzioso che attualmente grava sui nostri uffici giudiziari.
Premesso che una riforma non può darsi l’obiettivo di ridurre la misura del contenzioso, in quanto, sotto questo profilo, lo Stato semplicemente deve rendere giustizia nella misura in cui i cittadini la richiedono e non altro, residua tuttavia il tema della riduzione dei tempi, sul quale aggiungerei la riflessione che segue.
6. Segue: il correttivo da porre.
Ripeto, questa riforma a me non sembra funzionale alla riduzione dei tempi del processo.
Essa ha ad oggetto scelte di rito: alcune possono essere condivisibili, altre a mio parere, no; in ogni caso i tempi del processo dipendono da altro, non dipendono dal rito, dipendono dal rapporto tra domanda e offerta di giustizia.
Per l’esattezza, a fronte di un certo numero di domande di giustizia da parte dei cittadini, lo Stato deve organizzare una offerta di giustizia adeguata se vuole contenere in modo ragionevole i tempi dei processi. Se l’offerta di giustizia non è adeguata, è evidente allora che i processi durano un tempo non ragionevole, e a niente serve modificare in tal contesto le regole processuali.
E se vogliamo ridurre i tempi del processo, forse conviene allora ricordare Lodovico Mortara.
Lodovico Mortara, nel 1919, ristampava le sue Istituzioni di ordinamento giudiziario: in quell’anno, Lodovico Mortara era il Ministro della Giustizia, e seppur sospeso per l’incarico governativo, era anche il Primo Presidente della Corte di cassazione di Roma.
Quindi, immaginate l’autorevolezza di quella voce, primo magistrato del Regno e Ministro Guardasigilli.
Ebbene, Lodovico Mortara scriveva una cosa semplicissima.
Scriveva: “È chiaro che la nomina di un numero di magistrati corrispondenti, nei singoli gradi gerarchici, al bisogno del pubblico servizio, è una delle condizioni per cui lo Stato adempie il suo obbligo di organizzare l’amministrazione della giustizia”.
La funzione giurisdizionale, dunque, diceva Lodovico Mortara, deve muoversi in conformità alle esigenze della funzione, ovvero deve essere organizzata con un numero di magistrati corrispondenti al bisogno del pubblico servizio.
Anche oggi, così, se invece di cercare effimeri miglioramenti del servizio giurisdizionale modificando continuamente i riti, si facesse quello che a inizio ‘900 già diceva di fare Lodovico Mortara, ovvero semplicemente si aumentasse il numero dei magistrati e dei cancellieri fino a portarli ad una misura idonea al bisogno del pubblico servizio, probabilmente molti nostri problemi non ci sarebbero.
Questa, se si vuole ridurre i tempi della giustizia, è l’unica riforma da fare.
E non si dica che ciò avrebbe un costo, poiché, se si vuole, le risorse economiche vi sono; e a questo riguardo ricordo anch’io, come già ha fatto il mio Maestro Andrea Proto Pisani, l’eccellente volume di un altro ex magistrato, Marco Modena, Giustizia civile, Le ragioni di una crisi, ove l’autore sottolinea come la crisi della giustizia civile dipenda infatti dall’insufficienza dei mezzi, soprattutto umani, e che le risorse economiche vi sarebbero, se solo le si volessero utilizzare.
Peraltro, se a fronte di 2 milioni di nuove cause in Tribunale all’anno, abbiamo circa 10.000 magistrati, di cui parte sono addetti all’Ufficio della Procura della Repubblica, parte sono giudici che si occupano del penale, parte sono fuori ruolo o non attivi per ragioni varie, cosicché, si ritiene, che circa solo 3.000 magistrati, e non di più, si occupino, per tutti i gradi di giudizio, del contenzioso civile, non si vede proprio come i processi possano durare un tempo ragionevole, se 3.000 magistrati debbano far fronte ad un contenzioso di 2 milioni di cause ogni anno.
In tutti i settori economici, se aumenta la domanda, aumenta l’offerta; e questo aumento, in tutti i settori economici, è considerato un bene, non un male.
Solo nel campo del diritto processuale si ritiene che l’aumento della domanda sia un male, e si pensa che la soluzione all’aumento della domanda debba esser quello della sua forzata diminuzione.
Né, sia chiaro, può esser considerata una soluzione soddisfacente quella della riforma sull’Ufficio del processo di cui all’art. 12 bis del progetto; che certamente è lodevole, ma altrettanto certamente non è la soluzione.
Cinque odi per i nostri morti

LARGO FALCONE E BORSELLINO
di Werner Mussner
La città di Bolzano per esprimere la riconoscenza della comunità per l'impegno e per gli sforzi compiuti dai due magistrati in difesa delle Istituzioni ha a loro intitolato una piazzetta ed un vicolo cieco “Largo Falcone e Borsellino”.
Oltre al cartello stradale le Autorità hanno commemorato i due magistrati apponendo la famosa fotografia dei due giudici, ripresi mentre Paolo Borsellino commenta e Giovanni Falcone sorride durante un convegno, pochi mesi prima di cadere vittime dei due attentati. Una fotografia diventata simbolo della lotta alla mafia.
Si tratta di uno spazio minuto, a lato del Tribunale, che attraverso ogni giorno per recarmi al lavoro. E quasi quotidianamente la mia compagna – lei sì di buon umore sin dalla prima mattina - s’immagina una nuova battuta di Paolo Borsellino che fa sorridere Giovanni Falcone, cercando di far sorridere anche a me.
Ma al di là della nostra personale attenzione Largo Falcone e Borsellino, e con esso i magistrati cui deve il nome, forse non godono della dovuta considerazione. Sintomatica è la presenza ancora, accanto alla fotografia di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, di una fatiscente cabina telefonica, probabilmente dismessa, una delle ultime rimaste a Bolzano.
La sensazione è che in una terra geograficamente così lontana dalla Sicilia, la gente fatichi ancora oggi a comprendere appieno il significato dell’importanza dell’inibizione della criminalità organizzata, un contrasto che invece altri hanno condotto senza se e senza ma, con le Istituzioni non sempre al fianco. Un’attività volta semplicemente ad affermare lo stato di diritto ma che è costata la vita a molti magistrati ed agenti delle forze dell’ordine. Purtroppo, non solo fatica a capire il sacrificio compiuto in nome della giustizia dai colleghi, uomini e donne, ma spesso non si ferma nemmeno ad interrogarsi sulle ragioni che hanno reso necessaria la repressione del fenomeno mafioso e sulle radici della criminalità organizzata.
Sotto questo profilo la realtà locale presta senza dubbio il fianco a critiche. La necessità di studiare, analizzare e capire il crimine organizzato è poco sentita. Una lezione che sicuramente va ripetuta. Per non perdere l’eredità lasciataci da Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e da chi in nome della giustizia, con passione e professionalità, ha perso la vita.

di Lorenzo Miazzi
Sabato. Ero stato p.m. di turno, nella mia prima funzione che avevo scelto solo per stare vicino a casa e che adesso, dopo neanche due anni, mi piaceva sempre di più. Alle sei di un pomeriggio luminoso, con un caldo che annunciava l’estate, giocavo con mio figlio facendolo andare in biciclettina sull’aia dietro casa. In macchina avevo il regalo che gli avrei dato il giorno dopo, per il suo secondo compleanno. C’era anche mia moglie con in braccio Pietro, nato 14 giorni prima ed eravamo lì, in quel pomeriggio luminoso e nel caldo che odorava di estate, quando mio cognato ci disse che avevano fatto un attentato a Falcone.
Mia moglie rientrò e io rimasi fuori con Rocco che voleva ancora andare in bici, entravo in casa ogni tanto. Vidi immagini sconvolgenti, e ogni volta che entravo avevano aggiunto il nome di un morto della scorta e mostravano l’immagine di un ragazzo che non c’era più; non riuscivo a crederci. Vidi la gente che stava a guardare da fuori l’autostrada o si aggirava attorno alle macchine sventrate e alla buca creata dalla bomba come se fossero turisti; ne rimasi sbalordito, disorientato; non riuscivo a capire. Sentivo montare dentro di me, insieme, la rabbia contro gli assassini e un senso di estraneità rispetto a quella gente.
Poi venne sera, tv accesa su Raiuno per vedere, ero certo, un servizio che consentisse di capire anche a chi non aveva visto la tv nel pomeriggio. Invece apparve la faccia perplessa di Fabrizio Frizzi, che dopo alcune parole dedicate a Giovanni Falcone e alla sua scorta, in modo imbarazzato disse che lo spettacolo andava avanti, che era la decisione dell’azienda. E riprese con l’ultima puntata di “Scommettiamo che…” Allora anche quel senso di estraneità e stupore divenne rabbia.
Imprecavo contro quegli assassini; e detestavo quella gente che si mostrava indifferente; e mi sentivo in rivolta contro quello Stato che si rivelava neutrale fra mafia e antimafia, che voleva il compromesso e non la sconfitta della mafia, come nel caso del prefetto Mori. Solo che stavolta per non esporsi allontanando i magistrati antimafia, li aveva lasciati soli, aveva lasciato il lavoro sporco alla mafia stessa. Non siete il mio Stato, pensavo annichilito da un senso di impotenza, di inutilità del mio lavoro, dalla sensazione che fossimo in realtà un cane alla catena, e il messaggio era guai se andate oltre.
Domenica. Festeggiavamo il compleanno, mi chiesero cosa sapevo di Falcone. Raccontai un po’ la sua storia, comprese le perplessità che i suoi comportamenti mi avevano suscitato. Perché lasciare la procura per andare al CSM e poi al ministero? al CSM ci possono andare in tanti, ma lui era indispensabile, era il più bravo nella lotta antimafia. Perché non aveva voluto approfondire alcune indagini, fermandosi ai margini della politica che si intuiva già coinvolta, come aveva dimostrato due mesi prima l’omicidio di Lima? Ma ero troppo giovane. Non sapevo ancora che combattere, da dentro le istituzioni, quella parte dello Stato che era neutrale o alleata della mafia era necessario ed era più difficile che farlo da magistrato; non avevo ancora capito che quanto più è delicata la funzione, l’uso ragionevole, e non l’eccesso, dei propri poteri rende straordinario, come Falcone, un magistrato che voglia essere efficace e non insegua l’apparenza.
Lunedì. Quanta ipocrisia e quanto dolore vidi ai funerali. Le facce delle mogli distrutte, e le facce ributtanti dello Stato neutrale. Ancora più forte era il senso di estraneità rispetto a quello Stato, e di quello Stato rispetto a me, a noi che credevamo nel nostro lavoro e nel servizio alla comunità.
Poi, una domenica di luglio, afosa e sudata, sentii alla radio che avevano ucciso anche Borsellino e quel senso di estraneità divenne rabbia cieca, disillusione, sconforto, odio… Ma questa è un’altra storia.
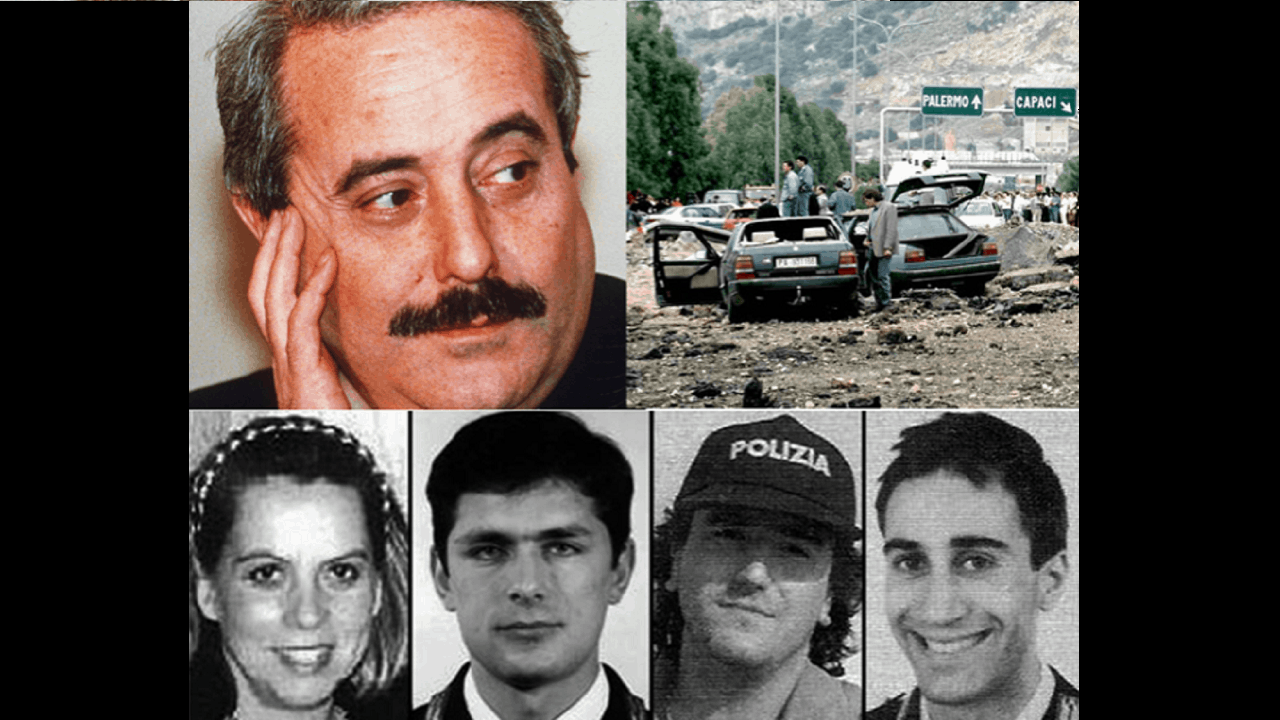
QUEL CHE RESTA DI QUEL GIORNO
di Maria Cristina Amoroso
Economia politica. Un esame surreale per chi si iscrive a giurisprudenza. Ostico.
La prima volta avevo rinunciato per la mia naturale idiosincrasia per tutto ciò che non è parola ma numeri, rette e grafici.
Ci stavo riprovando.
Maggio. Un maggio caldo, già in manica corta. Napoli di fuoco.
Ero una studentessa. Ero una ragazza.
L’ansia della chiamata… tra quando? Sistema il libretto, parla con voce calma, speriamo di ricordare tutto.
Il brusio degli studenti interrotto da una strana agitazione della Commissione.
Gli esami si fermano.
Capaci, Falcone, Morvillo, la scorta, un’autobomba.
Non ricordo neanche più come ce lo dissero. Ricordo solo che ci congelammo all’unisono, fermi, immobili.
La stanza diventò l’autostrada con il fumo nel naso.
Tutti in piedi. Un minuto di silenzio o forse di preghiera.
Quel minuto ancora lo porto dentro, venni invasa da un devastante e potente senso di appartenenza che non mi ha mai più lasciata.
In quel tempo indefinito e senza suoni, da studentessa diventai, violentemente, più che semplicemente adulta, un magistrato, tanto che l’accaduto da quell’esame in poi è stato semplicemente un duro, ma fisiologico, impegno per adeguare nella realtà la nuova forma che già avevo dentro.
DM 19 ottobre 2004, non più un giovane magistrato, quindi, e sicuramente non ancora tra quelli di maggiore esperienza, l’insegnamento di quel giorno, ovvero l’essere parte di un tutto, va pertanto annoverato tra quelli “laici”, tra quelli che mi hanno plasmata prima che prendessi servizio e che inevitabilmente mi hanno fatto da guida nel corso dello stesso.
Di Giovanni Falcone mi è rimasta dentro la sua coinvolgente determinazione nell’esportare i valori della verità e della giustizia anche al di fuori delle sedi giudiziarie; di Francesca Morvillo la riservata tenacia nel lavoro e la straordinaria forza di un amore che ha deciso, consapevolmente, di rinunciare ad una vita più “leggera” per condividere le paure e le restrizioni che comporta una vita blindata.
Di Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la capacità di essere protezione e famiglia al tempo stesso, come sanno fare solo coloro che vivono quotidianamente per tutelare gli altri.
Il dopo di quel giorno di maggio ho cercato di viverlo sempre così, come avevano fatto loro, sicuramente sbagliando, ma provando a farlo con tutte le mie forze.
Per questo, quando qualcuno mi chiede che lavoro faccio, istintivamente rispondo che “sono un magistrato”, non che “faccio” il magistrato, ma che lo sono.
Perché da quella mattina appartengo alla magistratura che si pone al servizio della collettività, non senza stanchezza, difficoltà, scoramento e delusione, ma sempre e innanzitutto al servizio, con generosità e con la consapevolezza che si può essere davvero per gli altri solo se si riescono a declinare, non solo nell’ambito lavorativo ma anche e soprattutto in altri contesti della vita quotidiana, i valori del rispetto, della giustizia della verità e della solidarietà, poiché, in quanto magistrato, avendo il potere di influenzare la vita degli altri, non si può che vivere così.
Nel mio breve percorso professionale ho incontrato moltissime volte colleghi animati dal medesimo senso di appartenenza, maturato o meno in quel maggio, e giovani laureati che, mossi da questa forza, sono riusciti a coronare il loro sogno di entrare in magistratura.
Quando ciò accade, è forte la percezione di trovarsi finalmente in quel luogo ideale comune per raggiungere il quale, nella età della giovinezza, abbiamo sacrificato tanto.
Quel posto c’è, non sempre, non ovunque, ma c’è, e quando c’è, se ne accorgono tutti.

LETTERA A GIOVANNI FALCONE
di Marta Agostini
23 Maggio 2021,
Questa sarà probabilmente la milionesima lettera che hai ricevuto, tra le tante scritte da chi, avendo avuto la fortuna di conoscerti, ha nostalgia di te e vive sulla propria pelle il tuo ricordo o da chi, invece, come me, ti ha conosciuto solo nei racconti degli altri, sui libri, nei film, nei documentari che parlavano di Palermo, di Cosa Nostra, del maxi processo e può soltanto provare ad immaginare chi tu fossi
Sono entrata in magistratura nel 2012, esattamente vent’anni dopo la tua morte.
Tu già allora probabilmente rappresentavi la parte migliore della magistratura italiana, il suo momento più alto. Io, invece, sono oggi testimone della sua storia peggiore, del periodo forse più buio.
Eppure mi piace pensare, con un certo orgoglio tipico di chi, nonostante tutto, mantiene un approccio idealistico alle cose della vita, di appartenere allo stesso corpo a cui appartenevi tu, quel corpo di uomini e di donne che, scegliendo questa professione, la nostra professione, hanno scelto un modo di essere. Non solo un lavoro, ma un servizio
Avevo più o meno undici anni quando sei stato ucciso e non ho alcun ricordo. Ma di certo ricordo come le stragi e, prima ancora, le tue indagini, la tua storia e quella del pool di Palermo, abbiano influito sulla mia decisione di entrare in magistratura. E come me credo che tantissimi altri colleghi della mia generazione, cresciuti anche loro all’ombra del tuo mito, abbiano inteso seguire i tuoi passi. Di questo, come di tanto altro, non finirò mai di ringraziarti perché ancora oggi, a distanza di quasi dieci anni dall’inizio del mio percorso professionale e nonostante tutto, rifarei quella scelta milioni di volte
È un’eredità importantissima quella che ci hai lasciato e, credimi, il grande insegnamento che hai regalato alle generazioni di magistrati che sono venute dopo di te è ancora vivo, fortissimo; anche se non abbiamo mai sentito la tua voce è come se ti conoscessimo da sempre e questo, caro Giovanni, è il dono più grande che tu potessi fare a questo Paese. Essere e restare una guida, un esempio, un simbolo di speranza e levatura morale per giudici e pubblici ministeri che, per tante e complicate ragioni, hanno perso molto della credibilità e della legittimazione che tu, assieme a chi con te ha perso la vita in ragione del proprio operato, avete contribuito a costruire e fortificare
Mi chiedo cosa penseresti di questi nostri tempi, di quello che siamo diventati, come cittadini e come magistrati, di come la giurisdizione, nel bene e nel male, sia cambiata rispetto a come la conoscevi tu.
Mi domando come avresti affrontato questa crisi etica profonda dalla quale la magistratura sembra non riesca ad uscire e che sta lentamente logorando il rapporto di fiducia tra questa e la società.
Ma credo anche che tutto sommato ogni epoca abbia i suoi mostri e tu sul tuo percorso ne hai trovati tanti, fuori e dentro lo Stato. Forse quanto è emerso negli ultimi anni, gli scandali e le polemiche che oggi continuano a provocare al nostro interno ferite laceranti, da fine conoscitore dell’animo umano quale eri, non ti avrebbero stupito affatto. Di certo comunque ne avresti sofferto, come ne soffro io
Mi ha sempre colpito molto, rivedendo le registrazioni delle tue interviste o degli interventi che hai fatto in TV o nei talk show a cui hai partecipato, l’integrità e la solennità con cui davi le tue risposte, la sobrietà con cui replicavi alle critiche ad agli attacchi, cercando di trattenere la rabbia, che pure a volte trapelava lasciando, così, intravedere anche la tua umanità (e la tua sicilianità). Mi colpiva l’autorevolezza e la fermezza con cui in quei momenti rappresentavi lo Stato, le sue Istituzioni, forte delle tue ragioni, che riuscivi a trasfondere anche nel semplice cittadino che nulla sapeva e capiva di diritto e di processi. Uno Stato in cui credevi ed in nome del quale combattevi, nonostante tu stesso fossi consapevole che, ad un certo punto, quello Stato ti aveva abbandonato.
Quel Giovanni Falcone mi ha insegnato quanto dirompente possa essere un’idea, anche la più folle (come folle era percepita all’epoca la tua visione-intuizione di cosa fosse e come operasse Cosa Nostra), se sostenuta dalla forza delle proprie ragioni, delle proprie convinzioni, a loro volta maturate a seguito di un intenso e serio lavoro e studio approfondito dei fatti. Nonostante la solitudine, quella che può uccidere anche il più forte degli uomini
E mi chiedo se oggi sarei in grado di avere quel tuo coraggio, quella tua ostinazione e determinazione nel portare avanti fino in fondo e a costo della vita un’idea che, nel tuo caso, in molti, sino alla fine, hanno osteggiato
Non so dare questa risposta, forse non so tuttora chi sono e chi sarò ancora in grado di essere. So per certo, però, anche grazie a te, cosa non voglio essere.
L’ho capito quando, almeno quindici anni fa, durante una vacanza estiva con gli amici in Sicilia, ci fermammo allo svincolo per Capaci, sull’autostrada, dove si erge il monumento in memoria della strage. Andavamo all’università, tutti iscritti a Giurisprudenza, tutti con lo stesso sogno, che poi siamo riusciti a realizzare. Quella tappa, nel corso del nostro giro in macchina della Sicilia, era scontata; la sentivamo tutti quasi come dovuta, senza bisogno di pianificarla. C’era un forte sole, faceva caldo e c’era uno strano silenzio, interrotto solo dalle macchine che passavano veloci, ma alle quali nessuno di noi faceva caso. Ricorderò sempre il profumo di quell’aria, l’ho respirata tutta, fino in fondo. Ricordo anche il calore della lacrima che mi sfuggì. E anche se non ne parlammo ed, anzi, restammo a lungo in silenzio anche dopo esserci rimessi in viaggio, so che quella forza, quella emozione profonda, l’empatia che provai con quei luoghi e quello che simboleggiavano, difficile da descrivere a parole, l’hanno percepita anche i miei compagni di viaggio che, come me, non la scorderanno
Porterò con me, sempre, un pezzo di te, del tuo ricordo, della tua storia, alla quale sono inscindibilmente legata perchè per tante ragioni in qualche modo fa parte della mia. Porterò con me quello che hai lasciato, l’esempio che per tanti di noi sei stato, quell’idea di magistrato che voglio essere e che, spero anche attraverso le future generazioni, continuerà ad esistere.

SPINTA EMOZIONALE SU E PER GIOVANNI FALCONE
di Andrea Apollonio
Ero andato a trovare un collega, a Palermo, molto più grande di me. Non c'erano ragioni di servizio, anzi avevo preso appositamente un giorno di ferie: lui aveva condotto, negli anni Novanta e Duemila, i principali processi contro Cosa Nostra, e mi si era presentata la possibilità di incontrarlo. Nella penombra della sua stanza, in cui la luce del sole faticava ad arrivare per via dei vetri blindati, parlavamo del momento difficile che stava attraversando la magistratura, degli scandali che si erano succeduti negli ultimi tempi, quando lui ad un tratto, improvvisamente e senza ragione, aveva preso a parlare di Falcone. Mi raccontava cose che nessuno poteva sapere, salvo chi non avesse lavorato con lui gomito a gomito. Mi spiegava - non era infatti un raccontare, era uno spiegare - come Falcone si comportava con i colleghi, con quelli amici e quelli che gli erano avversi, con i collaboratori di giustizia, con la polizia giudiziaria. Mi illustrava le tecniche di indagine e il modo con cui affrontava i processi. Come un magistrato non possa mai farne questioni personali, né abbia il diritto di sconsolarsi.
Tornando a casa, in treno, vedevo scorrere la costa siciliana ed ero frastornato. Perché, sebbene non ci fossimo mai incontrati prima, aveva voluto rendermi partecipe di ricordi tanto intensi, che certamente avevano riaperto ferite dolorose? Poi ci fu uno scambio di mail, e compresi. Lui mi aveva scritto: "Sappi che giovani come te danno senso all’ impegno che uomini come me, e molto migliori di me, hanno profuso per arginare il male e l’ingiustizia, perché alimentano la speranza che qualcosa resterà". Era chiaro a chi si stesse riferendo: a quale fosse il punto d'origine di quella catena. Cadeva così il velo che mi aveva impedito, fin lì, di comprendere la concretezza e la materialità dell'esperienza umana e professionale di Giovanni Falcone; ben oltre le effigi sui muri e le targhe nelle piazze.
Certo: la foto di Falcone e Borsellino era stata collocata nel mio ufficio prima d'ogni altra cosa, perché esprime un ideale (astratto, in quanto tale): lo spirito di servizio perseguito ogni oltre umano timore. Nessun magistrato dovrebbe prescinderne, e quella foto - esposta dentro il mio piccolo ufficio giudiziario di frontiera - intendeva testimoniare l'adesione ideologica allo spirito che animava i due colleghi. Intende ancora: ma dopo quell'incontro a Palermo mi è stato chiaro come la professionalità, la levatura morale e l'abnegazione di Falcone si fossero trasfuse - concretamente: nel modo di ragionare e nell'agire quotidiano - nella generazione appena successiva, e da questa a colleghi ancora più giovani, e via così: affinché quelle caratteristiche - dell'uomo e del magistrato Falcone - potessero essere ancora patrimonio e linfa della magistratura italiana, e non invece freddo reperto della memoria: che è sempre infeconda, se non coltivata a dovere.

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
