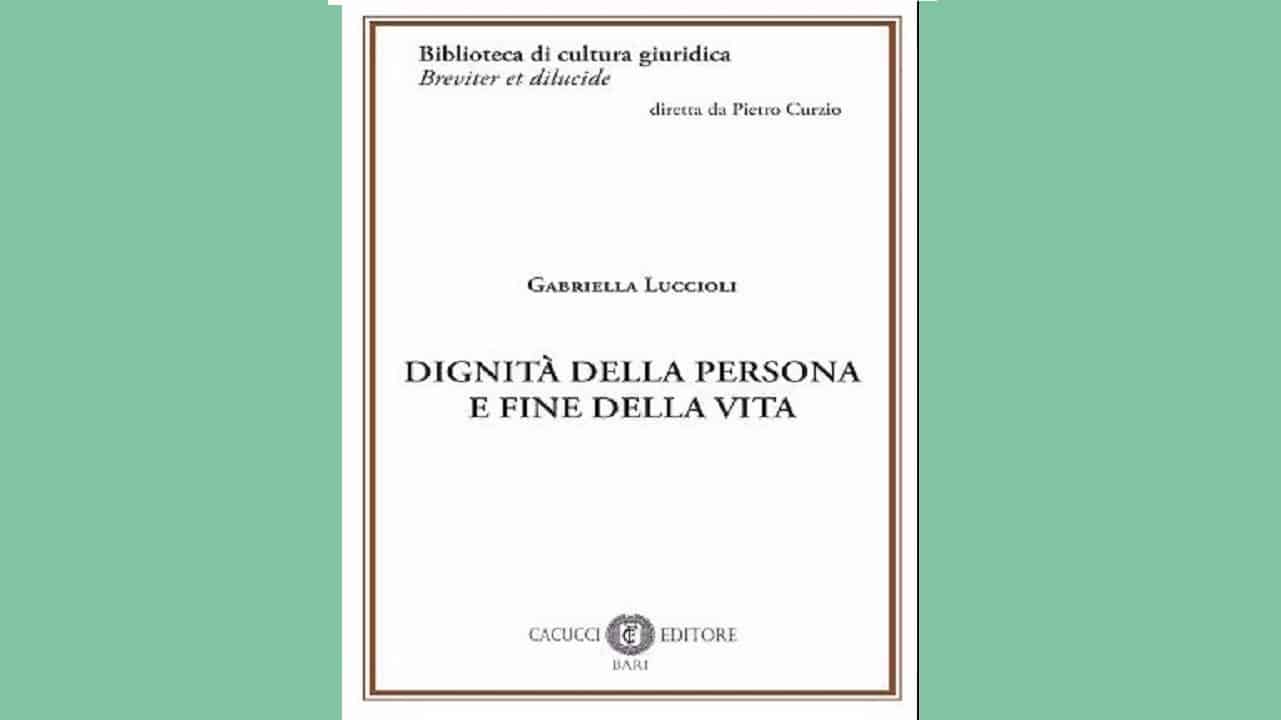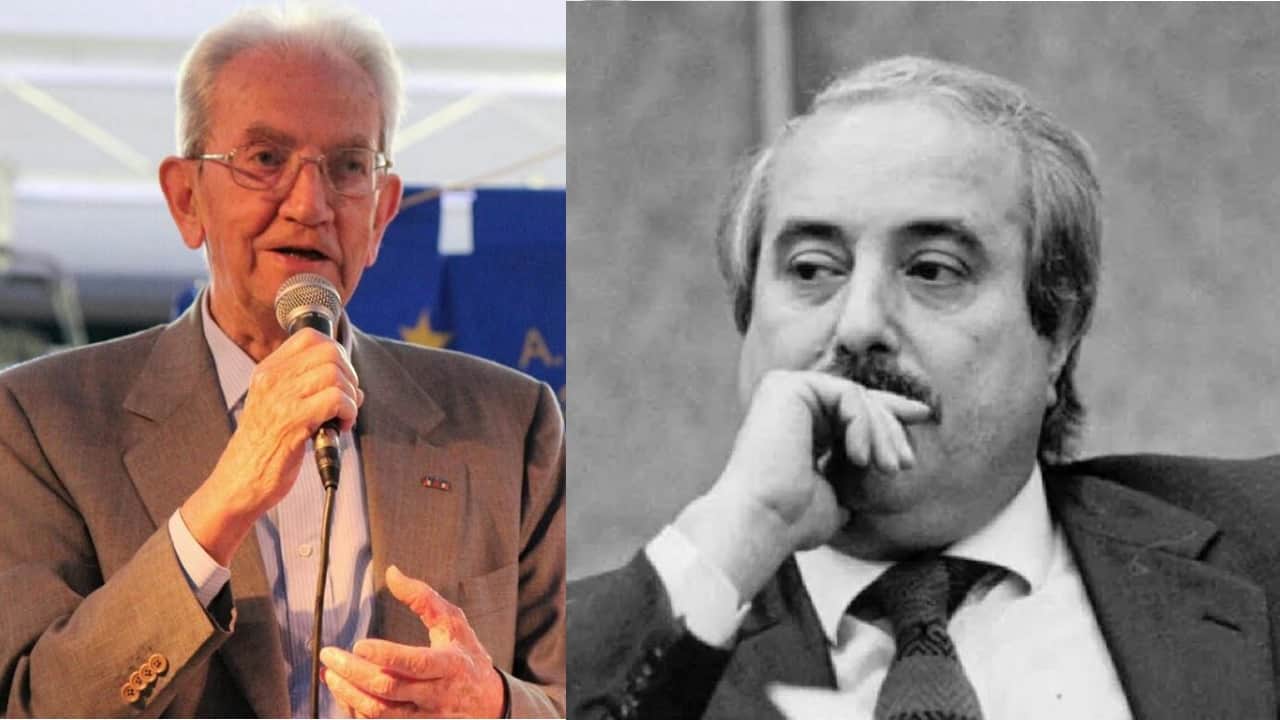Livatino ieri e oggi.
Sacrificio di un giudice e giurista d’altri tempi o testimonianza limpida di un magistrato "di ogni tempo" al servizio della società?
*in calce il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Caltanissetta di idoneità all'esercizio delle funzioni giudicanti e requirenti di Rosario Livatino
Intervista di Roberto Conti a Roberto Saieva
Il 21 settembre 1990 Rosario Livatino cadde, a 38 anni, sotto i colpi brutali della stidda a pochi chilometri da Agrigento, mentre a bordo della sua vettura stava per recarsi al Tribunale di Agrigento dove svolgeva le funzioni di giudice presso la sezione misure di prevenzione.
A trent'anni dalla morte Giustizia Insieme intende fare memoria su quell'agguato, raccogliendo la testimonianza di chi è stato accanto a Livatino, ne ha respirato l'aria, ha vissuto sulla propria pelle il prima, il durante e il dopo di quella vicenda e di quel periodo. Ciò in una prospettiva massimamente rivolta ai giovani, molti dei quali non hanno avuto conoscenza della statura morale e professionale di Livatino nè dell'humus in cui maturò la scelta di eliminarlo fisicamente.
Una testimonianza, quella di Roberto Saieva, oggi Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, che offre squarci importanti sul "contesto" ambientale – locale ma anche dei palazzi delle Istituzioni – nel quale maturò quell'omicidio e che assume oggi un valore davvero particolare provenendo da un magistrato schivo, che ha fatto della sobrietà e del riserbo la cifra della sua ormai lunga esperienza giudiziaria ma che oggi ha voluto tornare indietro nel tempo, forse convinto dalla drammaticità del momento storico che sta attraversando la magistratura e dal desiderio di offrire il ricordo di uno dei suoi più fedeli, coraggiosi e lindi rappresentanti.
Quale il senso delle sue riflessioni? Esse non sembrano affatto rivolte a suscitare consenso, ammirazione o clamore, ma semmai a scuotere le coscienze, a riannodare i fili di una magistratura colpita oggi al cuore da vicende che ne hanno minato profondamente la credibilità.
Saieva fuori da ogni retorica indossa l'abito di chi la storia l'ha vissuta in prima persona e scolpisce con poche espressioni il "modello" senza tempo di magistrato. Lo fa senza enfasi, attraverso le parole di Rosario Livatino e del Presidente della Repubblica, confidando - non per sè, ma per la società che cambia di cui Livatino si fece interprete - in risposte concrete, comportamenti coerenti, prese di posizione ferme e univoche che possano onorare e vivificare il sacrificio di quel "giudice ragazzino" per renderlo realmente "senza tempo" e moltiplicarlo all'infinito.
***
R. Conti Roberto, grazie per questa opportunità che offri ai lettori della rivista di ripercorrere l’esperienza di Rosario Livatino presso gli uffici del Tribunale di Agrigento che ti coinvolge in prima persona, essendone stato collega. Cominciamo dall’inizio. Come lo hai conosciuto e quale impressione suscitò in te inizialmente la sua figura di giovane magistrato?
R. Saieva Conobbi Rosario Livatino quando, dopo lo svolgimento del tirocinio a Palermo, assunsi le funzioni di giudice presso il Tribunale di Agrigento, nel settembre del 1979. Nello stesso periodo Rosario – eravamo stati nominati con lo stesso decreto ministeriale – cominciò, dopo avere effettuato il tirocinio presso gli uffici giudiziari di Caltanissetta, la sua attività di sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento e poiché in Tribunale, nel corso del primo anno, fui addetto alla sezione penale, i nostri rapporti furono ovviamente assidui. L’impressione che Rosario Livatino mi fece fu simile a quella che faceva a tutti coloro che si muovevano nel piccolo mondo giudiziario agrigentino: un’impressione notevole. Il suo lessico, parlato e scritto, era molto accurato e richiamava l’attenzione dell’interlocutore per la frequente inclusione di termini non comuni e il ricorso a figure retoriche. I suoi modi erano sempre inappuntabili, improntati ad una cortesia che anche quaranta anni fa si poteva considerare non usuale. In udienza dimostrava abitualmente una completa conoscenza degli atti dei processi e delle questioni giuridiche da affrontare, che non sempre i pubblici ministeri erano e sono in grado di esibire. Sosteneva le proprie tesi con convinzione, non dando mai l’impressione di considerare l’esercizio del proprio ufficio come un adempimento rituale.
Il rapporto con Livatino rimase professionale o diventò personale e quanto incise il contesto ambientale nel quale eravate chiamati ad operare?
I miei rapporti con Livatino si intensificarono allorché, nel gennaio del 1983, fui trasferito dal Tribunale alla Procura della Repubblica di Agrigento. Nel suo discorso di commiato ai colleghi ed al personale della Procura della Repubblica, quando si accingeva a trasferirsi in Tribunale, Rosario ricordò come io, negli anni della comune attività, avessi trascorso con lui assai più tempo di quello passato con la mia famiglia. I nostri rapporti tuttavia, per quanto intensi, rimasero prevalentemente professionali. Rosario non abitava ad Agrigento, era assorbito, nel tempo libero dal lavoro, dalla cura dedicata ai propri anziani genitori e, soprattutto, aveva un carattere schivo, riservato; d’altra parte, neppure io ho un carattere particolarmente estroverso.
In quegli anni non erano state ancora costituite le Procure Distrettuali Antimafia. Cosa rappresentava il giovane Rosario Livatino all’interno della Procura di Agrigento? Erano gli anni delle polemiche sorte sui giudici ragazzini dei quali aveva parlato il Presidente Cossiga. Arrivaste in terra di mafia preparati a confrontarvi con quella realtà o avvertivate disagio o inadeguatezza? Sentivate la protezione dei vertici dell’Ufficio? Era sufficientemente appagante?
Gli anni Ottanta del secolo scorso furono nell’azione di contrasto alle mafie anni di passaggio, di cambiamento, riflesso delle trasformazioni che si preparavano nel mondo e che, peraltro, non erano compiutamente e generalmente percepibili. Nelle fasi di transizione si muovono sempre forze contrastanti, il vecchio tarda a scomparire e il nuovo stenta a farsi largo. Anche il mondo giudiziario siciliano, con riferimento alle indagini sulle attività di cosa nostra, viveva in quegli anni una stagione mutevole, incerta. L’effetto che l’arrivo di Livatino in quella stagione produsse negli uffici giudiziari agrigentini fu quello della caduta di un sasso in uno specchio d’acqua stagnante. Livatino intraprese indagini antimafia di largo respiro – orientate anche, con l’ausilio della polizia tributaria, alla identificazione di patrimoni di illecita provenienza – che travalicarono i confini della provincia. Uno spunto investigativo di particolare interesse fu posto a base di una vasta indagine che ci portò alla fine del 1984 alla esecuzione di numerosi provvedimenti cautelari nei confronti dei vertici di cosa nostra agrigentina e poi ad un processo concluso con molte sentenze definitive di condanna. La sensazione di isolamento c’era e – anche se non in tutti i periodi e non con riguardo a tutti i soggetti con i quali ci si confrontava –, la si percepiva, a tratti nettamente, anche all’interno del Palazzo; era sicuramente causa di uno stato tensione; in compenso la consapevolezza dell’importanza del lavoro che si andava svolgendo e la coscienza dello straordinario impegno che vi si profondeva, era per noi fonte di soddisfazione professionale ed umana.
La paura che potesse accadervi qualcosa in ragione della vostra attività esisteva o no a quell’epoca e, se sì, vorresti descriverla a beneficio dei giovani magistrati, molti dei quali non vissero quella stagione per ragioni anagrafiche?
All’indomani della esecuzione dei provvedimenti restrittivi ai quali ho fatto cenno in precedenza fummo avvertiti dalle forze di polizia – che sul territorio avevano le loro antenne – che le associazioni mafiose avevano percepito come particolarmente duro il colpo assestato e che erano da mettere in conto possibili reazioni. Furono disposte misure di protezione nei confronti dei magistrati che avevano ruolo nelle indagini. E’ innegabile che ciascuno di noi nutriva allora timori per la propria incolumità personale. Si dice che il magistrato deve sempre esercitare il proprio ministero nec spe nec metu, ma ci si vuole normalmente riferire, oltre che alla speranza di vantaggi morali o materiali, alla paura di conseguenze negative del proprio operato sul piano professionale. Trovarsi nelle condizioni di dover nutrire timori per la propria incolumità personale, in ragione dell’adempimento dei doveri istituzionali, provocava un certo smarrimento, disorientava, legittimava l’interrogativo: “Ma che razza di Stato è questo nel quale si corre il rischio di essere uccisi a causa dell’esercizio, quali suoi funzionari civili, di pubbliche funzioni?”. Si faceva però in modo di gestire, di controllare l’ansia e, a tale scopo, serviva molto il rapporto di solidarietà che intercorreva tra di noi, tra Livatino, me e gli altri magistrati impegnati sullo stesso fronte.
La scelta di non fruire della scorta fu per Livatino un atto di fede, una scelta dettata dal fatalismo o un atto di amore per chi avrebbe dovuto difenderne l’incolumità?
Ci fu più di una ragione a sconsigliarlo. Livatino sapeva bene di vivere in un contesto ambientale – la cittadina di Canicattì – particolarmente difficile e temeva che l’esibizione di una scorta potesse essere percepita come una sfida dalle associazioni mafiose insediate in quel territorio. Non voleva inoltre recare turbamento ai propri genitori, evidenziando la situazione di oggettivo pericolo in cui versava. Era poi convinto che di fronte alla risoluzione di un’organizzazione criminale potente ci fossero ben scarse possibilità di difesa. La mafia aveva già dimostrato, in occasione dell’omicidio di Rocco Chinnici, di non indietreggiare davanti ad opzioni stragiste.
Voi colleghi aveste mai la percezione del rapporto che legava Livatino ai suoi familiari e quanto secondo te il contesto familiare e ambientale nel quale continuò a vivere fino ai suoi ultimi giorni Livatino a Canicattì incise sulla sua attività professionale?
Lo speciale legame che univa Rosario Livatino, figlio unico, ai genitori era evidente, come evidente era che proprio in ragione di questo legame familiare Rosario continuava a rimanere annodato ad un contesto ambientale dal quale si sarebbe altrimenti allontanato senza particolari rimpianti. Ed è in questo contesto che si radicano i moventi della sua uccisione.
Il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti di Livatino. Cosa spinse Livatino a quella scelta. Aveste mai modo di prefigurare possibili ritorsioni delle organizzazioni criminali locali rispetto a quella scelta?
Livatino passò alle funzioni giudicanti nell’agosto del 1989, alla vigilia dell’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. La riforma aveva tra i suoi obiettivi primari quello della “degiurisdizionalizzazione” del pubblico ministero, di cui veniva fortemente accentuato nel processo il ruolo di parte, trasformandolo da organo investito di poteri di acquisizione probatoria in organo di ricerca delle fonti della prova. Livatino era un pubblico ministero con una solida cultura della giurisdizione e preferì transitare nei ruoli della giudicante. Il passaggio, portato a compimento nella stessa sede giudiziaria, lo esponeva ulteriormente sotto il profilo della sua sicurezza personale; ne era consapevole e gli fu anche evidenziato, ma non ritenne di tornare sui propri passi.
Livatino persona, Livatino giurista e Livatino sostituto procuratore e poi Giudice di Tribunale. Qual è secondo te il tratto comune e aggregante che Livatino mostrava in ciascuna di quelle dimensioni?
La religiosità alla quale ispirava la sua condotta. Non mi riferisco a quella che derivava dalla sua fede cattolica, parlo di religione laica, la religione del dovere, che improntava in egual misura il suo essere magistrato e uomo. Richiamerò le parole da lui pronunciate in un suo intervento, dal titolo Il giudice nella società che cambia: “ … è da rigettare l'affermazione secondo la quale, una volta adempiuti con coscienza e scrupolo i propri doveri professionali, il giudice non ha altri obblighi da rispettare nei confronti della società e dello Stato e secondo la quale, quindi, il giudice della propria vita privata possa fare, al pari di ogni altro cittadino, quello che vuole …”. Ecco: era difficile poter distinguere, nella sostanza e nella forma, il Livatino magistrato dal Livatino uomo e, per questa ragione, è facile comprendere perché sia naturale rivolgersi alla figura di Rosario Livatino con grande rispetto e, al pensiero che la sua così gravosa, austera vita fu brutalmente stroncata quando non aveva ancora 38 anni, con pena altrettanto grande, soprattutto da parte di chi lo ha personalmente conosciuto.
Il rapporto di Livatino con il foro. Cosa ci puoi dire?
La cortese premura con cui Livatino trattava gli avvocati era massima, pari alla distanza che interponeva tra sé e loro. Aveva ben presente che magistrati e avvocati fanno mestieri diversi. La sua rigidità nel rispetto delle regole – anche di quelle formali, che rappresentano la necessaria premessa di quelle sostanziali – era non di rado causa di malcontento. I malumori crebbero quando passò alle funzioni giudicanti. Ricordo qualche memoria e qualche gravame avverso provvedimenti da lui redatti dai toni insolitamente aspri.
Quella mattina del 21 settembre 1990 ero nello studio di mio padre in Via De Gasperi e sentii un anomalo numero di sirene di auto delle forze dell’ordine imboccare la Via Nuova Favara, una dopo l’altra. Poi il silenzio… Rabbia, dolore, rassegnazione. Cosa prevalse nei giorni successivi?
La prima reazione fu di sbalordimento. Ho già detto che simili evenienze erano messe in conto, ma una cosa è immaginare il dramma, altra è vederlo concretamente rappresentato davanti ai propri occhi. Poi subentrarono il dolore e la rabbia, non la rassegnazione. Lo sconvolgimento delle nostre esistenze che quella morte produsse non poteva lasciare spazio alla rassegnazione. Mi riferisco ovviamente a quanti di noi avevano condiviso con Livatino un certo modo di intendere l’impegno professionale.
E il Tribunale di Agrigento come reagì, gli uomini di legge, la società civile?
Sul momento, com’è ovvio, il sentimento prevalente fu quello della commozione, anche tra coloro – avvocati, altri liberi professionisti, pubblici amministratori, colleghi – che nei suoi confronti non avevano nutrito particolare simpatia. La commozione è un sentimento facile. Poi ciascuno riprese inevitabilmente la propria strada. Ricordo una assemblea della locale sottosezione della ANM, svoltasi appena qualche giorno dopo l’omicidio, nel corso della quale, in un clima assai teso, archiviata la commozione, emersero opinioni tutt’altro che unanimi sulle posizioni da assumere, come magistratura associata, a fronte di quanto accaduto, corrispondenti alle “diverse sensibilità”, chiamiamole così, con le quali ci si rapportava al modello di magistrato che Livatino rappresentava e al tipo di attività giudiziaria che lui ed alcuni altri giovani magistrati – e tra questi anch’io – avevano sviluppato nel decennio precedente. E ricordo pure che nel dicembre di quell’anno 1990, nella cappella maggiore del seminario vescovile di Agrigento fu celebrata una solenne messa in suffragio di Rosario. Naturalmente i magistrati agrigentini furono tutti presenti. La cerimonia era aperta anche agli avvocati, ma soltanto tre di loro vi parteciparono. Uno dei tre era tuo padre.
Sono andato a ritrovare due tue interviste, una al settimanale Il Sabato, insieme al collega Fabio Salamone, riportata in stralcio in un periodico agrigentino “La Tribuna” ed un’altra di poco successiva, quando eri in procinto di lasciare Agrigento, che ricordo assai bene. In quest’ultima campeggia una foto con il Presidente della Repubblica Cossiga, il Ministro Vassalli, Martelli e Craxi dietro la bara di Livatino. Il senso complessivo che ne usciva mi pare essere quello di un pessimismo marcato per la risposta che lo Stato diede all’uccisione di Livatino. A distanza di tanto tempo come ti sentiresti di spiegare quel periodo a chi non visse quel periodo? E oggi quelle criticità che avevi manifestato ti sentiresti di ribadirle nell’attuale contesto storico-sociale?
Si, ricordo che in quel periodo alla domanda di un cronista ebbi a rispondere che noi magistrati impegnati sul fronte antimafia avevamo la sensazione di essere non funzionari dello Stato, ma liberi professionisti; e se non rappresentavamo lo Stato, se facevamo quel che facevamo per una nostra scelta individuale, era normale che subissimo le conseguenze di un impegno che nessuno ci chiedeva. Era una sensazione fondata. E infatti la scia di sangue, come sappiamo, non si sarebbe fermata. Ci sarebbero state ancora le stragi di Capaci e Via D’Amelio, le stragi sul continente.
Poi la risposta dello Stato prese corpo. Fu approntato un efficace strumentario normativo, furono istituite le direzioni distrettuali antimafia, furono messe in campo adeguate risorse finanziarie e personali. In parte fu effetto dell’ondata emotiva che aveva attraversato il Paese all’indomani della strage di Via D’Amelio; ma fondamentalmente l’attività di contrasto si sviluppò con pienezza in quanto erano maturate le condizioni politiche, interne ed internazionali, perché del fardello rappresentato da certe contiguità con le associazioni mafiose, con cosa nostra in particolare, le Istituzioni – o, comunque, determinati centri di potere – si liberassero.
Oggi la situazione è quindi ben diversa da quella di un trentennio fa, anche se è innegabile che la nebbia che ancora avvolge in parte gli avvenimenti che nell’arco di tre lustri, tra il 1979 e il 1993, sconvolsero la vita del Paese pesa su noi tutti. Dell’eredità di quel periodo non sarà possibile liberarsi fino a quando non sarà fatta piena luce sulle circostanze, sui moventi, sulle complicità di tanti delitti eccellenti.
Nei suoi due scritti lasciati a perenne memoria della sua persona, Il giudice nella società che cambia, che tu hai già citato, e Fede e diritto, Livatino traccia le linee portanti dell’essere magistrato di ogni tempo. Alla luce dell’esperienza che hai vissuto accanto a lui credi che l’Istituzione Magistratura abbia offerto nei territori ad alta densità mafiosa una risposta adeguata alle aspettative della società?
Credo che, con riferimento al profilo di cui parli, nell’attività della Magistratura debbano essere distinte due fasi, corrispondenti alle due fasi dell’azione dello Stato che ho in precedenza indicato. La risposta fu, non dico corale, ma diffusa solo nella seconda fase, quando cioè fu chiara la volontà dei pubblici poteri di sgominare le associazioni mafiose, cosa nostra soprattutto, che, per ragioni, ripeto, ancora largamente oscure, aveva scelto la strada dello scontro diretto con le Istituzioni. Insomma, molti magistrati avvertirono che il vento cambiava e furono lesti a conformarsi. Ho visto magistrati passare in pochi anni dalla negazione dell’esistenza della mafia, alla pubblica celebrazione dei secoli di carcere inflitti ai mafiosi.
Quanto alle linee portanti delle sollecitazioni di natura etico-professionale che compaiono a più riprese nel pensiero di Livatino in ordine alla figura del Magistrato, quali valutazioni ti senti di fare nell’attuale contesto storico?
Partirò dalla citazione di alcuni passi dell’intervento già richiamato, Il giudice nella società che cambia. Scriveva Livatino nell’aprile del 1984: “L'indipendenza del giudice … non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrifizio, nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative e ad affari, tuttoché consentiti ma rischiosi, nella rinunzia ad ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione ed il pericolo della interferenza; l'indipendenza del giudice è infine nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni ed in ogni momento della sua attività”. Ed ancora: “ … il giudice di ogni tempo deve essere ed apparire libero ed indipendente, e tanto può essere ed apparire ove egli stesso lo voglia e deve volerlo per essere degno della sua funzione e non tradire il suo mandato”. “Solo se il giudice realizza in se stesso queste condizioni, la società può accettare che egli abbia sugli altri un potere così grande come quello che ha.”.
Io sono convinto che il modello di magistrato scolpito da Livatino trentasei anni or sono, proprio perché “senza tempo”, sia ancora valido. Della immutabilità del profilo etico del magistrato ha parlato Alfonso Amatucci in un contributo recentemente pubblicato su questa rivista, affermando che “il privilegio di aver avuto la ventura di esercitare il più bel mestiere del mondo, [che conferisce] il potere di incidere fortemente sulle vite degli altri, non può non essere bilanciato da un assoluto rigore morale, da un profondo impegno allo studio e al continuo perfezionamento, dal costante sforzo di capire con autentica umiltà quali siano le speranze, i timori, le aspettative che si nascondono dietro ogni carta processuale e quali le loro ragioni. Altro che adempiere il munus publicum con disciplina ed onore! Il dovere del magistrato è enormemente superiore, ieri come oggi”.
E sono convinto che – sebbene il mutamento degli assetti politici e sociali e l’evoluzione dei costumi abbiano determinato un sensibile, diffuso affievolimento del senso dello Stato e della coscienza civica – siano tanti i magistrati che a quel modello corrispondono o che a quel modello con sforzo incessante si sforzano di aderire.
E’ però indubbio che la maggioranza dei cittadini considera oggi i magistrati ben lontani dal modello di cui discorriamo. Il livello di credibilità dei magistrati, nonostante la grande visibilità di cui l’ordine giudiziario ha goduto per effetto delle ampie deleghe di poteri ad esso conferite nel tempo dal ceto politico, è progressivamente scemato, a causa di ripetuti episodi di infedeltà ai doveri del loro stato, talora gravi o gravissimi, di cui molti, troppi magistrati si sono resi protagonisti, ed è letteralmente precipitato allorché sono state rese pubbliche le vicende emerse dalla nota indagine condotta recentemente dalla Procura della Repubblica di Perugia.
Vicende che non possono essere riassunte meglio di come ha fatto il Presidente della Repubblica, quando le ha qualificate come un “coacervo [“sconcertante e inaccettabile”] di manovre nascoste, di tentativi di screditare altri magistrati, di millantata influenza, di pretesa di orientare inchieste e condizionare gli eventi, di convinzione di poter manovrare il CSM, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere dello Stato … in totale contrapposizione con i doveri basilari dell’Ordine Giudiziario e con quel che i cittadini si attendono dalla Magistratura”, rimarcando che “quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l’autorevolezza [non soltanto del CSM] ma anche per il prestigio e l’autorevolezza dell’intero Ordine Giudiziario”; parole che ho richiamato nell’intervento che ho svolto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020 nel distretto di Catania, dedicato in larga parte, come peraltro l’intervento dell’anno precedente, alla questione etica che l’esercizio della funzione giudiziaria propone.
Sul tema il Presidente della Repubblica è ritornato il 18 giugno di quest’anno, svolgendo il suo intervento in occasione della cerimonia commemorativa del quarantesimo anniversario dell’uccisione dei magistrati Giacumbi, Minervini, Galli, Amato e Costa e del trentennale dell’uccisione di Rosario Livatino.
In quell’intervento il Presidente ha sottolineato l’amaro contrasto tra l’alto livello morale delle figure commemorate e il contesto documentato dall’indagine della Procura della Repubblica di Perugia, rimarcando come la pubblicazione di atti ulteriori rispetto a quelli diffusi l’anno precedente sembri presentare l’immagine di una Magistratura china su se stessa, preoccupata di costruire consensi a uso interno, finalizzati all’attribuzione di incarichi, fornendo la percezione della vastità del fenomeno e lasciando intravedere un’ampia diffusione della grave distorsione sviluppatasi intorno ai criteri e alle decisioni di vari adempimenti nel governo autonomo della Magistratura.
Nella medesima occasione il Capo dello Stato ha messo in risalto il ruolo decisivo per la formazione etica e professionale dei magistrati che può e deve assumere la Scuola Superiore, auspicando che essa dedichi sessioni di studio apposite ai doveri di correttezza e trasparenza nell’esercizio delle funzioni giudiziarie; affinché siano tradotti nei comportamenti a cui è tenuto ciascun magistrato, non soltanto nello svolgimento dell’attività giudiziaria ma anche nel servizio reso negli organi di governo autonomo.
E’ però evidente che una correzione di rotta nei comportamenti che ciascuno deve tenere nello svolgimento dell’attività giudiziaria, come nel servizio reso negli organi di governo autonomo, non può essere affidata esclusivamente al lento lavoro di propagazione dei principi etici tra i magistrati ad opera della Scuola, né alla concreta realizzazione dei propositi di rifondazione morale che sono stati enunciati (ma non è la prima volta che questo accade) da tanti esponenti dei gruppi associativi. Sono necessarie riforme, anche radicali, che rendano più incisivo il meccanismo dei controlli e quindi della responsabilità dei magistrati, che deve necessariamente corrispondere e controbilanciare l’ampiezza dei poteri ad essi attribuiti e che riconducano entro i confini della conveniente ed insopprimibile discrezionalità quelle pratiche di esercizio del governo autonomo che frequentemente sono state invece ispirate all’arbitrio.
Essenziale è che ogni modifica normativa si articoli lungo il tracciato delineato della Costituzione, poiché, come il Presidente della Repubblica ha costantemente ricordato, indipendenza e autonomia dell’Ordine Giudiziario sono principi fondamentali, irrinunziabili per la Repubblica.
Il sacrificio di Livatino quanto è servito alla nostra società e quanto quella società si è meritata una figura di uomo e di magistrato come la sua?
Non credo che i tanti magistrati che hanno sacrificato la vita nell’adempimento del dovere si siano chiesti se la società meritasse il loro sacrificio. Hanno agito sospinti da un imperativo morale, sentendosi parte di una comunità, convinti che la società questo da loro si aspettasse. Comunque ritengo che quel sacrificio sia servito. E’ stato scritto: “Beato il popolo che non ha bisogno di eroi”. Il nostro ne ha bisogno e Livatino sacrificandosi è entrato nella galleria degli eroi che i popoli come il nostro amano, perché servono a purificare la loro coscienza collettiva.
Hai mai avuto qualche rimorso inconfessato per quel che accadde il 21 settembre 1990?
In situazioni come quella che abbiamo rievocato chi sopravvive si interroga sempre sulle proprie eventuali colpe, ma dubito che la progressione di eventi che si sviluppò fino al suo fatale epilogo potesse essere fermata da me, come da qualcuno degli altri colleghi che a Rosario furono più vicini.