
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
L'ultimo articolo di Giacomo Matteotti - cento anni dopo
di Margherita Occhilupo
Questo articolo è apparso nel numero di luglio 1924 del periodico inglese English Life fondato da Brendan Bracken, uno degli amici più stretti di Winston Churchill che sarà poi Ministro dell'Informazione del suo governo tra il 1940 e il 1945. Si ritiene che Giacomo Matteotti lo abbia scritto nei primi giorni di giugno del 1924 [1]: questo lo rende uno degli ultimi testi a sua firma. Il contenuto fu parzialmente anticipato dalla stampa inglese nella seconda metà del giugno del ‘24, quando i giornali di tutta Europa denunciano incessantemente la scomparsa del deputato socialista. Matteotti oltre al suo costante impegno parlamentare e al suo lavoro sul territorio italiano, di cui molto si è detto su questa Rivista, aveva anche contribuito alla costruzione di un’opposizione internazionale al fascismo, viaggiando in tutta Europa e creando legami tra partiti socialisti e sindacati. Il suo rapimento ebbe un’immediata risonanza nei giornali di tutto il mondo occidentale, che seguirono la vicenda nel corso dell’estate del 1924 e poi continuarono a onorarne la memoria per decenni.
L'articolo "Machiavelli, Mussolini and Fascism", di cui pubblichiamo oggi una traduzione di servizio, è una risposta di Matteotti all'articolo a firma di Benito Mussolini apparso nel numero di giugno 1924 di English Life. Si trattava della rielaborazione, tradotta in inglese con il titolo “The Folly of democracy”[2], di uno scritto di Mussolini, "Preludio al Machiavelli”, già pubblicato in Italia sulla rivista Gerarchia nell’aprile del 1924, «nel quale, dietro la “disinvolta” attualizzazione dell’opera machiavelliana, si nasconde un atto di accusa alla democrazia e una feroce critica delle istituzioni politiche liberali»[3].
In questo scritto Matteotti confuta le storture dell’interpretazione che Mussolini dà al “Principe” di Machiavelli e afferma con incredibile lungimiranza che una delle peggiori creazioni di Mussolini sono i fascisti, ovvero il permearsi della mentalità e dei metodi fascisti nelle pratiche e nelle idee dei cittadini. Denuncia inoltre la corruzione degli alti funzionari fascisti, in particolare con riferimento alla convenzione siglata nell’aprile del 1924 dal Ministro dell’Economia nazionale con la compagnia petrolifera Sinclair Oil. L’affare Sinclar Oil fu poi utilizzato ai fini del depistaggio delle indagini per l’omicidio di Matteotti: collegare il delitto alla scoperta di fatti di corruzione portava a individuare come possibili mandanti soggetti diversi da Mussolini, in realtà l'unico mandante dell’omicidio. Matteotti fu fatto uccidere da Mussolini poiché era il più strenuo oppositore del regime fascista, il primo antifascista. Il depistaggio rallentò le indagini e consentì al regime di riassettarsi dopo “l’affare Matteotti” e così, con il trasferimento a Chieti, tutto finì con il “processo farsa”.
Come riporta l’occhiello dell’articolo «dal momento in cui questo articolo è stato scritto, Matteotti è stato rapito da alcuni sostenitori del fascismo ("Fascisti supporters") e la sua sorte è ancora ignota».
Il corpo dell’onorevole Giacomo Matteotti, assassinato da sicari fascisti il 10 giugno 1924, sarà ritrovato solo il 16 agosto 1924 alle porte di Roma e poi sepolto a Fratta Polesine, suo paese natale. Su questa Rivista abbiamo ricordato diffusamente la sua vita, il suo pensiero, il suo lavoro e l’importanza del suo contributo alle istanze antifasciste di tutta Europa. Si vedano: Giacomo Matteotti: il suo e il nostro tempo di Licia Fierro, Discorso alla Camera del Deputati del 30 maggio 1924 di Giacomo Matteotti, "Il delitto Matteotti" e quel giudice che voleva essere indipendente (nel 1924) di Andrea Apollonio, Una risalente (ma non vecchia) vicenda processuale: il pestaggio fascista in danno dell’on. Giovanni Amendola del 26 dicembre 1923 di Costantino De Robbio, La magistratura al tempo di Giacomo Matteotti di Giuliano Scarselli, A margine del Processo Matteotti: la coerenza di un magistrato in tempo di regime di Costantino De Robbio, Giacomo Matteotti. Il giurista di Giovanni Canzio, Note su Giacomo Matteotti ed il penale costituzionale: la legalità dalla crisi dello Stato liberale alla «dominazione fascista» di Floriana Colao, Un Matteotti poco conosciuto di Enrico Manzon, Il metodo per la riforma fiscale, preziosissima eredità di Giacomo Matteotti di Francesco Tundo.
Con questo contributo la Redazione di Giustizia Insieme, nel ricordo vivo di Giacomo Matteotti, saluta le lettrici e i lettori.
Ci ritroveremo a settembre. Buona lettura e buona estate!
Machiavelli, Mussolini e il fascismo
di Giacomo Matteotti
Segretario politico del Partito Socialista Italiano
Questo articolo è una risposta all'articolo del signor Mussolini apparso sul numero di giugno di English Life. Dal momento in cui questo articolo è stato scritto, il signor Matteotti è stato rapito da alcuni sostenitori del fascismo e la sua sorte è ancora ignota.
La democrazia inglese è stata recentemente allietata dalla conversione del signor Mussolini ai principi machiavelliani. Nel suo stravagante articolo su Machiavelli chiarisce che la forza è la sua unica guida politica. Le sue osservazioni su Machiavelli sono da inquadrare in forma perpetua in una tesi universitaria. Sono degne di essere analizzate da chi ha esperienza delle teorie di Mussolini applicate al governo. Egli afferma che «pochi sono coloro — eroi o santi — che sacrificano il proprio io sull'altare dello Stato. Ma ci sono molti cittadini disposti a rovesciare quell'altare e a sacrificare lo Stato per i propri scopi. La rivoluzione francese e altre rivoluzioni hanno tentato di risolvere questo dissidio che è alla base di ogni organizzazione sociale statale, facendo sorgere il potere come una emanazione della libera volontà del popolo. C'è una finzione e una illusione di più. Prima di tutto il popolo non fu mai definito. È una entità meramente astratta, come entità politica. Non si sa dove cominci esattamente, né dove finisca. L'aggettivo di sovrano applicato al popolo è una tragica burla. Il popolo tutt’al più, delega, ma non può certo esercitare sovranità alcuna. I sistemi rappresentativi appartengono più alla meccanica che alla morale. Anche nei paesi dove questi meccanismi sono in più alto uso da secoli e secoli, giungono ore solenni in cui non si domanda più nulla al popolo, perché si sente che la risposta sarebbe fatale; gli si strappano le corone cartacee della sovranità — buone per i tempi normali — e gli si ordina senz'altro o di accettare una Rivoluzione o una pace o di marciare verso l'ignoto di una guerra. Al popolo non resta che un monosillabo per affermare e obbedire. Voi vedete che la sovranità elargita graziosamente al popolo gli viene sottratta nei momenti in cui potrebbe sentirne il bisogno. Gli viene lasciata solo quando è innocua o è reputata tale, cioè nei momenti di ordinaria amministrazione. Vi immaginate voi una guerra proclamata per referendum? Il referendum va benissimo quando si tratta di scegliere il luogo più acconcio per collocare la fontana del villaggio, ma quando gli interessi supremi di un popolo sono in giuoco, anche i governi ultrademocratici si guardano bene dal rimetterli al giudizio del popolo stesso.»
«Regimi esclusivamente consensuali non sono mai esistiti, non esistono, non esisteranno probabilmente mai. Mi sostiene in questa opinione una pregnante citazione del “Principe” di Machiavelli: “Di qui nacque che tutti i profeti armati vincono e li disarmati ruinarono”. Perché la natura dei popoli è varia ed è facile persuadere loro una cosa, ma è difficile fermarli in quella persuasione. “E però conviene essere ordinato in modo, che, quando non credono più, si possa far credere loro per forza. Moisè, Ciro, Teseo e Romolo non avrebbero potuto fare osservare lungamente le loro costituzioni, se fossero stati disarmati.»
Ci si può chiedere se l'Inghilterra, il Paese di Gladstone e Bright, apprezzerà sentimenti tirannici così violenti - penso di no. La mia ultima esperienza in Inghilterra dimostra che il regime democratico si sta lentamente ma certamente imponendo sui vasti interessi imperiali dell'Inghilterra. Si tratta di una crescita graduale che sarà favorita da indiscrezioni come l'adesione di Mussolini ai principi infernali di Machiavelli. Quando Mussolini pone la domanda: «Vi immaginate voi una guerra proclamata per referendum? Il referendum va benissimo quando si tratta di scegliere il luogo più acconcio per collocare la fontana del villaggio, ma quando gli interessi supremi di un popolo sono in giuoco, anche i governi ultrademocratici si guardano bene dal rimetterli al giudizio del popolo stesso.» La risposta è che la povera e laboriosa gente comune si dichiarerebbe a stragrande maggioranza contro la guerra se fosse concesso loro un referendum. E perché no? Il mondo è decimato, impoverito e lacerato dalle terribili conseguenze dell'ultima guerra. Se nei Paesi coinvolti fossero stati indetti dei referendum, non ci sarebbe stata la guerra.
Secondo Mussolini i profeti armati conquistano. Potrebbe essere così. Ma le loro conquiste sono permanenti? No! Mussolini stesso, con grande energia, ha costruito una forma di governo dipendente dalla spada, dalla violenza, dalle perversioni politiche. Il vigore delle sue idee, il potere dei suoi spietati seguaci hanno soppresso per un certo periodo la democrazia italiana. Essa risorgerà. Il governo fascista è già gravemente pregiudicato dai metodi dei suoi leader e dalle sinistre attività commerciali perseguite da alti funzionari il cui formidabile potere impedisce il controllo pubblico dei beni che amministrano. Queste cose non possono essere soffocate ancora a lungo. Già adesso emergono fatti sui quali il nostro Paese sarà chiamato in giudizio.
La condotta della Banca Commerciale con riguardo al prestito polacco è un esempio dell'avarizia sfrenata permessa dai governanti fascisti. Molto più gravi sono le azioni del Ministero dell'Economia Nazionale nei suoi rapporti con la Sinclair Oil Company. Il Senatore Corbino, Ministro dell'Economia Nazionale, ha consegnato vasti spazi di terra in Emilia e in Sicilia contenenti oltre 100.000 ettari* (*circa 250.000 acri) di ricchi giacimenti di petrolio alla Sinclair Oil Company, collegata alla tentacolare Standard Oil Trust. Questo territorio immensamente ricco viene conferito a una società straniera senza garanzie. La natura sorprendente di questa concessione è illustrata dal nono paragrafo del comunicato ufficiale del governo: “La concessione comprende la produzione di oli minerali, gas e relativi prodotti idrocarburi, mentre lo sfruttamento delle rocce bituminose è riservato alle imprese italiane. L'accordo ha una durata di 50 anni. I privilegi fiscali concessi alla società sono i seguenti: a) Esenzione dai dazi d'importazione per i macchinari necessari alla società qualora non sia possibile ottenerli da imprese italiane. In ogni caso è riservata la preferenza per la fornitura di tali macchinari, a parità di altre condizioni; b) Esenzione dall'imposta sul reddito per i primi dieci anni.” Siamo già a conoscenza di molte gravi irregolarità relative a questa concessione. Alti funzionari possono essere accusati di corruzione e tradimento o del più vergognoso mercimonio. Molto più sinistro è il comportamento di molti fascisti al potere, che praticano un prelievo capillare su imprese private e semipubbliche allo scopo di finanziare giornali fascisti e altre organizzazioni per il loro interesse e profitto.
Quando Mussolini afferma nel suo articolo su Machiavelli che “c'è poca giustificazione morale per il governo rappresentativo”, potrebbe esaminare il sistema da lui stesso costruito, che è in parte un oltraggio alla moralità. Mentre è impegnato a denunciare i difetti della democrazia, una parte incontrollabile dei suoi seguaci commette crimini di violenza e ricatto. Egli fa pochi sforzi per rimproverarli, non può sopprimerli, perché dalle loro spalle è salito sul suo alto seggio. Lo hanno messo lì considerandolo un loro sostenitore, e lui è impotente nel controllare i loro disegni malvagi. Machiavelli avrebbe permesso questa situazione? Non lo avrebbe fatto. Sapeva che uno Stato deve perire se i prepotenti privilegiati possono commettere crimini senza restrizioni. Mussolini invoca la sua autorità per giustificare la sua politica. Dovrebbe leggere il suo Maestro con maggiore impegno. Che si rivolga al capitolo diciottesimo del “Principe” e legga cosa pensava Machiavelli a proposito del governo: «si può combattere in due modi: con le leggi o con la forza. Il primo è tipico dell'uomo, il secondo degli animali.»
O ancora nel nono capitolo del “Principe”. «E non venitemi fuori con quel vecchio e trito che chi si fonda sul popolo si fonda sul fango. Questo è vero per un privato cittadino che fa affidamento sul popolo e spera che il popolo lo salvi se egli fosse oppresso da nemici o da funzionari. Scoprirebbe subito di esseri ingannato, come avvenne a Roma ai Gracchi e a Firenze a Giorgio Scali. Ma quando invece è in principe a fare affidamento sul popolo, un principe che sappia comandare ed umano e non si lasci turbare dalla avversità e sia preparato ad affrontare la situazione, e tenga in pugno con il coraggio e gli ordini tutto il popolo, non sarà ingannato da esso e scoprirà di aver creato delle buone fondamenta.»
La democrazia in Italia può ora assopirsi, ma sentimenti come quelli di Mussolini non possono non rubare il loro sonno. Invece di effusioni rozze come questo articolo su Machiavelli, Mussolini potrebbe applicarsi nel purificare la sua creazione - i fascisti - le cui azioni pubbliche tendono a rendere l'Italia infame in tutto il mondo.
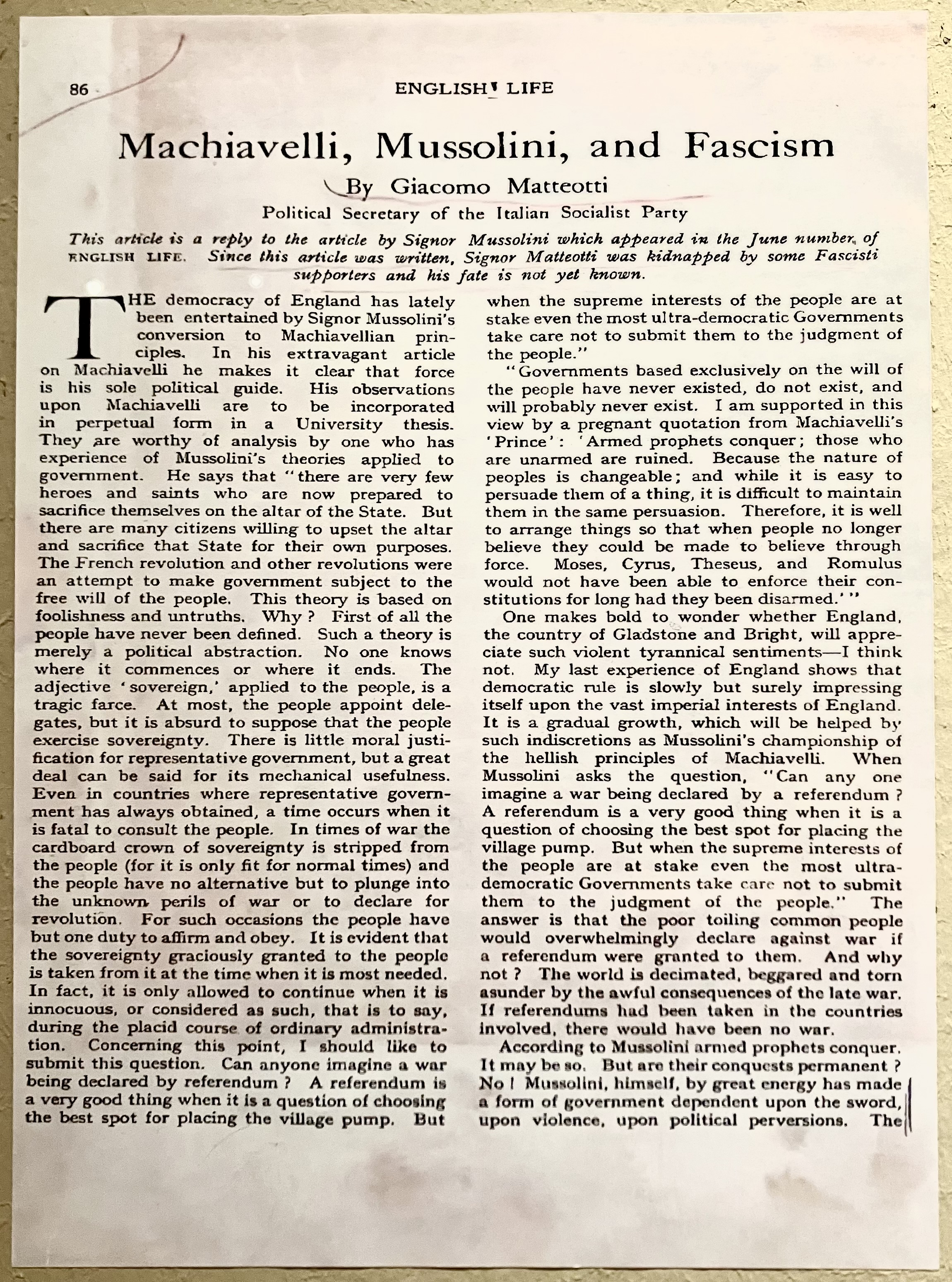
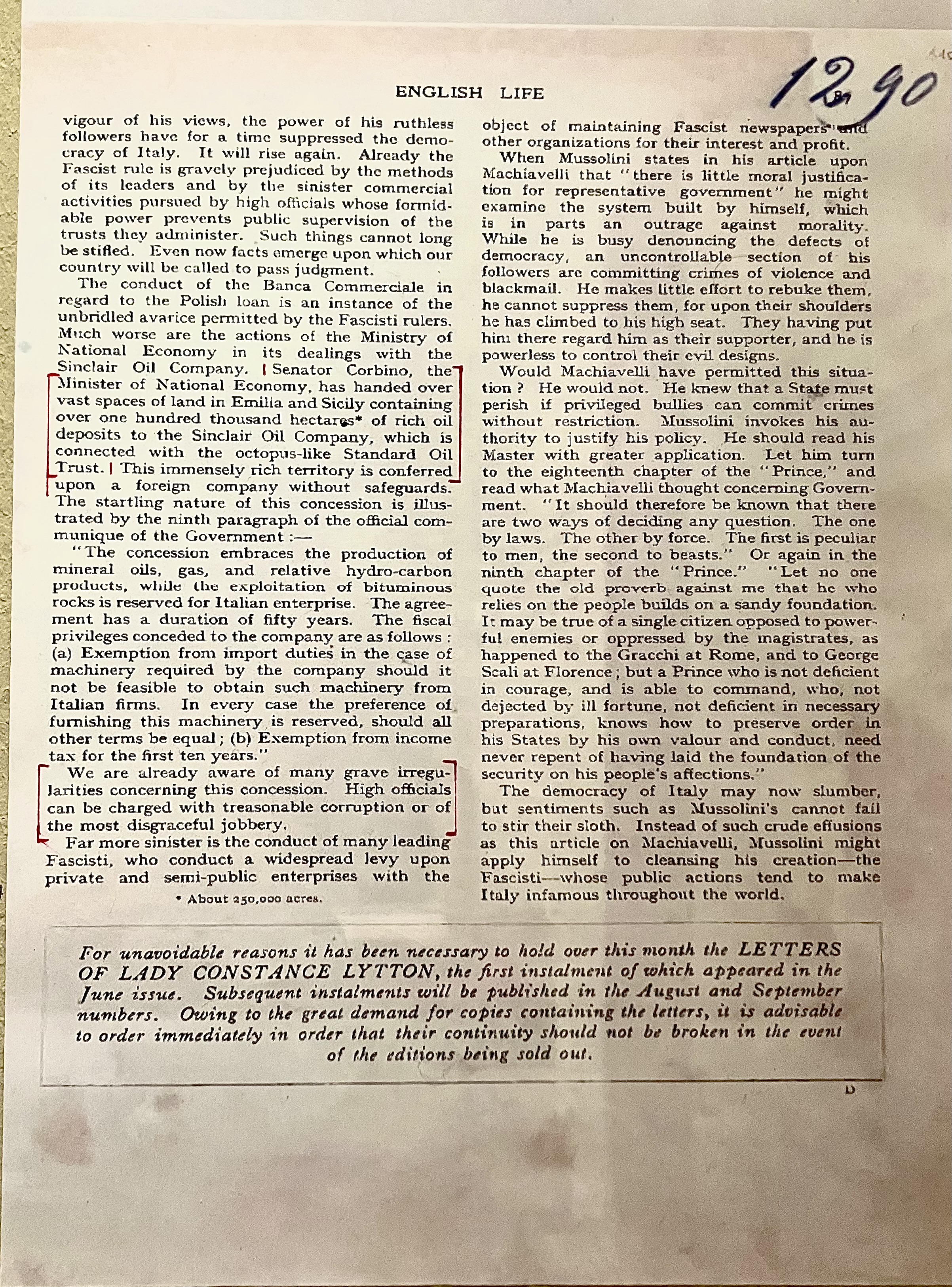
Machiavelli, Mussolini and Fascism
By Giacomo Matteotti
Political Secretary of the Italian Socialist Party
This article is a reply to the article by Signor Mussolini which appeared in the June number of ENGLISH LIFE. Since this article was written Signor Matteotti was kidnapped by some Fascisti supporters and his fate is not yet known.
The democracy of England has lately been entertained by Signor Mussolini’s conversion to Machiavellian principles. In his extravagant article on Machiavelli it makes it clear that force is his sole political guide. His observations upon Machiavelli are to be incorporated in perpetual form in a University thesis. They are worthy of analysis by one who has experience of Mussolini’s theories applied to government. He says that
«there are very few heroes and saints who are now prepared to sacrifice themselves on the altar of the State. But there are many citizens willing to upset the altar and sacrifice that State for their own purposes. The French revolution and other revolutions were an attempt to make government subject to the free will of the people. This theory is based on foolishness and untruths. Why? First of all the people have never been defined. Such a theory is merely a political abstraction. No one knows where it commences or where it ends. The adjective “sovereign” applied to the people is a tragic farce. At most the people appoint delegates, but it is absurd to suppose that the people exercise sovereignty. There is little moral justification for representative government, but a great deal can be said for its mechanical usefulness. Even in countries where representative government has always obtained, a time occurs when it is fatal to consult the people. In times of war the cardboard crown of sovereignty is stripped from the people (for it is only fit for normal times) and the people have no alternative but to plunge into the unknown perils of war or to declare for revolution. For such occasions the people have but one duty to affirm and obey. It is evident that the sovereignty graciously granted to the people is taken from it at the time when it is most needed. In fact it is only allowed to continue when it is innocuous or considered as such, that is to say during the placid course of ordinary administration. Concerning this point, I should like to submit this question. Can anyone imagine a war being declared by referendum? A referendum is a very good thing when it is a question of choosing the best spot for placing the village pump. But when the supreme interests of the people are at stake even the most ultra-democratic Governments take care not to submit them to the judgment of the people.»
«Governments based exclusively on the will of the people have never existed, do not exist, and will probably never exist. I am supported in this view by a pregnant quotation from Machiavelli “Prince”: “Armed prophets conquer; those who are unarmed are ruined”. Because the nature of peoples is changeable; and while it is easy to persuade them of a thing, it is difficult to maintain them in the same persuasion. Therefore it is well to arrange things so that when people no longer believe they could be made to believe through force. Moses, Cyrus, Theseus and Romulus would not have been able to enforce their constitutions for long had they been disarmed”.»
One makes bold to wonder whether England, the country of Gladstone and Bright, will appreciate such violent tyrannical sentiments – I think not. My last experience of England shows that democratic rule is slowly but surely impressing itself upon the vast imperial interests of England. It is a gradual growth which will be helped by such indiscretions as Mussolini’s championship of the hellish principles of Machiavelli. When Mussolini asks the question «can anyone imagine a war being declared by a referendum? A referendum is a very good thing when it is a question or choosing the best spot for placing the village pump but when the supreme interests of the people are at stake even the most ultra-democratic government take care not to submit them to the judgment of the people.» The answer is that the poor toiling common people would overwhelmingly declare against war if a referendum were granted to them. And why not? The world is decimated, beggared and torn asunder but the awful consequences of the late war. If referendums had been taken in the countries involved, there would have been no war.
According to Mussolini armed prophets conquer. It may be so. But are their conquests permanent? No! Mussolini himself, by great energy has made a form of government dependent upon the sword, upon violence, upon political perversions. The vigour of his views, the power of his ruthless followers have for a time suppressed the democracy of Italy. It will rise again. Already the Fascist rule is gravely prejudiced by the methods of its leaders and by the sinister commercial activities pursued by high officials whose formidable power prevents public supervision of the trust they administer. Such things cannot long be stifled. Even now facts emerge upon which our country will be called to pass judgment.
The conduct of the Banca Commerciale in regard to the Polish loan is an instance of the unbridled avarice permitted by the Fascisti rulers. Much worse are the actions of the Ministry of National Economy in its dealings with the Sinclair Oil Company. Senator Corbino, the Minister of National Economy as handed over vast spaces of land in Emilia and Sicily containing over 100,000th hectares* (*about 250,000 acres) of rich oil deposits to the Sinclair Oil Company which is connected with the octopus-like Standard Oil Trust. These immensely rich territory is conferred upon a foreign company without safeguards. The startling nature of this concession is illustrated by the ninth paragraph of the official communique of the government: – “The concession embraces the production of mineral oils, gas and relative hydro-carbon products while the exploitation of bituminous rocks is reserved for Italian Enterprise. The agreement has a duration of 50 years. The fiscal privileges conceded to the company are as follows: a) Exemption from import duties in the case of machinery required by the company should it not be feasible to obtain such machinery from Italian firms. In every case the preference of furnishing these machinery is reserved, should all other terms be equal; (b) Exemption from income tax for the first ten years.”
We are already aware of many grave irregularities concerning this concession. High officials can be charged with treasonable corruption or of the most disgraceful jobbery. Far more sinister is the conduct of many leading Fascisti, who conduct a widespread levy upon private and semi-public enterprises with the object of maintaining Fascist newspapers and other organizations for their interest and profit.
When Mussolini states in his article upon Machiavelli that «there is little moral justification for representative government» he might examine the system built by himself, which is in parts an outrage against morality.
While he’s busy denouncing the defects of democracy, an uncontrollable section of his followers are committing crimes of violence and blackmail. He makes little effort to rebuke them, he cannot suppress them, for upon their shoulders he has climbed to his high seat. They having put him there regarding him as their supporter, and he is powerless to control their evil designs.
Would Machiavelli have permitted this situation? He would not. He knew that a State must perish if privileged bullies can commit crimes without restriction. Mussolini invokes his authority to justify his policy. He should read his Master with greater application. Let him turn to the eighteenth chapter of the “Prince” and read what Machiavelli thought concerning Government. «It should therefore be known that there are two ways of deciding any question. The one by laws. The other by force. The first is peculiar to men, the second to beasts».
Or again in the ninth chapter of the “Prince”. «Let no one quote the old proverb against me that he who relies on the people builds on a sandy foundation. It may be true of a single citizen opposed to powerful enemies or oppressed by the magistrates as happened to the Gracchi at Rome and to George Scali at Florence; but a prince who is not deficient in courage and is able to command, who is not dejected by ill fortune, not deficient in necessary preparations, knows how to preserve order in his States by his own valour and conduct, need never repent of having laid the foundation of the security on his people’s affections.»
The democracy in Italy may now slumber, by sentiments such as Mussolini’s cannot fail to steal their sloth. Instead of such crude effusions as this article on Machiavelli, Mussolini might apply himself to cleansing his creation – the Fascisti – whose public actions tend to make Italy infamous throughout the world.
[1] https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/leg19/file/ASSR37_Chronicon.pdf
[2] “La follia della democrazia”. Una trascrizione dell’articolo inglese di Mussolini è reperibile qui https://andreapisauro.com/1924/06/01/the-folly-of-democracy/.
[3] MITAROTONDO L., The Folly of Democracy? Una pagina di resistenza e dissenso al Machiavelli in camicia nera, in Libertà uguaglianza democrazia nel pensiero politico europeo (XVI-XXI secolo), a cura di R. BUFANO, Lecce, Milella [«Politica Storia Progetto», n.7], 2018, pp. 165-180 (ISBN: 978- 88-3329-022-5).
Intervento alla cerimonia di commemorazione di Boris Giuliano
Scuola della Polizia di Stato (Roma, 23 luglio 2024)
Saluto con deferenza il Presidente della Repubblica, al quale porgo gli auguri più fervidi nel giorno del suo compleanno, esprimendo la mia gratitudine di cittadino e di magistrato per la guida saggia e illuminata che Egli assicura alla vita repubblicana.
Ringrazio il Capo della Polizia per l’iniziativa di dedicare al nome di Giorgio Boris Giuliano uno degli edifici di questa prestigiosa Scuola.
Una scelta che contribuisce a rinnovare il dovere di inchinarsi dinanzi al ricordo di un coraggioso servitore dello Stato, ma che impone anche di riconoscere il debito morale generato dalla consapevolezza che quel delitto fu il terribile epilogo di una vicenda profondamente segnata dalla solitudine istituzionale della vittima.
Una condizione che rese agevole il calcolo che precede l’assassinio: come era già avvenuto e come sarebbe ancora accaduto in quella Sicilia dove, secondo le parole dello storico Salvatore Lupo, negli ambienti polizieschi e giudiziari la maggioranza restava al riparo dell’ordinaria amministrazione, “per incapacità, o pigrizia, o paura, o complicità”.
Una condizione che rendeva immediatamente riconoscibili, non soltanto agli occhi di cosa nostra, i “morituri”: i pochi che sapevano dare prova di impegno efficace e intelligente.
È ciò che avvenne per Boris Giuliano.
La moglie Ines Maria, alla quale va oggi il mio omaggio devoto, lo ricordò ancora nell’aprile 1981 in una drammatica lettera al CSM, indicando i comportamenti passivi e remissivi di magistrati del tempo come fattore determinante dell’isolamento di un uomo inevitabilmente esposto alla rappresaglia mafiosa.
Fu così per Boris Giuliano.
Così come sarebbe stato da lì a poco anche per Cesare Terranova, Gaetano Costa e Giangiacomo Ciaccio Montalto.
Anche loro vittime di una violenza mafiosa che si scatenava quando ormai la vittima era già isolata in ambienti nei quali imperava la tentazione a lasciar andare tutto, senza concludere niente: per incompetenza, rassegnazione, indifferenza o compromissione.
Ben si comprende allora il senso profondo delle amare conclusioni che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino consegnarono nella sentenza-ordinanza che diede forma al Maxi processo, scrivendo: “se altri organismi statali avessero adeguatamente compreso e assecondato l’intelligente impegno investigativo del Giuliano probabilmente le strutture organizzative della mafia non si sarebbero così enormemente potenziate e molti efferati assassini, compreso quello dello stesso Giuliano, non sarebbero stati consumati”.
Parole che muovevano dal riconoscimento del grande valore delle indagini, “accurate e fruttuose”, che avevano condotto Boris Giuliano a scorgere, prima di tutti, il ruolo assunto da cosa nostra nel traffico internazionale degli stupefacenti e a percorrere con determinazione e lungimiranza le strade della cooperazione internazionale, innanzitutto con le agenzie americane che indagavano sulle importazioni dalla Sicilia della morfina base che inondava le strade di New York.
Per comprendere il significato innovatore dell’opera di Boris Giuliano basterebbe ricordare la modernità di un suo rapporto del 7 maggio 1979: “Accertamenti su attività illecite condotte dal crimine organizzato in Italia e negli U.S.A., con pagamenti attraverso operazioni bancarie”.
Per la prima volta, le indagini su Cosa Nostra si proiettavano verso quel medesimo sistema bancario che vedeva in Sicilia un cugino di Stefano Bontade, allora capo della famiglia di Santa Maria di Gesù, ricevere, quale dirigente di una banca di Palermo, le richieste di informazioni del Commissario Giuliano su un’operazione di riciclaggio di 300.000 dollari del tempo che quello stesso mafioso col colletto bianco aveva disposto sotto falso nome.
Una vicenda, come avrebbe in seguito sottolineato Giovanni Falcone, che rivelava, oltre all’impegno profondo di Boris Giuliano, la sua condizione di pratica solitudine.
Falcone ne trasse una lezione fondamentale per sviluppare le indagini che, muovendo dalle intuizioni di Boris Giuliano, egli condusse sul cruciale versante dei traffici di droga fra Sicilia e Stati Uniti: occorreva procedere in modo sistematico, accumulando e verificando dati, informazioni e fatti “fino a quando la testa scoppia”, come ebbe a dire nel 1991 nella sua famosa intervista a Marcelle Padovani.
Il cambiamento fu reso possibile, dunque, solo da un’organizzazione radicalmente nuova delle indagini, sottratte alla sorte del lavoro solitario, come quello che Boris Giuliano era stato invece costretto ad intraprendere.
A ben vedere, dunque, la terribile vicenda di Boris Giuliano fu dunque una delle radici profonde dell’esperienza del pool antimafia di Palermo.
Un’altra, ancor più profonda, radice muoveva dalla consapevolezza che la minaccia mafiosa gravava ormai sulle stesse sorti della democrazia italiana, come l’omicidio del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella aveva rivelato in modo eclatante e sinistro.
Una minaccia mafiosa che vedeva moltiplicare i suoi effetti destabilizzanti nell’obiettivo intreccio:
È importante ricordare oggi quella condizione di grave pericolo per la stabilità delle istituzioni democratiche, anche per comprendere appieno il valore di indagini che per la prima volta si proiettavano su due decisivi versanti:
Due direttrici di marcia nuove e feconde, che avrebbero dato grandi frutti negli anni successivi e che continuano anche oggi ad avere grande importanza.
Lo dimostrano le recenti indagini della Procura di Palermo e dell’United States Attorney Office for the Eastern District of New York, ancora una volta con il supporto dell’F.B.I.
Indagini che rivelano incredibili linee di continuità con quelle di Boris Giuliano, come dimostrato, ancora nel novembre 2023, dal nuovo arresto di quello stesso mafioso che il Commissario Giuliano aveva denunciato con il rapporto del 7 maggio 1979 che ho prima ricordato.
La collaborazione fra Italia e Stati Uniti è destinata a produrre ancora frutti importanti sull’asse Palermo-New York, ma ha un valore strategico su scala globale.
Noi lavoriamo innanzitutto per aprire ed estendere sempre più le strade della cooperazione internazionale nel contrasto della forza destabilizzante del narcotraffico e del riciclaggio dei relativi, enormi proventi.
Le tre giornate di lavoro fra decine di procuratori italiani e latino-americani svoltesi a Palermo in occasione del 32° anniversario della strage di Capaci stanno lì a dimostrarlo.
Un lavoro gomito a gomito, che ha generato nuove, importanti squadre investigative comuni e soluzioni condivise a tanti problemi delle più tradizionali forme di cooperazione giudiziaria: un incontro importante, che l’anno prossimo si rinnoverà a Rotterdam, come concordato con il Procuratore nazionale olandese e i Procuratori generali latino-americani.
Occorre proiettare sistematicamente le nostre indagini sulla dimensione globale del crimine organizzato, elaborando e condividendo progetti investigativi ambiziosi, necessari soprattutto per ricostruire i flussi finanziari a monte e a valle dei traffici di stupefacenti.
Abbiamo bisogno di sviluppare le nostre conoscenze sulla struttura e le logiche delle organizzazioni criminali che governano le rotte del narcotraffico internazionale, dando vita a network integrati che si avvalgono di una gigantesca rete logistica e di comuni strategie di occultamento e reinvestimento speculativo dei profitti dei traffici.
Un lavoro essenziale anche per cogliere la progressiva integrazione nella logica dei mercati criminali globali delle dinamiche evolutive di ‘ndrangheta, camorra e cosa nostra, ma soprattutto per illuminare i legami profondi del narcotraffico con i fenomeni di corruzione e finanziamento del terrorismo che si registrano su scala globale.
Serve insomma un deciso cambio di passo, abbandonando le asfittiche e vanagloriose logiche di indagini volte al mero sequestro di carichi di droga, la perdita dei quali spesso rappresenta per i narcos un costo già preventivato e talvolta persino sotterraneamente negoziato.
È necessario alzare lo sguardo e indirizzare le indagini verso le componenti più sofisticate delle organizzazioni criminali, come tali chiamate a guidarne i processi di trasformazione tecnologica e le strategie di mimetizzazione finanziaria.
Per farlo occorre rapidamente recuperare il grave gap tecnologico che rallenta l’azione delle nostre straordinarie forze di polizia e rischia di tenerle lontane dalle linee più avanzate della collaborazione internazionale.
Soprattutto, occorre condividere strategie investigative di più ampio respiro, possibili soltanto condividendo quel paziente lavoro di accumulazione, analisi ed elaborazione di dati e informazioni che Giovanni Falcone conduceva fino a farsi “scoppiare la testa” e che tutt’oggi non ha alternative credibili ed anzi può essere sostenuto e reso più efficace dalle nuove tecnologie digitali.
Una strada obbligata.
Anche per evitare pericolosi arretramenti del modello italiano di indagini sulla criminalità organizzata al quale, per la profonda conoscenza dei fenomeni criminali e il rigore dei metodi di lavoro, molti, in tutto il mondo, guardano con fiducia.
Un modello ammirato anche perché è costato, purtroppo, il sangue di alcuni e, per fortuna, il sudore di tanti.
Leggere il nome di Giorgio Boris Giuliano all’entrata dell’edificio a lui dedicato aiuterà molti a ricordare il dovere di non disperdere quel patrimonio di esperienza e di credibilità.
L’interesse ad accedere agli atti della procedura di project financing (Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 02/05/2024 n. 3979)
di Gloria Pelosi
Sommario: 1. La vicenda rimessa al vaglio del Consiglio di Stato. - 2. L’accesso difensivo nella legge n. 241/1990: natura giuridica, funzioni e requisiti di legittimazione attiva. - 3. La soluzione adottata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3979/2024.
1. La vicenda rimessa al vaglio del Consiglio di Stato.
Si riassume per sommi capi la vicenda che ha dato origine alla decisione in commento, considerato che le peculiarità della stessa hanno avuto un peso rilevante nell’individuazione delle questioni giuridiche sulle quali il Consiglio di Stato si è pronunciato.
Il giudizio di primo grado era stato instaurato dinanzi al TAR Lazio ai sensi dell’art. 116 del d. lgs. n. 104/2010 da parte di un operatore economico che, avendo presentato una istanza di accesso agli atti di una procedura ad evidenza pubblica, se l’è vista rigettare dalla pubblica amministrazione.
Occorre sottolineare come, nella specie, la procedura di gara era stata espletata ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d. lgs. n. 50/2016 (normativa applicabile ratione temporis al procedimento in questione) e, dunque, a seguito dell’approvazione di una proposta di project financing.
Per comprendere la portata della richiesta ostensiva rigettata, occorre sinteticamente descrivere la procedura di project financing di cui all’art. 183, comma 15, del d. lgs. n. 50/2016. Questa, come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento, consta di tre fasi.
La prima fase è quella dell’iniziativa, la quale è volta non già a scegliere il migliore fra una pluralità di offerenti sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, bensì all’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore inerente alla presentazione della proposta di finanza di progetto, in cui si esprime la valutazione dell’interesse pubblico. La seconda fase, che è di appannaggio della sola amministrazione, è volta a valutare la fattibilità della proposta e ad inserire l’opera dichiarata di pubblico interesse nella programmazione triennale, con sottoposizione ad approvazione del progetto preliminare rimessa al consiglio. La terza fase, invece, prevede l’indizione di una procedura di gara sul progetto approvato, soggetta ai principi comunitari e nazionali in materia di evidenza pubblica.
Ciò detto, l’istanza di accesso è stata presentata da una società che a detta procedura di gara non aveva mai preso parte, neppure nella fase a monte relativa alle consultazioni di mercato e alla predisposizione del progetto da porre a base di gara.
E tuttavia, la società istante, che riteneva che dalla realizzazione dell’opera pubblica programmata avrebbe subito una lesione ai propri diritti e interessi economici, da dapprima instaurato un giudizio volto all’annullamento dell’intera procedura, nell’ambito del quale era stata impugnata la determinazione dirigenziale con la quale l’amministrazione aveva approvato la proposta di project financing e, con motivi aggiunti, anche l’aggiudicazione.
Successivamente, ha presentato istanza di accesso ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, motivando la propria richiesta con riferimento alla necessità di utilizzare i documenti attinenti all’ultima fase della procedura di project financing (ossia quelli successivi all’adozione della lex specialis e, in particolare, tutti quelli attinenti all’aggiudicazione della procedura di gara, compresa l’offerta presentata dal RTI, unico concorrente, poi risultato aggiudicatario) per finalità difensive, non solo in considerazione del contenzioso già pendente, ma anche di eventuali iniziative future.
Di qui, la qualificazione dell’accesso come accesso difensivo.
Sulla predetta istanza si è formato il silenzio diniego, al quale ha fatto seguito una nota dell’amministrazione che motivava il diniego sulla base delle seguenti argomentazioni: assenza, in capo alla società istante, di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, dal momento che la stessa non aveva presentato un’offerta nell’ambito della procedura; assenza di un interesse difensivo nei confronti degli atti di gara, dal momento che il contenzioso pendente era volto all’annullamento e non all’aggiudicazione della procedura e presenza di una valida opposizione del controinteressato all’accesso agli atti di gara.
L’intero giudizio nell’ambito del quale si innesta la sentenza del Consiglio di Stato in commento si appunta sullo scrutinio di tale diniego di accesso agli atti. Mentre il giudice di primo grado ne aveva censurato l’illegittimità e, per l’effetto, aveva ordinato l’esibizione degli atti di gara richiesti, il Consiglio di Stato, quale giudice d’appello, ha ribaltato la decisione di primo grado accogliendo i motivi di ricorso del soggetto controinteressato all’accesso, nonostante gli atti di gara fossero stati esibiti in ottemperanza alla sentenza di primo grado. Infatti, come ricorda lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza in commento, che sul punto richiama un precedente in tal senso dell’Adunanza Plenaria (24 gennaio 2023 n. 4), ritenere che l’avvenuta ostensione dei documenti in ottemperanza alla sentenza di primo grado determini il venir meno dell’interesse a impugnare da parte del controinteressato all’accesso, significherebbe o privare la sentenza di primo grado di efficacia esecutiva o il processo sull’accesso del secondo grado di giudizio. Inoltre, l’interesse del controinteressato all’accesso alla decisione di secondo grado sussiste perché priva il ricorrente vittorioso in primo grado della possibilità di utilizzare i documenti ostesi e munisce l’appellante degli strumenti volti a tutelarsi da un eventuale uso indebito degli stessi.
2. L’accesso difensivo nella legge n. 241/1990: natura giuridica, funzioni e requisiti di legittimazione attiva.
Come è noto, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato introdotto nel nostro ordinamento con legge n. 241/1990, artt. 22 e ss., e consiste nel diritto dei soggetti privati interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dalla pubblica amministrazione[1].
Si tratta quindi di un istituto presente nell’impianto della predetta legge sin dalla sua introduzione, ed anzi ne costituisce uno dei maggiori punti di svolta, come si evince dal titolo della stessa, che detta “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”[2]. Ed infatti, la sua entrata in vigore ha contribuito ad invertire le regole del “segreto d’ufficio” e della segretezza in favore della trasparenza e della pubblicità degli atti[3].
Oggi, ai sensi dell’art. 22, secondo comma, della l. n. 241/1990, “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.
Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 è riconosciuto non al quisque de populo[4], ma soltanto a quei soggetti privati[5] che dimostrino di essere titolari di un interesse conoscitivo qualificato, in quanto titolari di una situazione giuridica soggettiva di base collegata al documento di cui è chiesta l’ostensione.
In tal senso, all’art. 25, secondo comma, della l. 241/1990 si prevede che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere motivata dal soggetto istante in relazione alla titolarità dei requisiti di legittimazione attiva all’accesso.
Questi sono delineati dall’art. 22, primo comma, lett. b) della l. n. 241/1990), il quale, precisamente, stabilisce che il diritto di accesso è attribuito a “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”[6].
L’accesso documentale è una tipologia di accesso che risponde essenzialmente ad un bisogno di conoscenza da parte di soggetti privati: “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni” (art. 24, terzo comma, l. 241/1990).
In altri termini, l’informazione non costituisce per il soggetto istante l’interesse finale, il bene della vita cui aspira. Piuttosto, il diritto di accesso delineato dalla legge n. 241/1990 si configura come una posizione giuridica soggettiva attribuita dall’ordinamento per la cura di una preesistente situazione giuridica collegata al documento di cui si chiede l’ostensione.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6 del 18 aprile 2006 ha espressamente riconosciuto il carattere strumentale del diritto di accesso, laddove ha stabilito che esso, a prescindere dalla questione – ancora dibattuta - circa la sua natura giuridica[7] (cioè della sua configurabilità come diritto soggettivo o come interesse legittimo), costituisce una situazione soggettiva che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, ormai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risulta caratterizzata per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante.
Da qui l’affermazione secondo cui il diritto di accesso documentale, contrariamente all’accesso civico, sia semplice, sia generalizzato[8], la cui disciplina è contenuta nel d. lgs. n. 33/2013, è volto al soddisfacimento di finalità di pubblico interesse, quali la trasparenza e l’imparzialità della pubblica amministrazione, soltanto se e nella misura in cui esso risponda ad un bisogno di conoscenza connesso ed un’esigenza di protezione di una situazione giuridica soggettiva preesistente[9].
Il diritto di accesso delineato dalla legge n. 241/1990, oltre ad essere strumento di partecipazione, di trasparenza e di imparzialità, può assumere un’ulteriore autonoma funzione, enucleata dall’ultimo comma dell’art. 24 della legge n. 241/1990. Si tratta dell’accesso difensivo (o difensionale), ossia dell’accesso agli atti esercitato da parte del soggetto istante con la finalità di curare o difendere i propri interessi giuridici. Tale norma, posta in chiusura del sistema delle esclusioni dal diritto di accesso agli atti, prevede che in tali casi l’accesso deve comunque essere garantito ai richiedenti se la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria (o, addirittura, strettamente indispensabile nei casi in cui l’accesso riguardi dati sensibili e giudiziari) per espletare le proprie esigenze difensive.
Tale particolare finalità dell’accesso difensivo, riconducile in senso lato al diritto di cui all’art. 24 Cost., permea l’intera disciplina cui esso è soggetto, tant’è che ormai ne viene affermata la piena l’autonomia concettuale e dogmatica[10].
Si tratta di una forma di accesso “caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la necessità della conoscenza dell’atto o la sua stretta indispensabilità, nel coso in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari”[11].
Il diritto di accesso motivato sulla base di esigenze difensive, dunque, si presenta come una situazione giuridica capace di resistere alle contrapposte esigenze di riservatezza che vengono in rilievo nel caso concreto. Ciò a condizione che nella motivazione posta a corredo dell’istanza ostensiva venga adeguatamente rappresentata la sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti di legittimazione attiva previsti dalla legge per tale tipologia di diritto di accesso.
Il legislatore ha infatti previsto dei puntuali criteri finalizzati ad individuare con precisione la situazione legittimante all’accesso difensivo, imponendo così al privato che voglia avanzare alla pubblica amministrazione una istanza di tal fatta un onere motivazionale aggravato rispetto a quello richiesto per l’accesso documentale semplice (o classico).
È necessario richiamare le argomentazioni e i principi di diritto contenuti della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18/03/2021, che ha contribuito a delineare in maniera chiara i confini applicativi dell’istituto in esame[12].
La ratio del diritto di accesso difensivo è costituita dal nesso di strumentalità necessaria, sulla base del quale occorre che vi sia un collegamento tra l’interesse difensivo che è alla base dell’stanza e il documento richiesto. La valutazione circa la sussistenza del nesso di strumentalità è regolata in ogni sua parte dalla legge, nonché dal relativo regolamento di attuazione (ossia il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184), in modo tale da non lasciar residuare “tratti liberi” rimessi all’interpretazione della pubblica amministrazione[13] ovvero al prudente apprezzamento del giudice.
La norma dalla quale si evince la centralità del nesso di strumentalità nell’ambito dell’istituto in esame è l’art. 22, comma 1, lett. b) della l. 241/1990, laddove si afferma che l’interesse all’accesso, oltre ad essere diretto[14], concreto e attuale[15], deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale l’accesso si riferisce.
Da qui il rilievo, evidenziato dall’Adunanza plenaria, secondo cui il giudizio sull’interesse legittimante è ancorato allo scrutinio di due parametri fissi, rigidi e predeterminati: la corrispondenza e il collegamento.
L’interesse conoscitivo legittimante l’accesso difensivo è quello che corrisponde in modo diretto concreto e attuale a delle preesistenti esigenze di cura o di difesa (anche in giudizio) di una situazione giuridicamente tutelata.
La valutazione circa la sussistenza del requisito della corrispondenza coincide essenzialmente con un giudizio di pratica sussunzione che l’interprete deve effettuare tra “il fatto concreto di cui la parte domanda la tutela in giudizio e l’astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale”[16]. In altri termini, esso è da ritenere sussistente in quelle sole ipotesi in cui vi sia piena corrispondenza tra le ragioni di tutela evidenziata nell’istanza (ossia i fatti, principali e secondari, di cui la fattispecie concreta si compone) e la fattispecie astratta che costituisce la base legale delle esigenze difensive avanzate nell’istanza.
Il requisito del collegamento, invece, sta ad indicare la necessità che il documento amministrativo di cui è richiesta l’ostensione sia connesso con la situazione giuridica controversa e con le esigenze difensive rappresentante nell’istanza ostensiva. Si richiede, in altri termini, che l’accesso sia utilizzato quale strumento per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica controversa.
La volontà del legislatore, nell’interpretazione del giudice amministrativo, è stata quella di esigere che le finalità difensive siano adeguatamente e puntualmente rappresentate nella richiesta ostensiva, in modo tale da permettere all’amministrazione detentrice del documento e al giudice eventualmente adito nell’ambito del giudizio di accesso il vaglio circa la sussistenza del nesso di strumentalità necessaria, tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione finale controversa[17].
Si deve invece escludere che nell’istanza di accesso sia sufficiente un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive (siano esse riferite ad un giudizio già pendente oppure ancora instaurando), ovvero all’incertezza della situazione giuridica sostanziale, “poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare”.
Con riferimento, però, alla tipologia di valutazione che spetta alla pubblica amministrazione ed eventualmente al giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a.[18], è importante precisare come essi “non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, di esercizio pretestuoso e temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241/1990”[19].
3. La soluzione adottata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3979/2024.
Il Consiglio di Stato, nella pronuncia in commento, è stato chiamato a verificare, nel caso di specie sopra brevemente delineato, la sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto di accesso difensivo, per poi scrutinare il diniego opposto dalla pubblica amministrazione.
In particolare, il collegio si è interrogato sul se un operatore economico che si trovi nella situazione sopra descritta possa vantare, come richiesto dall’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, un interesse “diretto, concreto e attuale” all’accesso, pervenendo ad una soluzione negativa e così sovvertendo la soluzione accolta dai giudici di prime cure.
Ciò sulla base del fatto che, secondo i giudici di Palazzo Spada, l’istanza di accesso concretamente presentata costituisce un tentativo di strumentalizzare il diritto di accesso agli atti di gara per delle finalità che vanno oltre la stessa.
L’interesse posto alla base dell’istanza di accesso, infatti, è quello di opporsi alla realizzazione dell’opera pubblica che era stata programmata e poi posta a base di gara; mentre invece gli atti oggetto dell’istanza erano quelli relativi terza fase della procedura di project financing e, in particolare, quelli inerenti alla fase conclusiva della gara. Tale circostanza evidenzia una palese discrasia, un vero e proprio scollamento, tra l’interesse sostanziale evidenziato nell’istanza di accesso e i documenti rispetto ai quali si appunta la richiesta ostensiva.
In altri termini, il ragionamento svolto dal collegio è il seguente: se l’interesse sostanziale evidenziato dalla parte istante è quello a che il progetto posto a base di gara non venga realizzato, gli unici atti che effettivamente minacciano la realizzazione di tale interesse e rispetto ai quali la società istante può vantare un interesse difensivo sono quelli relativi alla prima fase della procedura di project financing, ossia quella di progettazione.
La pubblica amministrazione, invece, avrebbe senz’altro potuto esibire i documenti relativi alla fase di gara soltanto qualora l’interesse difensivo rappresentato nella richiesta di accesso agli atti fosse stato quello di difendersi da una procedura di gara illegittimamente svoltasi al fine di ottenere l’aggiudicazione della commessa pubblica.
Queste osservazioni conducono i giudici a negare la sussistenza nel caso di specie del nesso di strumentalità, difettando la necessaria corrispondenza tra le ragioni di tutela evidenziate nell’istanza e l’astratto paradigma legale cui è rivolta l’esigenza difensiva.
Il paradigma costituente la base legale delle esigenze difensive avanzate nell’istanza viene identificato dal collegio nella possibilità di difendersi dagli atti di gara successivi all’adozione della lex specialis. Possibilità, questa, che dipende dalla sussistenza, in capo alla società istante, della legittimazione e dell’interesse ad impugnare gli atti di gara.
Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che alla società istante non spettasse la legittimazione a impugnare gli atti di gara successivi al bando. A sostegno di tale assunto i giudici richiamano la giurisprudenza nazionale (e, in particolare, le sentenze dell’Adunanza Plenaria del 26 aprile 2018 n. 4, del 7 aprile 2011 n. 4 e del 29 gennaio 2003 n. 1) secondo la quale in linea generale la legittimazione ad impugnare gli atti di gara spetta soltanto a chi vi ha partecipato, nonchè la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’unione europea (Cgue, sez. X, 9 febbraio 2023, C-53/22), laddove ha stabilito che l’ammissibilità del ricorso agli atti di gara deve essere assicurato a “chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione”, quindi soltanto chi ha presentato un’offerta ammissibile.
Per altro, si afferma nella sentenza in commento che l’interesse manifestato nell’istanza di accesso non presenterebbe il requisito dell’immediatezza. Ciò in quanto un eventuale annullamento degli atti di gara comporterebbe sì il soddisfacimento dell’interesse alla non realizzazione dell’opera, ma soltanto in via indiretta e soltanto a seguito di una pluralità di variabili: l’impugnazione e il successivo annullamento degli atti di gara e, inoltre, la decisione della stazione appaltante di non indire una nuova procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione della medesima opera.
Per questa ragione, nel caso di specie i giudici hanno ritenuto di non poter fare uso della nozione ampia di interesse a ricorrere delineata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò in quanto, mentre nel caso in esame l’interesse cui l’operatore economico aspira è il fallimento dell’opera pubblica programmata, nelle ipotesi ampia di interesse a ricorrere delineato dalla Corte di Giustizia, invece, si prende in considerazione l’interesse dell’operatore economico ad avere la possibilità di ottenere una nuova riedizione della gara, anche nell’ipotesi in cui egli avrebbe dovuto essere escluso dalla gara precedete.
L’interesse al fallimento dell’opera pubblica programmata, di per sé considerato, afferma il Collegio, non può per altro ritenersi meritevole di tutela nel nostro ordinamento, dal momento che la posizione del privato che dialoga con il pubblico potere è volta a far sì che l’esercizio legittimo di quest’ultimo sia volto alla migliore soddisfazione possibile dei propri interessi. Invece, nel caso di specie, l’operatore economico, al fine di non vedere realizzata l’opera programmata che lede i propri interessi, spera in un’inefficienza della pubblica amministrazione, che decida di non portare a termine il progetto programmato.
A ben vedere, difetterebbe anche la preesistenza della situazione difensiva. Infatti, la pretesa alla non realizzazione dell’opera potrebbe essere soddisfatta soltanto al verificarsi di una variabile estranea all’esito del giudizio amministrativo e del tutto casuale, ossia, come già sottolineato, la scelta discrezionale della stazione appaltante di non indire nuovamente la gara.
Oltre agli aspetti sin qui considerati, il Consiglio di Stato ritiene che il diniego opposto dall’amministrazione sia legittimo, anche in ragione dell’opposizione all’accesso presentata dal controinteressato a tutela della riservatezza della propria attività.
È noto infatti come, la disciplina dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, contenuta all’art. 53 del d. lgs. 50 del 2016, pur richiamando la disciplina generale prevista dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, costituisce un sistema normativo speciale in ragione delle peculiari esigenze di riservatezza che sono solite manifestarsi nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica.
Tra le specifiche disposizioni che qui vengono in rilievo vi è quella di cui al comma 5 dell’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, che prevede alla lettera a), tra i casi assoluti di esclusione del diritto di accesso, le informazioni rese nell’ambito dell’offerta che costituiscono, secondo motivata e comprovata opposizione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
Il successivo comma 6 dell’art. 53 del D. lgs. n. 50 del 2016, anche in presenza dell’opposizione motivata del controinteressato, consente comunque l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici al “concorrente” al fine di tutelare in giudizio i propri interessi.
Pertanto, la disciplina di cui al comma 6, che consente ai soli fini difensivi un accesso capace di prevalere sulle esigenze di tutela della riservatezza dei controinteressati, presuppone che l’operatore economico richiedente l’accesso sia un “concorrente” e che abbia quindi quanto meno presentato un’offerta ammissibile. Evenienza questa che, come già volte sottolineato, difettava nel caso di specie.
Ogni operatore economico partecipante è consapevole che, per ottenere il bene della vita anelato (l’aggiudicazione), è tenuto, così come gli altri concorrenti, ad assolvere agli oneri comunicativi imposti dalla stazione appaltante, la quale è tenuta a rispettare le esigenze di riservatezza che vengono in rilievo nelle procedure ad evidenza pubblica.
Il rapporto che si instaura tra gli operatori economici partecipanti e le Amministrazioni è stato definito come “rapporto di fiducia” ed esso è tale per cui gli operatori economici partecipanti alle gare devono poter confidare sul fatto che le stazioni appaltanti non rivelino a terzi le loro informazioni riservate, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la loro attività commerciale e falsare la concorrenza.
Il soggetto che è terzo, al contrario dei partecipanti alla gara, non ha assunto alcun rischio relativo alla propria attività imprenditoriale e, pertanto, non essendo la sua posizione paragonabile a quella degli altri operatori economici partecipanti, la sua richiesta ostensiva può non essere accolta.
Per tutti questi motivi, il Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimità del diniego di accesso agli atti serbato dalla pubblica amministrazione.
Alla luce di quanto fin qui esposto, è possibile affermare che nella sentenza in commento il Consiglio di Stato abbia adottato una soluzione che si pone del tutto in linea con i principi di diritto enucleati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4/2021 in materia di accesso difensivo.
L’analisi dell’apparato motivazionale posto a corredo della decisione in esame, anzi, costituisce l’occasione per vedere “attraverso la lente di ingrandimento” come, nella prassi, la pubblica amministrazione e il giudice amministrativo siano tenuti a scrutinare le istanze di accesso agli atti, onde verificare sussistenza, nel caso concreto, del requisito del nesso di necessaria strumentalità tra esigenze difensive rappresentate nell’istanza e documenti cui la stessa si riferisce.
La sentenza in commento, come già evidenziato, ribalta l’esito cui erano pervenuti i giudici di prime cure[20], i quali invece avevano ritenuto sussistente il nesso di necessaria strumentalità sulla base dell’assunto per cui non si può astrattamente escludere che l’ostensione della documentazione di gara possa rivelarsi utile per la coltivazione del giudizio volto a contestare la decisione della stazione appaltante di avviare la procedura di project financing.
Tuttavia, se in linea teorica tale affermazione può apparire condivisibile, ciò che in ogni caso effettivamente mancava nel caso concreto era una adeguata rappresentazione delle esigenze difensive nella motivazione dell’istanza di accesso. In questa, infatti, si sarebbe dovuta evidenziare la possibilità che, dall’accesso agli atti di gara, il soggetto istante mirava ad individuare degli specifici vizi relativi alla fase a monte della procedura, tali per cui si riusciva a dimostrare che quell’opera pubblica per la quale la gara era stata indetta in realtà mai si sarebbe potuta realizzare. Solo così si può cogliere quel collegamento tra l’esigenza di opporsi alla decisione a monte di realizzare un’opera pubblica e gli atti della procedura di gara indetta per la sua realizzazione che è necessario che attribuire la titolarità del diritto di accesso al soggetto istante.
Pur condividendo la soluzione accolta dal Consiglio di Stato, occorre infine svolgere ulteriori alcuni brevi considerazioni.
La sentenza in commento, infatti, ha sicuramente il pregio di mettere in risalto l’importanza che il nesso di necessaria strumentalità ha nell’ambito dei requisiti di legittimazione all’accesso difensivo. Tuttavia, appare comunque opportuno precisare come i concetti di interesse ad accedere agli atti e di interesse a ricorrere vadano tenuti nettamente distinti. Il giudizio circa la sussistenza nel caso concreto di un collegamento tra le esigenze difensive paventate nell’istanza e gli atti amministrativi richiesti non può (e non deve) coincidere con la valutazione circa la sussistenza di un interesse a ricorrere avverso quegli atti.
Mentre il primo spetta al giudice chiamato a valutare ex art. 116 c.p.a. la legittimità o meno del diniego serbato dalla pubblica amministrazione in materia di accesso agli atti; la seconda spetta unicamente al giudice della causa principale[21].
Il diritto di accesso e il relativo giudizio instaurato ex art. 116 c.p.a. davanti al giudice amministrativo hanno una valenza strumentale, ma comunque autonoma, rispetto sia alla situazione giuridica di base che si intende tutelare, sia all’eventuale giudizio principale instaurato o ancora da instaurare in cui quella situazione si intende far valere.
Pertanto, seppure negli anni, sia il legislatore, con la riforma del 2005, sia la giurisprudenza, con l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, abbiano accentuato l’importanza che il nesso di strumentalità ha nell’individuare la platea dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso difensivo, bisogna comunque tenere nettamente distinti i concetti di interesse ad accedere e di interesse a ricorrere, per evitare rischiose sovrapposizioni.
[1] Oltre all’accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990, il nostro ordinamento conosce altre due tipologie di accesso, di più recente introduzione, aventi una portata applicativa generalizzata, ossia l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato, disciplinate dal d. lgs. 33/2013, alle quali si affiancano altre forme di accesso settoriali (tra le quali si segnalano l’accesso ambientale di cui al d.lgs. 195/2005 e l’accesso nell’ordinamento degli enti locali di cui all’art. 10 del d. lgs. 267/2000 (TUEL). Per un approfondimento sulle distinzioni e i rapporti tra le varie forme di accesso agli atti, in dottrina si vedano: A. Celotto, La trasparenza e l’accesso ai documenti amministrativi, in C. Contessa, R. Greco (a cura di), L’attività amministrativa e le sue regole (a trent’anni dalla legge n. 241/1990), Piacenza 2020, p. 541; F. Manganaro, Evoluzione ed involuzione delle discipline normative sull’accesso a dati, informazioni ed atti delle pubbliche amministrazioni, in Diritto amm., 2019, p. 743; F. Patroni Griffi, La trasparenza della pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in federalismi.it, 2013, 8; S. Sergio, Il diritto di accesso procedimentale e il diritto di accesso civico, fra differenze e analogie. In particolare, la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso, in federalismi.it, 2020, fasc. 20; A. Simonati, I principi in materia di accesso, in M.A. Sandulli (a cura di) Codice dell’azione amministrativa, Milano 2017, pag. 1209.
[2] G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Ottava edizione, Torino 2017, p.245.
[3] M.C. Cavallaro, Garanzie della trasparenza amministrativa e tutela dei privati, in Diritto amm., 1° marzo 2015, fasc. 1, pag. 121, in cui l’A. sottolinea come “se prima la regola era il segreto e l’accesso rappresentava l’eccezione, la 241 capovolge tale rapporto, facendo divenire l’accesso ai documenti la regola generale e il segreto la relativa eccezione”.
[4] Questo a differenza di quanto previsto dal progetto di legge predisposto dalla Commissione Nigro, che legittimava all’accesso “tutti i cittadini”. Sul punto si veda F. Caringella, R. Garofoli, M.T. Sempreviva, in L’accesso ai documenti amministrativi – profili sostanziali e processuali, II edizione, Milano 2003, pag. 59, in cui si evidenzia come “la scelta della restrizione soggettiva, operata dal legislatore, trova la sua ratio in motivi di ordine pubblico, riconducibili al rischio che il riconoscimento a chiunque della facoltà di proporre istanza di accesso avrebbe comportato una mole di lavoro tale da provocare conseguenziali difficoltà organizzative da parte dell’amministrazione”. Sul punto cfr. Cons. St., Sez. VI, 20 novembre 2013, sent. n. 5515: “Il legislatore ha, inoltre, inteso configurare il diritto di accesso come strumento di composizione di interessi antagonisti incisi dall’azione amministrativa. Le disposizioni in materia di accesso mirano a coniugare la “ratio” dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della citata legge n. 241/1990 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti, inerenti non solo alla riservatezza di altri soggetti coinvolti, ma anche alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione, che appare da salvaguardare in presenza di richieste pretestuose e defatiganti, ovvero introduttive di forme atipiche di controllo”.
[5] R. Leonardi, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: a proposito dei soggetti attivi per un’azione amministrativa trasparente, ma non troppo, in Foro Amm., 2006, pagg. 2155 ss.
[6] La norma è il frutto di una modifica legislativa intervenuta ad opera della legge n. 15 del 2005, che ha completamente riscritto la fattispecie legittimante il diritto di accesso agli atti, rendendola molto più dettagliata e restrittiva della precedente. Per un commento sulle novità introdotte dalla riforma avutasi con l. n. 15 del 2055, si veda A. Sandulli, L’accesso ai documenti amministrativi, in Giorn. dir. amm., 2005, 5; M. Ciommola, La legittimazione ad accedere ai documenti amministrativi prima e dopo la l. 11 febbraio 2005 n. 11, Foro Amm. TAR, 2007, 3, pag. 1181.
[7] G. Virga, L’erba fenice della natura giuridica del diritto di accesso, in Lexitalia.it, 2006, fasc. 5.
[8] L’accesso civico semplice costituisce una forma di accesso di tipo “reattivo”, nel senso che serve da parte di “chiunque” per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi di pubblicazione legislativamente previsti (art. 5, primo comma, d. lgs. n. 33/2013); l’accesso civico generalizzato (introdotto nell’impianto del d. lgs. n. 33/2013 con la l. n. 97/2016), invece, è un accesso di tipo “proattivo”, nel senso che consente a chiunque, a prescindere dall’esistenza di obblighi di pubblicazione rimasti inadempiuti – di accedere a dati o documenti concernenti lo svolgimento dell’attività amministrativa. Sull’accesso civico semplice, ex multis: E. Carloni, L’obbligo di pubblicazione, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2017, p. 1397. Sull’accesso civico generalizzato, ex multis: M. Savino, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Giornale di diritto amministrativo, 2016, n. 5, pagg. 593 ss.
[9] Consiglio di Stato, Ad. Pl, 02/04/2020, n. 10: “Nell’accesso documentale ordinario, “classico”, si è dunque al cospetto di un accesso strumentale alla protezione di un interesse individuale, nel quale è l’interesse pubblico alla trasparenza ad essere […] “occasionalmente protetto” per il c.d. need to know, per il bisogno di conoscere, in capo al richiedente, strumentale ad una situazione giuridica pregressa. Per converso, nell’accesso civico generalizzato si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know, l’interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc. dd. eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 3 del d. lgs. n. 33 del 2013”. Sulla pronuncia, ex multis: F. Manganaro, La funzione nomofilattica dell’Adunanza Plenaria in materia di accesso agli atti amministrativi, in federalismi.it, 2021, fasc. n. 20, pagg. 159 ss.
[10] T. Raimo, Le potenzialità probatorie dell’accesso difensivo, in Urbanistica e appalti, 2021, fasc. 6, p.785.
[11] Consiglio di Stato, Ad.Pl., 25/09/2020, n. 19.
[12] G. Delle Cave, L’accesso difensivo post Adunanza Plenaria n. 4/2021 tra potere valutativo della P.A. e apprezzamento del giudice (nota a Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2022, n. 1342), in questa Rivista, 28 aprile 2022.
[13] F. Francario, Il diritto di accesso deve essere una garanzia effettiva e non una mera declamazione teorica, in federalismi.it, 2019, n.10, pagg. 9 ss.: “La regola è quindi che l’accesso, strumentale – si ripete – al soddisfacimento di un bisogno di tutela proprio di una situazione giuridica soggettiva, prevalga. L’eccezione è che rimanga insoddisfatto. Perché venga impedito è necessario che si contrapponga un interesse di “pari rango”, che vi sia cioè una eccezione espressamente contemplata sul piano normativo; e non già una semplice esigenza discrezionalmente apprezzabile della pubblica amministrazione”.
[14] M. Ciommola, op.cit., ove si sottolinea come il termine diretto, riferito all’interesse ostensivo, deve essere interpretato o come sinonimo di personale. Con tale requisito il legislatore ha voluto esprimere l’esigenza che ogni istanza di accesso riguardi interessi propri del soggetto richiedente e non interessi di terzi.
[15] Tale requisito è interpreta in senso ampio dalla giurisprudenza, la quale non richiede la sussistenza di una lesione attuale alla situazione giuridica soggettiva di base. Con. St., Ad. Pl., 24 aprile 2012, sent. n. 7: “la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto d’accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto”.
[16] Consiglio di Stato, Ad. Pl. 18/03/2021, n. 4, par. 14.
[17] I. Piazza, Strumentalità dell’accesso difensivo e sindacato giurisdizionale (nota a Consiglio di stato, sez. III, 31 dicembre 2020, n. 8543), in questa rivista, 2021.
[18] V. Parisio, La tutela dei diritti di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni nella prospettiva giurisdizionale, in federalismi.it, 2018, 11, pagg. 345 ss.
[19] Consiglio di Stato, Ad. Pl. 18/03/2021, par. 20.4.
[20] TAR Lazio, Roma, Sez. II, 13/12/2023, n. 18915.
[21] In questi termini, TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 21 marzo 2013, n. 442: “L’accesso ai documenti amministrativi […] può essere esercitato indipendentemente dal giudizio sull’ammissibilità o sulla fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso, con la conseguenza che la circostanza che gli atti oggetto dell’istanza ostensione siano divenuti inoppugnabili non preclude l’esercizio del suddetto diritto, in quanto l’interesse presupposto dall’art. 22, l. 241/1990è nozione diversa e più ampia dell’interesse all’impugnazione”. Conforme: Cons. St., Sez. II, 28 aprile 2021, n. 3426.
Abitare il tempo, abitare lo spazio.
Su queste rotte di orientamento e di orizzonte il Movimento per la Giustizia - Art. 3 ha costruito – o meglio ri-costruito – le sue nuove direttrici di marcia.
Sulle radici di un passato orgoglioso, canalizzata in Area l’ideologia associativa che ne aveva fatto un baluardo progressista in ANM e nell’organo consiliare, il Movimento, permanendo vitale, ha colto il bisogno di convertirsi in qualcosa di più prossimo ad una Giustizia a tutto campo; una Giustizia aperta al sociale, ai bisogni delle tante comunità in difficoltà che sul disagio e l’emarginazione costruiscono silenziosamente il loro grido d’aiuto; una Giustizia che dal ristretto perimetro del Foro, che ben conosce miseria e afflizione umana pur nell’esangue distacco proprio dell’ufficialità del ruolo, sappia guardare invece a percorsi più sciolti e diretti, informali e dunque più efficaci, di incidenza umana e sociale. L’impegno nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione dell’arte e della cultura portatrici del Giusto, nel credo d’accoglienza oggi troppo spesso retoricamente predicato se non addirittura negato, nella convinzione e partecipazione a contributi reali per una detenzione costituzionalmente più giusta, all’unisono con canoni di effettiva umanità. Nella costruzione, insomma, di un presente e di un futuro inclusivo e solidale, componente irrinunziabile di questo tempo di Giustizia.
Ecco perché occorre muoversi ad abitarlo così questo tempo, mettendo a frutto l’esperienza ultratrentennale di uomini e donne in toga e aggregando forze laiche e rinnovati entusiasmi per favorire il transito di un Movimento più contemporaneo anche in uno spazio diverso, dove si possa provare a dare risposte ai bisogni di giustizia ed equità con un armamentario più agile e flessibile.
E questo spazio nuovo da abitare, la nuova pelle di cui quest’anima rinnovata del Movimento vuole rivestirsi, ci viene offerta proprio dal terzo settore – l’àmbito in cui adesso anche formalmente esistiamo – perché è lì che i nuovi orizzonti possono trovare la giusta sagomatura operativa, intervenendo in affiancamento alle istituzioni e per esse supplendo alle diffuse carenze d’intervento in quei contesti d’interesse generale in cui il bisogno di giustizia e di solidarietà si fa grido sensibile e accorato.
La rivista Giustizia Insieme continuerà a tenerci legati e collegati al mondo del diritto, alla tutela dei vecchi e nuovi diritti, con l’autorevolezza dell’astrazione e l’incidenza di un pensiero progressista ormai ben gradito ai nostri lettori. Ciò che adesso vogliamo sul campo per il nostro Movimento è invece una rinnovata mobilità che dia sostanza sociale ad un’esperienza professionale vissuta sempre e soltanto come servizio. Un’esistenza che miracolosamente già conteneva i germi di questa svolta oggi portata a compimento.
Ad ottobre prossimo, precisamente venerdì 18, usciremo all’esterno con un primo appuntamento pubblico: nella cornice teatrale dello storico Kursaal di Bari, con il patrocinio della Regione Puglia, dell’Ateneo e dell’Ordine degli Avvocati di Bari, ci ritroveremo a discutere di lavoro, valore, identità, con un’iniziale presentazione del Segretario nazionale che servirà da manifesto pubblico del nuovo Movimento, cui farà seguito una sequenza di interventi che spazieranno sul tema con riguardo all’insicurezza, alla precarietà, e con autorevoli incursioni sui contesti estremi (carcere, migranti, povertà), avendo cura di inframezzare le relazioni con voci e letture affidate ad attori ed artisti noti. L’incontro culminerà con un intervento della Presidente del Movimento.
Un’occasione da non perdere, che fungerà da raccolta e confronto ideale e progettuale e al contempo da ribalta nazionale per la costruzione della nostra nuova identità sociale.
Consideriamoci tutti pronti!
Immagine: Onofrio Tomaselli, I carusi, olio su tela, 1905, Galleria di Arte Moderna, Palermo.
Sommario: 1. Introduzione - 2. L’abrogazione dell’abuso di ufficio - 3. Una manovra legislativa in due “tappe” (pressoché) sincroniche: abolizione totale dell’abuso d’ufficio con disegno di legge ed introduzione con decreto legge della nuova fattispecie di “indebita destinazione di denaro o cose mobili” - 4. La nuova fattispecie di “indebita destinazione di denaro o cose mobili” - 5. I rapporti fra le norme interessate dalla riforma: art. 323, art. 314-bis, art. 314.
1. Introduzione
Fra le diverse cose di cui il Ministro della Giustizia non si sarà accorto, nell’emanare il decreto legge 4 luglio 2024, n. 92[1], che, immediatamente prima dell’abrogazione dell’art. 323, ha introdotto nel codice penale l’art. 314-bis, fra quelle cose, a mio parere, vi è anche la singolare assonanza linguistica fra Arenula e Merulana: un accostamento che orienta verso la sgradevole impressione che con le due riforme collegate fra loro sia stato combinato un “Pasticciaccio brutto”, che, come nel romanzo di Gadda, sembra non potersi avviare verso una soluzione soddisfacente.
Infatti, riguardo alle norme penali sopra citate, la vicenda pone molti interrogativi, che le conferiscono quasi il carattere di un giallo (forse meglio noir?...): perché finire impietosamente un delitto già (mezzo) morto? Quali sono le vere ragioni che hanno indotto il Ministero a considerare un “caso straordinario di necessità e di urgenza” il recupero (in modo assai malacconcio) del peculato per distrazione, riconducendo nella sfera dei delitti di peculato ciò che nel 1990 ne era stato espunto? Perché limitare la punibilità degli abusi distrattivi al solo caso in cui questi vengano commessi mediante una destinazione di cose mobili? Perché punire le distrazioni di cose mobili solo se l’uso al quale queste vengono destinate è “diverso da quello previsto da specifiche disposizione di legge o di atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità”? È verosimile, o, più esattamente, è statisticamente significativo il caso che la destinazione impropria di denaro o altra cosa mobile sia intenzionalmente rivolta a recare danno ad altri?
La nostra rapida indagine cercherà di dare risposte a queste ed altre domande, movendo, comunque, dalla convinzione che l’art. 323 non avrebbe dovuto essere abrogato affatto e che l’abolizione dell’abuso di ufficio, associata alla contestuale previsione della inedita fattispecie, crei insanabili disarmonie e lacune nel sistema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P. A.
2. L’abrogazione dell’abuso di ufficio.
Ho già avuto modo di sostenere che non sarebbe stato opportuno abrogare l’art. 323[2] e riassumo qui in modo assai breve gli argomenti che – a mio parere – destituivano di fondamento le ragioni della abrogazione, come indicate nella Relazione del Governo al disegno di legge S 808 presentato al Senato, divenuto poi alla Camera d.d.l. C 1718 e definitivamente approvato il 10 luglio scorso.
Queste le ragioni addotte dai Ministri Nordio e Crosetto, proponenti il disegno di legge:
1. Vi sono pochissime condanne per abuso di ufficio, dopo la riforma dell’art. 323 operata dal d. l. 76 del 2020.
Sed contra: lo scarso numero di condanne, in assoluto, non è mai una ragione sufficiente per cancellare un reato, che può anche essere molto grave (es.: attentato al Presidente della Repubblica, strage).
2. Vi è uno squilibrio fra il numero delle iscrizioni nel registro degli indagati e il numero delle condanne, squilibrio dovuto - si voleva intendere - alla indeterminatezza, alla imprecisione della fattispecie incriminatrice; pertanto, l’applicazione di quella fattispecie di reato avrebbe comportato un inutile sovraccarico per l’apparato giudiziario, insieme a ricadute negative per gli indagati innocenti.
Sed contra: la fattispecie, soprattutto dopo la riforma del 2020, non era affatto imprecisa, essendo capace, con i suoi numerosissimi e (certamente troppo) stringenti requisiti oggettivi e soggettivi, di filtrare, nei vari gradi di giudizio, i fatti meritevoli di sanzione, come dimostra proprio lo scarso numero di condanne definitive. Quello squilibrio, con i conseguenti, innegabili, effetti negativi per il sistema giudiziario e per gli indagati, era piuttosto dovuto ad una inesatta applicazione della norma da parte della magistratura, per rimediare alla quale la riforma Cartabia aveva già adottato opportuni ed importanti accorgimenti, e che avrebbe dovuto trovare soluzioni sul terreno processuale[3]; comunque, non avrebbe mai dovuto risolversi con la cancellazione di una norma incriminatrice necessaria e nient’affatto connotata da indeterminatezza.
3. Il sistema dei delitti contro la P. A. è estremamente articolato. anche tenendo conto dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 9, c. p., (aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio) e, quindi, dall’abrogazione dell’art. 323 non sarebbe derivato alcun vuoto di tutela. E poi, se in futuro fossero pervenute dall’Unione Europea indicazioni volte a prevedere come reato l’abuso di ufficio, si sarebbe sempre potuto sempre ricorrere a interventi additivi.
Sed contra: tanto poco vero è che l’abolizione dell’abuso di ufficio non avrebbe lasciato vuoti di tutela, che lo stesso Ministro Nordio ha ritenuto di dover porre riparo ai vuoti e ai danni che si sarebbero determinati con quella abolizione, affrettandosi - proprio nello stesso giorno in cui la Camera approvava l’art. 1 del disegno di legge C 1718 (che disponeva l’abrogazione dell’art. 323) e sei giorni prima che quest’ultimo divenisse definitivo con l’approvazione dell’intero disegno di legge - ad emanare un decreto legge, con il quale è stato aggiunto al codice penale l’art. 314-bis, che prevede una sbilenca nuova figura di reato, nel solco del peculato per distrazione, ma in realtà a “copertura” del vuoto lasciato dal defunto abuso.
Nell’ambito di queste brevi considerazioni non ritengo necessario soffermarmi più oltre sulla inopportunità dell’abolizione dell’abuso di ufficio e passo a considerare i problemi creati dall’emanazione della nuova fattispecie di cui all’art. 314-bis c.p.
3. Una manovra legislativa in due “tappe” (pressoché) sincroniche: abolizione totale dell’abuso d’ufficio con disegno di legge ed introduzione con decreto legge della nuova fattispecie di “indebita destinazione di denaro o cose mobili”.
Come si è detto, il Ministro Nordio ha voluto introdurre nel codice penale questo “nuovo” reato, ricorrendo al decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, emanato esattamente lo stesso giorno in cui la Camera ha approvato, nella seduta pomeridiana, l’art. 1 del d.d.l. C 1718, quello che dispone l’abrogazione “secca” dell’art. 323 c. p.
Nella premessa al d. l. 92/2024 si legge che è “Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente”. Da tale premessa si può ricavare che: 1) l’emanazione dell’art. 314-bis si è resa necessaria proprio perché l’abrogazione dell’art. 323 comporta il venir meno della punibilità di quelle condotte ancora (cioè, sino all’approvazione definitiva del d.d.l. C 1718) rientranti nell’ambito dell’abuso di ufficio ed ora divenute punibili ai sensi della nuova fattispecie; 2) la punibilità delle condotte di indebita destinazione di beni è oggetto di un obbligo posto dall’UE.
In realtà, non è assolutamente vero quanto assicurato dal Ministro della Giustizia, cioè che l’abolizione dell’abuso non determini un vuoto nella tutela penale della P. A., anche in violazione di obblighi di penalizzazione posti dall’UE. Come è già stato puntualmente ed ampiamente osservato[4], l’art. 4, comma 3, della Direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017 impone agli Stati membri di considerare reato l’intenzionale appropriazione indebita, intendendosi per tale anche l’utilizzazione di tali beni per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell’Unione. E, nel rispetto di tale obbligo, il d. lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, aveva aggiunto all’art. 322-bis c. p., che estende ai funzionari europei la responsabilità per delitti contro la P. A. previsti dal codice penale, proprio l’art. 323; mentre il disegno di legge C 1718, art. 1, ha cancellato da quell’articolo 322-bis il riferimento all’art. 323 ed il d. l. 92/2024 vi ha aggiunto (cioè, sostituito) quello all’art. 314-bis[5]. Se, dunque, non fosse stato emanato il d l. 92/2024, l’Italia avrebbe violato un obbligo eurounitario e sarebbe stata esposta ad una procedura d’infrazione. Non è vero che il sistema dei delitti contro la P. A. non avesse bisogno, come aveva sostenuto il Ministro Nordio, dell’ulteriore tassello costituito dall’abuso d’ufficio. Evitare che si determinasse un vuoto, relativamente ad alcune condotte di distrazione, in conseguenza dell’abolizione dell’abuso di ufficio è, dunque, il vero scopo perseguito con questa manovra, articolata nei due diversi provvedimenti normativi.
Inevitabile chiedersi: perché allora, se l’abrogazione dell’art. 323 crea (relativamente a gravi condotte di distrazione) un vuoto inammissibile – in termini giuridici di fronte all’Europa, in termini politico-criminali di fronte al nostro Paese -, tanto che è necessario colmarlo immediatamente, con straordinaria urgenza, per mezzo di un decreto legge, perché allora non lasciare in vita l’abuso di ufficio, magari con modifiche ulteriori (sarebbe stata la quinta o sesta versione del delitto)? Appare sconcertante l’incoerenza di un governo che nella stessa giornata, mentre la maggioranza approva in Parlamento un disegno di legge che abolisce il delitto di abuso d’ufficio, ne introduce, con decreto legge, un altro, che copre una parte delle condotte costituenti (ancora, sino all’approvazione dell’intero disegno di legge) abuso, dopo aver respinto alla Camera tutti gli emendamenti che miravano a ridimensionare l’ambito della depenalizzazione! Purtroppo non riusciamo a trovare altra spiegazione a questo pasticcio se non quella che il governo non ha voluto recedere da un provvedimento di abrogazione divenuto simbolico – nella sua assolutezza e radicalità - della contrapposizione alla magistratura, pur a scapito della tutela dei beni giuridici del buon andamento e della imparzialità della P. A., della legalità nell’esercizio della funzione giurisdizionale e degli interessi finanziari dell’UE.
4. La nuova fattispecie di “indebita destinazione di denaro o cose mobili”.
Il nuovo art. 314-bis stabilisce “Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Secondo dichiarazioni rese alla stampa dal Ministro Nordio, la nuova fattispecie integrerebbe “un’ipotesi completamente diversa [da quella dell’art. 323 c. p.]. È diverso il bene protetto, qui si parla di distrazione… quindi non ha niente a che vedere con l’abuso di ufficio che prescindeva dalla distrazione”[6]. Tale affermazione non può essere condivisa: la nuova fattispecie è in rapporto di specialità con quella dell’art. 323 c. p.[7]: i soggetti attivi sono gli stessi, la forma del dolo è la stessa (intenzionalmente), l’evento è lo stesso (procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto). Quanto alla condotta (destinare denaro o altra cosa mobile altrui ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità), essa rientra interamente, come species, nel genus di condotta previsto dall’art. 323 (violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità). Ulteriore elemento specializzante del nuovo reato è che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio abbia per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità del denaro o della cosa mobile altrui. Tutte le condotte previste dall’art. 314-bis, senza eccezione, rientrano nell’insieme delle condotte punibili ai sensi dell’art. 323 c. p.
La nuova norma, anzi, è una specie di collage fra l’art. 314 (peculato), di cui condivide il presupposto (possesso o disponibilità di denaro o cosa mobile) e l’art. 323, dal quale mutua la descrizione della condotta, con le limitazioni specializzanti di cui abbiamo appena detto.
La differenza, rispetto al peculato di cui all’art. 314, è che quest’ultimo punisce la appropriazione, mentre l’art. 314-bispunisce la destinazione ad uso diverso. Ora, poiché “rivolgere indebitamente la cosa a un fine diverso da quello cui essa era originariamente destinata”[8] costituisce precisamente la condotta di distrazione, il nuovo delitto configura evidentemente un peculato per distrazione. La condotta tipica di questo reato, espunta dall’art. 314 dalla legge 86 del 1990, era considerata da dottrina e giurisprudenza capace di integrare il diverso delitto di abuso di ufficio, punibile ai sensi dell’art. 323 c. p.[9].
Ora, a mio parere, il collage fra art. 314 e art. 323 ha dato vita in realtà ad un pasticcio, per le ragioni di seguito esposte.
A) Sotto il profilo del nuovo delitto di indebita destinazione (leggi: peculato per distrazione) emergono numerose incoerenze e difetti.
Innanzitutto, non è ragionevole limitare la punibilità della distrazione a quei requisiti che (altrettanto irragionevolmente) erano stati dettati per l’art. 323, cioè che l’uso cui il denaro o la cosa vengono destinati sia diverso da quello “previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità”. Si tratta di un requisito che, per un verso, lascia fuori gravi distorsioni nella destinazione, palesemente dettate da intenti di favoritismo o di profitto, qualora ciò avvenga in casi che sfuggono a specifiche disposizioni, e particolarmente in tutti i casi, assolutamente normali, in cui il p. u. agisce con discrezionalità. Inoltre, pure per questo delitto, come per l’art. 323, il riferimento a specifiche disposizioni crea il rischio che anche irregolarità meramente formali e di poco conto possano essere ritenute tipiche, mentre quelle più gravi restino impunite. Infine, è irragionevole e grave avere escluso i regolamenti dal novero delle disposizioni che regolano la destinazione, posto che molto spesso saranno proprio i regolamenti a indicare dettagliatamente quale dovesse essere la giusta destinazione.
Non condivisibile, poi, è la limitazione di tipicità alle sole condotte che abbiano per oggetto “denaro o altra cosa mobile altrui”: si tratta di una “eredità” del peculato, che rende la nuova disposizione inadatta a regolare fatti certamente meritevoli di pena, in precedenza ricompresi tra gli abusi: quelli su cose immobili[10] o su energie lavorative[11].
Inusuale poi, tecnicamente inadatto, e foriero di possibili incertezze, il ricorso al termine “uso diverso” (invece di “scopodiverso”, previsto dall’art. 4, 3° comma, direttiva UE 2017/1371), che potrebbe creare confusione con la fattispecie di peculato d’uso (art. 314, 2° comma, c. p.) e potrebbe perfino dar luogo a gravi fraintendimenti, nel caso di destinazione d’uso per un significativo lasso di tempo, che non sia però definitivo, come invece avviene quando sia (definitivamente) mutata la destinazione del bene rispetto allo scopo originario.
Ancora si deve notare che dalla mal raffazzonata “derivazione” dell’articolo 314-bis dalla formulazione dell’art. 323 è venuto fuori un inedito “peculato per distrazione con dolo intenzionale di danno”. Ora, che un abuso (art. 323) possa essere compiuto allo scopo di arrecare un danno a taluno, senza mutare destinazione ad alcuna cosa, è un fatto normale. Altrettanto normale è che il mutamento di destinazione di una cosa, effettuato con l’intenzione di avvantaggiare un certo soggetto (art. 314-bis), come conseguenza speculare, non direttamente presa di mira, possa danneggiare qualcuno. Ma poiché, per la pasticciata derivazione del nuovo articolo da quello abrogato, si è copiata anche la parte del “procurare” intenzionalmente un danno, ne emerge la descrizione di un fatto del tutto inusuale, poco plausibile, perché chi agisce mutando la destinazione di una cosa agisce, nella quasi totalità dei casi, per avvantaggiare sé o altri, e non con l’intenzione preminente di recare un danno ad altri. O almeno, nel generale “smantellamento” del presidio penale contro gli abusi dei p. u., quest’ultima ipotesi è così remota da non giustificare la previsione di una apposita condotta penalmente rilevante. Traccia di questa malfatta riunificazione delle formule dei reati è anche l’uso del verbo “procurare”, frettolosamente riferito non al solo vantaggio, ma anche al danno, per il quale, più propriamente, il codice penale ha sempre usato il verbo “arrecare”, che molto meglio si addice ai danni.
Quanto al regime sanzionatorio, non è dato di capire perché questo delitto debba essere punito meno severamente (reclusione da sei mesi a tre anni) dell’abuso d’ufficio (reclusione da uno a quattro anni): dato che la destinazione indebita è un caso speciale di abuso, essa meriterebbe almeno la stessa pena, se non, addirittura, una più severa, considerato che, in particolare, essa comporta sempre anche l’offesa all’interesse della P. A. alla destinazione della cosa, che si aggiunge a quello del buon andamento e della imparzialità della P. A., tipico dell’abuso di ufficio. Altrettanto illogico è che la pena per il nuovo delitto sia uguale a quella prevista per il peculato d’uso (art. 314, 2° comma), che è sicuramente un delitto meno grave, dato che nel caso di quest’ultimo la cosa “dopo l’uso momentaneo” viene immediatamente restituita.
B) Anche sotto il profilo dell’abuso di ufficio, ormai abrogato[12], vi sono gravi o gravissimi difetti.
Il più rilevante, a mio parere, è quello di avere cancellato definitivamente, e di non avere adeguatamente riproposto mediante l’art. 314-bis, la rilevanza di tutte le condotte di abuso in danno, che abbiano recato offesa ai diritti delle vittime di atti arbitrari del p. u. o dell’incaricato di p. s. Come abbiamo detto sopra, che tali abusi “passino” per una condotta di destinazione della cosa intenzionalmente rivolta a danneggiare taluno è molto raro e proprio per questo poco significativo per la politica criminale: l’aggiunta nell’art. 314-bis, così circoscritta, del riferimento al danno non è affatto sufficiente a colmare questa intollerabile lacuna, non degna di uno Stato di diritto.
Gravi e non infrequenti, infatti, sono gli abusi che non comportino una distrazione di cose mobili, come nel caso di una autorità di p. s. che ponga in essere indebitamente una condotta di restrizione della libertà personale o di un responsabile di servizio pubblico (operatore sanitario, sindaco, ecc.) che non consenta l’esercizio di un diritto o non provveda al rilascio, quando dovuto, di un provvedimento di autorizzazione, concessione ecc., o, infine, di un magistrato che dolosamente pronunci ingiusta sentenza di condanna contro un innocente.
Il vero fatto è che la pasticciata riforma, nel destreggiarsi fra la necessità di evitare che dall’abolizione dell’abuso d’ufficio derivasse la violazione di obblighi eurounitari di penalizzazione, da un lato, e la incrollabile volontà di ridimensionare il potere della magistratura, dall’altro, si è preoccupata esclusivamente di evitare che dal controllo giudiziario di legalità potessero derivare accuse ingiustificate nei riguardi di titolari di funzioni pubbliche ed ha gravemente trascurato di tutelare i soggetti, generalmente più deboli, che hanno diritto ad un esercizio non arbitrario delle funzioni e dei servizi pubblici[13].
Impunite resteranno, in ogni caso, tutte le condotte di abuso delle funzioni che abbiano procurato ingiusti vantaggi patrimoniali, quando ciò non comporti un mutamento di destinazione di cose mobili di cui il p. u. abbia il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. Così, favoritismi, a carattere patrimoniale, come l’assegnazione di un posto di lavoro a soggetto non qualificato a seguito di concorso pubblico “truccato” o decisioni giudiziarie che avvantaggino amici e colleghi di partito senza esborso di danaro affidato al giudice; ovvero, il rilascio di autorizzazioni, licenze, ecc. in difetto dei presupposti richiesti dalla legge e dai regolamenti. Non saranno punibili nemmeno i casi di abuso corrispondenti al vecchio interesse privato, realizzati omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi prescritti. Un “libero mercato” delle funzioni e dei servizi pubblici, nel quale parenti, amici e sodali di ogni genere si avvantaggiano e (ammesso che non vi sia corruzione) nessuno è chiamato a risponderne, con buona pace di coloro che non hanno “santi in paradiso”.
5. I rapporti fra le norme interessate dalla riforma: art. 323, art. 314-bis, art. 314.
Per ciò che riguarda il rapporto fra l’art. 323 ed il nuovo art. 314-bis è pacifico che vi sia una continuità normativa, poiché, come si è detto sopra, il nuovo delitto – checché ne dica il Ministro Nordio – è (anche) un’ipotesi speciale di abuso d’ufficio, col passaggio da una norma generale (abuso) ad una speciale (destinazione indebita). Si verifica, dunque, un caso di successione con semplice modificazione del regime penale, regolata dall’art. 2, 4° comma, c. p.; pertanto, relativamente ai fatti commessi prima dell’emanazione del d. l. 92/2024, che abbiano tutti i particolari requisiti previsti dal nuovo delitto di destinazione indebita, e in passato fossero punibili ex art. 323, non potranno essere revocate le sentenze passate in giudicato, mentre, se non vi è ancora una sentenza definitiva, a tali fatti dovrà applicarsi il nuovo art. 314-bis, in quanto norma (posteriore) più favorevole rispetto all’art. 323. Ovviamente, i fatti commessi dopo l’emanazione del d. l. 92/2024 saranno regolati esclusivamente dall’art. 314-bis. Invece, inaccettabilmente, tutti gli altri fatti di distrazione che non corrispondano esattamente ai requisiti dettati dal nuovo art. 314-bis, anche se in precedenza eventualmente rientrassero nella previsione dell’art. 323[14], diventeranno non punibili, per abrogazione della norma incriminatrice (art. 2, 2° comma, c.p.).
Assai interessante, invece, è il rapporto fra il nuovo delitto di destinazione indebita e quello di peculato ex art. 314 c. p. Infatti, l’art. 314-bis esordisce con la clausola “Fuori dei casi previsti dall’art. 314”, che esclude l’applicabilità della prima norma quando il fatto costituisca un peculato per appropriazione.
Al riguardo, nella Relazioni illustrative presentate, con lo stesso testo, alla Camera[15] ed al Senato[16], per la conversione in legge del decreto legge 92/2024, che ha previsto il nuovo art. 314-bis, si chiarisce che in seguito alla riforma attuata con la legge 86/1990 “sono state soppresse dal peculato (art. 314 c. p.) le condotte di ‘distrazione a profitto proprio o di altri’ e, contemporaneamente si è riformato l’abuso d’ufficio. In conseguenza di ciò, la giurisprudenza ha qualificato come abuso d’ufficio le condotte non comportanti appropriazione, consistenti nel mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche [sic![17]] … L’intervento di cui all’articolo in esame [art. 9] risponde allo scopo di chiarire definitivamente i termini di punibilità di tali condotte non appropriative, anche in ragione della necessità di preciso adeguamento alla normativa euro-unitaria”[18].
Il Ministro, però, forse non si è accorto che nella Scheda di lettura per l’art. 9 del Dossier del Servizio studi del Senato, di corredo al d. d. l. di conversione del decreto 92/2024, si è impeccabilmente chiarito, nel paragrafo “La qualificazione penale delle condotte distrattive”, come vadano ricondotte al peculato le condotte di distrazione ad esclusivo profitto privato: viene, infatti citata dal Dossier, tra le altre, anche la recente sentenza Cass. Sez. VI, n. 36496 del 2020, secondo cui: «Costituisce principio di diritto ormai acquisito che, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene. Ciò nondimeno, affinché possa essere ravvisata la condotta distrattiva dante luogo al peculato, è necessario che il pubblico agente abbia impiegato le risorse - di cui aveva la disponibilità per le finalità pubbliche istituzionalmente previste - ai fini del soddisfacimento di finalità private, individuali, traendo cioè un vantaggio personale. Non è difatti configurabile l'appropriazione - necessaria ad integrare il delitto di peculato - nell'ipotesi in cui la disposizione di risorse pubbliche avvenga per finalità diverse da quelle specificamente previste, ma pur sempre nell'ambito delle attribuzioni del ruolo istituzionale svolto dall'agente pubblico in virtù delle norme organizzative dell'ente, perché in questa situazione permane la connessione fra la res ed il dominus e, quindi, la legittimità del possesso. In tale situazione può, se del caso, ravvisarsi la diversa fattispecie dell'abuso d'ufficio». E poco dopo, nel ciato Dossier si legge che “La giurisprudenza di legittimità ha qualificato come fatti di peculato anche le condotte di “distrazione” in cui la diversa destinazione impressa al bene trova fondamento in una causa illecita o illegittima, o, infine, nelle ipotesi in cui si assegni al bene una destinazione non consentita e connotata da alea (in questo senso, Cass, Sez. VI, n. 1247 del 2013). Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati il confine tra peculato e abuso d’ufficio era dunque segnato, con riferimento alle condotte distrattive, dalla natura delle finalità cui è destinato il bene. Se si tratta di finalità non privatistiche, il delitto di peculato non può configurarsi in quanto viene meno l'elemento tipico dell'appropriazione dei beni. La destinazione ad una finalità diversa da quella predeterminata ma pur sempre di interesse pubblico e non connotata da profili di illiceità o di alea restava, invece, riconducibile all’ipotesi di abuso di ufficio.”[19].
Dunque una consolidata giurisprudenza[20] conferma quell’orientamento, già sostenuto in dottrina[21], per cui se vi è commistione fra destinazione ad uno scopo diverso da quello originario, ma pur sempre di carattere pubblicistico, ed interessi privati, il fatto, anche se fossero realizzati tali interessi privati, integra(va) abuso d’ufficio, non essendovi espropriazione della P. A.[22], mentre quando la distrazione consista nel rivolgere la cosa esclusivamente verso una finalità privata, essa realizza una espropriazione della P. A. ed una “impropriazione”[23] (per sé o altri) da parte del privato, che integra una forma di peculato per appropriazione, rilevante ai sensi dell’art. 314 c. p.[24].
Al riguardo, Il Ministro non si è accorto neppure che anche l’Unione europea, nella citata direttiva 2017/1371, art. 4, 3° comma, impone agli Stati membri di considerare reato “l’intenzionale appropriazione indebita, intendendosi per tale anche l’utilizzazione di tali beni per uno scopo in ogni modo diverso da quello per essi previsto, che leda gli interessi finanziari dell’Unione” (corsivo aggiunto).
In conclusione: poiché l’art. 314-bis si applica “fuori dei casi previsti dall’art. 314”, la previsione del nuovo delitto non escluderà, neppure per il futuro, che distrazioni ad esclusivo profitto privato siano riconducibili ancora al peculato ex art. 314 c. p.[25]. Così, l’intenzione di alleggerire le responsabilità penali di sindaci e pubblici amministratori, che si è dichiarato essere il fondamento dell’abolizione dell’abuso di ufficio, non sortirà che mal coordinati e non condivisibili risultati.
Non è, allora, il caso di concludere che a via Arenula è stato combinato un “pasticciaccio brutto”, uscire dal quale è davvero complicato?
Resta da augurarsi che, sulla scorta delle osservazioni che varie voci hanno proposto, le Camere possano addivenire ad una più ponderata e razionale versione della nuova disposizione, in sede di conversione in legge del decreto legge. Ma la cosa non sembra molto probabile, visto l’incaponimento con cui si sta procedendo in tanti altri settori riguardanti la giustizia.
[1] Pubblicato sulla GU n. 155 del 4 luglio 2024, ed entrato in vigore il 5 luglio 2024.
[2] Mi permetto di rinviare, per più ampie considerazioni sul punto, a M. Parodi Giusino, La proposta di abolizione dell’abuso d’ufficio: discutibili ragioni e dannose conseguenze, in Leg. pen. web, 10.5.2024, passim.
[3] Così M. Donini, Abrogare i reati per risolvere i problemi del processo. Dal falso in bilancio all’abuso di ufficio, in SP, 15 luglio 2024. Che la “malattia” non fosse l’abuso, ma l’atteggiamento dei PM, troppo facilmente inclini ad iscrivere i fatti nel registro delle notizie di reato, anche quando ne mancassero gli elementi costitutivi è stato sostenuto già da M. Gambardella, L’abrogazione dell’abuso d’ufficio e la riformulazione del traffico d’influenze nel “disegno di legge Nordio”, in SP, 26 settembre 2023, p. 4.
[4] Per una completa ricostruzione sulla previsione del nuovo reato in relazione alla Direttiva sopra citata v. G. L. Gatta, Morte dell’abuso d’ufficio, recupero in zona Cesarini del ‘peculato per distrazione’ (art. 314-bis c.p) e obblighi (non pienamente soddisfatti) di attuazione della Direttiva UE 2017/1371, in SP, 10 luglio 2024.
[5] Dimenticando, tuttavia, di inserire il riferimento all’art. 314-bis anche nell’art. 323-bis (Circostanze attenuanti) e, secondo l’indicazione G. L. Gatta, Morte dell’abuso d’ufficio, cit., p. 9-10, anche negli artt. 322-ter, 240-bis, 322-quater, 32-quater, 32-quinquies, 165, 4° comma, e 166, 1° comma.
[6] In una intervista pubblicata su Il Fatto Quotidiano del 4 luglio 2024.
[7] In senso contrario, ma soltanto in base alla affermazione che i delitti di cui all’art. 323 e 314-bis sarebbero “strutturalmente eterogenei fra loro”, M. Gambardella, Peculato, abuso d’ufficio e nuovo delitto di “indebita destinazione di denaro o cose mobili” (art. 314-bis c. p.). I riflessi intertemporali del decreto-legge n. 92/2024, in SP 17 luglio 2024.
[8] A. Pagliaro – M. Parodi Giusino, Principi di diritto penale. P. s. I. Delitti contro la pubblica amministrazione10, Milano, 2008, p. 50.
[9] Quando non dovesse addirittura essere ricondotta all’art. 314, come vedremo più avanti.
[10] Come nota G. L. Gatta, Morte dell’abuso d’ufficio, cit. p. 8.
[11] Così M. Gambardella, Peculato, abuso d’ufficio, e nuovo delitto di “indebita destinazione di denaro o cose mobili”, cit.
[12] Al momento in cui scriviamo si aspetta ancora la pubblicazione della legge.
[13] Condivisibile il giudizio espresso in tal senso da M. Donini, Abrogare i reati per risolvere i problemi del processo, cit.
[14] Così, ad es., nel caso che la “violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità” riguardasse non l’uso diverso cui la cosa è destinata, ma altri profili della condotta; ovvero nel caso che la distrazione integrasse abuso d’ufficio perché il p. u. o l’incaricato di p. s. avessero agito “omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi prescritti”.
[15] AC 1947 - Relazione tecnica illustrativa del disegno di legge di conversione del d. l. 92/2024, presentato alla Camera il 4 luglio 2024.
[16] AS 1183 - Relazione tecnica illustrativa del disegno di legge di conversione del d. l. 92/2024, presentato al Senato il 5 luglio 2024.
[17] È noto che nel peculato le cose possono anche non appartenere alla pubblica amministrazione, essendo confluita (legge 86/1990) nell’art. 314 la “Malversazione a danno di privati”, sino ad allora prevista dall’abrogato art. 315 c. p.
[18] AC 1947, cit., p. 9; AS 1183, cit., p. 10.
[19] Dossier AS 1183, p. 35 ss.
[20] La giurisprudenza della Cassazione è costante al riguardo: fra le numerose decisioni v. Cass., Sez. VI, sent. 27910 del 23.9.2020 (dep. 7.10.2020) in Ced Cass. 279677; Cass. Sez. VI, sent. 19484 del 23.1.2018 (dep. 4.5.2018) in CED Cass. 273783.
[21] Già in tal senso A. Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte speciale. Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione5, Milano, 1992, pp. 31-34 e 39-40; M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Art. 314 – 335-bis cod. pen. Commentario sistematico3, Milano, 2013, pp. 35-36; volendo, anche M. Parodi Giusino, Abuso d’ufficio, in Dig. disc. pen., IV ed., vol. VIII, Torino, 1994, p. 597 ss.
[22] Di parere diverso D. Micheletti, La “distrazione” gioca brutti scherzi. Sulle ricadute intertemporali del nuovo art. 314-bis c. p., in disCrimen 8.7.2024, p. 3 e 4-5, secondo il quale la giurisprudenza avrebbe ricondotto al peculato “qualunque forma di condotta distrattiva del denaro o di altri beni pubblici che si traduca nel soddisfacimento di interessi privatistici” e, dunque, la riforma operata dal d. l. 92/2024 avrebbe avuto l’effetto, per le ipotesi di distrazione previste dal nuovo art. 314-bis, di ridurre sensibilmente la pena rispetto a quella prevista dall’art. 314 (reclusione da 4 anni a 10 anni e sei mesi).
[23] L’inusuale termine vuole tradurre il tedesco Aneignung. Secondo C. Pedrazzi, Gli abusi del patrimonio sociale ad opera degli amministratori, in RIDPP, 1953, p. 545, n. 37, sarebbe preferibile, in italiano, la traduzione con appropriazione. Tuttavia, è sembrato preferibile ricorrere al termine di impropriazione (così Cass. Sez. U., 19054 del 20.12. 2012 [dep. 2.5.2013], in Ced. Cass. 255296, p. 20 ss.) per esprimere più chiaramente che in ogni appropriazione vi sono due momenti: uno di estromissione del precedente proprietario (espropriazione) ed un altro di immissione di sé nei diritti spettanti al primo (appunto, impropriazione).
[24] Ancora secondo la stessa Cass., n. 36496 del 2020 “Va invero riaffermato che, nell'attuale assetto normativo quale risultante dalla riforma con la legge n. 86 del 1990, la "distrazione" del denaro o di altra cosa mobile altrui è punibile come peculato solo in quanto l'atto di destinazione sia compiuto per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali, sì da realizzare, nella sostanza, una sottrazione dal patrimonio dell'avente diritto del bene a vantaggio dell'agente che se ne impadronisca, cioè una "appropriazione", unica condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice de qua”.
[25] In tal senso, con argomentazioni pienamente condivisibili, M. Gambardella, Peculato, abuso d’ufficio, e nuovo delitto di “indebita destinazione di denaro o cose mobili”, cit. Contra D. Micheletti, La “distrazione”, cit., p. 5.
Immagine: particolare da Pieter Claesz, Stilleven met kalkoenpastei (Natura morta con pasticcio di tacchino), pittura a olio su legno, 1627, Rijksmuseum, Amsterdam.

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
