
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
LE TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - prima parte -
Il sistema tabellare di Gianfranco Gilardi
Sommario : 1. Il Consiglio superiore della magistratura come vertice dell’organizzazione giudiziaria. - 2. Organizzazione degli uffici giudiziari e funzione delle direttive del Consiglio superiore della magistratura in materia tabellare. – 3. Le prime circolari in materia tabellare e gli sviluppi successivi. - 4. Il sistema tabellare e la riforma dell’ordinamento giudiziario.
1. Il Consiglio superiore della magistratura come vertice dell’organizzazione giudiziaria
Dell’insieme di norme e garanzie che costituiscono l’assetto costituzionale della magistratura assumono specifico rilievo quelle relative al Consiglio superiore della magistratura, concepito dal Costituente quale barriera contro i rischi di condizionamento che, nell'assetto dello Stato pre-repubblicano, derivavano dalla conformazione gerarchico - burocratica della carriere e dalla sua riconduzione alla sfera del controllo politico attraverso il circuito Ministro/Corte di cassazione/capi degli uffici giudiziari[1]. Sono stati così devoluti al Consiglio superiore della magistratura (art. 105 Cost.) i poteri in tema di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati prima spettanti al Ministro, al quale rimangono attribuiti - ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, ed in una logica di leale cooperazione istituzionale più volte sottolineata dalla stessa Corte Costituzionale – l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.).
Il sistema “tabellare”[2] è nato dall’intreccio dei due fattori più sopra indicati, e trova fondamento nel principio secondo cui l’organizzazione del lavoro giudiziario deve ispirarsi all’esigenza - comune a ogni ramo della pubblica amministrazione - di garantire il buon funzionamento e l’imparzialità del servizio e, insieme, a quella di assicurare che lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali avvenga al riparo da ogni condizionamento non solo esterno, ma anche interno alla magistratura. L’intera trama delle norme costituzionali sull’indipendenza dell’ordine giudiziario è posta a presidio di questa finalità ed è diretta ad evitare che la scelta del giudice nella singola controversia possa essere influenzata dagli interessi in gioco o dalla qualità delle parti. Pertanto, come l’assegnazione di ciascun magistrato a questo o a quel posto dell’organico deve avvenire in base a concorsi interni diretti a garantite la trasparenza delle procedure, l’obiettività delle scelte e la funzionalità del servizio, così i singoli affari debbono essere distribuiti in base a criteri oggettivi, predeterminati e insuscettibili di deroghe che non siano a loro volta obiettivamente motivate.
Per assicurare le indicate finalità, che attingono direttamente ai principi costituzionali del giudice naturale (art. 25 della Costituzione) e del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 della Costituzione), il Consiglio Superiore della magistratura emana periodicamente (salvo che non si rendano necessari specifici interventi per far fronte a particolari esigenze) apposite circolari contenenti i criteri cui attenersi nella formazione delle proposte di organizzazione degli uffici giudiziari e, cioè, nella formazione delle c. d. “tabelle”. Come si legge nelle diverse circolari che nel corso del tempo hanno disciplinato la formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, il «sistema tabellare» costituisce il cardine della struttura organizzativa degli uffici, configurandosi come il primo essenziale atto organizzatorio degli uffici giurisdizionali, in quanto le tabelle delineano l'organigramma dell'ufficio, la sua ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse dei singoli magistrati ed i criteri di assegnazione degli affari giudiziari e, quindi, stabiliscono le linee informatrici dell'attività di organizzazione e ne consentono il controllo. Il procedimento di formazione delle tabelle, ed in particolare l'assegnazione degli affari effettuata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale, consente l'effettiva precostituzione del giudice naturale così come stabilito dall'art. 25 Costituzione[3], nonché la tendenziale attuazione dei valori di indipendenza interna (nel senso di assenza di ogni condizionamento proveniente dall'interno della stessa struttura giudiziaria), di inamovibilità ed imparzialità del giudice, nella consapevolezza che ogni assetto organizzativo non soltanto condiziona la funzionalità e l’efficienza del servizio, ma è altresì in grado di influenzare gli indirizzi, i modi di svolgimento e gli esiti stessi della giurisdizione: sicché la fisiologica discrezionalità spettante ai magistrati dirigenti nell’organizzazione degli uffici deve esercitarsi all’interno dei binari posti dalla normativa primaria e secondaria, anche allo scopo di garantire il principi per cui i magistrati non si distinguono tra loro se non per funzioni[4].
2. Organizzazione degli uffici giudiziari e funzione delle direttive del Consiglio superiore della magistratura in materia tabellare
I poteri del Csm in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, discendenti dall’art. 105 della Costituzione e peraltro inseriti in un complesso sistema di garanzie tutte preordinate a tutelare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, hanno natura amministrativa e sono diretti unicamente ad assicurare continuità ed unitarietà di indirizzo organizzativo. Neppure il Consiglio, infatti, potrebbe incidere sui contenuti della giurisdizione interferendo nell’attività interpretativa dei giudici. Si tratta invece di fare in modo che l’esercizio delle funzioni amministrative strumentali all’esercizio della giurisdizione, quali sono appunto le attività inerenti all’organizzazione degli uffici giudiziari, si svolgono in modo coerente e secondo indirizzi unitari, proprio allo scopo di tutelare l’indipendenza c. d. “interna” e la parità di trattamento dei magistrati contro possibili discriminazioni o arbitri nell’assegnazione dei posti o degli affari e, ad un tempo, di assicurare criteri di buona amministrazione nell’uso degli strumenti e delle risorse. Di qui l’esigenza che il Consiglio si ponga come momento di vertice rispetto ai dirigenti degli uffici giudiziari in capo ai quali (nonostante lo smantellamento del sistema gerarchico - burocratico delle carriere) sono rimasti concentrati per lungo tempo amplissimi poteri amministrativi ed organizzativi (dall'assegnazione dei processi alla sostituzione dei giudici, dalla gestione del personale a quella dei mezzi materiali) esercitabili e di fatto esercitati, in modo assolutamente discrezionale ed al riparo da efficaci controlli[5], e che sia ad esso attribuito il potere di impartire direttive vincolanti. Il Csm, beninteso, non può imporre direttamente moduli organizzativi, sostituendosi al potere di proposta spettante ai singoli dirigenti degli uffici, ma deve verificare che le proposte da questi formulate siano rispettose, oltre che delle norme di legge, delle direttive generali e dei principi di razionalità organizzativa. Le proposte tabellari, infatti, debbono costituire un vero e proprio progetto organizzativo funzionale all’esigenza di fornire una risposta tempestiva alla domanda di giustizia presente in ciascuna realtà territoriale, con l’obiettivo di massima efficienza che i dirigenti degli uffici giudiziari hanno il dovere di perseguire nel rispetto dei principi generali, delle norme sull’ordinamento giudiziario e delle direttive del Consiglio, che a partire dalla circolare relativa all’organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2002/2003 ha fatto esplicito richiamo, tra l’altro, al principio della ragionevole durata del processo poi anche formalmente enunciato dall’articolo 111 della Costituzione, e con la circolare relativa al biennio 2006 - 2007 ha introdotto le Commissioni per l’analisi dei flussi e delle pendenze, più comunemente denominate “Commissioni Flussi” che, in posizione strumentale rispetto all’operato del Consiglio giudiziario (ma con possibilità anche per il dirigente dell’ufficio di avvalersi del loro contributo), hanno il compito di valutare la correttezza dell’analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo e l’idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obbiettivi fissati[6].
Con delibera del CSM in data 23 luglio 2008 è stata inoltre istituita la Struttura Tecnica per l’Organizzazione (STO) prevista di cui all’art. 18 del Regolamento interno del Consiglio 2008 [7].
A proposito dei poteri regolamentari del Csm (di cui quelli in materia tabellare costituiscono una delle manifestazioni più significative) si è talvolta parlato di attività “paranormativa”, utilizzando un’espressione in qualche modo ambigua in quanto evocatrice di una sorta di sconfinamento del Consiglio dalle sue competenze istituzionali a quelle proprie del legislatore. In realtà tali poteri costituiscono naturale espressione della specifica collocazione istituzionale dell’organo quale vertice della magistratura dal punto di vista delle funzioni amministrative inerenti all’esercizio della giurisdizione e - risolvendosi nella preventiva determinazione dei criteri che il Consiglio intende applicare nell’esercizio dei propri compiti - si manifestano come momenti di autolimitazione della discrezionalità amministrativa e di certezza del comportamenti futuro cui si atterrà il titolare delle suddette competenze[8].
3. Le prime circolari in materia tabellare e gli sviluppi successivi
L'assetto normativo vigente costituisce il risultato di una evoluzione lunga e complessa che ha portato al formale e definitivo riconoscimento dell'esclusiva appartenenza al Consiglio superiore del potere di formazione delle tabelle degli uffici e della disciplina pressoché integrale del relativo procedimento. Il potere del Csm di emettere direttive per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, oltre che nell’art. 105 della Cost., trova fondamento nelle disposizioni contenute nell'art. 10 bis della legge 195/1958 (introdotto dall’art. 4 d.l. 394/1987 conv., con modificazioni, nella legge 479/1987) e negli artt. 7 bis e ter del r.d. 12/1941, aggiunti dall’art. 3 d.p.r. 449/1988, con le successive modifiche di cui al d. lg. 51/1998, alla legge 63/2001, al d. lg. 106/2006 ed alla legge 111/2007.
L’importanza e la centralità della disciplina tabellare in vista della realizzazione del principio del giudice naturale è stata espressamente affermata dalla Corte costituzionale che nella sentenza 14 gennaio 1986, n. 4 evidenziò il ruolo di “pietra angolare” del Consiglio superiore della magistratura nell’ordinamento giudiziario, posto che, “per espresso dettato della Costituzione (artt. 104 -107) sono riservati al Consiglio superiore tutti i poteri in ordine allo status di tutti i magistrati ordinari, siano giudicanti o requirenti, collegiali o monocratici, professionali od onorari. Ed in coerenza con l'attribuzione della totalità dei poteri sui singoli magistrati si deve riconoscere che spetta ad esso di deliberare anche i provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari oltre che il pubblico ministero”[9].
Le funzioni del Csm in materia tabellare hanno avuto una prima, significativa esplicazione con la circolare n. 81 del 1969. Dopo aver ribadito, alla stregua di un’interpretazione sistematica della normativa vigente, la propria competenza a provvedere sulla composizione di tutti gli uffici giudiziari (e, quindi, anche degli allora esistenti uffici della pretura che si volevano sottratti a tale competenza in base ad una lettura restrittiva dell’art. 63, 1° co. d.p.r. 916/1958), il Consiglio dispose che prima di formulare le proposte di assegnazione dei magistrati, i capi degli uffici dovessero interpellare gli interessati invitandoli ad esprimere eventuali rilievi, osservazioni e richieste, e stabilì che copia delle proposte fosse depositata nelle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle preture divise in sezioni per consentire a tutti i magistrati di inoltrare direttamente al Consiglio le proprie richieste ed osservazioni. Con tale circolare venne tra l’altro prescritto che le assegnazioni tabellari, modificabili in corso d’anno solo previa adeguata motivazione, fossero effettuate unicamente in base ad esigenze di servizio, al fine di evitare ingiustificate trasmigrazioni da una sezione all’altra o, peggio, trasferimenti punitivi dei magistrati dal ramo civile a quello penale” in ragione del merito dei provvedimenti da loro adottati o delle opinioni da loro espresse[10] e furono indicati criteri per la salvaguardia di alcune esigenze fondamentali tra cui, in particolare, quella di ridimensionare le (allora) pletoriche sezioni civili nella prospettiva di rivalutazione della giurisdizione penale; quella di distribuire le eventuali carenze dell’organico proporzionalmente su ciascuna sezione e di operare un certo avvicendamento dei magistrati, al fine di evitare specializzazioni limitate a settori circoscritti; di seguire fra le sezioni civili e penali il criterio di un’equa distribuzione qualitativa; di costituire sezioni promiscue nei tribunale e nella preture divise in sezioni, sulla base tuttavia di una attribuzione rigidamente predeterminata e di una composizione precostituita. Di tale circolare meritano di essere segnalati l’esplicito riconoscimento che l’”attività dell’organo di autogoverno risulterà tanto più efficace nella misura in cui ciascun magistrato potrà responsabilmente contribuire all’elaborazione dei fondamentali indirizzi di gestione dell’apparato giudiziario”, e la sottolineatura della stretta connessione intercorrente tra i provvedimenti di organizzazione e le “fondamentali guarentigie dei giudici”, in particolare la garanzia dell’inamovibilità da intendersi tutelata alla stregua dell’art. 107 Cost. – come già precisato dallo stesso Consiglio nella circolare n. 7640 del 1971 – quale garanzia di stabilità nella carica, nella sede e nelle funzioni”. Tale disciplina non subì modifiche nel corso della 4^ consiliatura (1972-1976), caratterizzata dalla composizione non pluralistica dell’organo e dall’assoluta prevalenza che il sistema elettorale allora vigente riuscì ad assicurare ad un gruppo associativo. Mutata, nella successiva consiliatura (1976-1981) la composizione dei componenti elettivi, l’accresciuta e più incisiva consapevolezza del proprio ruolo da parte del Consiglio, la riconduzione del principio di inamovibilità al più complesso sistema dei valori costituzionali che tutelano l’indipendenza, anche interna, della magistratura[11], la tragica emersione del terrorismo nel Paese furono all’origine delle importanti innovazioni introdotte con la circolare 7 ottobre 1977, n. 5520 e della successiva integrazione del 13 febbraio 1979[12].
L’insieme dei principi organizzativi risultanti dalla circolare n. 5520/1977, e dalla sua integrazione del 1979, fu ulteriormente arricchito nel corso della successiva attività consiliare. I più significativi sviluppi si sono avuti lungo quattro direzioni fondamentali: una più dettagliata disciplina della precostituzione dei collegi; una più specifica e garantistica regolamentazione delle procedure relative ai tramutamenti interni dei magistrati, opportunamente estesa ed adattata anche alle assegnazioni degli uditori (ora, magistrati di prima nomina); un’esplicita attuazione del principio del giudice naturale anche con riferimento ai criteri di distribuzione degli affari; l’estensione delle regole tabellari – con i dovuti adattamenti – alla Corte di cassazione ed agli uffici delle Procure.
Il significato della regola relativa alla precostituzione – che aveva suscitato osservazioni da parte di alcuni presidenti di Corte d’appello – fu illustrato dal Csm già in una delibera del 20 luglio 1978 ove si metteva in luce che la precostituzione dei collegi giudicanti ed i criteri subordinati per un avvicendamento precostituito (o sostituzione) dei relativi componenti, trovavano
La mancanza di regole procedimentali chiare ed esplicite sul delicato punto relativo ai tramutamenti interni dei magistrati, aveva consentito il permanere di larghi spazi di discrezionalità nelle scelte dei dirigenti, scelte che venivano non di rado attuate secondo logiche cooptatorie ed in base a criteri personali che variavano a seconda delle circostanze. A partire dalla circolare n. 8745/1984, fu pertanto stabilito che i dirigenti, prima di formulare le proposte di tramutamento, dovessero dare comunicazione dei posti da coprire a tutti i magistrati dell’ufficio, assegnando loro un congruo termine per proporre domanda. Con la stessa circolare venne inoltre precisato che i dirigenti avrebbero provveduto all’assegnazione degli uditori alle sezioni o ai settori di servizio proponendo, non appena il Csm avesse deliberato sulla destinazione alle sedi, le relative variazioni tabellari destinate ad avere effetto con il conferimento delle funzioni in modo tale da consentire un efficace svolgimento del tirocinio mirato, salva diversa destinazione per comprovate esigenze di servizio. Quanto ai parametri di valutazione ad adottare ai fini delle proposte di tramutamento, i congiunti criteri delle attitudini, dell’anzianità di servizio nell’Ufficio e dell’anzianità nel ruolo, su cui le direttive avevano finito per assestarsi fin dal 1981 (circ. n. 7252/1981), vennero precisati, con la circolare n. 7551/1986, nel senso di dare la prevalenza al criterio dell’anzianità nel ruolo, con la specificazione che ove fosse stato preferito il più anziano nel ruolo nel caso di tramutamento a domanda, ovvero il meno anziano nel caso di tramutamento d’ufficio, avrebbero dovuto essere esplicitamente motivate le ragioni per le quali non si fosse ritenuto prevalente un altro criterio. Pur consapevole della inadeguatezza del criterio dell’anzianità come strumento capace di assicurare in ogni caso la scelta più opportuna sotto il profilo del miglior svolgimento del servizio, a tale precisazione il Consiglio era stato indotto dalla considerazione della non manipolabilità del criterio in esame e, quindi, dalla sua funzione garantistica in un contesto caratterizzato dalla radicale insufficienza degli strumenti di formazione e di rilevazione della professionalità dei magistrati[13]. Di qui l’esigenza di specifica motivazione per le proposte di tramutamento fondate su criteri diversi dall’anzianità nel ruolo, con l’ulteriore prescrizione secondo cui “i criteri orientativi delle proposte dei dirigenti avrebbero dovuto essere essenzialmente coerenti e uniformi, e cioè validi per tutti e non modificati da caso a caso in relazione alle singole proposte di variazione tabellare” (circ. n. 7551/1986; n. 6308/1987).
Ma non meno significativi e rilevanti furono gli sviluppi assunti dalle circolari nell’ulteriore, duplice direzione dianzi segnalata. Al graduale emergere, nel dibattito culturale e dottrinario, dei valori racchiusi nel principio del “giudice naturale”, che da norma preordinata a porre la magistratura al riparo da interferenze di poteri esterni e da principio regolatore di un ordinato sistema di competenze, era stato finalmente recepito nel suo significato di garanzia anche contro possibili deviazioni imputabili alla stessa struttura giudiziaria (come espressiva, cioè, dell’esigenza che nessun giudice sia designato successivamente all’insorgere della regiudicanda) fece riscontro nel Consiglio superiore la circolare n. 8745/1984 nella quale venne per la prima volta precisato che, nell’esercizio delle funzioni di loro competenza in materia di distribuzione degli affari tra le sezioni e di assegnazione di essi ai singoli magistrati, i capi di tutti gli uffici dovessero adottare ed indicare nelle proposte tabellari criteri oggettivi e predeterminati, individuati e formulati in modo tale da consentire la successiva verifica della loro osservanza, così come avrebbero dovuto essere analiticamente specificati i criteri correttivi eventualmente previsti in relazione agli inconvenienti che si presume potessero verificarsi nell’applicazione concreta dei criteri di assegnazione.
Anche tali direttive, costituenti lo sbocco di un’evoluzione nella quale il Csm ha saputo esercitare un ruolo più avanzato rispetto a quello svolto sul punto dalla stessa Corte costituzionale, hanno suscitato vivaci reazioni, rimproverandosi da taluni al Consiglio di avere sconfinato in campi estranei alla propria competenza; ma è bene sottolineare che le circolari del Csm si astengono dal prescrivere i criteri che dovranno essere adottati in concreto all’interno dei singoli uffici giudiziari, e si limitano semplicemente a ribadire l’esigenza che l’assegnazione degli affari avvenga nel rispetto dell’art. 25 della Costituzione, il quale costituisce la fonte diretta e primaria degli obblighi imposti in materia ai dirigenti degli uffici. Conseguentemente, le direttive in esame hanno il solo scopo di controllare e assicurare che l’esercizio delle corrispondenti funzioni da parte dei dirigenti si svolga nel rispetto dei principi costituzionali.
Se nell’ottica dell’art. 25 Cost. è in gioco, in definitiva, “la capacità di uno dei fondamentali poteri dello Stato a venir gestito altrettanto pluralisticamente quanto eterogeneo è il novero delle forze sociali che compongono la collettività"[14], e se ai cittadini non è possibile assicurare la certezza del diritto, ma è doveroso garantire la certezza del giudice, l’anomalia del sistema non poteva non emergere a livello di quegli uffici, come la Corte di cassazione e le Procure, che avevano sempre usufruito di una sorta di extraterritorialità rispetto alle funzioni di governo e di controllo del Csm[15] I trasferimenti di tanti processi (dalle vicende di Piazza Fontana alla P2 ai fondi neri dell’IRI[16]) stavano a dimostrare quale sia il valore garantistico del principio del giudice relativo alla precostituzione del giudice. Ed è perciò che il Csm, con una direttiva di grande rilievo politico-istituzionale che incontrò le resistenze del presidente e del procuratore generale della Cassazione, nella circolare n. 6308/1987 sulle tabelle per il 1988 estese la procedura tabellare anche a quest’ultimo ufficio, sebbene la mancanza – sino all’istituzione del gruppo consultivo e, successivamente, del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione: cfr., infra, par. 7 - di un organo consultivo competente ad esprimere pareri in ordine a quell’ufficio, avesse reso inevitabile demandare la funzione consultiva sulle tabelle allo stesso Presidente della Cassazione e, cioè, allo stesso organo che formula le proposte.
Per gli uffici della Procura, più di ogni altro segnati da una concezione gerarchico - burocratica dell’istituzione e dall’ambigua commistione nel Pubblico Ministero (con riguardo alla legislazione allora vigente) della figura di parte e quella di giudice, la sola estensione ritenuta possibile fu quella risultante dall’art. 8 della circolare che apparve nondimeno, anche sul punto, dirompente e innovativa.
4. Il sistema tabellare e la riforma dell’ordinamento giudiziario
Quelle indicate sono le linee fondamentali lungo le quali si sono andate sviluppando le direttive tabellari del Csm, che l’esperienza concreta del governo autonomo, l’apporto dei consigli giudiziari e le osservazioni dei magistrati, gli incontri di formazione professionale hanno consentito nel corso degli anni di precisare e di rendere sempre più articolate e complesse, anche per la necessità di far fronte ad interventi legislativi che hanno influito in vario modo sull’organizzazione degli uffici.
La riforma dell’ordinamento giudiziario di cui alle leggi n. 150/2005 e successive[17], a parte quanto si dirà infra, al par. 11 per gli Uffici di Procura (che il d. lg. 106/2006 voleva caratterizzare nuovamente con un’impronta in senso fortemente gerarchico, non venuta del tutto meno neppure a seguito della legge 269/2007, limitatasi a cancellare solo gli aspetti più pericolosi figuranti nella legge n. 150), non ha alterato nella sostanza il sistema tabellare così come si era venuto delineando nel corso di un’esperienza ormai pluridecennale[18], pur essendo numerosi gli aspetti della riforma che, direttamente o indirettamente, lo hanno interessato: dalle disposizioni che hanno inciso sugli uffici delle Procure e sulla relativa organizzazione, tra cui in particolare l’abrogazione dell’art. 7 ter, terzo comma ord. giud., alla norma che ha elevato a tre anni la durata delle tabelle[19], con effetti anche su quelle relative al biennio 2007/2008[20], dalle modifiche concernenti gli organi ausiliari preposti al sistema dei controlli tabellari (composizione, durata, sistema elettorale, compiti e funzioni dei consigli giudiziari; istituzione del consiglio direttivo presso la Corte di cassazione), a quelle relative alle incompatibilità nei tramutamenti[21], alla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi[22] ed ai limiti di permanenza massima nelle medesime funzioni o nel medesimo incarico nell’ambito delle stesse funzioni[23], destinate ad avere ripercussioni immediate, già nella fase transitoria, sugli assetti tabellari; dalle previsioni del d. lg. 240/2006 in tema di c.d. “doppia dirigenza”[24] e di “programma delle attività” che il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo dovranno redigere annualmente; a quelle sul divieto per i magistrati ordinari al termine del tirocinio di essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell’udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità (ma vedi, già, da ultimo, le indicazioni contenute nell’art. 35 della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2006/2007), alle norme sulle valutazioni di professionalità e sui tramutamenti, di cui sono evidenti i possibili risvolti anche nella materia tabellare.
[1] Cfr. in generale, anche con riferimento alla situazione della magistratura negli anni cinquanta ed alla storia dell’associazionismo giudiziario, Storia della magistratura italiana, Il Mulino, Bologna, 2012; id., La storia dell’associazionismo giudiziario: alcune notazioni, in Questione Giustizia, n. 4/2015, http://questionegiustizia.it/rivista/2015/4/la-storia-dell-associazionismo-giudiziario_alcune-notazioni_303.php; Scarpari, I magistrati, il fascismo, la guerra, in Questione Giustizia, 2008, 71 ss.; Scarselli, Ordinamento giudiziario e forense, Milano, 48 ss., 75 ss.; Bruti Liberati, La magistratura dall'attuazione della Costituzione agli anni Novanta, in Storia d’Italia Einaudi in 10 cd - rom, nono cd – rom; Palombarini, Giudici a sinistra, Napoli, 2000, 29 ss.; V. Zagrebelsky, La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi, in Legge, Diritto, Giustizia, Einaudi, 1998; Bruti Liberati-Pepino, Autogoverno o controllo della magistratura?Il modello italiano del Consiglio superiore, Milano, 1998, 13 ss.; Onida, La posizione costituzionale del Csm e i rapporti con gli altri poteri, in Magistratura, Csm e principi costituzionali, a cura di B. Carovita, Bari 1994; Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e istituzionale, Torino 1990 (terza ed.); Bonifacio – Giacobbe, Art. 104 – 107, in Commentario della Costituzione, Bologna - Roma 1986; Treves, Giustizia e giudici nella società italiana, Bari1975; Canosa – Federico, La magistratura in Italia dal 1945 ad oggi, Bologna, 1975; Magistrati o funzionari? (a cura di G. Maranini), Milano 1962. Tra i più recenti cfr. Paciotti, Breve storia della magistratura italiana, ad uso di chi non sa o non ricorda, in Questione Giustizia, 7 marzo 2018; Bruti Liberati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Edizioni Laterza, 2018; Scarpari, Giustizia politica e magistratura dalla Grande Guerra al fascismo, Il Mulino, 2019; R. Rordorf, Magistratura Giustizia Società, Cacucci Editore, Bari 2020 nonché - anche per ulteriori riferimenti - il mio La crisi dell’associazionismo giudiziario e la necessità di risalire la china, in Questione Giustizia, 30 ottobre 2020 https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-crisi-dell-associazionismo-giudiziario-e-la-necessita-di-risalire-la-china
[2] Cfr., in generale,Viazzi, Natura, funzione e principali problematiche del sistema tabellare, Relazione alle giornate di studio del Csm su temi interdisciplinari per uditori giudiziari nominati con D.M. 19.10.2004 (I gruppo), Roma, 17 – 19 ottobre 2005; Garzia, Natura, funzioni e principali problematiche del sistema tabellare, Relazione alle giornate di studio del Csm su temi interdisciplinari per uditori giudiziari nominati con D.M. 19.10.2004 (IV gruppo), Roma, 24 – 26 ottobre 2005; Scarselli, cit., 116 ss.; Galoppi, Il sistema tabellare come strumento di garanzia e di efficienza; diritti e doveri nel procedimento tabellare, Relazione alla prima settimana di studio del Csm relativa al tirocinio ordinario in materia ordinamentale riservata agli uditori giudiziari nominati con D.M. 19.11.2002, Roma, 15 – 17 settembre 2003; Genovese, Storia e funzione del diritto tabellare (dalle previsioni ordinamentali del 1865 all’ordinamento Grandi, dalla Costituzione all’attuale disciplina), Relazione alle giornate di studio del Csm su temi interdisciplinari nell'ambito del tirocinio ordinario per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 18.01.2002, Roma, 30 settembre – 3 ottobre 2002; Fantacchiotti, Il sistema tabellare degli uffici giudiziari; il programma Valeria. La mobilità dei giudici: tramutamenti, applicazioni e supplenze, coassegnazione e supplenza infradistrettuale, la pianta organica dei magistrati infradistrettuali, Relazione alle giornate di studio del Csm su temi interdisciplinari per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 18.01.2002, Roma, 8 – 11 luglio 2002; Diotallevi, L’immediata esecutività delle variazioni tabellari tra giudice unico e sezioni stralcio, in Dir. pen. proc., 2000, 636.
[3] Cfr. tra gli altri, anche per un’analisi dello sviluppo dottrinario, legislativo e giurisprudenziale sul principio del giudice naturale, Scarselli, Ordinamento giudiziario e forense, cit., 113 ss.; Viazzi, Ordinamento giudiziario, organizzazione degli uffici, distribuzione degli affari, questioni tabellari, Relazione all’incontro di studio del Csm nell’ambito della formazione decentrata, Palermo 20 dicembre 2003; Conti, Sistema tabellare e precostituzione del giudice: una disciplina solo apparentemente innocua, nota a Cass. 11 giugno 1999, in Dir. pen. proc., 1999, 1286; Salvato, L’organizzazione degli uffici giudiziari: il sistema tabellare, in Cass. pen., 1999, 1045; Salmè, Disciplina tabellare e funzionamento della corte di cassazione, in Gazz. Giur., 1999, fasc. 29, 3; Romboli, Giudice naturale, voce dell’Enc. del diritto, Milano, 1998, II, Agg., 365; Id., Teoria e prassi del principio di precostituzione del giudice, in Il principio di precostituzione del giudice, in Quaderni del Csm, 1995, n. 66; Id., Il giudice naturale, Milano, 1981; Nobili, Commentario della Costituzione a cura si G. Branca, Bologna - Roma, 1981, sub. art. 25, 135 ss.; Mattone, Il giudice naturale, in La professione del giudice, Milano, 1986, 23 ss.
[4] Cfr. Gilardi, La gestione degli uffici giudiziari a Milano, in Questione Giustizia, 1986, 331 ss.
[5] Da tempo la dottrina aveva definito il rapporto tra Consiglio superiore della magistratura e dirigenti degli uffici giudiziari in termini di relazione gerarchica: vedi, già, Pizzorusso, Organi giudiziari, in Enc. del diritto, vol. XXXI, Milano, 1981, 83 ss.; Id., L’organizzazione della giustizia in Italia, Torino, 1985, 85- 86; Viazzi, I consigli giudiziari. Natura, poteri e prospettive, in Quaderni della giustizia, n. 52, 31 ss.
[6] Si tratta di organismi ausiliari dei Consigli giudiziari istituiti presso ogni distretto di corte d’appello. La loro composizione (che prevede anche la presenza di avvocati) varia a seconda delle dimensioni del distretto, ed il relativo funzionamento è disciplinato dalla Circolare sulla formazione delle tabelle e dai regolamenti dei singoli Consigli giudiziari.
[7] Si tratta di un organo consiliare permanente composto da dieci magistrati nominati dal Consiglio, previo interpello, tra coloro che abbiano maturato esperienza in tema di organizzazione e informatizzazione degli uffici, di analisi dei flussi, di carichi di lavoro e di pendenze dei procedimenti e dei processi, con i seguenti compiti:
- acquisire ed analizzare informazioni sui carichi di lavoro, sui flussi e sulle pendenze dei procedimenti e dei processi sia a livello nazionale sia provenienti dalle Commissioni flussi distrettuali, al fine di verificare l’efficienza e l’efficacia dei progetti di organizzazione degli uffici giudiziari e di effettuare adeguate comparazioni tra gli stessi;
- promuovere il confronto e la diffusione delle buone prassi metodologiche e operative anche attraverso la sperimentazione e l’utilizzazione di tecniche innovative;
- favorire omogeneità e qualità delle attività e delle strumentazioni anche informatiche a livello nazionale;
- fornire supporto al Consiglio sia per la verifica dei risultati operativi ottenuti attraverso le attività di indirizzo e di regolamentazione, sia per la definizione periodica del fabbisogno informativo e formativo in questo settore, sia per l’interscambio di dati con il Ministero della Giustizia e le sue articolazioni;
offrire servizi di assistenza a specifiche richieste di intervento locale;
- diffondere gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura a tutti i responsabili di riferimento a livello locale;
- curare i rapporti con il Consiglio direttivo della Corte di cassazione e i Consigli giudiziari e, in particolare, con i rispettivi referenti distrettuali per l'informatica;
- curare, su indicazione della Settima commissione, l'implementazione del portale unico istituzionale con apposite sezioni relative al processo civile telematico, al processo penale telematico e alle buone prassi di organizzazione.
La STO è disciplinata dal Regolamento approvato dal CSM con delibera del 18 luglio 2018, ed divenuta operativa per la prima volta dopo la nomina dei componenti, avvenuta con delibera plenaria del 10 febbraio 2010.
[8] La Commissione Paladin (istituita dall’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga con il compito di indagare, fra l’altro, in ordine al fondamento normativo delle circolari consiliari) e presieduta dal prof. Livio Paladin, nella sua Relazione del 1° gennaio 1991, a proposito delle “circolari indirizzate dal Consiglio…agli altri organi dotati di poteri in tema di amministrazione della giurisdizione” sottolineava la difficoltà di immaginare interventi normativi la cui disciplina fosse “così dettagliata e stringente da annichilire il ruolo che, per una serie di aspetti, compete al Consiglio quale vertice organizzativo della magistratura ordinaria”. Sul testo del messaggio alle Camere del 26 luglio 1990 (pubblicato - insieme al testo del decreto istitutivo della Commissione - in Questione giustizia, 1990, 499 ss.) cfr. Borrè, Csm e presidente. Il messaggio alle camere del 26 luglio 1990, ivi, 548 ss. Amplius, sul potere regolamentare del Csm, Bruti Liberati – Pepino, Autogoverno o controllo della magistratura, cit., 90 ss. ed ivi, ampi richiami di dottrina.
Sul ruolo del CSM quale organo non meramente amministrativo cfr., tra gli altri contributi, quelli richiamati nel mio Magistrati e “carriera”: ritrovare l'orgoglio delle funzioni "ordinarie", in giudicedonna.it, n. 2/2020, nota 16 http://www.giudicedonna.it/ cui adde i pareri del CSM sul disegno di legge AC 2681 richiamati in nota 1 del mio Ancora sulle proposte di riforma dell’ordinamento giudiziario, del funzionamento e della legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura, ivi, n. 1/2021. Vedi altresì, tra i più recenti, Guglielmi, Dalla crisi e dalle cadute nel governo della magistratura all’attacco alla Giurisdizione, in Questione Giustizia, 22 marzo 2021 https://www.questionegiustizia.it/articolo/dalla-crisi-e-dalle-cadute-nel-governo-della-magistratura-all-attacco-alla-giurisdizione
[9] Vedi, altresì, la sentenza 23 dicembre 1998, n. 419 ove è stato sottolineato come l’individuazione dell’organo giudicante debba “rispondere a regole e criteri che escludano la possibilità di arbitrio anche nella specificazione dell’articolazione interna dell’ufficio cui sia rimesso il giudizio”, e la sentenza 17 luglio 1998, n. 272 con la quale la Corte costituzionale ha puntualizzato che proprio il sistema tabellare, la definizione dei criteri organizzativi da parte del Consiglio superiore della magistratura ed il conseguente controllo ad esso riservato in ordine alla correttezza delle loro applicazioni concorrono ad assicurare il rispetto della garanzia costituzionale.
[10] In occasione della formazione annuale delle tabelle degli uffici giudiziari, il presidente della corte d’appello di Milano, ad esempio, aveva proposto la rimozione di tre pretori del lavoro ed il procuratore generale di Firenze aveva chiesto la rimozione di quattro giudici dalle funzioni penali (cfr. Pappalardo, Gli iconoclasti. Magistratura Democratica nel quadro dell’Associazione Nazionale Magistrati, Milano, 1987, 286 - 287). Cfr. altresì – per l’uso della sanzione disciplinare come strumento di repressione delle opinioni espresse dai magistrati - Palombarini, cit., 175 ss.
[11] Cfr. Csm, Relazione al Parlamento del 1976 sullo stato della giustizia., 73 - 74.
[12] Nel par. 1 vennero enunciate direttive per razionalizzare e potenziare il settore penale. In particolare, allo scopo di assicurare la sollecita trattazione dei procedimenti relativi alla criminalità organizzata ed ai reati di maggiore allarme sociale, fu stabilito che i dirigenti dovessero assegnare a tale settore almeno la metà dei magistrati in organico, salva la possibilità di una diversa distribuzione sulla base di reali e motivate esigenze di servizio. Nel par. 2 venne inserito il limite del biennio di permanenza nella precedente sezione o settore di servizio come requisito di legittimazione per i tramutamenti interni dei magistrati e furono indicati i criteri di valutazione da seguire per la copertura dei posti vacanti (maggiore anzianità di servizio ed attitudini nel caso di più aspiranti al tramutamento; minore anzianità nel servizio in caso di mancanza di aspiranti). Nei par. 3 e 4 furono dettati i criteri per l’assegnazione dei presidenti di sezione, per la precostituzione dei collegi e la composizione degli Uffici Istruzione specificandosi, rispetto a questi ultimi, che alle esigenze relative avrebbe dovuto provvedersi con l’assegnazione di magistrati aventi almeno un anno di anzianità nell’esercizio delle funzioni (circolare 13 febbraio 1979). Seguiva, quindi, un paragrafo relativo al deposito delle proposte tabellari, al parere dei Consigli giudiziari, utilizzati per la prima volta dal Csm come organi consultivi nella materia in esame ed alle procedure da adottare per i tramutamenti in corso d’anno. Nel par. 6, infine, veniva precisato come il principio del giudice naturale postulasse, per un verso, che i componenti delle singole unità operative fossero individuati in modo stabile e senza alternative lasciate alla discrezionalità del “caso per caso”; per l’altro verso un sistema di distribuzione degli affari capace di non vanificare il principio della naturalità del giudice, ma di rispettarlo e potenziarlo.
La direttiva con la quale, a cominciare dal 1977 in poi, si era stabilito che al settore penale fosse da assegnare, in linea di principio, la metà dei magistrati in organico, era stata da taluni criticata sotto il profilo che il Consiglio, esorbitando dalla propria competenza, aveva assunto un ruolo d’indirizzo suscettibile di interferire sui concreti contenuti delle attività giurisdizionali. In realtà si trattava di interventi pur sempre relativi all’organizzazione del servizio ed alla individuazione delle priorità nell’impiego delle risorse disponibili, quelle priorità che nel 1969 indussero giustamente a privilegiare l’esigenza di definizione delle controversie di lavoro, ed a partire dalla circolare n. 7582 del 1981 anche la sollecita trattazione dei procedimenti a carico dei detenuti. Piuttosto è da osservare che la scelta del Consiglio è stata certamente influenzata da quel clima dell’”emergenza” che nell’ultimo decennio aveva sbilanciato il sistema della giurisdizione in Italia a tutto danno della giustizia civile. Molto opportunamente, pertanto, il Csm, pur ribadendo come prioritaria l’esigenza di assicurare la sollecita trattazione dei procedimenti penali relativi alla criminalità organizzata, ai reati di maggior allarme e di quelli a carico dei detenuti, a partire dalla circolare n. 6308 del 1987 non ha più confermato la direttiva in questione, scegliendo la strada della ripartizione proporzionata tra il settore penale e quello civile, secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari.
[13] Cfr., successivamente, la nuova disciplina regolamentare di cui alla delibera del 21 novembre 2007, integrativa della circolare n.13000/1999 in tema di conferimento di uffici direttivi, adottata dal Consiglio anche sul rilievo che la riforma dell’ord. giud. e, in particolare, l’art. 12 del d lg. 160/2006, come modificato dalla legge 111/2007, avesse configurato l’anzianità fondamentalmente come requisito di legittimazione, e cioè come presupposto per la partecipazione al concorso, restringendone notevolmente la valenza quale criterio di valutazione, nel senso che il fattore “tempo”, o meglio il fattore “durata”, diviene criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore.
Per gli incarichi semidirettivi cfr. la circolare n. P11036/08 di cui alla delibera del 30 aprile 2008, con la quale venne modificata la circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 e succ. mod. rilevandosi come anche per gli incarichi semidirettivi il valore dell’anzianità quale parametro di valutazione può residuare solo in termini di “indice dell’esperienza professionale acquisita” e che, effettuata la selezione dei candidati in possesso del requisito legittimante costituito dal conseguimento della necessaria valutazione di professionalità, la durata della positiva esperienza professionale potrà rilevare come criterio di validazione dei requisiti delle attitudini e del merito.
Con la Circolare n. P-14858-2015, approvata con deliberazione del 28 luglio 2015 il CSM ha adottato il “Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria” che, sostituendo la previgente circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010, ha messo a punto un articolato sistema di “indicatori generali” (artt. 6-13) e di “indicatori specifici” delle attitudini direttive (artt. 14-23), parametrati ai diversi incarichi oggetto di conferimento. Sul T.U. cfr. Campanelli, Il Nuovo Testo unico sulla Dirigenza giudiziaria: possibili effetti sui limiti del sindacato giurisdizionale, in Questione Giustizia, 9 aprile 2016.
Si rinvia - per le ulteriori modificazioni che si prospettano in materia con il ddl di riforma dell’ord. giud. – infra, al contributo di prossima pubblicazione "Le proposte di riforma dell’ordinamento giudiziario".
[15] L’attuazione del Csm (e quella della stessa Corte costituzionale) non è stata immediata ed ha incontrato resistenze anche all’interno del corpo giudiziario, in particolare da parte della Corte di cassazione che, esercitando un rilevante potere di conformazione attraverso il sistema delle carriere, pur dopo la nascita dei Consiglio vi ebbe per molto tempo un peso dominante, anche per effetto del sistema elettorale allora vigente. Amplius, Pepino - Bruti Liberati, cit., 20 ss., 28 ss
Sul tentativo dell’ex Ministro della giustizia Castelli di ristabilire la Corte di cassazione come vertice anche ordinamentale dell’ordine giudiziario cfr., tra gli altri, AA.VV., in Obiettivo: La corte di cassazione tra istanze di riforma e trasformazione del ruolo, Questione Giustizia, 2005, 949 ss.
[16]Cfr. sul punto, Palombarini, cit., 30-31.
[17] Su riforma vedi, tra gli altri, AA.VV., La “riforma della riforma” dell’ordinamento giudiziario, in Foro it., 2008, V, 87; Pepino, Quale giudice dopo la riforma dell’ordinamento giudiziario? in Questione Giustizia, 2008, 651 ss.; Fazio, La sfida dell’ordinamento giudiziario (Considerazioni realistiche sul “progetto Mastella”), in Questione Giustizia, 2007, 217 ss.; Civinini - Proto Pisani – Salmè - Scarselli, La riforma dell’ordinamento giudiziario tra il ministro Castelli e il ministro Mastella, in Foro it., 2007, 12; Corrado, Le principali novità della legge 111/2007, in Guida al dir., 2007, 33, 115; AA.VV., “Restyling” per la progressione in carriera, in Gli speciali di Guida al diritto, 2007, 34, 14; Patarnello, La dirigenza in magistratura, in Questione giustizia, 2007, 475; Piraccini, La temporaneità delle funzioni e degli incarichi direttivi e semidirettivi, Relazione all’incontro di studio del C.S.M. sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, Roma 8 – 10 ottobre 2007; Castelli (C.), La progressione in carriera, in La controriforma dell’ordinamento giudiziario alla prova dei decreti delegati (una questione ed uno scontro ancora aperti, in Questione Giustizia, 2006, 72 ss.; Erbani, La giustizia disciplinare, ivi, 128 ss.; Giangiacomo, I consigli giudiziari, ivi, 93 ss.; Gilardi, La Corte di cassazione, ivi, 119 ss; Marini, La dirigenza degli uffici giudiziari e il decentramento del Ministero, ivi, 139 ss.; Menditto, L'organizzazione delle Procure nella stagione della controriforma, ivi, 890 ss.; Morosini, La scuola della magistratura, ivi, 85 ss.; Pepino, Introduzione a La controriforma dell'ordinamento giudiziario alla prova dei decreti delegati (una questione e uno scontro ancora aperti), ivi, 53 ss.; Pepino, La buona politica e l'ordinamento giudiziario (editoriale), ivi, V; Santalucia, L'accesso alla magistratura ordinaria, ivi, 57 ss.; Id., Il pubblico ministero, ivi. 103 ss.; Rossi, Il futuro dell'ordinamento giudiziario, ivi, 2006, 219 ss. Cfr., altresì, La giustizia secondo il ministro Castelli, in Questione Giustizia, 2002, Obiettivo, 781 ss. con scritti di Erbani, Pizzorusso, Rossi, Salmè, Civinini, Proto Pisani.
Sull’ordinamento giudiziario, più in generale, cfr. tra gli altri S. Petralia, Compendio di ordinamento giudiziario, Neldiritto Editore, 2021; Dal Canto, Lezioni di ordinamento giudiziario, Giappichelli, 2020; Pizzorusso, L'ordinamento giudiziario, Vol. 1, Editoriale Scientifica, 2019; Guarnieri-Insolera-Zilletti, Anatomia del potere giudiziario. Nuove concezioni, nuove sfide, Carocci, 2016; Pomodoro – Pretti, Manuale di ordinamento giudiziario, Giappichelli, 2015; Vietti, Codice dell'ordinamento giudiziario, EGEA. 2013; Scarselli, Ordinamento giudiziario e forense, Giuffrè, IV edizione, 2013; M. Cassano, Ordinamento giudiziario: organizzazione e profili processuali, a cura di D. Carcano, Giuffrè, 2009.
[18] Anche in questi giorni, tuttavia, tornano ad agitarsi altri e gravi venti di modifica che vanno dalla separazione delle carriere, di cui costituisce un aspetto specifico la proposta di istituire Consigli superiori distinti per i magistrati giudicanti e per quelli delle procure, ad una Sezione disciplinare collocata al di fuori del Csm, alla discrezionalità dell’azione penale, ed altro ancora. Sula recentissima iniziativa referendaria in tema di giustizia, cfr. Rossi, Referendum sulla giustizia. E’ possibile parlarne nel “merito”? in Questione Giustizia, 9 giugno2021 https://www.questionegiustizia.it/articolo/referendum-sulla-giustizia-e-possibile-parlarne-nel-mer
[19] Richiamato art. 4, 19° co. della legge 111/2007, che ha modificato l’art. 7 bis dell’ordinamento giudiziario di cui al r.d. 12/1941. Con le proposte di riforma dell’ordinamento giudiziario menzionate infra, al par. 13, si intende elevare la durata delle tabelle a quattro anni.
[20] Risoluzione 10 ottobre 2007 del Csm in materia di durata delle tabelle degli uffici giudicanti e dei criteri di organizzazione degli uffici requirenti, ove si precisò che in conseguenza delle nuove disposizioni fosse da considerare prorogata di diritto fino al 31 dicembre 2008 l’efficacia di tutte le tabelle relative al biennio 2006/2007, sia di quelle già approvate dal Consiglio, sia di quelle in corso di approvazione, ferma per i dirigenti degli uffici la possibilità di proporre per le tabelle in vigore (seguendo l’ordinaria procedura prevista dalla vigente circolare in materia) modifiche ed integrazioni rese necessarie o dimostratesi comunque opportune per adeguare le scelte organizzative alla più lunga durata di cui all’art. 4 della legge 111/2007.
[21] Art. 13, 4° co. d.l. 106/2006, come modificato dalla legge 111/ 2007, che ha disciplinato il passaggio di funzioni da requirenti a giudicanti e viceversa. Con delibera del 4 ottobre 2007 (“Direttive generali in relazione all'applicazione dell'art. 13 del D. Lgs. 160/06 come modificato dalla Legge 111 del 30 luglio 2007 ai procedimenti di nomina per uffici direttivi e semidirettivi in corso alla data del 31 luglio 2007”) il Csm, occupandosi del problema dell’applicabilità della nuova normativa ai procedimenti in corso di trattazione per posti direttivi e semidirettivi già banditi prima dell’entrata in vigore della legge, chiarì che - in assenza di una normativa transitoria - l’applicabilità dello ius superveniens nell’ambito delle procedure concorsuali in itinere trovasse il solo limite dell’intangibilità delle situazioni giuridiche definite. Ove, pertanto, la procedura di concorso si fosse divisa in varie fasi coordinate, la nuova norma avrebbe potuto trovare applicazione per le fasi che all’atto della sua entrata in vigore non si fossero ancora realizzate, tenendo presente comunque che la nuova legge avrebbe dovuto trovare applicazione immediata in tutte le ipotesi in cui non si fosse esaurita la fase dispositiva, e restando esclusa la possibilità di emettere un provvedimento finale in contrasto con le disposizioni di legge immediatamente ed autonomamente applicabili. Da tale premessa il Consiglio trasse il corollario che in base all’art. 13, 4° co. d. lg. 160/2006 vi è un divieto assoluto per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa, all’interno del medesimo circondario e della stessa provincia (nonché per i trasferimenti in secondo grado all’interno del distretto), e che la disposizione integra una norma interdittiva autonomamente ed immediatamente applicabile.
[22] Gli artt. 45 e 46 d. lg. 160/2006, nell’introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che esse siano conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un’ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Csm - dell’attività svolta. In caso di valutazione negativa, nei successivi cinque anni, il dirigente non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi. Analoga previsione è contenuta nell’ art. 46, che ha esteso la preclusione ai concorsi per il conferimento di funzioni semidirettive. Sulla materia il Csm, all’indomani della riforma, è intervenuto con la ricordata delibera del 21 novembre 2007 di integrazione e modifica della circolare n. 13000/1999 in tema di conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, al fine di adeguarla alla nuova normativa in ciò che concerne, in particolare, i requisiti per la nomina; con la risoluzione del 10 aprile 2008, mediante la quale sono stati fissati, d’intesa con il Ministero della giustizia, gli indicatori da cui desumere l’attitudine direttiva; con la ricordata delibera del 30 aprile 2008, mediante la quale è stata modificata la normativa secondaria relativa al conferimento degli incarichi semidirettivi, rimodulando in particolare i criteri di selezione, ridimensionando il peso specifico da attribuire al parametro dell’anzianità e valorizzando maggiormente l’esperienza organizzativa; con la delibera del 24 luglio 2008, specificamente relativa alla procedura di conferma nell’incarico direttivo o semidirettivo.
Sul tema della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi il CSM è poi intervenuto con varie delibere di risposte a quesiti, e con delibera del 28 luglio 2015 è stato approvato il T.U. sulla dirigenza giudiziaria (cfr. circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 e succ. mod.), al quale con la recentissima delibera del 16 giugno 2021 sono state apportate ulteriori modificazioni nella parte relativa al procedimento di conferma di direttivi e semidirettivi; e ciò allo scopo di dare affidabilità e concretezza alla valutazione delle attitudini direttive dimostrate all’esito del primo quadriennio di esercizio delle relative funzioni. In particolare la riforma prevede una approfondita istruttoria del Consiglio - anche mediante il coinvolgimento dei magistrati dell’ufficio - in ordine all’attività svolta dal dirigente in conferma, istruttoria favorita da Format (specifici con riguardo ad ogni tipologia di ufficio) per la redazione dell’autorelazione, del rapporto informativo e del parere del Consiglio Giudiziario. Ciò consentirà, in modo omogeneo e semplificato, uno scrutinio dell’attività svolta dai direttivi e semidirettivi basato su elementi obiettivi e non su valutazioni ed aggettivi, spesso altisonanti, ma disancorati dai risultati dell’attività organizzativa.
Per le valutazioni relative al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi cfr., tra i contributi di poco successivi alla riforma, Maccora, La selezione dei dirigenti degli uffici giudiziari, in Questione Giustizia, 2008, 25 ss. e, più recentemente, Patarnello - Maccora, La dirigenza descritta dalla proposta di Riforma del Ministro Bonafede, in Questione Giustizia, 15 luglio 2019; Castelli, La nomina dei dirigenti: problema dei magistrati o del servizio? in Questione Giustizia, 9 giugno 2020 http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-nomina-dei-dirigenti-problema-dei-magistrati-o-del-servizio_09-06-2020.php
Sulle proposte di riforma in tema di incarichi direttivi e semidirettivi contenute nel ddl AC 2681 (ddl “Bonafede”) approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto 2020 e recante “Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”, cfr. il mio Ancora sulle proposte di riforma dell’ordinamento giudiziario, del funzionamento e della legge elettorale del Consiglio superiore della magistratura, in giudicedonna.it, n. 1/2021 www.giudicedonna.it proposte che hanno costituito oggetto di modifica da parte della Commissione ”Luciani” richiamata infra, nel par. 13 del testo.
[23] In base all’art. 19 d.lg. 160/2006, come modificato dalla legge 111/ 2007, i magistrati che esercitavano funzioni di primo e secondo grado avrebbero potuto rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, avrebbero potuto restare nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore con proprio regolamento tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci anni a seconda delle diverse funzioni. Il magistrato che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non avesse presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all’interno dell’ufficio o ad altro ufficio, sarebbe stato assegnato ad altra posizione tabellare o altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell’ufficio immediatamente esecutivo. Il regolamento in questione è stato approvato dal Csm in data 13 marzo 2008. Lo stesso Consiglio, con risoluzione del 15 novembre 2007, aveva chiarito che, nel frattempo, la nuova disciplina non fosse applicabile in alcuna sua parte e che i tempi massimi di permanenza nei posti “tabellari” coincidessero con quelli decennali di cui al par. 46 della circolare sulle tabelle per il biennio 2006/2007, da intendersi “prorogate” sino al 2008.
[24] Sulla c.d. “doppia dirigenza” e, più in generale, sui rapporti tra magistrato dirigente e dirigente amministrativo cfr., tra gli altri, Aprile, La gestione delle risorse esistenti: i modelli organizzativi proponibili. Il rapporto tra produttività, organizzazione del lavoro e gestione del personale amministrativo. Gestione delle risorse umane e gestione delle risorse finanziarie e strumentali, Relazione all’incontro di studio del Csm sul tema La riconversione da magistrati giudicanti a direttivi requirenti, Roma 17 – 18 marzo 2008; Castelli (C.), La gestione delle risorse esistenti: i modelli proponibili. Il rapporto tra produttività, organizzazione del lavoro e gestione personale amministrativo. Gestione delle risorse umane e gestione delle risorse finanziarie e strumentali, Relazione all’incontro di studio del Csm sul tema La riconversione dei direttivi da magistrati giudicanti a requirenti, Roma 28 – 29 gennaio 2008; Id., La direzione degli uffici giudiziari: dirigenza unica, doppia dirigenza, Relazione all’incontro di studio del Csm sul tema La dirigenza degli uffici giudiziari, Roma, 16 – 17 aprile 2007; Barbuto, Programmazione delle attività annuali e patologie nella programmazione, Relazione all’incontro di studio del Csm sul tema La dirigenza degli uffici giudiziari, Roma, 16 – 17 aprile 2007; Guarda, La dirigenza degli uffici giudiziari, Relazione all’incontro di studio del Csm sul tema La dirigenza degli uffici giudiziari, Roma, 16 – 17 aprile 2007; Romano, La gestione delle risorse umane, Relazione all’incontro di studio del Csm sul tema La dirigenza degli uffici giudiziari, Roma, 16 – 17 aprile 2007; Sciascia, Gestione delle risorse umane, Relazione all’incontro di studio del Csm sul tema La dirigenza degli uffici giudiziari, Roma, 16 – 17 aprile 2007; AA.VV., Le competenze dei dirigenti amministrativi negli uffici giudiziari, in Rivista delle cancellerie, 2006, 647; Sarao, Dirigenza degli uffici giudiziari – Ancora luci ed ombre, in Rivista delle cancellerie, 2006, 648; Abate, I rapporti con la dirigenza amministrativa. La prospettiva del magistrato: i poteri di direzione e di intervento del magistrato dirigente, Relazione all’incontro formativo del Csm dedicato ai magistrati con funzioni direttive e semidirettive di nuova nomina, Roma, 24 – 26 novembre 2003; Ippolito, In favore della dirigenza amministrativa negli uffici giudiziari, in Rivista delle cancellerie, 2001, 30; Marinelli - Olivieri, Problemi interpretativi ed attuativi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in Documenti e giustizia, 1993, 809.
La rivoluzione “clandestina” dopo il caso Dj Fabo: commento alla sentenza del Tribunale di Ancona del 9 giugno 2021
di Daria Passaro
Sommario: 1. Il rumore di fondo del fine vita. Nelle mani di un Parlamento sordo - 2. Commento all’ordinanza del Tribunale di Ancora del 9 giugno 2021: il riconoscimento del “diritto all’accertamento” - 3. Verso il referendum sull’eutanasia legale, considerazioni e prospettive a breve termine.
1. Il rumore di fondo del fine vita. Nelle mani di un Parlamento sordo
Sono trascorsi due anni da quando il Parlamento fece scadere il tempo concesso dalla Corte costituzionale per riempire il profondo vuoto normativo intorno al suicidio assistito, prima di pronunciarsi sul noto caso di Dj Fabo e di Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, finito a processo per aver aiutato a morire l’ex dj in una clinica in Svizzera.
L’ultimo tassello sul tema dell’aiuto al suicidio era stato apposto dalla scriminante ad hoc introdotta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 242/2019, un unicum nel panorama delle cause di non punibilità, coerentemente con le fattezze del tema del fine vita, un universo dai confini tutt’altro che agevolmente individuabili, al limite tra etica e biodiritto.
Nell’ormai celebre caso Cappato, i giudici costituzionali, con la sopra menzionata pronuncia avevano dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi ha agevolato l’esecuzione del proposito suicida di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili.
Tale incostituzionalità trova supporto, a sua volta, nella ratio della Legge sul testamento biologico, l. 22 dicembre 2017, n. 219, imperniata sull’inviolabile diritto all’autodeterminazione del paziente e sull’altrettanto irrinunciabile diritto a rifiutare trattamenti sanitari indesiderati, quand’anche necessari alla sopravvivenza.
Nondimeno, la configurabilità della scriminante novella introdotta dai giudici della Consulta, esige la presenza di requisiti precisi e indispensabili.
La persona interessata, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, deve essere tenuta in vita da un trattamento di sostegno vitale ed essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili. Nella medesima direzione, è presupposto imprescindibile che le precedenti condizioni e le modalità di esecuzione siano verificate da una struttura sanitaria nazionale pubblica, previo parere del comitato etico territorialmente competente.
Dinanzi alle rigorose coordinate disposte dalla Corte Costituzionale, la giurisprudenza di merito non è rimasta silente, di recente compiendo un ulteriore passo in avanti verso il diritto al suicidio assistito. Invero, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Massa intervenuta il 27 luglio 2020 nel caso “Trentini”- dall’esito assolutorio per Mina Welby e Marco Cappato- partendo dai principi formulati nella sentenza della Consulta, aveva fornito un’ interpretazione estensiva della nozione di “trattamento di sostegno vitale”, riconoscendone la pacifica sussistenza in Davide Trentini. La portata estensiva e innovativa è ravvisabile nella circostanza in ordine alla quale, mentre nel caso esaminato dalla Consulta Fabiano Antoniani era tenuto in vita da una macchina, il paziente Trentini risultava affetto da sclerosi multipla.
La dipendenza da “trattamenti di sostegno vitale” non significa necessariamente ed esclusivamente “dipendenza da una macchina”, ben potendo venire in rilievo in tutti i trattamenti sanitari all’interruzione dei quali si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida.
Pertanto, in ottica volutamente ampliativa, la Corte di Assise di Massa, estendendo le maglie della nozione di “sostegno vitale” aveva lucidamente consentito l’applicazione della scriminante- per chi prestasse ausilio nell’esecuzione di un proposito suicidiario autonomamente cristallizzatosi- altresì nell’ipotesi di aiuto al suicidio di un paziente sottoposto a un trattamento farmacologico indispensabile, senza il quale seguirebbe certamente la morte.
Ad oggi, deve sottolinearsi che, sebbene la Corte Costituzionale del 2019 abbia in più battute ribadito la necessità di un chiaro intervento normativo sul tema del fine vita, ad apparire sordo alle esigenze di definizione legislativa è proprio il Parlamento, in seno al quale i numerosi disegni di legge presentati negli anni alle Camere sembrano dissolversi come polvere e giammai avanzare ad uno stadio maturo di regolamentazione.
Le esigenze di disegnare un limpido dato normativo si scontrano, fatalmente, con l’intuibile difficoltà di maneggiare un argomento sì delicato e complesso, dai risvolti tanto giuridici quanto etici, morali, religiosi, nonché con le ideologie di diffidenza, più o meno palesata, al cospetto del più ampio tema della Dolce Morte; così come si traduce dal greco la parola Eutanasia.
Nell’ordinamento italiano, tutto quello che promana dal Parlamento circa il fine vita è attualmente regolato dalla legge n. 219 del 2017, permettendo ad ogni persona capace di agire di esercitare il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario, ivi compresi l’idratazione, la nutrizione e la ventilazione. Ne deriva il dovere del medico di rispettare la volontà espressa dal paziente nel rifiutare il trattamento sanitario o rinunciare al medesimo. Con la sentenza 242 del 2019 la Corte Costituzionale, si ribadisce, ha voluto fare un passo in più, sancendo in parte l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del codice penale sì da escludere la punibilità per chi agevoli il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi nelle situazioni sopra descritte.
Da tale avanzamento rivoluzionario prendeva forma la netta sensazione di un prossimo dibattito parlamentare a cui dare deciso compimento. Per contro, oggi questo auspicio smentito dalla realtà assume i connotati di un’ottimistica illusione, difficilmente realizzabile in assenza delle solide fondamenta di un servizio sanitario ineccepibile e efficiente, atto a individuare con chiarezza i “casi eccezionali e ben determinati” in cui è consentito scriminare l’ausilio fornito nell’abbreviare la vita. In disparate occasioni, i fautori dell’orientamento “diffidente” hanno evidenziato i rischi che comporterebbe una scelta da parte del legislatore di depenalizzazione o di legalizzazione del suicidio medicalmente assistito modellato sulla falsa riga di quello effettuato da alcuni paesi europei, pena il vulnus irrimediabile al principio secondo il quale compito primario e inderogabile del medico deve rimanere l’assoluto rispetto della vita dei pazienti.
Sullo sfondo, un ruolo di non poco conto è rivestito dal sistema delle cure palliative, a voler sottolineare come prima di offrire a un malato la possibilità di scegliere la morte come opzione vi sia ancora molto di cui discutere, moltissimo da attuare. Quel che è certo è che le pressanti esigenze di chiarezza e regolamentazione normativa mediante una legge sul fine vita non rappresentano il grido di una minoranza ideologicamente rumorosa, bensì una questione tutt’altro che meramente giuridica, appartenente davvero a tutti. Figurarsi al Parlamento, che proprio di tutti è la rappresentanza. Un tema, evidentemente, rispetto al quale il legislatore, lungi dal perseverare in una sorda inerzia, è tenuto ad imboccare, prima o poi, una direzione.
2. Commento all’ordinanza del Tribunale di Ancora del 9 giugno 2021: il riconoscimento del “diritto all’accertamento”
Come di sovente accade nell’evoluzione giuridica, in mancanza di un intervento legislativo chiarificatore da parte del Parlamento, la giurisprudenza di merito non rinuncia a colmare le lacune attraverso interpretazioni più o meno estensive ed esplicative del diritto positivo nonché degli orientamenti pretori precedentemente intervenuti. È quanto si è verificato in seno al Tribunale Ordinario di Ancona lo scorso 9 giugno, data in cui per la prima volta in Italia un giudice ordinario, con ordinanza, ha applicato i principi costituzionalmente orientati della sentenza Cappato al caso di un uomo tetraplegico di 43 anni.
Ancora una volta i giudici, che come disposto della Costituzione sono soggetti solo alla legge e alla medesima sono tenuti ad attenersi nell’applicazione del diritto cui sono chiamati, contribuiscono fattivamente ad attuare una rivoluzione quasi “dal basso”. Se un passo deciso verso la regolazione dei casi di suicidio assistito è stato compiuto dall’alto della sentenza della Corte Costituzionale del 2019 in relazione al caso Dj Fabo, accade nuovamente oggi- cosa che ancor più rileva- in sede di ordinario giudice di merito con atto di ordinanza.
Invero, il Tribunale di Ancona, applicando i principi della Sentenza Cappato della Consulta, riconosce espressamente il diritto all’accertamento delle condizioni utili a scriminare l’aiuto al suicidio di un giovane uomo tetraplegico. La svolta è di non poco momento, per la prima volta un Tribunale impone alla ASL di verificare i presupposti stabiliti dai giudici costituzionali e, in caso positivo, ammettere il paziente alla somministrazione del farmaco letale, senza risvolti penalmente rilevanti per chi presti l’aiuto al suicidio di cui all’art. 580 c.p.
La pronuncia in esame racconta l’intenzione di proseguire il cammino intrapreso dai giudici per introdurre il diritto al suicidio assistito, supplendo alla mancanza di una legge del Parlamento. Il giurista tedesco Bernd Rüthers, in tempi non sospetti (1968) parlava di rivoluzione “clandestina”, come tendenza all’ormai irrefrenabile passaggio dallo Stato di Diritto allo Stato dei Giudici.
Ma dietro ogni svolta giurisprudenziale, deve ricordarsi, posano le vite degli individui e le occasioni poste dalla vita reale per interrogarsi sull’attualità del diritto nel dare risposte ai consociati. Per quanto attiene all’ordinanza anconetana, l’evoluzione trae origine dalla storia di un paziente di nome Mario, di anni 43, una storia come se ne sentono tante, fatta di dolore e di un presumibile epilogo infausto, che di “dolce morte” ha davvero poco. Ma di dignità ne ha tanta, di pretesa di rispettare la persona nella sua proiezione più grande, di lucido coraggio nel fronteggiare il dolore e la malattia, prendendo atto che altresì per chi vive in tali condizioni la vita degna di essere vissuta forse è altro e dovrebbe poter essere altro.
Mario, originario delle Marche, a causa di un grave incidente stradale che gli ha provocato la frattura della colonna vertebrale con la conseguente lesione del midollo spinale, ad oggi versa in condizioni irreversibili, essendo tetraplegico con altre gravi patologie da circa dieci anni.
Nell’ottica di accedere al suicidio assistito, nel mese di ottobre 2020 gli veniva comunicato un diniego da parte dell’ASL senza che venissero attivate le procedure indicate dalla sentenza della Corte costituzionale. Precisamente, davanti alla domanda di “accedere con urgenza a farmaco letale per procedere con suicidio assistito”, la ASL aveva motivato il proprio diniego partendo dalla vigente normativa sul consenso informato e sul rapporto medico-paziente (L. 219/2017) che né all’art. 1 in tema di consenso né all’art. 2 sulle cure palliative per il dolore consentirebbe al medico di somministrare farmaci letali.
Secondo la ASL, in mancanza di una legge in materia di suicidio assistito, non potrebbe ammettersi l'eutanasia ricorrendo ai principi formulati nella sentenza della Corte Costituzionale, che rispondeva al diverso problema di individuare una scriminante ad hoc nella punibilità del reato di aiuto al suicidio.
A ben vedere, a tale assunto non può prestarsi obiezione, la sentenza Cappato-Dj Fabo limitandosi a stabilire che per ottemperare alla richiesta della persona interessata occorre verificare da parte di una struttura pubblica del Ssn, previo parere del comitato etico territorialmente competente, il sussistere di almeno quattro condizioni: che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; che sia affetta da una patologia irreversibile; che detta patologia determini intollerabili sofferenze psicofisiche; che il paziente sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Nondimeno, quel che sorprende è che la Asl abbia altresì negato l'attivazione delle procedure di verifica imposte dalla Consulta, finendo col negare qualsivoglia rilievo ad una pronuncia sì innovativa. Pertanto, con l’assistenza dei legali dell'Associazione Coscioni, da lungo tempo in primo piano sul tema, il paziente ha presentato ricorso di urgenza al Tribunale di Ancona, affinché venisse ordinato all'Asl la verifica delle sue condizioni.
In prima battuta, in data 26 marzo, il giudice del Tribunale ha confermato il diniego motivando che, pur riconoscendo nel paziente i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 242/19 sul caso Cappato-Dj Fabo, non sussisterebbero motivi per ritenere che la Corte abbia fondato un diritto del paziente, ove ricorrano tali ipotesi, ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell'attuare la sua decisione di porre fine alla propria esistenza; né può ritenersi che il riconoscimento dell'invocato diritto sia diretta conseguenza dell'individuazione della neo-introdotta scriminante.
Tanto deciso, la “rivoluzione clandestina” giunge a seguito del reclamo presentato dai legali di Mario all'ordinanza di diniego, i magistrati del Collegio del Tribunale di Ancona, dopo la discussione dell'udienza del 28 maggio in Camera di Consiglio, depositandone una nuova in cui si ordina all'Azienda sanitaria unica regionale delle Marche, previa acquisizione del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, di provvedere ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dalla Consulta.
I giudici affermano con convinzione che l’istante ha il diritto di pretendere che si effettuino gli accertamenti disposti dalla Consulta con sentenza 242/19, affinché l'aiuto fornito non costituisca reato ai sensi dell'articolo 580 del codice penale.
L’ordinanza del 9 giugno ha precisato che l’istante, per vero, ha invocato non già un diritto al suicidio bensì il diritto ad ottenere dalla struttura sanitaria pubblica competente l’accertamento dei presupposti illustrati dalla Consulta, il cui esito è pregiudiziale alla non punibilità dell’aiuto.
In base al quanto ritenuto, Mario avrà il diritto di pretendere dall’Asur Marche l’accertamento della sussistenza dei presupposti richiamati nella sentenza della Corte Costituzionale, in vista della non punibilità di un aiuto al suicidio praticato in suo favore da un soggetto terzo; la verifica sull’effettiva idoneità ed efficacia delle modalità, della metodica e del farmaco (Tiopentone sodico nella quantità di 20 grammi) prescelti dall’istante per assicurarsi la morte più rapida, indolore e dignitosa possibili, rispetto all’alternativa del rifiuto delle cure o della sedazione profonda ovvero di qualsivoglia soluzione praticabile, ivi compresa la somministrazione di un farmaco diverso.
Nel disporre ciò, il giudice delle Marche ha espressamente richiamato quanto ritenuto altresì dalla Consulta nel 2019, secondo cui il potere di rifiuto delle cure con contestuale sedazione profonda- pacificamente previsto dalla legge n. 219/2017 agli artt. 1 e 2- potrebbe non essere ritenuto sufficiente dal paziente in questione, comportando un processo più lento per congedarsi dalla vita nonché più carico di sofferenze per sé e per i cari, per un tempo non determinabile. In effetti, il paziente de quo, ribadisce il Tribunale, versa in gravi e irreversibili condizioni patologiche, connotate dalla dipendenza continuativa da macchinari elettromedicali salvavita (pacemaker), da presidi medicali persistenti (catetere urinario) nonché da compromissione pressoché assoluta delle funzioni corporali.
Vieppiù che, come il giudice di Ancona tiene a evidenziare, si impone alla struttura ospedaliera di provvedere all’accertamento richiesto previa acquisizione del relativo parere del comitato etico territoriale.
La pronuncia di Ancona, dunque, compie ancora un passo in avanti, passando dalla non punibilità del reato per chi aiuta il malato a morire al riconoscimento di un vero e proprio diritto di questi a chiedere la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dell’esimente delineata dalla Consulta in occasione del caso Fabo.
Ciò che il giudice marchigiano ha sottolineato con forza è la circostanza per cui dalle statuizioni del 2019 giammai deve desumersi un diritto ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell’attuare la decisione di ricorrere al suicidio assistito, quanto piuttosto un diritto all’accertamento dei presupposti stessi.
A tal fine, l’ordinanza ha affermato la necessità di fare distinzione tra la scriminante di un reato e la sussistenza di un diritto: come a voler specificare che un conto è dire che chi aiuta un malato al suicidio non commette un reato, un altro conto è sostenere che esista un diritto soggettivo del malato a togliersi la vita con un corrispondente obbligo dei sanitari a somministrare il farmaco letale.
Quel che si rileva è il dato obiettivo in ordine al quale dopo dieci mesi, passando per due udienze e due pronunce, dietro la persistente intenzione di recarsi in Svizzera per morire aiutato dai familiari senza che rischino di essere inquisiti, il paziente de quo sarà sottoposto alla verifica delle sue condizioni che rendono non punibile l'aiuto al suicidio.
Ne deriva che, nell’ipotesi di accertamento positivo da parte dei sanitari, l’uomo avrà diritto di accedere al farmaco letale da lui richiesto per garantirgli una morte rapida ed indolore, senza dover temere risvolti penalmente rilevante per chi presti l’aiuto al suicidio.
La svolta pretoria intercorsa nella giurisprudenza di merito è di immediata evidenza e costituisce la riprova di come, in assenza di un pur necessario intervento legislativo sul tema, i giudici di merito, dietro le rigide coordinate disegnate dalla Consulta, possano attuare una rivoluzione a tutti gli effetti, esaminando i contorni del caso concretamente posto alla loro attenzione.
Si delinea, così, lo spazio di un filone di giurisprudenza per così dire “normativa” idonea non solo a far luce su questioni ricorrenti nella prassi, ma soprattutto a costituire una base di pronunce utili a meglio orientare il legislatore che, inevitabilmente, si troverà presto a legiferare in materia e a dover dare risposte, tardive ma imprescindibili, a problematiche giuridiche, etiche e sovra-individuali difficilmente procrastinabili sine die.
3. Verso il referendum sull’eutanasia legale, considerazioni e prospettive a breve termine
Quanto asserito dal Tribunale di Ancora in ordine all’accertamento delle condizioni idonee a scriminare l’aiuto al suicidio rappresenta senza particolari dubbi la conferma di come in Italia manchi ancora una legge sul fine vita, la cui importanza è richiamata ripetutamente nelle tredici pagine di ordinanza del tribunale anconetano.
A fronte di casi ormai sempre più frequenti di pazienti che chiedono di poter scegliere come morire- vedendosi costretti a impegnativi viaggi all’estero o, diversamente, a terminare la propria vita in un dolore che non ritengono di poter sopportare- al cospetto di un Parlamento paralizzato e sordo persino ai richiami della Corte costituzionale, è stata avanzata la necessità di un referendum sul tema. Come a voler dichiarare che, se a tutti gli effetti deve ritenersi possibile una rivoluzione dal basso, questa è, fino a prova contraria, nelle mani dei cittadini.
A tal fine, l’associazione Coscioni ha recentemente giocato la carta del referendum costituzionale, depositando in Corte di Cassazione a Roma un referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 del codice penale sulla fattispecie di reato dell’omicidio del consenziente. Ne deriva che, se i promotori dovessero raccogliere le firme richieste e vincere il referendum, verrebbe depenalizzata l’eutanasia attiva, il medico potendo somministrare un farmaco eutanasico al paziente che lo richiedesse, come già previsto in altri paesi europei e non.
Da ultima, la Spagna ha visto l’entrata in vigore della propria legge sull’eutanasia solo il 25 giugno scorso, divenendo il settimo paese al mondo a depenalizzare l’aiuto a morire per pazienti affetti da determinati tipi di malattie gravi e incurabili. La norma, varata nel mese di marzo 2021, prevedeva un periodo di tre mesi per consentire alle regioni del paese iberico di creare organismi responsabili di valutare le richieste di accesso a tale diritto, sebbene tale programmazione non sia stata poi effettivamente compiuta in tutte le regioni. Permangono, difatti, crescenti dubbi sul piano applicativo, altresì in ragione della categoria dei medici “obiettori di coscienza”, in alcune regioni prevedendosi la formazione di liste dei professionisti sanitari contrari alla pratica eutanasica.
Tornando al fronte nazionale, nell’iniziativa referendaria in corso deve ravvisarsi una mossa tanto audace quanto non agevole da realizzare, in tutta Italia prevedendo la raccolta di 500.000 firme tra luglio e settembre- da consegnare in Corte di Cassazione il 30 settembre- altresì attraverso la disponibilità di volontari disposti a predisporre luoghi e occasioni utili al raccoglimento delle stesse. D’altro canto, ad oggi risulta essere l’unica possibilità per legalizzare l’eutanasia in questa legislatura, diversamente si rinvierebbe la prospettiva di un intervento legislativo a non prima di 3 o 4 anni, sempre che nel prossimo Parlamento vi sia una maggioranza favorevole. Ancora una volta, in ogni caso, ciò che sorprende è il persistente silenzio della classe politica sul tema.
Il recentissimo avvio della raccolta firme in esame- promossa dall’Associazione Luca Coscioni durante la campagna tenutasi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati- ha preannunciato il repentino allestimento dei primi tavoli a cominciare da Milano e Roma, per poi estendersi a tutta Italia.
A ben vedere, il referendum per l'Eutanasia Legale è stato depositato su iniziativa della predetta Associazione lo scorso 20 aprile in Corte di Cassazione, prevedendo una parziale abrogazione dell'art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente), che ad oggi, ferme restando le precisazioni della Consulta sulla scriminante prospettabile nei casi di aiuto al suicidio, impedisce con rigore la realizzazione dell’eutanasia attiva, sul modello olandese o belga. Si tratterebbe, inevitabilmente, si una rivoluzione copernicana su quello che per decenni è apparso come un baluardo intramontabile nel nostro ordinamento, ossia il divieto di pratiche atte a cagionare il decesso tramite la somministrazione diretta e non autonoma di farmaci che inducono la morte.
In realtà, in disparte all’iniziativa referendaria, l’urgenza di una regolamentazione su base normativa intorno al tema de quo è altresì il riflesso dell’esaminata sentenza proveniente dalla Corte Costituzionale nel 2019, che tiene fuori dall’ambito applicativo della non punibilità almeno due fattispecie di pazienti: chi non è tenuto in vita da sostegni vitali, come i malati di cancro, nonché i pazienti non sono in grado di darsi la morte autonomamente, in quanto totalmente immobilizzati.
Rebus sic stantibus, una decisa mobilitazione, vogliasi in direzione referendaria ovvero in ottica legislativa, rappresenta un’incombenza non ulteriormente rimandabile.
Inoltre, se si rileva che sono trascorsi 37 anni da quando Loris Fortuna, il padre della legge sul divorzio, presentò la prima proposta di legge per la legalizzazione dell'eutanasia, la prima occasione di silenzio serbato dal Parlamento risale a molti anni fa. E, se non bastasse, ne sono passati 15 dalla lotta di Piergiorgio Welby, "appena" 8 anni dal deposito della legge di iniziativa popolare sottoscritta da 140.000 cittadini. Passando per i processi Dj Fabo, Davide Trentini e autorevoli richiami della Corte costituzionale.
Certa è la convinzione che l’esigenza normativa che gravita intorno al fine vita non è battaglia di pochi, non è la storia di “casi”, più o meno noti all’opinione pubblica. Non è neppure una successione di risvolti giurisprudenziali, di interpretazioni estensive e costituzionalmente orientate. È la storia di persone, di famiglie, di vite umane vissute in stato di sofferenza e agonia, persone a cui spetta tempo, attenzione, discussione, normazione e, se non altro, doveroso rispetto. Alle spalle del diritto, giova ripeterlo, risiede e scalpita la vita reale in tutta la sua complessità.
La strada è ancora e sempre in salita, il dettato della Consulta rappresenta una solida base e l’ordinanza del Tribunale di Ancona uno dei tanti tasselli mancanti.
Anche l’immagine di un tavolo di raccolta firme, visto da lontano, sembra essere poco più di una goccia nel mare, ma del resto, i latini direbbero gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, "la goccia perfora la pietra non con la forza, bensì con il continuo stillicidio".
Riferimenti
1. Corte Costituzionale, ordinanza del 24 ottobre 2018, n. 207, depositata il 16 novembre 2018, pubblicata in G.U. il 21 novembre 2018 n. 46;
2. Corte Costituzionale, sentenza del 25 settembre 2019, n. 242, depositata il 22 novembre 2019, pubblicata in G.U. il 27 novembre 2019 n. 48;
3. Corte d’Assise di Appello di Massa, sentenza del 27 luglio 2020 n. 1, depositata il 2 settembre 2020;
4. Legge sul Consenso Informato e sulle DAT del 22 dicembre 2017 n. 219, pubblicata in G.U. del 16 gennaio 2018, n. 12;
5. Passaro D., Lo scenario italiano del fine vita, in Giustizia Insieme, 15 aprile 2019;
6. Passaro D., A sostegno e a difesa della persona umana: il diritto al rifiuto delle cure tra poteri dell’ADS e prerogative del giudice tutelare, in Giustizia Insieme , 24 marzo 2020;
7. Tribunale Ordinario di Ancona, ordinanza del 9 giugno 2021, Presidente Silvia Corinaldesi, Estensore Alessandro Di Taro.
8.V. gli interventi editi sulla Rivista sul tema del fine vita, a partire da "Il fine vita e il legislatore pensante." Editoriale - Il fine vita e il legislatore pensante. 1. Il punto di vista dei penalisti (di Vincenzo Militello, Beatrice Magro e Stefano Canestrari) - Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte I (di Mario Serio, Giuseppe Giaimo, Rosario Petruso e Rosalba Potenzano) - Il fine vita e il legislatore pensante. 2. Il punto di vista dei comparatisti - Parte II (di Mario Serio, Nicoletta Patti e Giancarlo Geraci) - Il fine vita e il legislatore pensante. 3. Il punto di vista dei filosofi del diritto (di Angelo Costanzo, Lorenzo d'Avack, Salvatore Amato, Carla Faralli). 4 Il fine vita e il legislatore pensante. 4. Il punto di vista dei civilisti (di Mirzia Bianca, Gilda Ferrando, Teresa Pasquino e Stefano Troiano)
Giustizia e comunicazione. 7) Il linguaggio giuridico nell’Accademia
di Marina Castellaneta
La rubrica della Rivista sul tema Giustizia e comunicazione, proseguendo nel percorso annunciato nell’editoriale del 18 maggio 2021, dopo aver ascoltato la voce della magistratura di legittimità e di merito nei contributi di Gianni Canzio, Giovanni Melillo, Claudio Castelli, ospitato il punto di vista della comunicazione professionale di Rosaria Capacchione e Giovanni Bianconi, discusso del valore della parola quale strumento chiave dell’emancipazione dell’individuo e della società nel contributo di Francesco Messina, affronta il tema del linguaggio dell’Accademia.
Nello scritto che segue, la Professoressa Marina Castellaneta, esperta di linguaggio giuridico e degli atti processuali, offre un quadro lucido e disincantato della lingua delle aule universitarie, evidenziandone criticità e carenze. La giurista sofferma poi l’attenzione sull’interazione tra lingua parlata e scritta, stigmatizzando lo scarso valore riconosciuto a quest’ultima soprattutto in ambito accademico, mettendo in luce le falle di un sistema in cui si arriva alla tesi di laurea senza aver mai scritto nulla prima, ed in cui, invece, sarebbe massimamente opportuno che il futuro avvocato, giurista, magistrato o altro professionista conosca e applichi le regole del linguaggio chiaro sintetico e preciso, evitando stereotipi a vantaggio della qualità.
L’elaborato affronta inoltre il tema della tecnica di redazione degli atti legislativi, non risparmiando di enfatizzare la differenza tra il legislatore attuale e quelli passati.
§§§
Periodi lunghi, giungla di subordinate, profluvio di parole superflue, aggettivi roboanti, gerundi a più non posso. Rendere oscuro ciò che è chiaro e non far comprendere ciò che è oscuro. E, poi, mai far mancare “atteso che”, “di guisa”, “talché”, “ed invero”, qualunque cosa vogliano dire nello specifico contesto di un discorso (lezione, conferenza, consigli di organi collegiali, verbali di concorso, saggi). Si aggiunga un linguaggio stereotipato, zeppo al tempo stesso di termini arcaici e usati in modo inappropriato e ricorso massiccio all’inglese, anche quando esiste una parola italiana ancora più chiara. È questo in diversi casi il linguaggio giuridico che esce dall’accademia e talvolta travolge gli studenti che sin dalle aule universitarie si confrontano con scritti di difficile comprensione non solo per il contenuto, ma anche per la scrittura utilizzata. E, di conseguenza, poi ripropongono quei riti di scrittura. E questo vale anche per il linguaggio nelle aule universitarie con buona pace di ciò che è realmente l’insegnamento: non monologhi con pubblico, ma trasmissione e scambio del sapere.
Il linguaggio nell’accademia malgrado i cambiamenti epocali non fa molti passi avanti e non riesce ad evolversi malgrado i mutamenti nella comunicazione e malgrado interventi, appelli di giuristi e dell’Accademia della Crusca per evitare anglicismi e complessità inutili che trasformano degli scritti scientifici, che dovrebbero servire a divulgare lo stato delle conoscenze e fare avanzare le ricerche in un settore, a messaggi in codice comprensibili solo a una determinata categoria di persone di riferimento. Un linguaggio per un circolo ristretto che si riproduce e che impedisce anche la diffusione della cultura scientifica.
Mentre tutto cambia i riti del linguaggio giuridico, almeno in molte aule universitarie, rimangono gli stessi. E che in pochi vogliano davvero cambiare è evidente dalla circostanza che, mentre si discute di modificare i corsi di studio in giurisprudenza, non risultano proposte per rendere obbligatorie materie come linguaggio e scrittura giuridica. Né ci si interroga più di tanto sulla necessità di prevedere aggiornamenti sulle modalità della didattica per gli stessi docenti, a partire dal linguaggio e dalla comunicazione, che pure sarebbe necessaria per favorire la diffusione anche di verifiche scritte.
E così mentre la Scuola Superiore della Magistratura prevede tra le attività formative corsi e incontri sulla scrittura giuridica e la Scuola Superiore dell’Avvocatura ha attivato analoghi percorsi[1], l’anello debole di un cambiamento non più rinviabile è proprio all’interno dell’università perché il contributo dell’accademia al miglioramento del linguaggio e della scrittura giuridica è limitato e lasciato alla buona volontà di pochi. Se poi si leggono talvolta sentenze incomprensibili, atti legali che puntando su un linguaggio aulico mettono da parte ogni forma di chiarezza, non si può non individuare tra i responsabili anche l’università.
Tutti d’accordo sul degrado del linguaggio e sulla necessità di sradicare quella che la giurista autrice del saggio imperdibile “Prontuario di punteggiatura” Bice Mortara Garavelli chiamava i “fossili lessicali”, ma pochi pronti a rendere il cambiamento strutturale[2]. Anche perché, come al solito, ci sono in ballo crediti formativi che poi contano per la programmazione, l’invenzione di un algoritmo e la programmazione dei posti.
In molti Dipartimenti di giurisprudenza delle università italiane, nonché nelle associazioni scientifiche il tema non sembra appassionare e in effetti non risultano proposte particolarmente innovative neanche da contesti collettivi come le conferenze dei direttori e la Conferenza delle Associazioni Scientifiche di Area Giuridica (CASAG) che raccoglie le società scientifiche di diversi settori disciplinari. Si procede così in ordine sparso: alcune università hanno compreso, infatti, la necessità di un insegnamento ad hoc sul linguaggio e sulla scrittura giuridica e hanno attivato dei percorsi, in taluni casi favorendo anche la formazione dei docenti. Ancorati a un linguaggio quasi rituale e talvolta quasi funzionale a rendere complesso ciò che è chiaro, costituito da frasi fatte e da “formule” ripetute che danno sicurezza, non sono pochi quelli che trascurano l’importanza di esempi e modelli chiari per accantonare finalmente una lingua stereotipata[3]. Che talvolta è frutto di un vuoto di contenuti con le parole utilizzate non per chiarire ma per soffocare o nascondere ciò che non c’è.
Tra le diverse iniziative, si può ricordare l’Università di Trento che ha un corso opzionale su “Le abilità del giurista” curato dal professore Giovanni Pascuzzi che nel programma prevede anche una parte dedicata alla redazione di testi, saggi giuridici, tesi, atti normativi, atti del processo e pareri[4].
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari aveva previsto per l’anno accademico 2019/2020 l’attivazione di un Laboratorio innovativo di pratica del diritto “Abilità retoriche per giuristi” affidato allo scrittore Gianrico Carofiglio, ma l’avvio è stato rinviato a causa della pandemia. Questo laboratorio nasce quasi come uno spin-off di un ciclo di incontri attivato nel dottorato di ricerca “Principi giuridici tra mercati globali e diritti fondamentali” (coordinato dal prof. Vito Sandro Leccese), avviato nel 2019/2020 e oggi al secondo anno di attività. Il corso ha potuto contare sulla partecipazione, tra gli altri, degli scrittori Gianrico Carofiglio e Francesco Caringella, del Presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini e di altri relatori[5].
Le iniziative post-laurea sono in effetti più diffuse. Così il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze ha un Corso di perfezionamento in “Professioni legali e scrittura del diritto. Tecniche di redazione per atti chiari e sintetici” (direttori i docenti Federigo Bambi, Paolo Cappellini, Ilaria Pagni e Marco Biffi) giunto ormai alla VII edizione, ma riservato a laureati e, in particolare, a professionisti del diritto e dell’amministrazione pubblica[6]. L’Università di Pavia ha attivato da diversi anni un Master di II livello sulla lingua del diritto, coordinato dalla professoressa Giulia Rossolillo, proprio partendo dal presupposto che il “diritto ha bisogno di un linguaggio appropriato e dei professionisti della scrittura”[7].
Incontri, iniziative, corsi master sono destinati ad aumentare perché la richiesta è in aumento. Ma quello che serve è iniziare a confrontarsi con la scrittura giuridica e il linguaggio chiaro sin dalle aule universitarie. E oggi più che nel passato tenendo conto che i due anni di didattica a distanza nelle scuole a causa della pandemia ha in molti casi impedito lo svolgimento di prove scritte, con un possibile peggioramento nella preparazione.
È necessario rimediare perché non è più ammissibile che, proprio in un settore in cui le parole sono così importanti lo studente di giurisprudenza riprenda a scrivere solo per la tesi di laurea. In quel momento l’apporto del docente non può che essere limitato e, quindi, è indispensabile intervenire per fare sì che il futuro avvocato, giurista, magistrato o altro professionista conosca e applichi le regole del linguaggio chiaro (che certo richiede più tempo rispetto a quello complesso), sintetico e preciso, evitando stereotipi a vantaggio della qualità. Il progressivo peggioramento del linguaggio e della scrittura giuridica ha una manifestazione concreta proprio nella produzione legislativa: basta leggere il testo della Costituzione del 1948 mettendo a confronto le norme scritte all’inizio e quelle modificate nel corso degli anni (si veda per tutti l’articolo 117 che ha creato e continua a creare un contenzioso proprio per la difficile interpretazione della norma, scritta in modo sciatto). Per non parlare di testi legislativi che, frutto del determinante contributo degli uffici legislativi, dimenticano che le leggi devono essere chiare a tutti, a ogni individuo che solo così può partecipare concretamente alla vita democratica[8].
C’è da chiedersi se l’accademia sia finalmente pronta a un cambiamento come quello che ha portato alla lenta ma progressiva diffusione delle cliniche legali nei corsi di studio in giurisprudenza. Anche in questo caso i ritardi sono stati imperdonabili. Basti pensare che Francesco Carnelutti sin nel 1935 aveva pubblicato un saggio in cui invocava l’ingresso tra gli insegnamenti delle cliniche legali. L’illustre giurista scriveva: “Eppure noi continuiamo a vivere in questo assurdo, quanto alla giurisprudenza. Se non ci hanno provveduto da sé, i nostri discenti diventano dottori, senza aver mai veduto un caso vivo del diritto”[9]. Analogo discorso per la scrittura: non si può arrivare alla tesi di laurea senza aver scritto nulla.
È così arrivato il momento, soprattutto in questa fase in cui si sta procedendo alla modifica del corso di studio per acquisire la laurea magistrale in giurisprudenza, di rendere obbligatorio l’insegnamento sul linguaggio e sulla scrittura, anche per salvaguardare la lingua italiana e non cedere a una diffusione di anglicismi che non ha riscontri in Francia o in Spagna. Se non si cambia e se non si iniziano a formare laureati con un consolidato bagaglio anche linguistico si dovrà ricorrere a un sistema di intelligenza artificiale per tradurre i testi legislativi e le sentenze da italiano a italiano.
Marina Castellaneta
[1] Cfr. D. Cerri, La scrittura degli atti processuali e il Protocollo d’intesa C.N.F., in Questione Giustizia, 2016, nel sito https://questionegiustizia.it; D. Borri, Il Programma di gestione della Cassazione per il 2021: chiarezza e concisione nel linguaggio del giudice (e delle parti), 9 giugno 2021, in Giustizia e insieme, 2021.
[2] Cfr. anche B. Mortara Garavelli, Le parole e la giustizia, Torino, 2001.
[3] I. Calvino, Lezioni americane, Milano, 1993; M. Ainis La legge oscura. Come e perché non funziona, Bari, 2010; G. Carofiglio, La manomissione delle parole, Milano, 2010; B. Pozzo e F. Bambi (a cura di), L’italiano giuridico che cambia, Accademia della Crusca, Firenze, 2012; A. Mariani Marini e F. Bambi, Lingua e diritto, Accademia della Crusca, 2013.
[4]Si veda il programma nel sito https://www.esse3.unitn.it/Guide/PaginaADErogata.do?ad_er_id=2020*N0*N0*S2*49440*87608&ANNO_ACCADEMICO=2020&mostra_percorsi=S
[5] Ci permettiamo di segnalare che il corso è coordinato da Marina Castellaneta. Per dettagli sul corso si veda la pagina web https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/post-laurea/dottorati-di-ricerca/dottorati-di-ricerca-1/attivita-formativa-didattica/attivita-formative.
[6] Si veda il sito https://www.dsg.unifi.it/vp-613-professioni-legali-e-scrittura-del-diritto-tecniche-di-redazione-per-atti-chiari-e-sintetici-vii.html.
[7] Ulteriori informazioni nel sito http://lalinguadeldiritto.unipv.it.
[8] P. Caretti, Discutere del linguaggio dei giuristi per riflettere sul loro ruolo oggi: qualche considerazione a conclusione del convegno “La lingua dei giuristi”, in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2015 nel sito https://www.osservatoriosullefonti.it/mobile-saggi/speciali/speciale-convegno-la-lingua-dei-giuristi/842-osf-3-2015-caretti/file.
[9] Così F. Carnelutti, Clinica del diritto, in Rivista di diritto processuale, 1935, I, 169 ss.
La settima sezione penale nel programma di gestione della Corte di Cassazione per l’anno 2021
di Pierluigi Di Stefano
Sommario: 1. Esame preliminare dei ricorsi e settima sezione penale - 2. Conclusioni - 3. La durata dei procedimenti in settima sezione penale - 4. Ridurre i tempi.
1. Esame preliminare dei ricorsi e settima sezione penale
Il programma di gestione della Corte per la prima volta comprende il settore penale e, quindi, consente una valutazione dinamica dell’esistente e della previsione di gestione futura.
Qui si considera tale programma per la parte che riguarda la gestione dei fascicoli di manifesta inammissibilità, da decidere secondo le specifiche, e più snelle, procedure dell’art. 610, commi 1 e 5 bis, cod. proc. pen., con assegnazione alla settima sezione penale.
Si tratta di profili organizzativi della massima rilevanza perché, pur se si tratta del materiale “da scartare” a prima vista, senza alcun serio impegno delle professionalità della Corte, si discute di numeri che arrivano alla metà delle sopravvenienze e, per ciò solo, drenano rilevanti risorse; al di là della più facile gestione dei “contenuti” (è pacifico che la stragrande maggioranza di tali fascicoli occupi ben poco tempo per valutazione, decisione e successiva redazione della motivazione), comunque i singoli consiglieri del settore penale arrivano a svolgere una udienza su quattro udienze mensili medie per tali procedimenti[1]. Inoltre, la gestione burocratica differisce da quella dei fascicoli ordinari solo per le minori attività connesse alla differenziazione di rito, avendo per il resto un simile impatto sulle attività delle cancellerie.
Il complesso di tali fascicoli, quindi, incide in modo rilevante e non in termini positivi, sottraendo (costose) risorse che dovrebbero essere, invece, impegnate nei compiti propri del giudice di legittimità.
Interessano, quindi, le valutazioni programmatiche che riguardano gli uffici (“spoglio”) istituiti presso le singole sezioni per l’esame preliminare dei ricorsi su delega del Primo Presidente la cui prima attività è quella di individuare i fascicoli da assegnare alla “apposita sezione” istituita per la rapida definizione dei procedimenti inammissibili.
Come noto, la settima sezione penale costituisce la “apposita sezione” individuata dall’art. 610 cod. proc. pen., come modificato nel 2001, quale destinataria dei ricorsi per i quali sia evidente la inammissibilità, da dichiarare con ordinanza in udienza camerale non partecipata previa comunicazione alle parti di un avviso che enuncia la causa di inammissibilità rilevata in sede di primo esame.
La organizzazione, ormai stabile, della Corte di Cassazione è nel senso che alla settima sezione sono coassegnati magistrati delle sezioni ordinarie (attualmente tutti i consiglieri); ogni sezione ordinaria ha a disposizione delle udienze che verranno tenute in sede di settima sezione da propri magistrati con un ruolo di cause predisposto dal proprio ufficio “spoglio”.
Su tale organizzazione ha inciso la legge n.103/2017 che ha previsto (art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.) una procedura senza alcuna formalità (de plano) per la declaratoria di inammissibilità quando ricorrano cause sostanzialmente “automatiche” (ricorso non proposto da soggetto legittimato, ricorso tardivo, provvedimenti non impugnabili, ricorso avverso patteggiamento per motivi di motivazione, patteggiamento in appello). Per questi casi la norma non prevede l’assegnazione alla sezione del primo comma, ma la regola “tabellare” al riguardo ha previsto che anche tali fascicoli siano trattati dalla settima sezione che, quindi, utilizza due diverse discipline processuali.
Per valutare i contenuti del programma di gestione, si considera innanzitutto la organizzazione tabellare per quanto di interesse sia con riferimento alla tabella triennale 2017/2019 che alla tabella 2020/2022, ancora in itinere:
| § 50. — Esame preliminare dei ricorsi. 50.1. Presso ciascuna sezione è costituito l'ufficio esame preliminare dei ricorsi del quale fanno parte, di regola, non meno di quattro e non più di sei consiglieri delegati dal Primo Presidente ….
| § 57. — Esame preliminare dei ricorsi 57.1. come 50.1
|
|
|
|
| 50.3. I consiglieri provvedono all'esame preliminare dei ricorsi trasmessi dalla cancelleria centrale penale alle rispettive sezioni e inoltrano alla Settima sezione i ricorsi per i quali rilevano una causa di inammissibilità.
| 57.4. I consiglieri provvedono, secondo le direttive emanate dal Primo Presidente a norma dell’art. 610, comma 1, cod. proc. pen., all'esame preliminare dei ricorsi trasmessi dalla cancelleria centrale penale alla sezione e inoltrano alla Settima sezione i ricorsi per i quali rilevano una causa di inammissibilità, attribuendo loro un valore ponderale di difficoltà da 1 a 3
|
| § 52. — Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi. 52.1. Il Primo Presidente nomina con decreto motivato, tra i presidenti non titolari, il coordinatore dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi il quale riveste anche la qualità di presidente coordinatore della Settima sezione e svolge altresì l'incarico di referente della cancelleria centrale penale.
| § 52. — Coordinamento dell'attività dei magistrati dell'ufficio esame preliminare dei ricorsi. Come 52.1
|
| Sezione settima § 56. — Competenza della Settima sezione. 56.1. La Settima sezione è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il magistrato delegato all'esame preliminare dal Primo Presidente abbia rilevato una causa di inammissibilità. | § 63. — Competenza della Settima sezione. 63.1. La Settima sezione è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il magistrato delegato dal Primo Presidente all'esame preliminare abbia rilevato una causa di inammissibilità, anche a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., salvo che ricorrano ragioni di urgenza che impongono l’immediata trattazione de plano nella sezione ordinaria. |
| 56.2. La Sezione, oltre ad ordinanze di inammissibilità, può emettere sentenze di annullamento senza rinvio esclusivamente nei seguenti casi: improcedibilità o improseguibilità dell’azione penale; estinzione del reato per morte dell’imputato, per remissione di querela, per prescrizione quando manchi la costituzione di parte civile; fatto non previsto dalla legge come reato, anche per abolitio criminis o per dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; possibilità di procedere alla determinazione della pena a norma dell’art. 620, comma 1 lett. l), c.p.p. | 63.2 Come 56.2
|
| 56.3. Nei casi di mutamenti normativi o di pronunce della Corte costituzionale che incidono sulla pena, intervenuti dopo l’assegnazione alla Settima sezione, quest’ultima può emettere sentenze di annullamento con rinvio. Ove si tratti di ricorsi avverso sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la Sezione può pronunciare sentenze di annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria di provenienza. | 63.3. Nei casi di mutamenti normativi o di pronunce della Corte costituzionale che incidono sulla pena, intervenuti dopo l’assegnazione alla Settima sezione, quest’ultima può emettere sentenze di annullamento con rinvio. Ove si tratti di ricorsi avverso sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 e 599-bis cod. proc. pen., la sezione può pronunciare sentenze di annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria di provenienza. |
| 56.4. La Sezione può adottare i provvedimenti correttivi previsti dall’art. 619 c.p.p. | 63.4 Come 56.4. |
| 56.5. Qualora il ricorso del pubblico ministero, pur in presenza di altri motivi inammissibili, contenga censure attinenti all’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria o alla mancata applicazione di pene accessorie non discrezionali o di sanzioni amministrative obbligatorie, la Sezione può emettere pronunce definitorie di annullamento senza rinvio, limitatamente ai detti punti, adottando le conseguenti statuizioni.
| 63.5 Come 56.5. |
| 57.3. I componenti dei singoli collegi sono individuati sulla base di un assetto organizzativo che preveda: a) la coassegnazione alla Settima sezione dei magistrati delegati all'esame preliminare dei ricorsi delle singole sezioni e di un numero di ulteriori magistrati non inferiore a sei; b) la tendenziale partecipazione dei magistrati coassegnati che svolgano l’attività di spoglio ad almeno una udienza mensile, con corrispondente riduzione del numero delle udienze sezionali.
| 64.2. I componenti dei singoli collegi sono individuati sulla base di un assetto organizzativo che prevede la tendenziale co-assegnazione di tutti i magistrati di ciascuna sezione, per favorire il più ampio scambio di esperienze e di orientamenti e l’equa distribuzione dei carichi di lavoro. I magistrati che svolgono l’attività di spoglio tengono, di regola, una udienza mensile alla Settima sezione. In ogni caso, i magistrati che tengono udienza alla Settima sezione fruiscono della corrispondente riduzione del numero delle udienze sezionali |
| 57.4. Salvo deroghe specificamente motivate la composizione dei collegi deve prevedere la designazione di componenti provenienti da una medesima Sezione, due dei quali, di regola, addetti all'esame preliminare dei ricorsi. | 64.3. Salvo deroghe specificamente motivate, la composizione dei collegi deve prevedere la designazione di componenti provenienti da una medesima sezione, almeno uno dei quali, di regola, addetto all'esame preliminare dei ricorsi |
| 57.6. Nella Settima sezione i procedimenti vengono assegnati secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo, in numero di regola non inferiore a centottanta per udienza, egualmente distribuiti tra i componenti del collegio, escluso il presidente. Per ogni trimestre di riferimento il presidente coordinatore può variare il numero dei ricorsi da trattare in funzione della definizione delle pendenze.
| 64.5. I procedimenti vengono assegnati secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo, in numero di regola non inferiore a centosessanta per udienza, oltre ai procedimenti ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., egualmente distribuiti tra i componenti del collegio, escluso il presidente, secondo l’ordine crescente di anzianità di ruolo. Per ogni trimestre, il presidente coordinatore può variare il numero dei ricorsi da trattare in funzione del numero delle pendenze di ogni singola sezione. |
| 57.7. Dei provvedimenti selezionati per l'udienza, vengono preliminarmente individuati quelli pertinenti a materie che secondo le disposizioni tabellari avrebbero dovuto essere trattate dalle sezioni di provenienza dei componenti del collegio, a ciascuno dei quali gli stessi vengono assegnati. 57.8. I ricorsi in materia cautelare personale vanno comunque trattati prioritariamente. | 64.6 e 64.7 come 57.7 e 57.8
|
Si notano le modifiche principali apportata con il nuovo progetto tabellare, in corso di approvazione:
- si prevede che il Primo Presidente emani specifiche direttive riguardanti l’attività dei magistrati addetti agli uffici “spoglio” quanto alla selezione dei fascicoli da destinare alla settima sezione penale. È una previsione programmatica, evidentemente mirata a uniformare i criteri tra le varie sezioni, esigenza di cui si dirà dopo.
- Anche ai procedimenti destinati alla settima sezione penale deve essere attribuito un “valore ponderale di difficoltà”, da 1 a 3. Tale attribuzione è finalizzata a rendere possibili ulteriori disposizioni organizzative.
- Alla settima sezione penale è attribuita la competenza anche per la trattazione dei procedimenti de plano salvo “ragioni di urgenza”. Tale competenza, si ripete, è una scelta esclusivamente “tabellare” in quanto non è prevista dall’art. 610 cod. proc. pen.
- Di norma, va disposta la coassegnazione di tutti i magistrati delle sezioni penali ordinarie anche alla settima sezione. La previsione variabile lascia spazio ad una organizzazione più elastica, secondo le necessità del periodo. In conseguenza di tale partecipazione più ampia, si prevede che ogni collegio della settima sezione debba essere formato con almeno un magistrato “spogliatore” (non più due come da precedente tabella).
- il numero minimo di fascicoli da trattare in ogni udienza della settima sezione viene rimodulato (da 180 a 160), considerato vi è una quota aggiuntiva di procedimenti con trattazione de plano.
Come risulta dal programma di gestione e dal documento organizzativo generale per il triennio 2020-2022 che riportano i dati statistici degli ultimi anni, la funzione di filtro degli uffici spoglio con attribuzione alla settima sezione della numerosa massa dei ricorsi di evidente inammissibilità, ha sostanzialmente funzionato bene: il numero complessivo di ricorsi alla settima, difatti, è giunto al 43% del totale delle sopravvenienze del settore penale.
Tale dato percentuale è ancor più rilevante perché dal numero globale vanno esclusi i numerosi procedimenti in materia cautelare, personale e reale. Questi procedimenti, pur essendo possibile la loro assegnazione alla settima sezione ricorrendo le condizioni di evidente inammissibilità, sono trattati per prassi presso le sezioni ordinarie con l’ordinaria procedura camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. La ragione è che, in considerazione della materia che richiede una decisione immediata, risulta preferibile ricorrere alla procedura ordinaria che consente la trattazione in termini più rapidi: l’avviso alla parti, secondo il procedimento ordinario (artt. 311 e 324 cod. proc. pen.) deve essere dato 10 giorni prima dell’udienza e non 30 giorni prima come è previsto per il procedimento speciale ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Il programma di gestione, sulla scorta di tali risultati che offrono un quadro chiaro e sostanzialmente positivo della gestione dei fascicoli di manifesta inammissibilità, non segnala particolari obiettivi per la settima sezione.
I dati utilizzati, che possono essere valutati unitariamente perché i trend sono alquanto costanti negli ultimi anni, evidenziano come la sezione riceva, come detto, una rilevante parte dei procedimenti totali con percentuali che variano abbastanza da sezione a sezione. La ragione di tale diversità è individuata in un diverso approccio da parte degli uffici spoglio delle singole sezioni ma è presumibilmente conseguente anche alla tipologia di procedimenti trattati. È indubbio che in determinati settori la percentuale di ricorsi di immediata inammissibilità, proposti in via meramente strumentale, è certamente più elevata (es. stupefacenti, evasioni etc). Sul punto, invero, non risultano comunicati dati statistici.
Anche il risultato qualitativo della selezione fatta in sede di spoglio, sul piano numerico, è decisamente apprezzabile in quanto la quasi totalità dei procedimenti trasmessi alla settima sezione vengono definiti con la decisione di inammissibilità mentre solo una percentuale che non supera il 4% viene restituita alle sezioni per approfondimenti (da valutare, poi, quanti di questi non vengano comunque dichiarati inammissibili o rigettati).
Allo stesso tempo, tale quota di fascicoli trasmessi alle sezioni ordinarie è segno di come funzioni anche la garanzia che in sede di settima sezione vi sia una seria valutazione dei procedimenti e non un esame superficiale fidando solo sulla delibazione della fase di spoglio (si rammenta come una direttiva ormai risalente preveda che il magistrato spogliatore non assegni i fascicoli destinati alla settima sezione a sé stesso proprio per garantire una più ampia valutazione).
I risultati positivi hanno quindi giustificato il mantenimento della stessa organizzazione con minimi adattamenti. Ciò anche per le modalità di composizione dei collegi della settima sezione per i quali si è voluto garantire la partecipazione di almeno uno dei magistrati addetti all’esame preliminare dei fascicoli, scelta sicuramente opportuna per il dovuto confronto e approvazione delle scelte fatte dai magistrati spogliatori nella attività di selezione fascicoli da trasmettere per la declaratoria di inammissibilità.
Tali risultati, ovviamente, riguardano l’accuratezza della selezione in ingresso, ma non consente di valutare se l’attività di filtro degli uffici spoglio abbia raggiunto sempre una soglia adeguata.
Non sembra, difatti, impossibile incrementare ulteriormente la trasmissione dei fascicoli in alcuni casi poiché ad una prima approssimazione la forte diversità di percentuale tra le varie sezioni sembra non dovuta solo a diversità di materie, come già si è detto, ma anche ad filtraggio più accurato[2]. D’altro canto, va considerato che si discute di un ambito di valutazioni per cui non si può ragionare in termini semplicemente meccanicisti ed è comprensibile che non sia un settore sul quale si possa facilmente intervenire.
Certamente, appare opportuno che, per ragioni di omogeneità, vi sia un indirizzo da parte del coordinatore della settima sezione. Il programma di gestione , difatti, negli obiettivi qualitativi quanto all’esame preliminare dei ricorsi prevede che il coordinatore verifichi il rispetto dei parametri di esercizio dell’attività di “filtraggio”, attività che presumibilmente sarà ancora più accurata in ragione delle direttive che saranno adottate secondo la previsione del nuovo progetto tabellare, come sopra si è riportato.
Vi è comunque anche un limite al “filtro” dell’ufficio spoglio: al magistrato addetto all’esame preliminari dei fascicoli si affida una valutazione che, a parte profili sostanzialmente automatici di non impugnabilità (tardività, provvedimento non impugnabile etc.), prevede da parte sua una “constatazione” della presenza di motivi mirati alla rivalutazione del merito o generici etc. ma non una vera e propria delibazione sulla presumibile infondatezza. Questa è la ragione per la quale non va richiesto all’ufficio spoglio una selezione sulla scorta di un approfondimento dei contenuti; contrariamente a quanto è stato anche oggetto di qualche critica negli anni recenti, il “superamento” della selezione settima/sezione ordinaria e la fissazione del procedimento in udienza ordinaria non può essere ritenuto una sorta di garanzia della non manifesta infondatezza che giustifichi l’aspettativa di un risultato in termini quantomeno di “rigetto” del ricorso.
In ragione degli obiettivi generali di benessere organizzativo, nel programma di gestione anche in riferimento alla attività della settima sezione è stato determinato un concetto di “carico esigibile” individuale, computato in collegamento al dato analogo sviluppato per ciascuna sezione ordinaria, essendo tutti i magistrati coassegnati al 25%.
In realtà, pur a fronte dell’elaborazione di tale dato del carico esigibile nel programma (al punto “8.5 Carico esigibile”), vi è una previsione rigida nelle tabelle di un numero minimo di procedimenti da fissare per ciascuna udienza: il vecchio progetto prevedeva 180 fascicoli per udienza (quindi 45 per consigliere), il nuovo riduce i fascicoli ordinari a 160 cui vanno aggiunti i procedimenti de plano.
Quindi, allo stato, il carico di lavoro per la settima sezione penale risulta predeterminato nel minimo ad un livello abbastanza elevato senza l’elasticità del carico esigibile.
In concreto, per fare ad esempio il caso della sesta sezione penale, per le proprie udienze di settima sezione prevede 50 procedimenti per relatore, di cui tendenzialmente 10 de plano, con eventuali procedimenti urgenti (scadenze misura cautelare, richieste di remissione ex art. 45 cod. proc. pen.) in sovrannumero assegnati al presidente.
Quindi, in realtà, sulla scorta di un dato tendenziale di assegnazione di ciascun consigliere per il 25% del numero di udienze alla settima sezione, le tabelle, considerando una sostanziale equivalenza di difficoltà (o, in questo caso, semplicità) di ciascun affare trattato, hanno già predeterminato nel minimo il carico esigibile.
Si noti come il progetto tabellare in approvazione introduca per la prima volta la assegnazione di un valore ponderale (nella più limitata scala da 1 a 3 rispetto a quella in uso per gli altri fascicoli “ordinari”) anche per i procedimenti destinati alla settima sezione. A tale previsione, per ora, non sembra accompagnarsi alcuna conseguenza, il numero di fascicoli per udienza nel medesimo progetto tabellare non è determinato in base al relativo peso, né vi è altra differenza. Potrà essere utilizzato il dato nella futura organizzazione concreta per le direttive sulla gestione o, eventualmente, anche come base per introdurre modalità differenziate quanto alle motivazioni preconfezionate[3].
Nella individuazione degli obiettivi qualitativi invero la settima penale non è considerata in via diretta bensì risente degli obiettivi riferiti alle attività di esame preliminare dei ricorsi presso le sezioni ordinarie. Questa è la fase in cui si “filtrano” le sopravvenienze e si alimenta la settima sezione, con la già citata inevitabile parziale difformità di situazioni a seconda delle singole sezioni che trasmettono i procedimenti (e che poi li gestiscono con i propri magistrati).
Il programma segnala anche le prove, per ora limitate ad alcune sezioni, di “informatizzare possibili schermi logici di decisione in relazione alla diversa tipologia di questioni“, in parole povere di predisporre dei modelli preformati per i procedimenti di maggior semplicità. È questo un tema sul quale si tornerà.
Nell’ambito degli obiettivi qualitativi, si individuano i compiti propri del coordinatore la settima sezione penale il quale deve assicurare il “rispetto dei parametri generali ed omogenei fissati in tabella alla cui stregua gli Uffici spoglio possano improntare il giudizio circa rispetto del requisito normativo della specificità dei motivi”. E’ un ruolo importante che, si ripete, potrà essere incrementato in collegamento con la nuova previsione tabellare delle direttive del Primo Presidente.
Infine, pur non essendovi indicazioni specifiche nel programma, la settima sezione, svolgendo attività “massiva”, è ovviamente particolarmente interessata alla informatica giudiziaria intesa quale modalità di velocizzazione delle operazioni. Tanto già è stato fatto con le comunicazioni e notificazioni telematiche, con il ruolo di udienza informatizzato che, per il lavoro su grandi numeri, ha ben semplificato il lavoro complessivo dei vari utenti interessati (pur se anche la sola arretratezza sull’uso della firma digitale costringe ancora i presidenti, in esito alle udienze, ad attività quali la firma manoscritta di oltre 180 dispositivi per volta.). I prossimi passaggi potranno riguardare la automazione della redazione delle decisioni, in un settore che ben si presta per il carattere ripetitivo e privo di contenuti giuridici rilevanti dei casi da trattare.
2. Conclusioni
In definitiva, il programma organizzativo giustamente rileva un andamento sostanzialmente virtuoso della gestione della assegnazione alla settima sezione penale e della successiva lavorazione dei procedimenti. La attività di “filtro” a monte funziona, con percentuali maggiori o minori che certamente rientrano in un ambito sostanzialmente fisiologico considerato che in tale contesto gioca molto il tipo di materia, l’esperienza, la sensibilità individuale che rendono difficile una misurazione meccanica.
La capacità di definizione è buona e il rapporto tra fascicoli in ingresso e in uscita è nel senso della piena capacità di smaltimento.
L’obiettivo di differenziare i procedimenti per i quali seguire il ponderoso procedimento ordinario, con l’intento di non appesantirlo, non sprecare risorse e nel contempo non pesare sulla qualità e quantità delle definizioni appare raggiunto.
3. La durata dei procedimenti in settima sezione penale
Invero, dalla lettura del programma di gestione e del progetto organizzativo, considerati i dati forniti, risultano situazioni rispetto alle quali si possono prospettare delle modifiche. In particolare, rilevano la tempistica di definizione dei procedimenti destinati alla settima sezione, sulla scorta dei dati utilizzati nel progetto tabellare e nel documento organizzativo, di quelli riportati nel programma di gestione e dei dati comunicati periodicamente.
I numeri globali dei fascicoli, come detto, sono sostanzialmente stabili, al netto delle variazioni riscontrate nel 2020 che trovano motivo nella fase del rallentamento delle attività per la pandemia. La ragionevole aspettativa è che tali numeri tornino ai precedenti livelli rispettandosi i medesimi trend degli ultimi anni.
Meritevole di valutazione sono, però, i giorni di durata dei procedimenti per quanto poi si dirà.
Ragioni ovvie rendono particolarmente importante il ridurre i tempi di gestione dei fascicoli di manifesta inammissibilità.
Il carico gestito dalla settima sezione penale è sostanzialmente tutto ciò che in Corte di cassazione non avrebbe neanche dovuto arrivare, e che invece arriva nella piena consapevolezza degli istanti che si tratta di materiale spurio: ricorsi di soggetti non legittimati, contro provvedimenti non impugnabili, motivi non proponibili o proposti in forma solo generica. La stragrande parte dei fascicoli trattati nella settima sezione rientra in quest’ambito, considerato che è in questione la selezione dei soli procedimenti per i quali la inammissibilità è evidente e sostanzialmente non opinabile.
Anche l’auspicio di una prassi di “filtro” a maglie più strette riguarda, comunque, solo i ricorsi che rientrano nell’ambito della evidenza della inammissibilità e non quelli per i quali possa esservi un ambito di valutabilità, sia in punto di diritto che di vizi della motivazione.
La principale ragione di tali numeri di ricorsi inconsistenti è ovvia e trova riscontro nel fatto che anche dopo la introduzione della procedura de pano non sono venute meno neanche i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento per il vizio di motivazione (non più ammesso):
se la sentenza di condanna non è eseguita nel caso in cui si proponga ricorso, ancorchè inammissibile, vi sarà comunque un interesse fattuale al ricorso.
Si potrà discutere se riteniamo o meno accettabile una tale impostazione secondo i “nostri” parametri, ma i difensori semplicemente perseguono l’interesse dell’imputato ormai condannato.
Si rammenta, poi, che la decisione di inammissibilità preclude il pagamento delle relative prestazioni in caso di gratuito patrocinio e, quindi, non vi è neanche il sospetto che l’eccesso di contenzioso nasca dalla possibilità di ottenere la retribuzione anche per tali attività inutili.
È evidente che pressoché tutti coloro che presentano i ricorsi destinati naturalmente alla settima sezione penale sono consapevoli che non vi sia alcuna possibilità non tanto di accoglimento ma di effettiva trattazione in udienza partecipata nelle sezioni ordinarie. Del resto, una scelta come l’introduzione della procedura de plano dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. è stata utile per semplificare la gestione da parte della Corte, ma, si ripete, non sembra avere indotto le parti a ridurre il numero di ricorsi presentati. L’importante, dal punto di vista del ricorrente, è posticipare l’eseguibilità della sentenza.
La conclusione evidente è che se si vuole seriamente privare di interesse la proposizione di ricorsi inutili, contro cui poco può una sanzione pecuniaria di fatto irrecuperabile nella maggior parte dei casi o una rigida interpretazione dei criteri di specificità dei motivi di ricorso (cosa importa a chi non ha alcun interesse a “vincere” perché sa già che è impossibile?), risulta della massima importanza ridurre al massimo i tempi di trattazione dei procedimenti in settima sezione penale.
Solo una decisione quantomai rapida (auspicando anche un miglioramento dei tempi nella fase di trasmissione della impugnazione) può essere un serio deterrente al ricorso strumentale. Non è certamente un deterrente la crescita esponenziale negli ultimi anni degli importi delle nostre condanne a sanzione pecuniaria per la inammissibilità in quanto, a fronte del dato formale dei 200 milioni di euro cumulati nell’ultimo anno (in sé superiore al complesso degli stipendi dei magistrati e del personale della Corte), andrebbe valutato quale sia stata la percentuale di incasso effettivo negli anni precedenti (detratti i costi di recupero).
Invece, proprio la settima sezione penale sembra avere qualche sofferenza in più sul piano della durata dei procedimenti che non aiuta a deflazionare il contenzioso inutile.
Colpisce guardando i dati presenti nel programma di gestione, che peraltro confermano anche quelli ulteriori e più analitici che risultano dalla trasmissione delle elaborazioni statistiche periodiche, il fatto che la sezione con il più consistente arretrato di procedimenti antecedenti al 2020 è proprio la settima sezione penale.
Si tratta di un dato grezzo (non è offerto un dato comparabile per gli anni precedenti e vi è la variabile “covid”), ma discretamente significativo che chi propone ricorso per ritardare il giudicato ha più chances se il suo procedimento inammissibile venga trasmesso alla settima sezione piuttosto che se resti in sezione ordinaria.
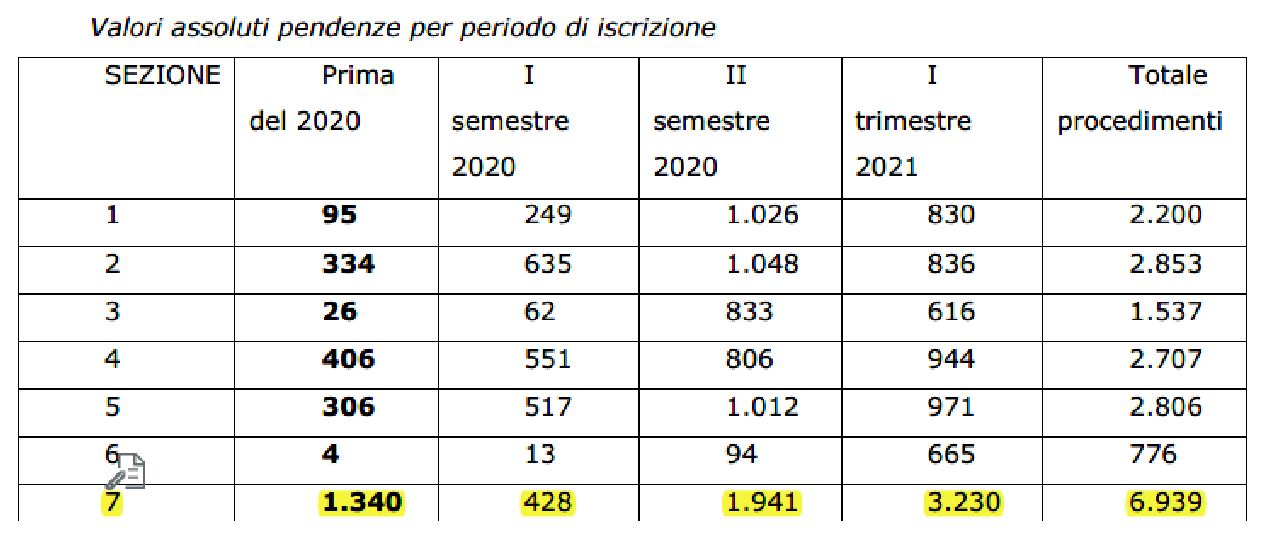
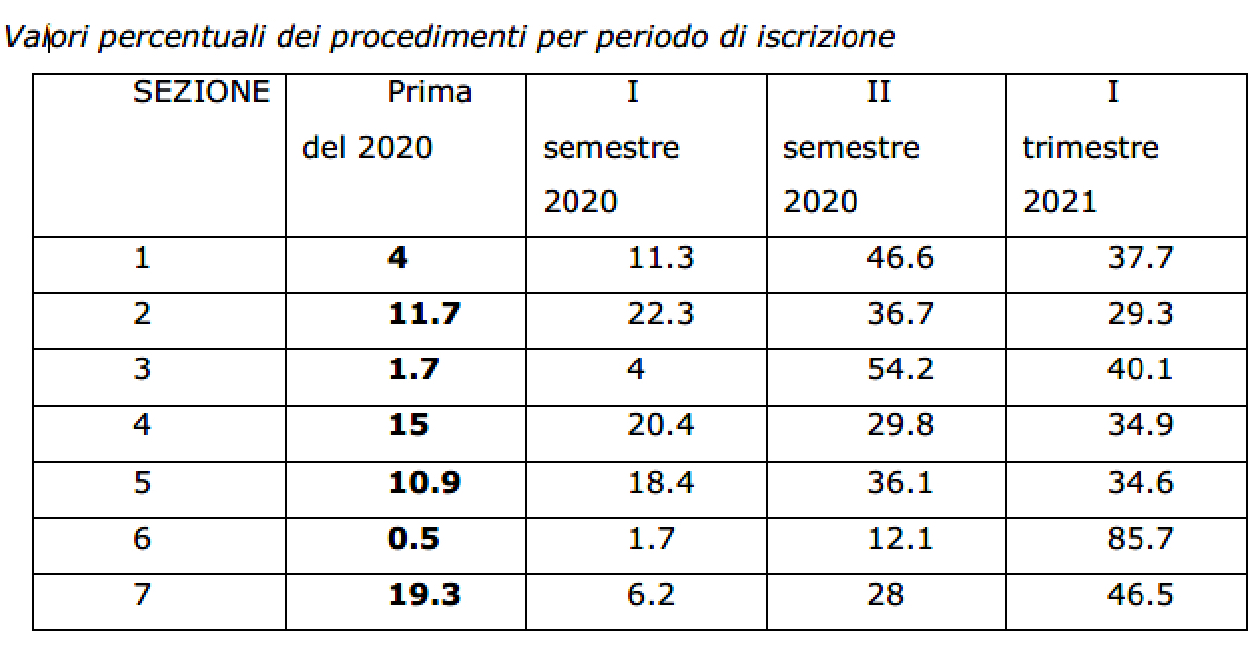
Il dato della maggiore permanenza del procedimento prima del suo esaurimento trova riscontro anche nella sintetica tabella sulla durata media in giorni dei processi:
Presso la settima sezione penale
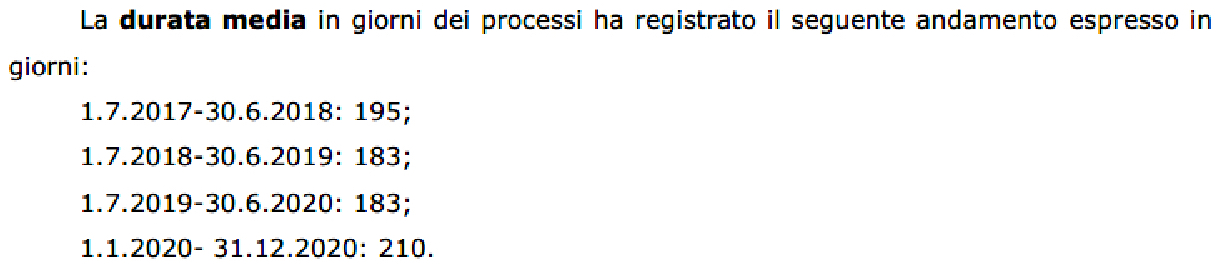
Per tutto il settore penale
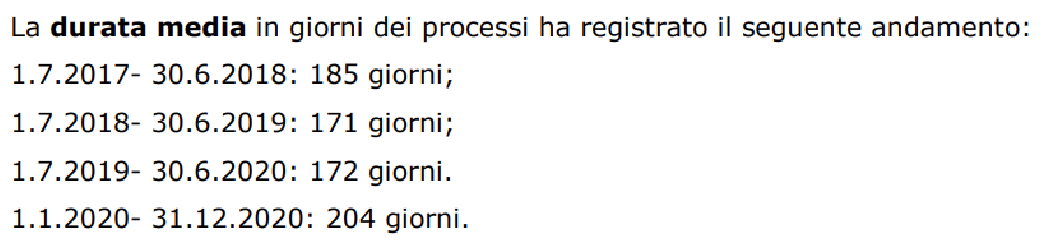
Facendo riferimento al dato luglio 2018/luglio 2019 (così evitando il condizionamento del periodo pandemia che ha pesato diversamente sui vari settori), a fronte della durata di 183 giorni presso la settima sezione penale, abbiamo numeri di durata dei processi presso le singole sezioni pari a 224, 191, 164, 133, 127e 119 giorni[4].
In tali numeri si annida il rischio della incentivazione del “ricorso inutile”: più lunghi sono i tempi di trattazione, più le parti avranno interesse a proporne.
Questa constatazione suggerisce una fase di accelerazione per portare a tempi più brevi le decisioni (una volta raggiunto l’obiettivo, non dovrebbe essere particolarmente impegnativo mantenerlo).
4. Ridurre i tempi
Al di là di una parziale spinta in aumento delle decisioni che, ovviamente, sconterebbe l’incidenza sulle altre attività a parità di risorse, possono cercarsi soluzioni utili ad una gestione più rapida.
Una prima soluzione riguarda i procedimenti de plano.
Potrebbe ragionevolmente ripensarsi sulla gestione di tali procedimenti per i quali attualmente è previsto che, salvo urgenza, debbano essere trasmessi alla settima sezione. Del resto è la stessa legge che, pur inserendo la nuova procedura ultrasemplificata nello stesso art. 610 cod. proc. pen., non ha previsto l’assegnazione alla apposita sezione, preferendo lasciare ogni scelta all’autonomia organizzativa della Corte.
La scelta normativa di azzerare la gestione burocratica di procedimenti per i quali non vi è alcun ambito di opinabilità sulla inammissibilità in teoria potrebbe portare, quanto meno per la parte di decisione del giudice, ad una decisione in tempo sostanzialmente reale, come consente il carattere del tutto informale della procedura.
Se, invece, i procedimenti de plano vengono fissati innanzi alla settima sezione insieme ai procedimenti di settima “ordinari”, i tempi sono ben più lunghi e sono sostanzialmente equiparabili a quelli degli altri procedimenti.
Eppure, non appare difficile ipotizzare una soluzione “sbrigativa” che, con l’esperienza dell’ufficio spoglio, può così immaginarsi:
il magistrato addetto allo spoglio, anche con l’aiuto della cancelleria, separa pacchi di 5-10 procedimenti de plano che, di solito, sono immediatamente individuati senza alcun “apprezzamento” (larga parte sono patteggiamenti, provenienti dal giudice di primo grado, per i quali basta un mero riscontro di copertina, o patteggiamenti in appello, dato immediatamente evidente dal dispositivo, o atti firmati dalla parte personalmente) e li consegna secondo un ordine ai colleghi di sezione che curano personalmente la redazione di un modulo di decisione il cui contenuto per quasi tutti i casi può essere ridotto all’osso (tipo “l’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non consente il ricorso per ragioni di motivazione” o “l’articolo 613 cod. proc. pen. non consente il ricorso personale”, bastando fare uso di normale modulistica informatizzata, come quella standard di MS Word) e chiedono alla cancelleria la registrazione per la propria prima o seconda udienza utile; in tale udienza, attesa la materia, il confronto con presidente e colleghi per la decisione richiederebbe una manciata di secondi senza alcuna reale incidenza sulla restante attività.
Tra la consegna del fascicolo alla sezione e la adozione della decisione sarebbero sufficienti pochissimi giorni.
Ad una tale attività semplicissima si aggiunge, però, la gestione di cancelleria, considerando che i numeri non sono bassi e le attività post udienza non dissimili da quelle dei fascicoli ordinari. Ma, in questo caso, potrebbe certamente curarsi una successiva gestione materiale dei fascicoli da parte della medesima cancelleria della settima penale, in quanto organizzata per personale e modalità di lavoro alla gestione di grandi numeri.
In questo modo, si potrebbe ottenere, spostando un lavoro che a ben vedere è di minimo impegno, utilizzando ritagli di tempo nel corso di altre attività, una decisione quasi in tempo reale di quelle che sono arrivate ad una discreta percentuale sul totale dei fascicoli (particolarmente elevata per la “piccola” droga e i furti), sino al 12,5% come segnalato[5].
Ciò lascerebbe anche la possibilità di gestire più rapidamente i fascicoli ordinari della settima sezione. L’eliminazione dei fascicoli de plano, recuperati con una migliore organizzazione dei tempi, è in grado di portare a una riduzione dei tempi di fissazione delle udienze di settima sezione da parte delle sezioni ordinarie allo stato in sofferenza.
Anche per la settima sezione “ordinaria” va considerato che, se si vuole raggiungere un obiettivo di riduzione (anche se non nel breve periodo) delle sopravvenienze, si deve disincentivare il vantaggio pratico.
Qualsiasi soluzione che renda più complesso predisporre un ricorso ammissibile è di scarsa efficacia (come essere più rigidi sul requisito della specificità dei motivi, sulla autosufficienza etc): le impugnazioni vengono proposte nella piena consapevolezza che la destinazione “naturale” del procedimento è la settima sezione penale e ciò che può disincentivare è solo il rendere quanto più celere la decisione.
L’intervento possibile è tentare di allineare le sezioni con tempi più lunghi alle altre, redistribuendo temporaneamente i carichi. La organizzazione tabellare non limita la formazione dei collegi e l’assegnazione dei fascicoli e, ad es., potrebbe assegnarsi una quota di fascicoli delle sezioni più gravate ad altra con tempi inferiori o consentire in via provvisoria collegi “misti” in modo da offrire temporaneamente più possibilità di trattazione alle sezioni che devono ridurre i propri tempi di trattazione.
Il ragionevole obiettivo deve essere quantomeno di non avere tempi di trattazione per la settima sezione penale superiore a quelli per il procedimento ordinario.
Nell’ambito degli obiettivi individuati al programma si fa anche un accenno alla creazione di un sistema informatico di schemi di motivazione per velocizzare la redazione delle ordinanze (e il loro deposito)[6]. Questo è un obiettivo rilevante per ridurre al minimo anche la fase di redazione dei provvedimenti, evitando nel contempo che vengano redatte ordinanze dal contenuto eccessivo rispetto alle finalità dell’atto, contribuendo a quella che è la effettiva finalità della settima sezione penale (e della gestione dei procedimenti de plano), ovvero la rapida eliminazione dei procedimenti di manifesta inammissibilità per dedicare il tempo all’attività propria del giudice di legittimità.
[1] Il programma, al punto 8.5, dà atto che per tutti i consiglieri la coassegnazione alla settima sezione penale è stata disposta per il 25% della loro attività.
[2] Da dati statistici generali nel 2019, la percentuale tra le varie sezioni era tra il 31,2% e il 53%
[3] Es., disporsi che per i fascicoli di valore 1 il relatore possa limitarsi a dare atto della assenza ictu oculi di uno sviluppo di motivi che giustifichi un riferimento concreto al contenuto del ricorso.
[4] Si tenga però conto che la base da cui sono tratti i dati non è del tutto comparabile; per le sezioni ordinarie vi sono i procedimenti cautelari che hanno tempi più brevi.
[5] Ciò, ovviamente, non risolve il tema del tempo tra la adozione del provvedimento impugnato e il pervenimento degli atti alla Corte ma per gli uffici più grandi, che producono la gran parte dei patteggiamenti, i tempi sono abbastanza brevi.
[6] “Con specifico riguardo all’attività di esame preliminare dei ricorsi, merita di essere condivisa, nel prossimo triennio, l’esperienza, avviata presso la Settima sezione penale dai collegi di alcune sezioni penali, di concerto con il C.E.D., di informatizzare possibili schemi logici di decisione in relazione alla diversa tipologia di questioni poste dai ricorsi in modo da razionalizzare il lavoro dei consiglieri, facilitare la lettura dei provvedimenti, rendere più incisivo il messaggio nomofilattico in ordine a principi ormai consolidati non confutati criticamente e in maniera specifica dalla parte ricorrente”.
Corte di Cassazione, prima sezione penale, 16 febbraio 2021 nr. 6089 e il divieto di partecipare a pubbliche riunioni nella sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: la regula iuris della pronuncia a Sezioni Unite nr. 46595 del 28 marzo 2019
di Giuseppe La Corte
Sommario: 1. Ordinanza di rimessione, sezione prima penale, nr. 2124 del 2019, Presidente Bonito, relatore Magi: profili problematici - 2. Le Sezioni Unite sulla nozione di “pubbliche riunioni”: una lettura “tassativizzante” della prescrizione di cui all’articolo 8, comma 4, in rapporto all’articolo 75 comma 2 del Codice Antimafia - 3. Possibili soluzioni interpretative: de jure condendo - 4. E dopo…Corte di Cassazione, prima sezione penale, 16 febbraio 2021 nr. 6089 presidente Casa, relatore Renoldi - 5. Breve conclusione rebus sic stantibus.
1. Ordinanza di rimessione, sezione prima penale, nr. 2124 del 2019, Presidente Bonito, relatore Magi: profili problematici
Con sentenza emessa il 7 febbraio 2017, la Corte di Appello confermava la penale responsabilità degli imputati in relazione al reato di cui all’art. 75, co. 2, D.lgs. 159/2011(Codice Antimafia). In particolare, gli stessi avrebbero frequentato soggetti pregiudicati e partecipato ad un torneo internazionale di tennis, così violando la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni. La principale doglianza contenuta nel gravame presentato dalla difesa ha ad oggetto la ritenuta punibilità della partecipazione del sorvegliato speciale alla suddetta manifestazione sportiva. Secondo il ricorrente, infatti, il divieto di partecipare a manifestazioni pubbliche riguardava celebrazioni di particolare rilievo in occasione delle quali l’animosità del pubblico fa sorgere liti e risse. Ciò che era impossibile si verificasse in un incontro di tennis ove il silenzio del pubblico è, invece, una prerogativa essenziale del gioco.
Con ordinanza del 19 dicembre 2018, la prima sezione penale della Corte di Cassazione rimetteva la trattazione del ricorso innanzi alle Sezioni Unite. Il divieto di partecipare a pubbliche riunioni rientra tra le prescrizioni che il Tribunale della prevenzione deve applicare “in ogni caso” ovvero senza alcun margine di discrezionalità sull’an, in ossequio a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 8[1], la cui violazione è sanzionata penalmente dall’art. 75. Disposizione che, al comma 1, qualifica come contravvenzione l’infrazione posta in essere da un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale semplice e, al comma 2, come delitto, punito con la reclusione da 1 a 5 anni, la trasgressione realizzata da un soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.
Il collegio remittente, riprendendo le argomentazioni della sentenza De Tommaso, critica la formulazione della norma in esame non solo perché la stessa violerebbe il principio di legalità - in quanto il precetto sarebbe formulato in maniera ampia e vaga - ma anche alcuni suoi corollari quali sono il principio di offensività e proporzionalità.[2] Da una parte, infatti, affinché sia meritevole la sanzione irrogata, deve trattarsi di condotte che esprimano una effettiva volontà di ribellione nonché manifestino una totale vanificazione della misura irrogata. Dall’altra, invece, si evidenzia che l’applicazione di una imposizione estesa a tutti “in ogni caso” non sia in grado di rappresentare un valido canone di controllo sulle limitazioni dei diritti fondamentali.[3] Punctum dolens: la definizione del concetto di pubbliche riunioni. Secondo un orientamento minoritario, il divieto in questione va inteso nel senso di non prendere parte a qualsiasi riunione di più persone in luogo pubblico o aperto al pubblico al quale abbiano accesso un numero non determinato di persone indipendentemente dal tipo di riunione. Un ulteriore indirizzo, invece, sostiene che il rinvio espresso dall’art. 75, co. 2, alle prescrizioni afferenti alla sorveglianza speciale non possa ricomprendere il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, in virtù di una formulazione ampia e non univoca della suddetta nozione.
Il Collegio, sulla base delle suddette argomentazioni, ritiene di formulare il seguente quesito “se, ed in quali limiti la partecipazione del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad una manifestazione sportiva tenuta in luogo aperto al pubblico risulti fatto punibile in riferimento al reato di violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale di cui agli articoli 8 e 75 del codice Antimafia”.
2. Le Sezioni Unite sulla nozione di “pubbliche riunioni”: una lettura “tassativizzante” della prescrizione di cui all’ articolo 8, comma 4, in rapporto all’articolo 75 comma 2 del Codice Antimafia
Con informazione provvisoria pubblicata l’1 aprile 2019, il servizio novità della Suprema Corte comunica che, in esito alla pubblica udienza celebrata il 28 marzo 2019, le Sezioni Unite hanno risolto la questione in esame nei seguenti termini: “Negativa, in quanto l’articolo 8 Decreto Legislativo n. 159 del 2011 si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico”. La Corte di Cassazione, dopo aver, preliminarmente, richiamato le perplessità emerse in sede di rimessione, si interroga sulle tematiche affrontate dalla diverse pronunce che hanno trattato la materia de qua.
La prima afferisce al rispetto del principio di offensività e proporzionalità. Il richiamo è alla sentenza “Sinigaglia” che ha evidenziato come “possano essere punite soltanto quei comportamenti che costituiscano indice di una persistente pericolosità e non qualsiasi défaillance comportamentale”.[4]
Altra problematica riguarda la legittimità delle prescrizioni previste per il sorvegliato speciale alla luce della necessità di tutelate diritti costituzionalmente garantiti. Questione già affrontata dai Giudici di Strasburgo, nella nota sentenza De Tommaso, che hanno espresso preoccupazione per il fatto che “misure previste dalla legge comprendano l’assoluto divieto di partecipare a pubbliche riunioni”.[5] Dapprima viene richiamata la sentenza “Pellegrini” che ha ritenuto che il rinvio espresso nella disposizione di cui all’art. 75, co. 2, non potesse ricomprendere il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, stante l’indeterminatezza della suddetta formulazione e la conseguente mancanza di tassatività della fattispecie.[6]
Un ulteriore orientamento, espresso nella sentenza “Lo Giudice”, ha, invece, ribadito che il divieto, di cui all’art. 8, co. 2, riguardasse qualsiasi riunione di più persone in luogo pubblico o aperto al pubblico.[7]
Altro indirizzo ancora, invece, contenuto nella sentenza “Sassano”, ha affermato che il Giudice avesse l’obbligo di indicare le ragioni per cui la prescrizione de qua si renda necessaria in funzione di controllo della pericolosità sociale del prevenuto al fine di evitare compressioni generalizzate di una libertà costituzionale.[8]
Nessuna delle tre soluzioni viene integralmente accolta dalle Sezioni Unite. La Suprema Corte non ritiene convincenti le motivazioni espresse dalla pronuncia “Pellegrini”. La sentenza, infatti, non verifica la possibilità di individuare una nozione di pubblica riunione valida per tutte le norme che la contengano. La pronuncia suddetta disapplica un norma interna in contrasto con la CEDU. In questi casi, invece, avrebbe dovuto rivolgersi alla Consulta, organo giurisdizionale deputato alla dichiarazione di illegittimità della disposizione interna in contrasto con l’art. 117 della Costituzione di cui la CEDU costituisce parametro interposto. In altre parole, punto debole della soluzione “Pellegrini” è quello di aver adottato la medesima operazione tassativizzante sperimentata dalle Sezioni Unite Paternò in relazione ad una prescrizione del tutto diversa e fatta oggetto di una differente censura da parte della Corte Europea.[9] Mentre, infatti, gli obblighi di “vivere onestamente” e “di rispettare le leggi” non possono considerarsi vere e proprie prescrizioni aventi contenuto precettivo, non imponendo comportamenti specifici ma ammonimenti morali, valevoli per qualsiasi consociato; il divieto de quo rappresenta un comando specifico, rivolto solo a particolare tipi di individui, che è connesso alle finalità di prevenzione, in quanto la partecipazione alle pubbliche riunioni rende più difficile il controllo del prevenuto. Neppure convincente appare la soluzione espressa nella sentenza “Lo Giudice”. Il risultato di tale linea interpretativa, infatti, è una nozione ampia e non delimitata della prescrizione che lascia spazio alla discrezionalità del Giudice e, si legge, “si disinteressa del tema della conoscibilità della norma penale da parte del destinatario e della conseguente prevedibilità delle conseguenze della sua azione”.[10] Quanto all’orientamento formulato dalla sentenza “Sassano”, la Suprema Corte ritiene si tratti di una “soluzione forzata, non necessaria e superflua”.[11] Appare ragionevole, infatti, l’impiego della sanzione penale, in caso di violazione di quelle prescrizioni che, in quanto significative, siano applicate in ragione della pericolosità del Sorvegliato. Altresì, l’individuazione di una nozione condivisa di pubbliche riunioni permette di colpire, in ossequio al principio di offensività, solamente quelle condotte che possano elidere la sorveglianza del prevenuto.
Le Sezioni Unite accolgono una soluzione interpretativa che precisa gli spazi applicativi della prescrizione esaminanda. La norma cui fare riferimento è contenuta nell’art. 17 della Costituzione, come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza numero 27 del 5 maggio del 1959. In quell’occasione, la Consulta aveva affermato che l’art.17 Cost. consente il divieto delle pubbliche riunioni per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, in questo modo riconducendo la nozione di pubbliche riunioni all’ipotesi prevista dal terzo comma che fa riferimento alle riunioni in luogo pubblico.[12] L’assolutezza di questa affermazione, tuttavia, viene mitigata da quelle ipotesi “estreme”[13] in cui il precetto penale non possa ritenersi integrato, nonostante la partecipazione del prevenuto ad una pubblica riunione.[14]
Il sorvegliato, infatti, ben potrà chiedere al Tribunale l’autorizzazione a partecipare ad una riunione pubblica e, se chiamato a rispondere della sua violazione, avrà l’onere di dimostrare che la sua condotta sia stata inoffensiva. Non si tratta, si badi, di una probatio diabolica perché il tribunale potrà valutare i motivi giustificativi con gli accertamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria all’uopo delegata. In mancanza di allegazioni e prove concrete, non sembra vi sia spazio per il Giudice della prevenzione di ritenere la relativa condotta inoffensiva. La valutazione di quel comportamento, infatti, è stata già effettuata, ex ante, dal legislatore che ha ritenuto necessaria quella prescrizione al fine di limitare la pericolosità sociale del prevenuto. Tuttavia, l’Autorità Giudiziaria potrà ritenere giustificata quella stessa partecipazione se dall’analisi del caso concreto emerga la non offensività della violazione e la non meritevolezza della sanzione penale. Tale interpretazione, pur riducendo l’ambito applicativo della prescrizione esaminanda, escludendo, infatti, le riunioni in luogo aperto al pubblico, non indebolisce la misura di prevenzione irrogata. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, del Codice Antimafia, infatti, il Tribunale potrà imporre tutte “le prescrizioni che riterrà necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, sulla base di una motivazione adeguata che tenga conto delle esigenze del caso concreto”. Ben potrebbe, ad esempio, il Giudice vietare al prevenuto la partecipazione a qualsiasi riunioni o manifestazioni. In questo si sarebbe fatto entrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta.
Tale supposizione è, tuttavia, erronea.[15] Per prima cosa, non tiene in considerazione il fatto che, in ossequio al principio di tassatività e precisione, il Giudice non potrà utilizzare formule vaghe e indeterminate che riproporrebbero tutte le problematiche che la giurisprudenza ha, di volta in volta, risolto.[16] L’Autorità Giudiziaria, altresì, dovrà individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che impongono al soggetto controllato ulteriori obblighi o divieti al fine di contenere le pulsioni antisociali del prevenuto. Tali prescrizioni, infatti, dovendo essere adottate in contraddittorio tra le parti, dovranno garantire non solo una scelta equilibrata del Tribunale chiamato a pronunciarsi ma anche l’imposizione di obblighi o divieti “personalizzati” e “individualizzati” alla pericolosità del proposto.
In definitiva, il principio di diritto che deve essere affermato è il seguente “la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 8, comma 4, Decreto Legislativo nr. 159 del 2011, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico”.
3. Possibili soluzioni interpretative: de jure condendo
Dalla pronuncia in commento possono farsi alcune considerazioni che avrebbero suggerito ai Giudici una soluzione diversa sul piano metodologico.[17] Per un verso, se la disposizione controversa fosse stata rispondente ai canoni di precisione e determinatezza ma foriera di interpretazioni tra loro contrastanti, sarebbe stato più corretto rivolgersi ai Giudici della nomofilachia per dipanare il contrasto. Dall’altra, invece, nel caso in cui gli Ermellini avessero dubitato del rispetto della norma ai parametri di precisione, offensività e proporzionalità sarebbe stato utile rivolgersi alla Corte Costituzionale affinché ne dichiarasse la illegittimità per contrasto al principio di legalità.[18]
L’ordinanza di rimessione, pur evidenziando delle criticità sulla formulazione della disposizione esaminanda, sceglie di adire il Supremo Consesso della Cassazione piuttosto che la Consulta. La via della questione di legittimità costituzionale, invece, sarebbe stata preferibile in ragione della vicenda, del tutto sovrapponibile, che ha riguardato le prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare la legge”. In quel caso, le Sezioni Unite[19] avevano optato per una interpretazione convenzionalmente conforme alla CEDU attraverso l’eliminazione, in via ermeneutica, dall’area del penalmente rilevante, delle due ipotesi che, nonostante fossero ricomprese nel tenore letterale della disposizione di cui all’art. 75, co. 2, risultavano estranee ai principi immanenti al diritto penale. Il precetto penale, ex art. 75 co. 2, risultava, pertanto, essere stato abrogato parzialmente, seppur in via interpretativa, nella parte in cui prevedeva potesse costituire reato la violazione delle prescrizioni suddette.[20] Il 26 ottobre 2017, tuttavia, la seconda sezione penale ha sollevato questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la normativa che era stata già esaminata, pochi mesi addietro, dalle Sezioni Unite.[21] La scelta della rimessione della eadem quaestio alla Consulta risulta giustificata dal fatto che solo una pronuncia di illegittimità potesse assicurare una adeguata garanzia sia nei confronti di coloro che sono stati già condannati in ragione della violazione dei suddetti obblighi sia per orientare, in funzione generalpreventiva, le condotte dei consociati senza timore di doversi difendere da un ulteriore revirement giurisprudenziale.
L’orientamento espresso dalla Suprema Corte rappresenta pur sempre una interpretazione giurisprudenziale che è estranea ai meccanismi che regolano la successione delle leggi penali del tempo, di cui all’articolo 2 cod. pen.[22] Una pronuncia di illegittimità, invece, non solo avrebbe effetti erga omnes ma anche eliminerebbe una disposizione che, in contrasto con i principi della nostra Carta fondamentale, non potrebbe essere più applicata. In altre parole, un conto è una sentenza che riforma quella impugnata per un sopravvenuto ius supervenies suscettibile però di mutare nel corso del tempo con effetti inter partes; altro è una pronuncia del Giudice delle leggi che, in virtù di quanto specificato dall’articolo 136 della Costituzione, cancella dal nostro ordinamento una disposizione affetta da invalidità genetica.
Nel caso di specie, le Sezioni Unite, ma ancora prima i giudici remittenti, avrebbero potuto sollevare questione di illegittimità costituzionale dell’art. 75, co. 2, in combinato disposto con l’art. 8 comma 4, per violazione degli artt. 25 e 117 alla luce dell’art. 2 del relativo Protocollo numero 4.[23]
Sulla scia della pronuncia Paternò, in alternativa, il Collegio avrebbe potuto formulare una interpretazione “abrogante” (la cosiddetta interpretatio abrogans) il comma 2 dell’art. 75 nella parte in cui punisce il sorvegliato speciale che violi la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni. Il precetto de quo, infatti, viziato da eccessiva genericità, non potrebbe essere preso in considerazione dall’Autorità Giudiziaria per una eventuale condanna.[24] La strada intrapresa, invece, è stata quella di formulare una interpretazione “tassativizzante”, id est, mantenere salva l’applicazione del divieto ma precisarlo al fine di renderlo compatibile con il principio di conoscibilità del precetto penale.
È compito ineludibile del giudice, infatti, quello di interpretare le locuzioni ampie e polisenso alla luce del contesto normativo in cui sono inserite. L’utilizzo di tali espressioni generali, infatti, “non comporta un vulnus del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca – di stabilire il significato di tale elemento mediante un’operazione interpretativa non esorbitante l’ordinario compito a lui affidato”[25]. La norma così applicata dal giudice, infatti, non è destinata, semplicemente, a fornire il criterio di giudizio per il caso concreto sottoposto alla sua attenzione ma si candida ad operare come possibile parametro di decisione per analoghi casi futuri. Molto efficacemente, “ogni giudice (…) non ricerca soltanto la soluzione avvertita come “giusta” nel caso concreto, ma è ben cosciente della necessità di fondare la decisione su un criterio –una regola– pensata già in origine come generalizzabile a tutti i casi futuri che presenteranno analoghe caratteristiche.[26]
Secondo diversa dottrina invece, l’opzione preferibile sarebbe stata quella di interrogare la Consulta e ciò per due ragioni.[27] In primo luogo perché il legislatore costituente, nel collegare la disciplina della libertà delle riunioni al luogo del loro svolgimento, avrebbe esplicitamente scartato la dicotomia “riunioni pubbliche-riunioni private”, in quanto non sufficientemente univoca (sulla base di tale distinzione, infatti, potrebbe considerarsi pubblica, ad es., anche una riunione in luogo privato composta da un gran numero di partecipanti, ovvero una riunione avente per oggetto tematiche di interesse pubblico); dall’altro, la stessa Corte di Strasburgo sembra aver posto l’accento, nel passo della sentenza De Tommaso poco sopra riportato, sul difetto di determinatezza e, dunque, sulla scarsa prevedibilità della prescrizione e della norma incriminatrice, più che sull’ampiezza dell’orizzonte semantico della locuzione in discorso: il che comporta una problematica compatibilità della prescrizione in parola con il principio di legalità convenzionale.
4. E dopo…Corte di Cassazione, sezione prima penale, 16 febbraio 2021 nr. 6089, Presidente Casa, relatore Renoldi
L’indirizzo ermeneutico scelto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come fino ad ora esposto, è stato seguito da una più recente pronuncia. Il ricorrente era stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Bergamo, per rispondere del reato di cui al D. lgs. 159/11, art. 75, co. 1, per avere partecipato ad una presentazione della sua squadra di calcio, violando il divieto di presenziare a pubbliche riunioni impostogli con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, emesso dallo stesso Tribunale in data 11/2/2016, per la durata di un anno e sei mesi. Con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 11/1/2019, fu però assolto da tale imputazione, con la formula “perché’ il fatto non sussiste”.
Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo, al contrario che he la nozione di partecipazione a pubbliche riunioni risultasse chiara tanto nel riferimento al contesto (“pubbliche”) quanto nell’oggetto (“riunioni”), facendo essa rinvio a qualsiasi situazione in cui possa intervenire un numero elevato e indeterminato di persone, tale da rendere più difficile il controllo dei presenti e più agevole la commissione di reati. La Corte di Cassazione ritiene il ricorso infondato e richiama le argomentazioni contenute dal supremo consesso della corte di legittimità. “Le Sezioni unite hanno precisato che la suddetta prescrizione si riferisce esclusivamente alle riunioni “in luogo pubblico”, con la conseguente esclusione delle riunioni in luoghi “aperti al pubblico”, come, ad esempio, le manifestazioni sportive in luoghi come gli stadi o i palasport, rispetto alle quali, come è stato nel frangente osservato, vige la autonoma normativa dettata dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, che contempla anche la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive”.[28] Nel caso qui in rilievo lo stadio nel quale si svolgeva l’incontro di presentazione della squadra di calcio doveva essere qualificato come “luogo aperto al pubblico” e, pertanto, non si realizzavano gli elementi oggettivi della violazione di cui all’art.75 del Codice Antimafia.
5. Breve conclusione rebus sic stantibus
In conclusione, si può affermare che le Sezioni Unite abbiano dipanato un contrasto giurisprudenziale tra le corti e che tale impostazione sia stata, al momento, seguita dalle pronunce successive.
È indubbio che la soluzione accolta dalle Sezioni Unite garantisca maggiormente la posizione del sorvegliato speciale in ordine a eventuali ingiustificate limitazioni della sua libertà di movimento poco chiare e prevedibili. In questo senso, il proposto non potrà mai prendere parte a riunioni in luogo pubblico, salvo in quelle ipotesi estreme già viste, mentre potrà partecipare a quelle aperte al pubblico, a meno che il giudice lo vieti espressamente in ragione della pericolosità e delle caratteristiche personologiche del proposto.
[1] Cfr. “In ogni caso, (il Tribunale) prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni”.
[2] Cfr. La sentenza De Tommaso vs Italia emessa dalla Corte EDU il 23 febbraio 2017 ha duramente criticato la formulazione delle disposizioni contenute nel Codice Antimafia I Giudici di Strasburgo affermano che “la loi n. 1423/1956 -la cui disciplina è stata trasposta nel D. lgs 159/2011- ètait libellèe des termes vagues et excessivement gènèraux (…) ni le contenu de certaines de ces mesures n’ètaient dèfinis avec une prècision et une clartè suffisantes, §104-105.
[3] La prescrizione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni è stata più volte oggetto di attenzione della Corte Costituzionale. In particolare, con sentenza 27 del 18 febbraio 1959, la Consulta ne ha affermato la compatibilità con gli artt.2 e 17 della Costituzione dalla quale sarebbe ricavabile un principio di prevenzione e sicurezza sociale. Con sentenza 126 del 21 aprile 1983, ancora, si è ritenuto insussistente il contrasto tra l’imposizione de qua e gli articoli 21 e 49 della Costituzione in quanto, seppur vero che il divieto suddetto possa comportare un’ ingiustificata ingerenza su diritti costituzionalmente garantiti al prevenuto, tale limitazione sarebbe addebitale non già alla previsione legale nella sua astratta formulazione ma alla sua concreta applicazione. Spetterebbe al Giudice, infatti, determinare i concreti elementi di fatto che concorrono, di volta in volta, a realizzare la fattispecie penale di trasgressione agli obblighi della sorveglianza speciale.
[4] Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, numero 32923 del 2014. La vicenda riguardava la violazione della prescrizione di cui all’articolo 8 comma 7 da parte del sorvegliato speciale di portare con sé la carta di permanenza, p. 15. Più approfonditamente, si rinvia a M.C. UBIALI, Le sezioni unite sulla violazione dell’obbligo, per il sorvegliato speciale, di esibire la carta di permanenza, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 18 settembre 2014.
[5] Cfr. § 123 e 124. La Corte EDU, si legge, altresì, “è anche preoccupata (…) che la legge non specifica alcun limite temporale o spaziale di questa libertà fondamentale, la cui restrizione è lasciata interamente alla discrezionalità del Giudice”. Come indicato, tuttavia, dalla sentenza in commento, si tratta di un accenno poco chiaro. Il Tribunale, infatti, né ha la discrezionalità di modulare il divieto di partecipare a pubbliche riunione né sono necessari ulteriori specificazioni per l’applicazione della prescrizioni suddetta da parte del Giudice, p.8.
[6] Cfr. Corte di Cassazione, sezione Prima penale, numero 31322 del 09 aprile 2018.
[7] Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, numero 28261 del 08 maggio 2018.
[8] Cfr. Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, numero 49731 del 06 giugno 2018.
[9] Così S. FINOCCHIARO, Le Sezioni Unite sul reato di trasgressione al divieto di partecipare a pubbliche riunioni imposto con la misura di prevenzione della Sorveglianza speciale (art. 75 codice antimafia), in www.sistemapenale.it, p.5
[10] §16, p.18.
[11] §17, p.19.
[12] L’articolo 17 della Costituzione prevede che “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”. Per riunione in luogo privato si deve intendere quella che si svolge in uno spazio fisico delimitato, fra persone determinate che vi accedano in forza della loro ammissione da parte di chi legalmente dispone del luogo; Per riunione in luogo aperto al pubblico deve intendersi quella che si svolge in uno spazio delimitato cui possa accedere chiunque, liberamente o condizionatamente, secondo la volontà del soggetto che legalmente dispone del luogo; riunione in luogo pubblico, ovvero quella che si svolge in uno spazio accessibile da chiunque e destinato, di diritto o di fatto, al pubblico uso.
[13] Cfr. § 17, p. 19
[14] Così S. FINOCCHIARO, Le Sezioni Unite sul reato di trasgressione al divieto di partecipare a pubbliche riunioni imposto con la misura di prevenzione della Sorveglianza speciale (art. 75 codice antimafia), cit., p. 7.
[15] Alcuni autori hanno rilevato un profilo di contraddizione laddove le Sezioni Unite, dopo aver limitato il concetto di pubbliche riunioni alle sole riunioni in luogo pubblico, ammettono che il giudice, attraverso la clausola di cui all’art.8, co. 5, possa vietare al sorvegliato speciale, alla luce delle circostanze del caso concreto, di prendere parte ad assembramenti che si svolgono in luogo aperto al pubblico. Delle due l’una: o l’art.17 Cost. consente di comprimere in via preventiva la libertà di riunione solo qualora essa sia esercitata in luogo pubblico e allora non sembra possibile utilizzare lo strumento delle prescrizioni discrezionali per limitare tale diritto quando le riunioni si tengano in luoghi diversi, oppure dalla suddetta norma costituzionale non è possibile ricavare una tutela così intensa del diritto di riunione, ed allora limitazioni ulteriori rispetto a quelle costituzionalmente previste-ad esempio attraverso l’art.8, co.5, Cod. Ant.- sono ammissibili in E. ZUFFADA, Per le sezioni unite il divieto di partecipare a pubbliche riunioni imposto al sorvegliato speciale è da considerarsi limitato alle sole riunioni “in luogo pubblico”, 05.12.2021, in www.dirittopenaleuomo.it, p.7
[16] Il Giudice non potrebbe vietare al sorvegliato speciale la partecipazione alle riunione in luogo pubblico e ad “altre manifestazioni”. Quest’ultima risulterebbe una espressione vuota che accentuerebbe la discrezionalità del Giudice nel valutare la violazione del divieto nel caso concreto, in barba ai principi di tassatività e legalità.
[17] E. ZUFFADA, Alle Sezioni Unite un nuova questione relativa alla configurabilità del reato di cui all’ art.75 Cod. Antimafia, questa volta in caso di trasgressione del divieto di partecipare a pubbliche riunione, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 6 marzo 2019, pp. 5 ss.
[18] In virtù di quanto previsto dall’articolo 25, infatti, le pene devono essere irrogate sulla base di criteri che devono tenere conto non solo della riserva di legge ma anche della tassatività e determinatezza delle fattispecie criminose. La volontà del legislatore, pertanto, deve esprimersi in maniera chiara e univoca al fine di permettere non solo ai singoli di comprendere quali siano le condotte lecite da quelle non ammesse ma anche di evitare che l’Autorità Giurisdizionale possa utilizzare la sua attività discrezionale nell’interpretare, in modo arbitrario, la legge penale.
[19] Cfr. Cassazione Sezioni Unite 40076 del 27 aprile 2017 “Paternò”
[20] Per un approfondimento della questione si rinvia a G. BIONDI, Le Sezioni Unite Paternò e le ricadute della sentenza Corte EDU De Tommaso c. Italia sul delitto ex art.75, comma 2, D. Lgs n. 159/2011: luci ed ombre di una sentenza attesa, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 10/2017, pp.165 ss. e F. VIGANO’, Le Sezioni Unite ridisegnano i confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De Tommaso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, settembre 2017, pp. 146 ss.
[21] F. VIGANÒ, Ancora sull’indeterminatezza delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione: la seconda sezione della Cassazione chiama in causa la Corte Costituzionale, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 10/2017, pp. 272 ss.
[22] È bene precisare, per completezza che, negli ordinamenti di civil law, come il nostro, non vige la regola dello stare decisis, in forza del quale l’Autorità Giudicante è obbligata a conformarsi alla decisione adottata in una precedente pronuncia, nel caso in cui la fattispecie portata al suo esame sia identica a quella già trattata nel caso in essa deciso. Ciò comporta che, i Giudici, essendo soggetti solo alla legge ed essendo liberi nella valutazione delle prove e degli argomenti di prova prodotti dalle parti in corso di causa, possano discostarsi da un precedente orientamento interpretativo. Un caso, invero, in cui sarebbero obbligati ad aderire al principio di diritto sotteso è previsto dall’articolo 627 cod. proc. pen., così formulato “Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.”
[23] Paradossalmente sarebbe questo il suggerimento offerto dal collegio della prima sezione penale in sede di rimessione. Questi, infatti, affermano che “il raggiungimento di un assetto applicativo rispettoso di determinati canoni, più in particolare di correlazione individualizzata tra la prescrizione imposta e la pericolosità manifestata dal soggetto nel rispetto del canone di proporzionalità delle limitazioni delle facoltà costituzionalmente protette, potrebbe essere estraneo ai contenuti di una mera operazione nomofilattica ma ciò non toglie che simile opzione vada rimessa alle valutazioni dell’organo di risoluzione del conflitto interpretativo”, p. 7. In altre parole, Il Collegio rimettente avverte una ipotesi di legittimità costituzionale ma lascia alle Sezioni Unite decidere se sia o meno opportuno interpellare la Corte Costituzionale.
[24] Va precisato che le Sezioni Unite Paternò avevano escluso che la violazione delle prescrizioni sottoposte alla loro attenzione potessero integrare il precetto penale ma le stesse, però, potevano rilevare in sede di aggravamento della misura, ex art. 11 comma 2 Codice Antimafia.
[25] Così Corte Cost., sent. 7-23 luglio 2010, n. 282, in Giur. cost., 2010, pp. 3535 ss., con nota di A. TESAURO, Corte costituzionale e sorveglianza speciale: una breve analisi filosofico-giuridica tra uguaglianza e ragionevolezza.
[26] F. VIGANÒ, Il diritto giurisprudenziale nella prospettiva della Corte costituzionale, in Sistema penale, 19 gennaio 2021, p. 2.
[27] E. ZUFFADA, Per le sezioni unite il divieto di partecipare a pubbliche riunioni imposto al sorvegliato speciale è da considerarsi limitato alle sole riunioni “in luogo pubblico”, cit., p. 7
[28] § 4.

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
