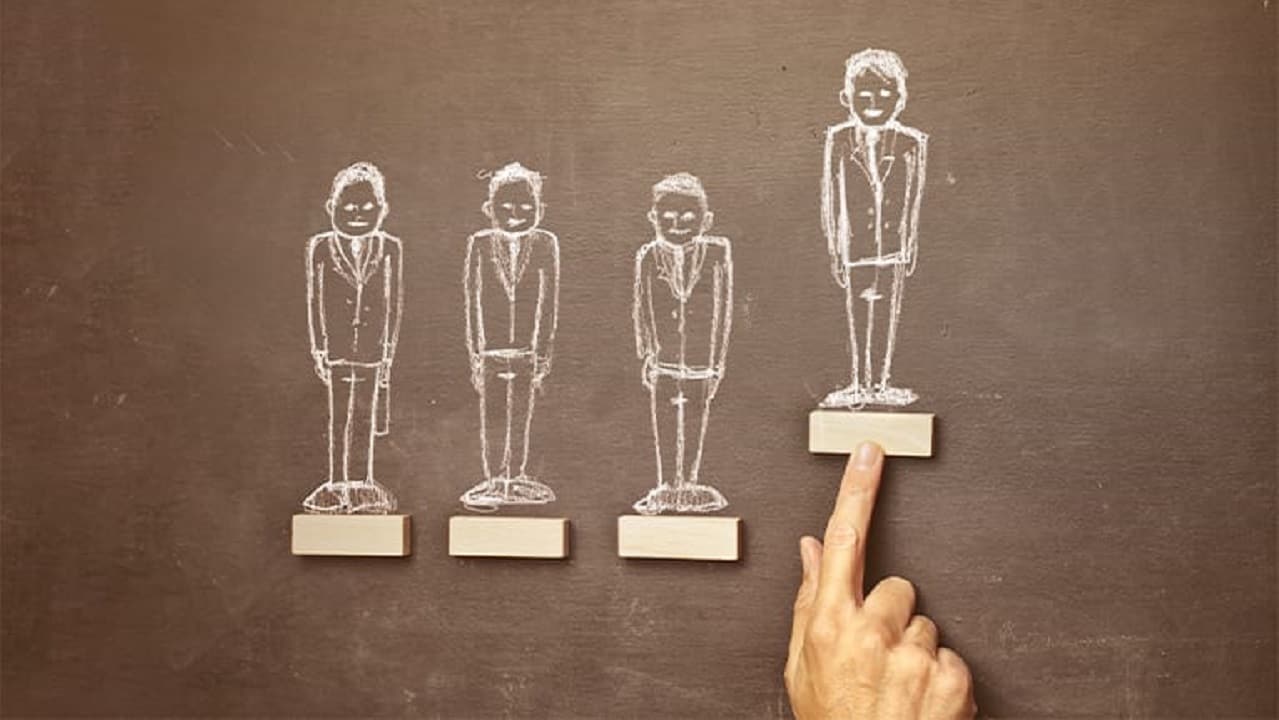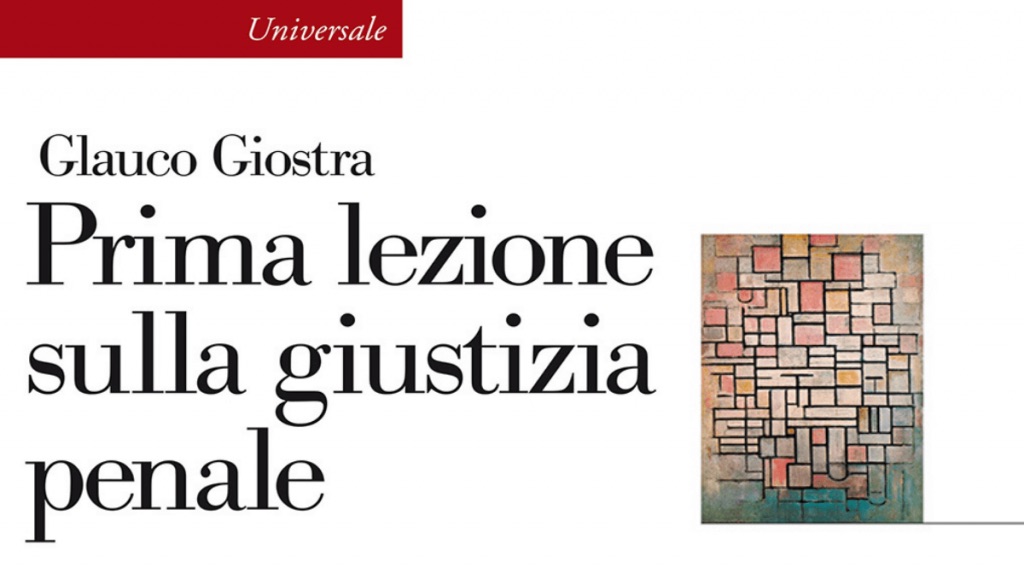
Giudicare: un compito necessario e impossibile a un tempo
Recensione a Glauco Giostra, Prima lezione sulla giustizia penale, II ed. Laterza, Bari-Roma 2025, pp.208.
Sommario. 1. Processo penale: uno stretto ponte tibetano - 2. Contraddittorio e ricerca della verità - 3. Le strutture portanti dell’attuale processo penale - 4. Processo penale e comunicazione - 5. La separazione delle carriere - 6. Questa nostra giustizia imperfetta.
1. Processo penale: uno stretto ponte tibetano.
“Giudicare: un compito necessario e impossibile a un tempo. Necessario, soprattutto quando abbiamo a che fare con fatti di reato, perché una società non può lasciare privi di conseguenze comportamenti incompatibili con la sua ordinata sopravvivenza. Impossibile, perché non siamo in grado di conoscere la verità. O, meglio, non possiamo mai avere la certezza di averla conseguita.” Incipit della nuova edizione ampliata e aggiornata della “Prima lezione sulla giustizia penale” di Glauco Giostra, professore emerito di procedura penale presso l’Università la Sapienza di Roma. L’A. ripropone l’immagine del processo “come uno stretto ponte tibetano… Affinché abbia tenuta sociale è necessario che la collettività riconosca che lo stesso costituisce la via meno imperfetta e per cercare di attingere la verità nel contesto storico, culturale e scientifico in cui è chiamato ad operare: soltanto così il prodotto finale, la sentenza, si rende eticamente accettabile socialmente accettato, nonostante la sua insopprimibile fallibilità.” L’intento di dirigersi anche a lettori non giuristi è raggiunto grazie alla chiarezza dell’esposizione, nonché al Glossario, cui nel testo si fa rimando quando compaia un indispensabile termine specialistico. Le duecento pagine del volumetto sono ricchissime di spunti di approfondimento per chi abbia già avuto modo, come studioso o pratico, di confrontarsi con le tematiche del processo. Troviamo analisi accurate, anche prese di posizione nette, ma proposte sempre all’esito di un esame degli argomenti pro e contro; mai scorciatoie argomentative o posizioni “assolutiste”.
Subito un esempio: “la condizione di terzietà del giudice è un elemento necessario, ma non sufficiente per avere la certezza che possa assolvere la sua funzione con neutrale obbiettività. Ogni persona investita del titanico compito del giudicare ha un vissuto, un patrimonio culturale e un assetto emotivo che fatalmente ne influenzano le capacità di percepire, di valutare e di decidere.” (p.5).
Il nucleo centrale della riflessione dell’A. è nella parte intitolata “Il volto costituzionale della nostra giustizia penale”. La svolta è avvenuta con il codice di procedura penale del 1989:” Il tempo del ‘più informazioni si hanno, meglio si decide ‘, doveva lasciare il posto ad un ‘meglio si decide, quando le informazioni sono assunte con un metodo che ne garantisca l'affidabilità’ ” (p.41). Dieci anni dopo, superate resistenze e passi indietro, le regole del giusto processo vengono fissate “con la riscrittura dell'articolo 111 Costituzione, peraltro di assai discutibile fattura tecnica.” (p.44)
Dopo la netta presa di posizione: “Il contraddittorio costituisce uno strumento, ancor oggi il meno imperfetto, per la ricerca della verità o meglio per ridurre il più possibile lo scarto fra verità giudiziale e verità storica” (p.45-46), l’A. mette in guardia contro ogni “sorta di rappresentazione ‘agiografica’ del nostro sistema processuale: avere consapevolezza critica dei suoi limiti può servire al legislatore e all'interprete almeno per contenerne le conseguenze.” (p. 50). Infatti “Il processo penale costituisce l'ambito giurisdizionale in cui il contraddittorio risulta di più necessaria, ma anche di più difficile realizzazione.” (p.55) Non si sottace la difficoltà di assicurare la cosiddetta “parità delle armi” tra accusa e difesa: “A differenza di quanto accade nel processo civile, in cui i contendenti disputano per l'affermazione dei propri speculari interessi, nel processo penale abbiamo un soggetto privato che difende la sua libertà e la sua reputazione e un soggetto pubblico che non ha interessi in senso proprio a limitare la prima e a macchiare la seconda, ma che deve accertare con obiettività l'esistenza di un fatto penalmente rilevante e individuarne il responsabile.”( p.56)
Richiamata l’imparzialità istituzionale del Pm, l’A. avverte quanto però operi la “legge psicologica dell'inerzia” (Cesare Musatti): “L'organo inquirente formula un'ipotesi per cercare la verità, ma sovente finisce per cercare la verità della sua ipotesi. Ha un'attenzione selettiva, una visione monoculare, parziale della realtà. In questi ineludibili termini il pubblico ministero è parte.” (p. 68). Non giova eludere le differenze: “Il legislatore ordinario è chiamato quindi ad un compito molto difficile: non deve puntare ad un'impossibile uguaglianza delle parti, attesa la congenita asimmetria strutturale del rito penale, ma deve costruire un sistema in cui l'accusa e la difesa abbiano equivalenti opportunità di influire sul convincimento giudiziale e quindi sull'esito finale del processo.” (p.69).
2. Contraddittorio e ricerca della verità.
Di qui la particolare attenzione al contraddittorio nella formazione della prova. Sottolinea l’A. che il contraddittorio trova la sua massima espressione quando sono assicurate l’oralità e la contestualità del confronto. La pratica, peraltro, ci insegna quanto i tempi lunghi dei dibattimenti finiscano per mettere in crisi questi principi. Quando i giudici (togati e popolari) si ritirano in camera di consiglio per la decisione a conclusione di un dibattimento durato mesi, se non anni, il ricordo dell’assunzione orale della prova è soppiantato dalla rilettura del verbale di quella udienza. Il principio della ragionevole durata del processo è sì un diritto dell’imputato, ma anche garanzia di un processo giusto, che si fondi sull’effettività dei principi del contraddittorio e dell’oralità.
Sul tema della verità l’A. ritorna in più passaggi: “Tra le tante verità possibili quella espressa dal processo costituisce la migliore verità che una società è in grado di darsi nel rispetto dei diritti dei suoi consociati.” (p. 10). Ma vi sono limiti alla ricerca della verità: limiti valoriali (non solo la tortura, ma “l’ordinamento ripudia il ricorso a metodiche lesive della dignità umana, anche ove utili all’accertamento della verità” p. 17) e limiti epistemologici (“connaturati alla fallibilità dei nostri strumenti di conoscenza” p.21). Limiti, ma contraddittorio come lo strumento meno imperfetto “per la ricerca della verità”.
L’A. senza neppure citarle liquida così le teorie del processo come “gioco di parti”, indifferente allo scopo purché siano rispettate le “regole del gioco”. Si è già citata la immagine del processo come stretto ponte tibetano: “la via meno imperfetta per cercare di attingere la verità”.
Non mancano coloro che, in omaggio ad una mitica purezza del modello accusatorio, fanno proprie teorie che, pur presenti tra autori americani, sono ormai da tempo abbandonate in quella Inghilterra che è pur sempre la patria del processo adversary. A far giustizia di sbrigative posizioni giova una citazione da un testo del 2001 di Lord Justice Auld (all’epoca presidente di una Royal Commission sulla riforma del processo penale inglese): “Il processo penale non è un gioco. È la ricerca della verità secondo la legge, attraverso una procedura accusatoria nella quale l’accusa deve provare la colpevolezza secondo uno standard particolarmente elevato”.[1]
Qualche anno fa Mireille Delmas Marty scriveva: “In effetti, se l’esercizio del dubbio fonda l’etica del giudice penale, è perché il riferimento alla verità, ed alle incertezze che inevitabilmente l’accompagnano, resta al centro della giustizia penale”.[2]
Una volta riaffermato che la “verità processuale” non può essere la verità assoluta[3], possono essere severamente liquidate, come osserva Paolo Ferrua, le semplificazioni: “Si è diffusa una dannosa tendenza a concepire il processo accusatorio come pura soluzione di conflitti tra le parti, dominato da una esasperata disponibilità della prova, da una logica di laissez faire, pronta a sacrificare le esigenze di giustizia sostanziale».[4]
Uno studioso inglese, John Spencer, professore all’Università di Cambridge e profondo conoscitore dei sistemi continentali, affrontando il problema delle regole probatorie nel processo penale nel confronto tra sistemi di tradizione accusatoria e di tradizione inquisitoria, si chiedeva se si potessero ravvisare segni di avvicinamento. “A prima vista la risposta è: ‘no, il fossato si allarga’ […]. Questa visuale, tuttavia è ingannevole. Malgrado certe differenze evidenti e talora profonde, ciascuno dei due gruppi ha già fatto proprie, in parte, idee dell’altro, più razionali e più civili […]. Soprattutto, però, contrariamente a quanto talora si sente, i due gruppi sono unanimi su ciò che è per ciascuno lo scopo essenziale delle regole probatorie: dappertutto è l’accertamento della verità.”[5]
John Spencer riporta a sostegno l’osservazione di un celebre giudice inglese, Lord Denning: “Neppure in Inghilterra il giudice è semplicemente un arbitro chiamato a rispondere alla domanda How’s that? che è l’espressione tradizionale del giocatore di cricket che crede di avere segnato un punto e chiede all’arbitro di dargliene conferma”. Peraltro anche nell’accusatorio in declinazione Usa dove il giudice nel processo con giuria avrebbe un ruolo di mere umpire (mero arbitro) non mancano temperamenti. Anche se esercitata con molta parsimonia il giudice ha la facoltà di convocare un teste per interrogarlo personalmente e può rivolgere domande a quelli convocati dalle parti.[6] Si consideri il rilevante ruolo del giudice nell’ammettere o escludere prove. Inoltre, a conclusione del dibattimento,” il giudice impartisce le instructions alla jury, rendendola edotta delle norme sostanziali, processuali e probatorie applicabili e sul significato dello standard di prova a cui deve attenersi nel decidere.”[7]
Secondo il nostro A. quello dei poteri da conferire al giudice è “uno dei passaggi più delicati e più stretti del nostro ‘ponte tibetano’ […] È un problema delicatissimo di bilanciamenti, di dosaggio. Inaccettabili le soluzioni estreme. Sia quella che vorrebbe il giudice passivo spettatore, sia quella che ne vorrebbe fare l'attore protagonista. Anche in questo caso, bisogna tener presente che dialettica tra le parti e imparzialità del giudice sono mezzi, non fini: è quindi bene prevederne temperamenti quando ciò, per esperienza e per logica, risulta utile al perseguimento della verità. In tal senso si è opportunamente orientato il nostro legislatore, che riconosce al giudice poteri di intervento di ufficio, ma soltanto a carattere residuale (anche nel senso di successivo alle iniziative delle parti) e comunque con un invalicabile confine: il giudice non può mai formulare, neppure parzialmente, l’accusa, né gestire l'istruzione dibattimentale secondo una propria ipotesi di ricostruzione dei fatti.” (pp.141-142)
3. Le strutture portanti dell’attuale processo penale.
La parte III è dedicata alla ricognizione delle “Strutture portanti dell’attuale processo penale”, segnalando le innovazioni più recenti. Oggi, sulla richiesta del Pm di applicare una misura cautelare, decide il Gip come giudice singolo; con legge del 2024 si è previsto un Gip collegiale. L’entrata in vigore della riforma è stata rinviata di due anni, ma si può sin da ora prevedere che formare questo collegio di tre giudici sarà possibile, e con difficoltà, solo nei grandi Tribunali metropolitani, una dozzina in tutta Italia. Per il resto si dovrebbe provvedere con magistrati applicati ad hoc, magari provenienti dal settore civile, con una serie di ricadute negative a livello organizzativo.
Una recentissima modifica ha introdotto la figura dell'interrogatorio anticipato per garantire un confronto preventivo tra accusa e difesa dinanzi al giudice prima che questi si pronunci sull'emissione del provvedimento cautelare. Anche qui ottimo proposito, ma di difficile praticabilità, soprattutto perché calibrato su indagini con un solo indagato, mentre nella realtà normalmente gli indagati sono diversi.
Ancora una innovazione di grande interesse: la “giustizia riparativa”, ma, avverte l’A. come sia “impervia la difficoltà di disciplinare le interazioni tra il percorso di giustizia riparativa e il processo penale. Abbiamo a che fare infatti con due mondi che hanno grammatica e sintassi più che diverse opposte” (p.170).
4. Processo penale e comunicazione
La parte IV è dedicata alla narrazione della giustizia penale. La posizione dell’A. è netta. “Ogni ordinamento moderno è alla difficile ricerca di un punto di equilibrio ottimale tra le esigenze dell'informazione, della giustizia e della riservatezza individuale. A me sembra che quello espresso dal nostro sia largamente insoddisfacente: mal tutelate le prime, iperprotettive le seconde, garantite random le ultime” (p.174). Un’accurata trattazione è dedicata a tutte le problematiche coinvolte e non poteva essere altrimenti, data la costante attenzione dell’A. a questa tematica a partire dal pionieristico studio del 1989 “Processo penale e informazione”. Vale la pena, dunque, di riprendere diversi illuminanti passaggi.
La “giustizia è amministrata in nome del popolo” (art. 101 co. 1 Cost): dunque informazione sul modo con il quale viene resa giustizia, quale controllo e fonte di legittimazione. “Un controllo sociale inteso non certo ad approvare o a contestare la singola decisione, bensì a verificare se la collettività si riconosce nelle vigenti regole della iurisdictio o se ritiene necessario darsene di diverse, qualora il metodo, le controindicazioni e i risultati non corrispondessero più alla sua mutata sensibilità.” (pp. 171-172).
Durante la fase delle indagini preliminari” vi è la necessità di garantire altri interessi confliggenti non meno meritevoli di tutela. [..] La difficoltà per il legislatore è riuscire a tutelare la riservatezza delle indagini senza prolungare il black out informativo oltre il necessario, arrecando ingiustificato pregiudizio al diritto della collettività ad essere informata; nonché, realisticamente, determinando una decrescente tenuta del divieto di pubblicazione.” (pp.172-173). Quanto alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, l’A. liquida diffuse quanto infondate polemiche. “È bene fare a riguardo una precisazione. Solitamente si dice che va tutelata la riservatezza dei soggetti estranei al processo: a me sembra che il discrimine non debba intercorrere tra soggetti, bensì tra atti rilevanti e atti irrilevanti per il processo. Rispetto ai primi, che riguardino imputato, persona offesa o soggetti terzi, deve prevalere sempre l'interesse pubblico alla conoscenza; rispetto ai secondi, invece, dovrebbe sempre prevalere l'interesse alla tutela della riservatezza della persona, a prescindere dal suo rapporto con il procedimento.” (p.173).
Un argomento portato a sostegno dei limiti alla pubblicabilità degli atti non più segreti è quello della tutela della cosiddetta verginità cognitiva del giudice. Di questi atti è consentita la pubblicabilità del solo contenuto, ma non del testo né integralmente né parzialmente. “Si ritiene che il convincimento del giudice possa subire qualche condizionamento dalla riproduzione letterale dell'atto, mentre resterebbe impermeabile al suo riassunto giornalistico. Da un punto di vista teorico siffatto ragionamento regge, ma la realtà induce a riflessioni un po’ più pragmatiche. […] appare improbabile che in un domani lontano, tra anni, il giudice sia condizionato dalla pubblicazione, oggi, di un atto non segreto, quando ancora ignora se quel procedimento sarà archiviato, se verrà instaurato un rito speciale, se la competenza potrà essere sua.” (p.175-176) Anche su questo tema la conclusione dell’A. è netta:” Insomma, questo divieto di pubblicare in tutto in parte un atto non segreto sembra una barriera di cartapesta, che, senza giovare alla giustizia, fa male alla cronaca giudiziaria. Sarebbe opportuno quindi abbandonare questa tartufesca distinzione atto /contenuto e fare affidamento su un giudice che sappia distinguere tra la conoscenza psicologica e quella giuridica, utilizzando soltanto quest'ultima per le sue decisioni, l'unica peraltro utilizzabile per motivarle” (p.176).
Una questione delicata si pone: “quando la notizia rimasta impigliata nella rete a strascico dell'inchiesta penale, pur processualmente irrilevante, sia di pubblico interesse: di pubblico interesse, si ribadisce, e non di mero interesse del pubblico”. L’A. cita la famosa sentenza Dupuis contro Francia (Corte Edu 12 novembre 2007) e in quella linea conclude: “Le notizie rilevanti per il processo, ancorché lesive della reputazione o della privacy, dovrebbero essere sempre conoscibili e divulgabili dal giornalista: in tal caso l'interesse pubblico alla conoscenza è in re ipsa, avendo il popolo il diritto di sapere conviene amministrata la giustizia in suo nome (art. 101 comma 1 Cost.). Le informazioni irrilevanti per il processo, invece, potrebbero essere legittimamente divulgate solo ove si dimostri, e in tal caso sarebbe onere del giornalista dimostrarlo, che ricorre un interesse pubblico alla loro conoscenza.” (p.182)
5. La separazione delle carriere.
Non si può evitare una notazione su un tema di attualità. La separazione delle carriere è ritenuta da più parti imposta dal modello accusatorio; il Ministro Nordio addirittura evoca la categoria teologica del “consustanziale” (Concilio di Nicea). A fronte della grandissima attenzione alla effettività del contraddittorio e alle garanzie di difesa, colpisce che alla questione della separazione Glauco Giostra dedichi non più di poche, ma decisive, righe ritenendo “angusti i margini in termini di architettura del sistema per separare a livello ordinamentale il pubblico ministero dal giudice senza mettere a rischio l'indipendenza del primo, che pure la stessa Costituzione vuole sia assicurata.” (p.60). Questione non eludibile.
6. Questa nostra giustizia imperfetta.
Ed infine l’Epilogo, con le parole dell’A. “Se dalla nostra piccola lezione ormai al termine fossimo riusciti a ricavare la grande lezione della irrinunciabilità etica e politica di questa nostra giustizia imperfetta, amministrata da uomini imperfetti, ma indipendenti da ogni potere e soggetti soltanto alle imperfette regole a cui la collettività chiede loro di attenersi, avremmo ben speso il nostro tempo” (p.186).
Chi avrà modo di leggere questa “Prima lezione” ne trarrà una guida per avventurarsi nei tanti problemi aperti della nostra giustizia, fuori dell’approssimazione, della faziosità e della demagogia oggi così diffuse.
P.S. Il recensore si è attenuto alla norma introdotta per i limiti alla pubblicabilità degli atti non più segreti usando la tecnica del “riassunto”, ma l’ha anche molto spesso violata pubblicando molte citazioni parziali del testo. Ad evitare il rischio che il lettore si appaghi dei riassuntini e delle citazioni parziali, vale anche in questo caso la regola di esperienza che la lettura del testo integrale è sempre preferibile. E poi, come dicono certe pubblicità in Tv, vi assicuro che nel lavoro di Glauco Giostra: “Vi è di più, molto di più!”.
[1] In A rewiew of the Criminal Courts of England and Wales, September 2001, www.criminal-courts-rewiew.org.uk , p. 11: The criminal process is not a game. It is a search for truth according to law, albeit by an adversarial process in which the prosecution must prove guilt to a heavy standard.
[2] M. Delmas-Marty, La prova penale, in L’indice penale, 1996, n. 3, pp. 609-610.
[3] Cfr. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, V ed., Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 94-135 e p. 546 ss; L. Ferrajoli, L’etica della giurisdizione penale, in Etica e deontologia giudiziaria, Vivarium, Napoli, 2003, p. 31.
[4] P. Ferrua, Contraddittorio e verità nel processo penale, in P. Ferrua, Studi sul processo penale, Vol. II, Anamorfosi del processo accusatorio, Giappichelli, Torino, 1992, p. 48-49
[5] J.R. Spencer, in Procedure penali d’Europa, cit., pp. 614-616).
[6] V. Fanchiotti, La giustizia penale statunitense. Procedure v. antiprocedure, Giappichelli, Torino 2022, p. 93
[7] V. Fanchiotti, ivi, p. 100

![Pubblico Ministero: leggende metropolitane e problemi aperti di Edmondo Bruti Liberati, già Procuratore della Repubblica di Milano[1]](/foto/2906.jpg)