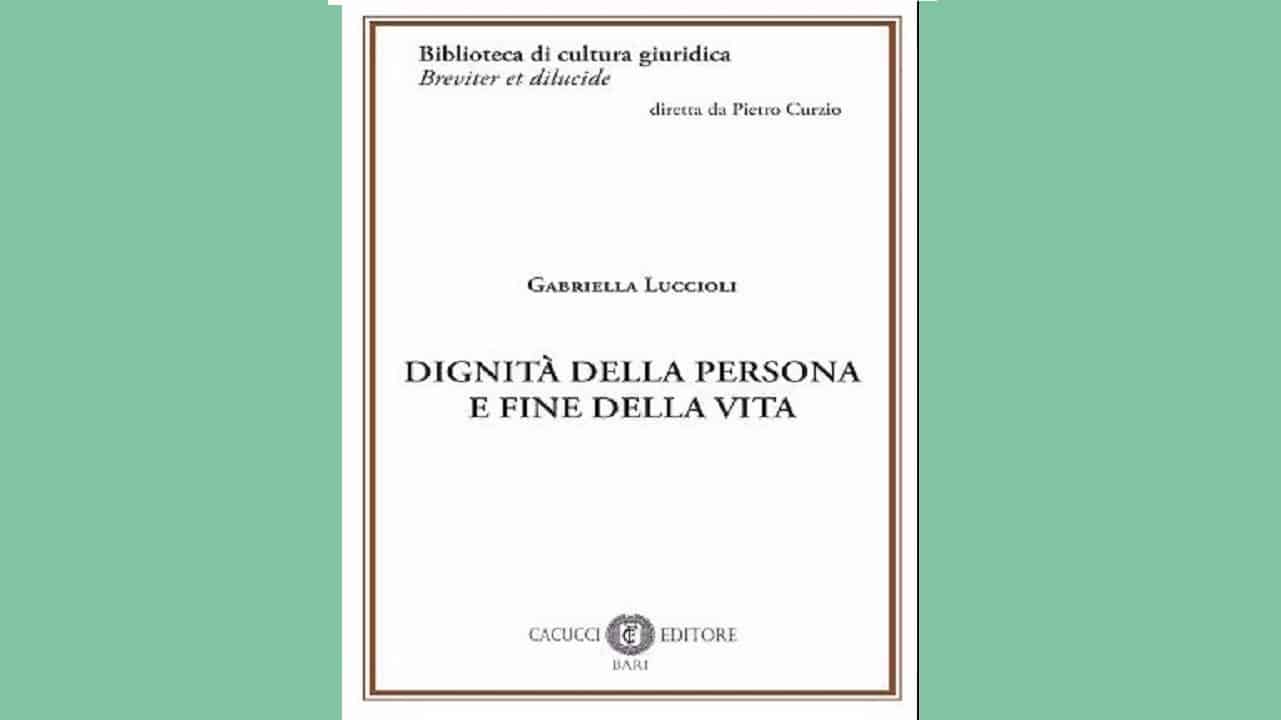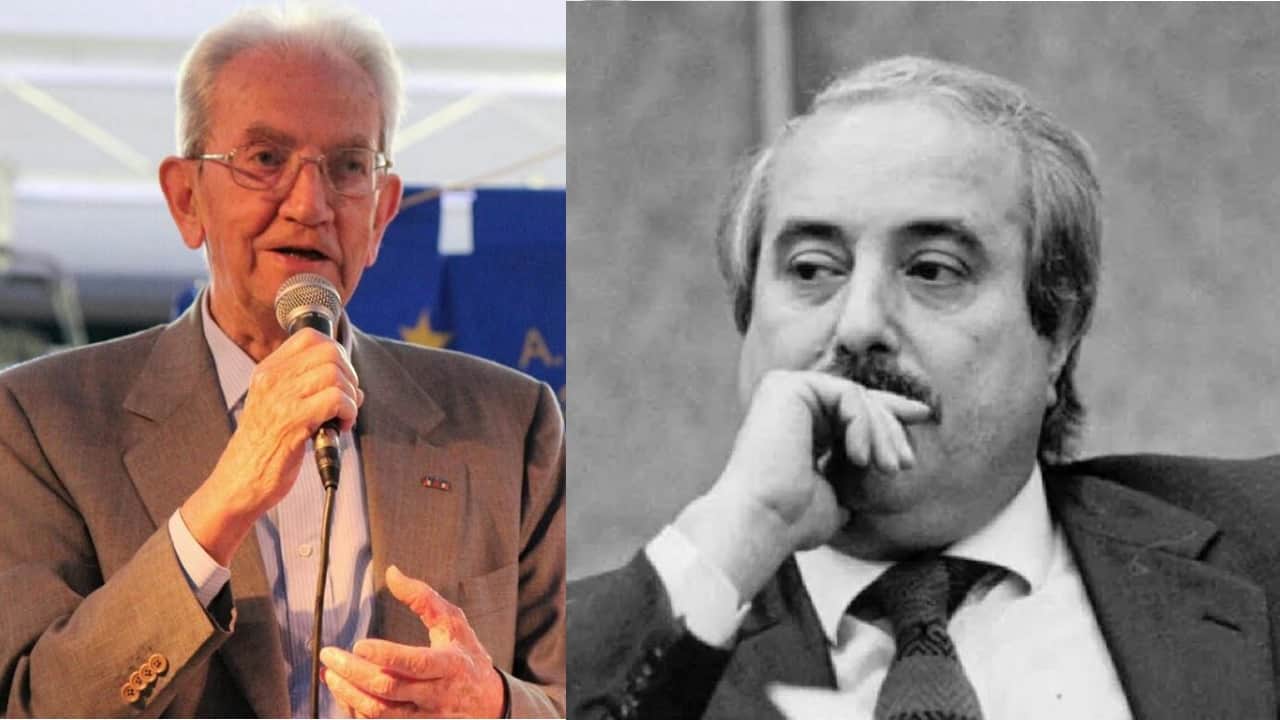Le interviste di Giustizia insieme
di Roberto Giovanni Conti
Il giudice disobbediente nel terzo millennio
Prof. Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte costituzionale
Prof. Vincenzo Militello, ord. Diritto penale Univ. Palermo
Prof. Davide Galliani, ass. Diritto Pubblico Univ. Milano
Sommario: 1.La scelta del tema. 2. Le risposte. 3. Le repliche. 4. Le conclusioni. 5. L’intervista in pdf.
1) Recenti casi giudiziari e le connesse iniziative di amministratori pubblici che hanno dichiarato di volere “disobbedire” alle leggi ritenute in contrasto con i valori supremi del nostro Paese hanno riportato al centro del dibattito il rapporto fra Legge e Costituzione. Secondo Lei quali strumenti ha il giudice comune per riportare a coerenza il sistema ritenuto in contrasto con i valori fondanti della società?
2) Come si concilia il dovere del giudice di applicare la legge con quello di segnalare, anche in ambiti apparentemente estranei all’esercizio della giurisdizione, le frizioni del sistema con i metaprincipi della società? Intravede nell’attività di esternazione dei giudici al di fuori delle sentenze un possibile vulnus ai canoni dell’autonomia e dell’indipendenza del giudiziario?
3) Marta Cartabia, in un suo recente saggio dedicato ad una riflessione a due voci con Luciano Violante su Antigone ed Edipo,individua, ricordando l’esperienza del Guido Calabresi “giudice” di una Corte federale americana, le possibili strade che il giudice deve percorrere per ricercare, reperire e inventare, per dirla con Paolo Grossi, soluzioni che impediscano l’applicazione di pene ingiuste. Quali suggerimenti si sente di dare ai giudici sul tema?
1.La scelta del tema
Roberto Giovanni Conti
Riflettere sulla disobbedienza del giudice può sembrare una contraddizione in termini. Il giudice chiamato ad attuare ed applicare la legge non potrebbe né dovrebbe ad essa sottrarsi, né alla stessa potrebbe e dovrebbe contravvenire. D’altra parte, la soggezione del giudice alla legge dovrebbe impedire al giudice di ribellarsi alla sua forza cogente.
L’avvento delle Costituzioni liberali e l’emersione inarrestabile dei diritti fondamentali, anche in una dimensione sovranazionale, ha fatto però vacillare quelle certezze, attribuendo al giudice il controllo di garanzia che lo pone come autentico anello di raccordo fra legge, persona e valori fondamentali.
Da qui l’emersione di nodi problematici di portata generale quanto al ruolo del giudice e del legislatore in una particolare contingenza storica che ha visto progressivamente modificarsi le coordinate tradizionali dei sistemi giudiziari, per l’un verso immettendo prepotentemente il controllo di legalità del giudice sulle leggi e, per altro verso, innestando nel tessuto normativo interno altre fonti produttive di significativi mutamenti ed aggiornamenti delle coordinate dei diritti stessi.
Ma in che misura, come e quando il giudice può disobbedire alla legge? Quali sono gli strumenti all’interno del suo arsenale? Con quali mezzi egli può o deve manifestare il proprio dissenso rispetto ad una legge ingiusta? Quali sono i confini rispetto alle “esternazioni” dei magistrati? Qual è il rapporto fra corpo giudiziario e social media? Fino a che punto può e deve arrivare la disobbedienza del giudice?
Il tema è denso di suggestioni e di complicate ricadute sulla democrazia.
Non resta che lasciare parlare le tre personalità che hanno accettato di dialogare con Giustizia Insieme: Gaetano Silvestri, Presidente emerito della Corte costituzionale, Vincenzo Militello, ordinario di diritto penale dell’Università di Milano e Davide Galliani, associato di diritto pubblico dell’Università Statale di Milano.
Segue, in coda alle risposte ed alle repliche, l’intervista integrale scaricabile in formato pdf.
2. Le risposte.
Prima domanda
1) Recenti casi giudiziari e le connesse iniziative di amministratori pubblici che hanno dichiarato di volere “disobbedire” alle leggi ritenute in contrasto con i valori supremi del nostro Paese hanno riportato al centro del dibattito il rapporto fra Legge e Costituzione. Secondo Lei quali strumenti ha il giudice comune per riportare a coerenza il sistema ritenuto in contrasto con i valori fondanti della società?
Gaetano Silvestri
Da quando si sono diffuse le costituzioni rigide non limitate ai meccanismi di funzionamento del sistema istituzionale, ma cariche di valori etici e sociali, che assumono la veste giuridica di princìpi, il problema del rapporto fra legge e costituzione si può valutare su due livelli di confronto.
a) Il primo, e ordinario, livello è il raffronto, operato dal giudice – costituzionale o comune, a seconda del tipo di ordinamento e di situazione concreta – tra norme primarie e norme costituzionali. Variano le procedure e gli organi giurisdizionali coinvolti, ma la sostanza rimane quella di un’applicazione dei princìpi di gerarchia e di competenza, variamente deducibili dalle singole carte costituzionali.
b) Il secondo livello, più problematico, è quello in cui sia il giudice costituzionale che il giudice comune procedono a quella che potremmo chiamare la “bonifica costituzionale” del sistema normativo, mediante la riconduzione a legittimità costituzionale delle norme oggetto del controllo, avvalendosi delle molteplici tecniche interpretative utilizzabili.
| Si discute sul grado di “creatività” dell’interpretazione conforme del giudice comune e quindi sui suoi limiti. Senza approfondire questa problematica – su cui sono stati versati fiumi di inchiostro, non sempre indispensabili – mi sembra di poter dire che questa prospettiva del rapporto legge-costituzione varia radicalmente se si prendono le mosse, o non, dalla nota distinzione tra disposizione e norma. Se si nega questo punto di partenza, si devono coerentemente restringere al massimo i margini di manovra disponibili per l’interprete e soprattutto si deve negare il cruciale passaggio costituito dall’estrazione di più norme dalla medesima disposizione e dalla successiva “scelta” dello stesso interprete. In astratto, quest’ultima può essere arbitraria – secondo le inclinazioni soggettive del giudice – oppure guidata dalla maggiore o minore “vicinanza” ai princìpi costituzionali delle singole norme ricavate dalla disposizione. Si sfugge a questo dilemma solo se si dà credito all’idea che esista una interpretazione “vera” della disposizione. Per quanto mi riguarda, io sto con Kelsen, nel negare valore scientifico a tale cognitivismo interpretativo. | …Si discute sul grado di “creatività” dell’interpretazione conforme del giudice comune e quindi sui suoi limiti…. |
Come si vede, il metodo non è neutrale rispetto ai risultati. La scelta dell’una o dell’altra strada incide sulla dinamicità dell’ordinamento e - se si vuole andare sino in fondo - sullo stesso concetto di costituzione. L’interpretazione della legge in conformità ai princìpi costituzionali implica che questi siano “immanenti” nell’ordinamento giuridico e non semplicemente sovraordinati alle fonti primarie e secondarie sul piano gerarchico.
…Premessa teorica fondamentale è che i princìpi abbiano contemporaneamente efficacia normativa e valore ermeneutico… |
Premessa teorica fondamentale è che i princìpi abbiano contemporaneamente efficacia normativa e valore ermeneutico. Se mancasse l’una o l’altra componente di questa premessa, la macrolegalità della costituzione stenterebbe a penetrare nella microlegalità delle norme particolari, che regolano i rapporti civili, economici e sociali tra le persone, e tutto il processo di “costituzionalizzazione” del sistema normativo subirebbe un forte rallentamento. La costituzione rimarrebbe un “cappello” posto sulla sommità dell’elenco tradizionale delle fonti (non a caso si parla, ancor oggi, di fonte “superprimaria”) forse bello a vedersi, ma suscettibile di essere portato via da un colpo di vento. |
Il giudice comune possiede dunque, nella prospettiva prima indicata, il potere di imprimere all’ordinamento, mediante una sua interpretazione costituzionalmente orientata, una dinamicità supplementare a quella che può provenire dal solo giudice delle leggi.
Vincenzo Militello
Tanto il contrasto fra legge e Costituzione, quanto la connessa questione del ruolo del giudice comune di fronte a tale situazione interna all’ordinamento, non sono certo novità dei nostri giorni, rappresentando evenienze ordinarie in ordinamenti a base costituzionale rigida, quali quelli occidentali contemporanei, che per questo li regolano con appositi meccanismi destinati a superare l’antinomia.
| Nel nostro sistema giuridico notoriamente il giudizio di costituzionalità della legge assegna al giudice comune un ruolo indefettibile nel complesso procedimento volto a verificare la compatibilità di una norma di legge alla Costituzione, attraverso l’ordinanza di remissione degli atti di un procedimento giudiziario alla Corte Costituzionale, in presenza dei noti presupposti di rilevanza e di non manifesta infondatezza. | …In ambito penalistico il giro di boa è stato segnato dalla teoria di Franco Bricola sui beni giuridici costituzionali… |
Una via maestra che tuttavia è stata esclusiva solo fino a quando il giudice italiano non ha maturato una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme: questa soluzione alternativa per ricomporre in sede giudiziaria e da parte del giudice comune le antinomie fra i due ranghi primari dell’ordinamento è stata battuta sin dalla seconda metà degli anni settanta, sulla base di una rivisitazione complessiva del ruolo della Costituzione nel nostro sistema giuridico.
In ambito penalistico il giro di boa è stato segnato dalla teoria di Franco Bricola sui beni giuridici costituzionali, in cui di fronte al disegno di tutela penale risalente al codice Rocco, gravato da numerosi aspetti ormai difficilmente riconducibile alla trama costituzionale si propone di superare la lettura tradizionale della tipicità (conformità del fatto concreto alla fattispecie incriminatrice) con una sua rivisitazione in chiave costituzionale, che ponga a centro della tutela penale il bene giuridico nella sua “concreta dimensione sociale e costituzionale”. In tal modo, si consente che in sede applicativa prima ancora che di riforma possano espungersi dalla portata della norma penale incriminatrice i fatti astrattamente tipici, ma concretamente inoffensivi.
La teoria di Bricola ha avuto un effetto dirompente nella quiete dello stagno penalistico, non solo perché ha stimolato una riflessione rinnovata sul concetto cruciale di bene giuridico offeso dalla condotta illecita e sulla definizione sostanziale di reato, ma anche perché ha aperto una strada per una interpretazione critica della fattispecie, che dava in mano al giudice uno strumento nuovo e potenzialmente in grado di alterare la sua tradizionale posizione nel rapporto con la legge. Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio l’effettiva tenuta logico-giuridica della teoria di Bricola; basterà ricordare che l’idea di ricavare dalla Costituzione una precisa gerarchia di valori in grado di proiettarsi sulle molteplici fattispecie di un ordinamento moderno - pur volendo accedere ad un modello di intervento penale ridotto alle forme più gravi di offesa ai beni giuridici costituzionalmente rilevanti - finisce per trascurare l’oggettiva difficoltà di instaurare un preciso orientamento, quantomeno in tutti i casi in cui più beni costituzionali entrino in reciproco conflitto e dunque necessitano di una ponderazione reciproca per individuare dove debba arrivare il rispettivo bilanciamento. D’altra parte, la reale capacità selettiva della teoria sulla lista di beni giuridici tutelabili penalmente, doveva fare i conti in qualche modo con il “certificato di nascita” della Costituzione, che ad esempio non poteva considerare ancora la non ancora avvenuta emersione e successiva esplosione dei beni informatici. Cosicché, la teoria di Bricola era già negli anni settanta anni giocoforza obbligata ad ampliare la rosa dei beni penalmente tutelabili a quelli anche solo implicitamente contenuti nella Costituzione (come ad esempio l’ambiente, rispetto all’allora esclusivamente richiamato paesaggio): in tal modo, si finiva però per disperdere l’efficacia selettiva stringente sulle scelte di incriminazione e si ripiegava su un effetto solo di orientamento.
La versione che ha finito per prevalere ed affermarsi, benché ridimensionata rispetto alle aspirazioni iniziali, rivela però anche il nucleo di verità della teoria e può compendiarsi nell’idea che la Costituzione indica “direttive programmatiche di tutela penale” tanto per il legislatore quanto per il giudice, che deve appunto interpretare in senso conforme a Costituzione le fattispecie esistenti. Se questa versione edulcorata finisce per essere di relativa utilità come vincolo in sede legislativa, essa mantiene una grande potenzialità in mano al giudice che può ricavare e ritagliare dimensioni costituzionalmente compatibili nelle scelte incriminatrici del legislatore.
| …L’interpretazione conforme al diritto europeo - diventa con la sentenza Pupino del 2005 una chiave dalla stessa Corte di Giustizia UE per ridurre le discrasie fra ordinamento europeo e quello interno… | Un approccio la cui vitalità si conferma nella – pur di molto successiva – valorizzazione di un’analoga chiave interpretativa nel momento in cui l’ordinamento ha aperto anche la sua dimensione penalistica all’interazione con il piano sovranazionale della tutela dei diritti di fonte europea. L’interpretazione conforme al diritto europeo – in particolare rispetto alle decisioni quadro, quali strumenti normativi nel settore della cooperazione in materia di giustizia penale - diventa con la sentenza Pupino del 2005 una chiave dalla stessa Corte di Giustizia UE per ridurre le discrasie fra ordinamento europeo e quello interno. Ci si affida a tal fine direttamente all’attività del giudice, che in via interpretativa può ricavare dalla fonte sovranazionale contenuti normativi non ancora implementati nel diritto interno tramite l’ordinaria via legislativa. |
Rispetto alla specifica dimensione penalistica, entrambe queste valorizzazioni della posizione del giudice rispetto alla dimensione del legislatore ordinario, non possono però che avere una portata solo limitata a soluzioni conformi al favor rei e mai invece portare ad una espansione della materia penale, anche laddove ad esempio il giudice rilevi nel panorama legislativo esistente lacune di tutela penale rispetto a un bene costituzionalmente rilevante o – in relazione al diritto europeo – a un bene tutelato dalla CEDU o dalla Carta europea dei diritti fondamentali. Troppi evidenti sarebbero infatti le conseguenze di limitazione dei fondamentali diritti di libertà del cittadino tutelati dal principio di legalità rispetto tanto alla riserva di legge, quanto al correlato divieto di analogia delle norme incriminatrici.
Davide Galliani
Grazie a Giustizia Insieme. Per le domande, coraggiose. Per l’invito, immeritato.
| Si sbaglia quando si guarda alla complessità come fosse un nemico. I riduzionisti, alcuni dei quali anche particolarmente sovranisti, cercano conforto in un passato che non torna. Sia benedetta la complessità. Nessuno al centro del mondo del diritto. In ordine cronologico, non la dottrina (gli studiosi), non il legislatore (il politico), non i giudici (i giudici). Da soli non si va da nessuna parte. Si rende un buon servizio alla Giustizia in un unico modo, Insieme. Ciascuno facendo il proprio mestiere, considerandoli però come parte di un tutto, complesso. Questa la mia premessa. Un ringraziamento, ma anche il metodo per rispondere nel merito alle domande. | … Sia benedetta la complessità… |
| …Da soli non si va da nessuna parte. | La prima domanda. Il politico, se ritiene di non “obbedire” ad una legge, ha una sola possibilità, dico una sola nel senso di quella che ritengo l’unica giustificabile: non rispetta la legge, lo dichiara pubblicamente, ne accetta le conseguenze. Il sistema così salta? Non sono d’accordo. Il sistema così va avanti. Ricordati di ricordare, scriveva Henry Miller. |
Non posso obbedire a questa legge, la ritengo ingiusta: processatemi. Pensiamo veramente che tutti i politici siano pronti a “pagare” di persona, eventualmente? Ma quando mai. La storia dimostra che per la disobbedienza di pochi, noi tutti abbiamo avuto grandi benefici. Per non vagare, qualche nome, per stare nella penisola italiana: Don Lorenzo Milani, Marco Pannella, Marco Cappato, Domenico Lucano.
Scelgo i meno politici, nel senso comune (sbagliato) del termine, come se politico fosse solo chi ha una tessera di partito e si candida alle elezioni. Prendo i primi due, un sacerdote che faceva politica (non partitica) e un politico da marciapiede (definizione di Umberto Eco), che faceva politica come nessun altro, fondando un partito politico transpartitico.
Si leggano la lettera ai giudici di Don Lorenzo Milani e la sentenza della IV sezione penale del Tribunale di Roma (15 febbraio 1966), che lo assolse dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituiva reato. Quando Don Milani scrisse la lettera, il 18 ottobre 1965, in carcere, per obiezione di coscienza al servizio militare, si contavano 31 ragazzi. Come noto, si schierò al loro fianco, contro un ordine del giorno dei cappellani militari. Per questo finì a processo.
Ecco un passaggio della lettera ai giudici: “La tragedia del vostro mestiere di giudici è che sapete di dover giudicare con leggi che ancora non sono tutte giuste. Sono vivi in Italia dei magistrati che in passato han dovuto perfino sentenziare condanne a morte. Se tutti i giorni inorridiamo a questo pensiero dobbiamo ringraziare quei maestri che ci aiutarono a progredire, insegnandoci a criticare la legge che allora vigeva. Ecco perché, in un certo senso, la scuola è fuori dal vostro ordinamento giuridico”.
Un altro passo: “In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani, non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo di amare la legge è obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano cambiate. La leva ufficiale per cambiare la legge è il voto. La Costituzione gli affianca anche la leva dello sciopero”.
| Queste le premesse. Il punto fondamentale: “Ma la leva vera di queste due leve del potere è influire con la parola e con l’esempio sugli altri votanti e scioperanti. E quando è l’ora non c’è scuola più grande che pagare di persona un’obiezione di coscienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa prevede. E’ scuola per esempio la nostra lettera sul banco dell’imputato e è scuola la testimonianza di quei 31 giovani che sono a Gaeta. Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri. Non capisco come qualcuno possa confonderlo con l’anarchico. Preghiamo Dio che ci mandi molti giovani capaci di tanto”. | ..La tragedia del vostro mestiere di giudici è che sapete di dover giudicare con leggi che ancora non sono tutte giuste… |
Un’ultima frase: “Nessuno può accusarmi di eresia o indisciplina. Nessuno d’aver fatto carriera. Ho 42 anni e sono parroco di 42 anime”. Tornerò alla fine, in risposta alla terza domanda, su questa ultima chiosa.
Che fare di fronte alla legge che si vorrebbe disobbedire? Il politico deve fare come Don Lorenzo Milani. Legga le sue parole, tragga insegnamento.
| …Ditemi se non dobbiamo il progresso anche a chi ha deciso di disobbedire, pagando in prima persona. | Anche Marco Pannella ha condotto una vita interessante, anche mettendola a repentaglio. Quando scioperava dal cibo fino a diventare scheletrico. Quando non beveva altro che la sua urina. Quando Natale, Pasqua e Ferragosto li trascorreva in carcere, con detenuti e polizia penitenziaria. In tutti questi e altri casi, qualcuno pensa lo facesse per lui? Non sto dicendo che, per combattere una causa nella quale credono, tutti i politici devono perdere la metà del proprio peso, bere solo la propria urina, stare più in carcere che in Parlamento. Semplicemente, che il mondo va avanti anche grazie a chi decide di farlo. |
Il divorzio. L’aborto. La moratoria ONU sulla pena di morte. Lo Statuto della Corte penale internazionale, senza pena di morte, senza ergastolo senza condizionale. Il testamento biologico. Ditemi se non dobbiamo il progresso anche a chi ha deciso di disobbedire, pagando in prima persona.
La Giustizia si fa Insieme, abbiamo detto. A differenza del politico, il giudice ha ruolo e mestiere diversi. Il giudice vive in questo mondo, non su Marte. Chiaro che non può essere indifferente a ciò che accade in questo mondo. Non di meno, non è un politico, è un giudice. Lasciamo stare le differenze, tra le quali la motivazione della sentenza è la più importante. Proviamo a fare un altro ragionamento. Non sono pochi gli strumenti a disposizione del giudice quando si trova di fronte una legge in contrasto con i valori fondanti della società, per stare precisamente alla precisa prima domanda che ci è posta.
| Il giudice, una volta occupatosi dei fatti, appena prende in mano una legge, la primissima cosa che dovrebbe fare è rispondere a questa domanda: “la legge che penso si debba utilizzare in questo caso, questa legge che ho in mano, è conforme alla Costituzione?”. Se ha il minimo dubbio (questo significa il manifestamente) deve sollevare la questione di costituzionalità. | … La Giustizia si fa Insieme, abbiamo detto… |
| … Il giudice, una volta occupatosi dei fatti, appena prende in mano una legge, la primissima cosa che dovrebbe fare è rispondere a questa domanda: “la legge che penso si debba utilizzare in questo caso, questa legge che ho in mano, è conforme alla Costituzione?”. | So bene che, se non tenta l’interpretazione costituzionalmente orientata, rischia che la Consulta rimandi indietro la questione. Ma il sistema oggi è meglio funzioni con (in prima battuta) il sindacato di costituzionalità accentrato. Finché non avremo una nomofilachia degna di questo nome. Finché il precedente sarà più una questione di massime (senza fatti) che di seguito convinto di un orientamento convincente. Finché il giudice sarà lasciato solo a gestire una montagna enorme di casi. Insomma, finché non cambierà il contesto, la mia opinione è che la prima cosa da fare, per un giudice, di fronte ad una legge che ritiene in contrasto con i valori fondanti della società, è la seguente: se ho un dubbio di costituzionalità, sollevo, così ho più possibilità di risolvere, insieme al mio caso, anche tutti gli altri. Se non ha alcun problema, la testa del giudice pensa alla parte, la sua penna si pronuncia sul chiesto, tutto il chiesto. Se ha un problema, di costituzionalità, la testa del giudice pensa alla Consulta, la penna serve per scrivere la quaestio. |
| Parlo di prima cosa da fare, ma intendiamoci. Immagino che il giudice senta dentro l’esigenza di fare giustizia nel caso di specie. Di conseguenza, che, a rendere giustizia, ci debba pensare lui, subito, senza attendere la Consulta. E che, pertanto, deve usare l’interpretazione costituzionalmente orientata, per prima cosa. Ora, non sto dicendo che sbaglia il giudice che fa questo ragionamento. E capisco che scrivere una questione di costituzionalità non è come scrivere un appunto su un quaderno. Mi sembra però che il giudice, solo dopo aver escluso la quaestio, procede con l’interpretazione costituzionalmente orientata. La priorità è logica, quasi naturale: se ritieni di dover disobbedire ad una legge, è molto probabile che il tuo problema non sia solo il caso di specie che hai di fronte, ma davvero vuoi che quella legge sia cancellata dall’ordinamento, per tutti. | … il sistema oggi è meglio funzioni con (in prima battuta) il sindacato di costituzionalità accentrato… |
E’ il problema di ogni giudice di ogni tempo: rendere giustizia per la persona che ha di fronte o per tutte le altre che potrebbero trovarsi nella stessa situazione? Se la domanda alla quale si chiede di rispondere è cosa deve fare il giudice di fronte alla legge in contrasto con i valori fondanti della società, quindi il giudice di fronte non a qualsiasi legge, ma a una legge di questo tipo, la mia risposta è: se il giudice ha un dubbio sulla costituzionalità, solleva, spiegando alla Corte perché non aveva alternative.
| … Se la legge dice nero e il nero è contro i valori fondanti della società, io (giudice) vorrei ottenere il massimo, togliere di mezzo quella legge dall’ordinamento… | Non forza a dismisura la lettera della legge. Forza la Consulta a cancellare quella legge. Il tempo che impieghi per interpretare in senso costituzionalmente orientato è identico a quello che impiegheresti per sollevare un dubbio di costituzionalità. Se la legge dice nero e il nero è contro i valori fondanti della società, io (giudice) vorrei ottenere il massimo, togliere di mezzo quella legge dall’ordinamento. La parte potrà faticare a comprendere, ma è pur sempre la stessa parte che, leggendo la quaestio, capirà di avere il giudice dalla sua parte. Ricordiamoci come inizia Lettera al mio giudice di Georges Simenon: “Signor giudice, vorrei tanto che un uomo, un uomo solo, mi capisse. E desidererei che quell’uomo fosse lei”. |
La Consulta sta ripensando le inammissibilità dovute al mancato tentativo di interpretazione conforme a Costituzione. Le rose sono fiorite, oltre le aspettative. Il problema è sempre lo stesso: non possono essere rose a Santa Maria Capua Vetere e cespugli a Marsala. Lasciamo stare la certezza del diritto, che a volte dovrebbe fare la stessa fine del giudicato. Ma nessuno può negare che sia insopportabile essere condannato a morte a Monza e non esserlo a Macerata, perché nel secondo caso il giudice ha disapplicato una legge ritenuta contraria alla Costituzione. Per non condannare a morte nessuno, il meglio che abbiamo inventato si chiama Corte costituzionale, se fa del suo meglio, chiaro.
E la fase calante delle rime obbligate è di buon auspicio, apertura di credito ad un mondo migliore, più costituzionale: una quaestio è ammissibile, non tanto perché esiste un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, ma perché esistono, nell’ordinamento, una o più soluzioni costituzionalmente adeguate (da ultimo, la stupenda, nel metodo e nel merito, n. 99/2019).
| Ribadisco: mi fidanzerei con i giudici costituzionalmente orientati, ma sposerei i giudici che inabissano la Consulta di questioni di costituzionalità. Il primo in Italia si chiamava Nino Caponnetto, con il quale concluderò queste riflessioni. Ricordo qui, per venire ai giorni nostri, non vicini, nemmeno lontani, che la legge n. 189 del 2002, la legge Bossi-Fini, tra il 2003 e il 2004, fu portata a Palazzo della Consulta una cosa come 800 volte. Per due anni, in media, una quaestio al giorno. Questo è un sistema che a me piace moltissimo. Giustizia Insieme: giudici e giudici costituzionali. | … mi fidanzerei con i giudici costituzionalmente orientati, ma sposerei i giudici che inabissano la Consulta di questioni di costituzionalità… |
Poi vi è la questione europea, le nuove possibilità di disapplicare una legge, ribellandosi (siamo sempre nel campo di una legge contro i valori fondanti della società). Qui il mare è in tempesta, dici una cosa oggi, domani cambia il mondo. Mi riesce difficile prendere posizione, devo essere onesto. Dico solo che all’orizzonte non vedo che burrasca. Si diventa matti (a ragione) sul rinvio pregiudiziale prima o dopo la questione di costituzionalità. A me pare che si debba ragionare anche su un’altra questione, burrascosa: che fare quando il giudice disapplica formalmente per contrasto con Lussemburgo, ma sostanzialmente sta usando Strasburgo, integralmente recepito dalla Corte di Giustizia? Bel problema, per chi pensa sia un problema. Anche in questo scenario, che poi è quello (complesso) nel quale siamo dentro, sento non di meno di confermare la posizione prima esposta: nella stragrande maggioranza dei casi, quello che ci dicono Lussemburgo e Strasburgo lo potremmo ben dire noi in una ordinanza con la quale solleviamo questione di costituzionalità al giudice delle leggi. Non sempre, ma spesso. Che solo la Corte di Giustizia o la Corte di Strasburgo hanno contezza dei valori fondanti della società?
Faccio un solo esempio. Il mandato di arresto europeo. Lo nego se le carceri del paese richiedente sono sovraffollate. A mio parere, lo devi negare anche quando la pena viola la dignità umana: perché devo chiedere questo a Lussemburgo, sapendo che si rifarà a Strasburgo, ai casi nei quali ha condannato le pene inumane e degradanti? Non parlo di aria fritta, parlo di ergastolo senza possibilità di accedere alla liberazione condizionale: viola la Carta dei diritti, viola la Convenzione, prima di tutto viola la Costituzione italiana. Nel caso del MAE sarebbe tutto un problema di interpretazione, nessun problema mi verrebbe da dire. Quando però il giudice ha di fronte una pena contraria al senso di umanità (Costituzione), inumana e degradante (Convenzione), che viola la dignità umana (Carta dei diritti), se quella pena è prevista dalla legge italiana, chiara, cristallina, non puoi tentare l’interpretazione costituzionalmente orientata, poiché il solo tentarla significa che ti sei posto il dubbio di costituzionalità, quindi sollevi. Ripeto, sto ragionando a fronte di leggi che violano i valori fondanti della società.
| … dopo il politico e il giudice, se la Giustizia è Insieme, qualche parola sullo studioso e il disobbedire… Uno studioso è un partigiano puntiglioso del dubbio, un resistent ostinato della complessità… | Infine, dopo il politico e il giudice, se la Giustizia è Insieme, qualche parola sullo studioso e il disobbedire. Salvatore Satta sosteneva che giurista è colui che dice di no. I grandi maestri sanno dire in poche parole grandissimi concetti. A differenza del politico e del giudice, lo studioso che non disobbedisce non è uno studioso. Deve criticare dalla mattina alla sera. Deve rompere le scatole, letteralmente, aprirle, guardarci dentro, mischiare le carte, ravanare alla ricerca dell’ago nel pagliaio. Non accontentarsi mai, insomma. Il pungolo del dubbio, l’inquietudine della ricerca, diceva Norberto Bobbio. |
Nel DNA di uno studioso deve esserci una naturale obiezione ad ogni cosa, figuriamoci ad una legge in contrasto con i valori fondanti della società. Sono i criceti che fanno girare la ruota, dei quali parla Roberto Bin in A discrezione del giudice.
Ancora una volta, però, gli studiosi da soli nulla fanno. Gli studiosi criticano giudici e legislatori, sperando di essere un attimo ascoltati. Se va male, hanno fatto il loro mestiere, una voce dopo l’altra diventano alla lunga un coro. Se parlano di Marte, non si lamentino di non essere ascoltati. Se parlano della terra, dei suoi problemi, in una mano la mazza, nell’altra la cazzuola. Lo studioso critica in questo modo: abbatte e costruisce. Qualcuno che ti ascolta, prima o poi, se resisti, lo trovi. Se no, pazienza: ma qualcuno per caso scrive senza sperare che qualcuno lo ascolti?
Uno studioso è un partigiano puntiglioso del dubbio, un resistente ostinato della complessità. Abbatte muri e costruisce ponti. Usa la ruspa della ragione per sgomberare i manicomi, apre i porti perché semplicemente ragiona.
Lo studioso penetra nelle motivazioni dei giudici, grazie alle citazioni che devono diventare esplicite (se citi leggi, se leggi citi, very easy). Certamente dà una mano quando gli viene concesso di presentare un amicus curiae (ce la faremo, anche in Italia, Yes We Can). Invece di mandare i supremi giudici amministrativi e contabili in Cassazione, aprendo la Suprema Corte e ferendo la Costituzione, non sarebbe meglio aprire le Sezioni Unite di Piazza Cavour agli amici curiae e alle citazioni esplicite della dottrina? Aprire per aprire, si apra senza problemi di costituzionalità.
| Lo studioso deve credere che può influire sulla Giustizia, che si fa solo in un modo. Insieme. Non si dica che non si riesce: 10.000 magistrati ordinari, 8.000 onorari, 500 amministrativi, 600 contabili, da un lato e, dallo stesso lato, 4.000 professori ordinari, associati e ricercatori nell’area delle scienze giuridiche, dallo IUS 01 fino allo IUS 21 (diritto privato, privato comparato, agrario, commerciale, economico, della navigazione, del lavoro, costituzionale, pubblico, amministrativo, canonico/ecclesiastico, tributario, internazionale, dell’Unione Europea, processuale civile, processuale penale, penale, romano, storia del diritto, filosofia del diritto e pubblico comparato). | …Invece di mandare i supremi giudici amministrativi e contabili in Cassazione, aprendo la Suprema Corte e ferendo la Costituzione, non sarebbe meglio aprire le Sezioni Unite di Piazza Cavour agli amici curiae e alle citazioni esplicite della dottrina… |
Grosso modo, non dovrei aver lasciato fuori nessuno. Ci sono 23.000 persone, una marea di persone, che a volte hanno bisogno di un politico che disobbedisce. Ad ogni modo, per ogni politico che siede in Parlamento, ci sono potenzialmente 23 persone pronte a confrontarsi sui valori fondanti della società. Una proporzione di uno a ventitré, come tra abitanti e caribù in Alaska. Possibile non si riesca a fare Giustizia Insieme?
Seconda domanda
2) Come si concilia il dovere del giudice di applicare la legge con quello di segnalare, anche in ambiti apparentemente estranei all’esercizio della giurisdizione, le frizioni del sistema con i metaprincipi della società? Intravede nell’attività di esternazione dei giudici al di fuori delle sentenze un possibile vulnus ai canoni dell’autonomia e dell’indipendenza del giudiziario?
Gaetano Silvestri
| Il giudice ha il dovere, come magistrato e come cittadino, di levare la propria voce di fronte ai pericoli che possono correre i princìpi fondamentali (non amo l’espressione “metaprincìpi”) della Costituzione, anche fuori dell’esercizio della funzione giurisdizionale. Il dovere di fedeltà alla Repubblica – che grava su ogni cittadino ai sensi dell’art. 54 Cost. – è particolarmente qualificato per il magistrato, a causa della sua preparazione giuridica e della sua collocazione a garanzia della legalità, che non è solo quella ordinaria, ma soprattutto quella costituzionale. Se si intravede il pericolo che la casa bruci, non ci si può riparare dietro il comodo schermo dell’indipendenza, giacché quest’ultima è garanzia della giurisdizione di fronte agli altri poteri dello Stato e non, paradossalmente, neutralità di fronte ai nemici mortali dell’ordine costituzionale. | … Il dovere di fedeltà alla Repubblica – che grava su ogni cittadino ai sensi dell’art. 54 Cost. – è particolarmente qualificato per il magistrato… |
| … Il giudice ha il dovere, come magistrato e come cittadino, di levare la propria voce di fronte ai pericoli che possono correre i princìpi fondamentali… | Quest’ultimo è un tutto unitario. Non avrebbe senso pertanto distinguere tra ambiti interni o estranei all’esercizio della giurisdizione. La separazione dei poteri implica un loro costante equilibrio, senza il quale vacillerebbero anche i presupposti da cui prende vigore la stessa indipendenza della magistratura. Ogni grave turbamento dell’equilibrio costituzionale in un punto del sistema è destinato a ripercuotersi, prima o poi, in tutti i settori. |
Naturalmente potranno essere oggetto di valutazione nelle sedi competenti continui e infondati allarmi lanciati da alcuni magistrati, che potrebbero celare intenzioni politiche di parte, del tutto inammissibili per chi esercita la giurisdizione.
| Detto ciò, mi sembra di dover affermare una netta contrarietà ad ogni commento da parte del magistrato su processi in corso affidati a lui o ad altri colleghi. Le norme esistenti, che censurano questi comportamenti, dovrebbero essere applicate con la massima severità. La garanzia rafforzata, rispetto ad altri soggetti istituzionali, dell’indipendenza dei giudici non è un privilegio senza contrappesi. Essa comporta dei costi individuali in termini di dovere di autocontrollo, al fine di mantenere non il “prestigio” (concetto ormai superato), ma la credibilità della giurisdizione, senza la quale il cittadino è portato a non accettare l’esito dei giudizi e ad allinearsi, anche in buona fede, ad attacchi provenienti da chi quell’indipendenza vuole abolire, o attenuare, per proteggere interessi illeciti o per istaurare regimi autoritari. Ritenersi vittima di un giudice politicamente fazioso è la premessa al prestare ascolto a coloro che vorrebbero una maggiore faziosità, purché sia alla loro parte. | … mi sembra di dover affermare una netta contrarietà ad ogni commento da parte del magistrato su processi in corso affidati a lui o ad altri colleghi… |
| … Non abbiamo bisogno di giudici che dispensano quotidianamente la loro saggezza su tutto e su tutti… | Per lo stesso motivo, sarebbe opportuno che i magistrati si astenessero da dichiarazioni o prese di posizione su temi di rilievo politico immediato, a meno che non si tratti di interventi in sedi culturali o scientifiche qualificate. Non abbiamo bisogno di giudici che dispensano quotidianamente la loro saggezza su tutto e su tutti. Gli effetti della loquacità di alcuni si ripercuotono talvolta sull’intera categoria, anche perché non sempre le dichiarazioni mostrano una sufficiente informazione o riflessione sui temi trattati. Se i cittadini dalle dichiarazioni “a ruota libera” dei magistrati traggono un’impressione di superficialità, oltre che di narcisismo mediatico, sono indotti a pensare che gli stessi vizi si riproducano nelle indagini e nei processi. L’effetto è talvolta disastroso, a beneficio soprattutto dei corrotti, molto ansiosi di passare per vittime di persecuzioni. |
Sono consapevole che l’art. 21 Cost. è un grande ombrello, che copre i magistrati come tutti i cittadini, ma occorre riflettere sul fatto che la parola di un giudice, in taluni campi della vita politica e sociale, possiede un plusvalore, in quanto idonea ad ingenerare nell’opinione pubblica la convinzione che le opinioni personali del magistrato “esternante” corrispondano a precetti giuridici. Lo stesso – ma in misura minore – vale per i tanti “grilli parlanti”, che sdottoreggiano su tutti gli argomenti, usando talvolta le loro qualifiche accademiche o professionali come garanzia della profondità delle loro riflessioni, spesso invece improvvisate. Per quanto riguarda i magistrati, talvolta la ricerca di visibilità mediatica è finalizzata alla conquista di potere correntizio. Ancora peggio!
| Più che con divieti di difficile applicazione e dubbia costituzionalità, si dovrebbe fare appello al senso di responsabilità e del limite, beni rari in tempi di ricerca spasmodica di consenso e popolarità. Nell’intento di approfondire questa delicata e difficile tematica, la Scuola superiore della magistratura organizza ogni anno corsi sui rapporti tra comunicazione e giurisdizione. Troppo poco? Meglio che niente. | … Più che con divieti di difficile applicazione e dubbia costituzionalità, si dovrebbe fare appello al senso di responsabilità e del limite… |
Vincenzo Militello
Distinguerei due tipi di esternazioni del giudice: quelle relative a norme che non riguardano casi sottoposti al concreto esercizio della sua attività giurisdizionale, e quelle invece riferite a norme che qualificano situazioni oggetto del suo giudizio. Se per queste ultime è più facile il giudizio di assoluto sbarramento, tutelato anche penalmente dal segreto di ufficio, la questione relativa alle prime è più complessa e mi sembra dipende molto dalla contestualizzazione dell’esternazione. Evidente infatti che un giudice chiamato ad intervenire in un convegno dedicato al commento di una riforma normativa (si pensi alla nuova normativa sulla legittima difesa, o alla riforma della prescrizione) ben possa manifestare perplessità, critiche o soluzione alternative ad una legge, pur formalmente legittimata dall’approvazione parlamentare.
Più problematico il caso diventa quando la sede dell’intervento pubblico del magistrato diventa non di studio, ma all’opposto dichiaratamente politica, per es. il congresso di un partito o anche di un’associazione sindacale, dove anche la competenza tecnica del giudice può essere fatta valere come elemento di un preciso orientamento politico e dunque rischia di suscitare nel pubblico “un possibile vulnus ai canoni dell’autonomia e dell’indipendenza del giudiziario”.
| … Più problematico il caso diventa quando la sede dell’intervento pubblico del magistrato diventa non di studio, ma all’opposto dichiaratamente politica, per es. il congresso di un partito o anche di un’associazione sindacale,… | Esiste certo una gamma estremamente variegata di situazioni intermedie, rispetto alle quali il pur non facile giudizio nel caso specifico non deve mai trascurare che in una società dell’informazione e della comunicazione diffusa come quella attuale sarebbe inesigibile richiedere al giudice un’astensione piena dalla partecipazione al dibattito pubblico, che se non altro limiterebbe insopportabilmente – ed illegittimamente - il suo diritto alla libera manifestazione del pensiero. Pur scontando dunque una componente necessaria ed ineliminabile di presenza del giudice nel dibattito pubblico, che fa ritenere da tempo colmato quel rigido vallo di separatezza con la società che caratterizzava la magistratura italiana direi fino a cinquanta anni fa, a me pare che – dopo le stagioni che hanno portato ad un profondo mutamento nel ruolo del giudice nella società italiano, ad un significativo ampliamento della composizione sociale di provenienza, ad una crescita velocissima della presenza femminile – attualmente i pericoli per l’indipendenza e l’imparzialità della magistratura non vengano solo dall’esterno, ma possano trovare alfieri o comunque agevolatori anche da parte di alcuni soggetti ad essa interni. |
Non si tratta tanto di censurare il protagonismo di questo o di quel magistrato nei rapporti con i media, ma di non dimenticare che la realtà degli ultimi anni ha offerto esempi non rari di passaggi di campo nella politica di magistrati e che questo esito è stata spesso preceduto da una sovraesposizione mediatica dei soggetti in questione. So bene che tali eccessi sono solo in parte dovuti a scelte del singolo magistrato, ma spesso dipendono dal sistema dell’informazione, che concentra la propria attenzione su questo o quel soggetto, sollecitandone un protagonismo che finisce per fagocitare i freni di autocontrollo di molte persone. Sarebbe però lontano dalla realtà negare che, nel composito mondo dei rapporti fra giustizia ed informazione, vi siano anche casi in cui è lo stesso magistrato a contribuire alla costruzione di una propria immagine pubblica attraverso l’intervento nei mass media. In casi simili – indipendentemente da ogni valutazione sulle qualità di giudice del singolo soggetto, che può ben essere un giurista acuto e sensibile ai problemi della società – mi chiedo se alla crescita di profilazione pubblica del singolo magistrato non corrisponda un effetto sistemico sull’immagine della magistratura nella società che ne incrina quei caratteri di autonomia ed indipendenza.
|
Se allora si tratta di trovare un modo per bilanciare gli interessi primari in gioco nel caso di esternazioni atipiche del magistrato (quelle appunto al di fuori dell’esercizio della giurisdizione) a me pare che una tentativo equilibrato sia offerto dalla norma che attualmente regola la materia dei rapporti con i media nel codice etico dell’ANM. Il relativo art. 6 non solo ricorda al magistrato di non “sollecitare” la pubblicità di notizie connesse al proprio ufficio, ma anche quando riconosce uno spazio legittimo di rapporti con la stampa, collega tale attività a fini non personali ma sociali, come la garanzia della “corretta informazione dei cittadini”, il “diritto di cronaca”, la “tutela dell’onore dei cittadini”, e soprattutto ribadisce l’importanza di non ricorrere a “canali informativi privilegiati”. Ancora più importanti, quanto ai contenuti, sono le modalità indicate per evitare che la libertà di manifestazione del pensiero del magistrato si trasformi in una sorta di abuso della posizione sociale collegata al ruolo pubblico rivestito, e che possono essere sintetizzate in una regola aurea di “continenza” dell’esternazione: “il magistrato si ispira a criteri di equilibrio, dignità e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa, così come in ogni scritto e in ogni dichiarazione destinati alla diffusione”. |
…la realtà degli ultimi anni ha offerto esempi non rari di passaggi di campo nella politica di magistrati e che questo esito è stata spesso preceduto da una sovraesposizione mediatica dei soggetti in questione… |
Mi sembra un approccio corretto, anche per il ruolo di moral suasion che connota lo strumento in questione, tale da metterlo al riparo da rischi di confusione con regole rigide di tipo censorio, che sarebbero pericolose per le posizioni individuali e contrarie al principio di libertà di manifestazione del pensiero, non a caso ribadito nel contesto dello stesso art.6. Dove piuttosto la relativa previsione mi appare datata è rispetto al settore dei c.d. new media, ed in particolare dei social network, dove è sempre più frequente la presenza di voci di magistrati che esprimono le loro posizioni su provvedimenti legislativi o iniziative del governo o di partiti politici. Per restare ad esempi recenti della nostra vita pubblica, a temi come la nuova modifica della legittima difesa, o alle iniziative sulla chiusura dei porti alle navi delle ONG, o ai più recenti provvedimenti in materia di sicurezza. Anche qui direi che sarebbe impensabile negare al magistrato di intervenire su questi argomenti nel contesto dei social network, per le ragioni prima sinteticamente richiamate, ma al contempo ribadirei quelle esigenze connesse alla “continenza” delle esternazioni che non mi sembrano mutare nel passaggio dai media tradizionali a quelli ormai impostisi nel dibattito collettivo. Sotto questi profilo, mi sentirei di segnalare l’esigenza di un aggiornamento della ricordata norma del codice etico dell’ANM, in modo da espressamente ricomprendere nella sua portata anche i social network, accanto agli “altri mezzi di comunicazione di massa”.
Davide Galliani
Ho utilizzato troppo spazio per rispondere alla prima domanda. Rimedio ora, perché questa seconda la vedo più semplice. Il senso della misura, questo è il cuore del mestiere del giudice, che ne deve dare conto in motivazione. Posso già fermarmi qui: il senso della misura vale anche quando un giudice esterna. E il senso della misura non lo possiamo decidere in termini astratti, validi una volta per sempre. Dipende dai singoli casi, di volta in volta. A volte va bene, a volte meglio sarebbe stato il silenzio. La differenza sta esattamente in quelle quattro parole, il senso della misura.
| … L’unica cosa che mi sembra proponibile in termini generali è quella di utilizzare, sempre, il senso della misura… come il Capo dello Stato, così i giudici, esternando, dovrebbero sempre considerare il senso della misura… | L’unica cosa che mi sembra proponibile in termini generali è quella di utilizzare, sempre, il senso della misura. Il calibro è l’attrezzo che deve regolare le corde vocali di un magistrato, così come la sua penna al di fuori dell’esercizio delle funzioni (figurarsi dentro). Se una virgola o una parola possono arrecare problemi, devi mettere il freno a mano. Vale per i giudici, vale per i pubblici ministeri. |
Poi ci sono le eccezioni, i momenti nei quali è giusto lasciarsi un attimo andare. Non quando si è in pensione, quella è un’altra storia. No, parlo del giudice che esterna quando è in servizio. Erano i fascisti a gridare “me ne frego”. Lo dicesse un giudice gli darei dello sfascista. Non accetto un giudice (e un pubblico ministero) che parlano della mattina alla sera, in televisione, alla radio. Non chiudo le televisioni. Nemmeno le radio! Suggerisco al giudice il contegno, quello che spesso suggerisce alle parti. Al pubblico ministero non saprei, forse serve qualcosa di altro, da suggerire. Ma anche a lui direi solo questo: un attimo di contegno. Detto questo, neppure accetto un giudice che risponde “me ne frego”. Deve dire ciò che pensa, ma con il senso della misura, con il calibro. Tutto qui.
| Una risposta insoddisfacente, la mia. È che censori e cesoie non sono ammessi in democrazia. Oscar Luigi Scalfaro (dalla DC) e Giorgio Napolitano (dal PCI) dissero a Francesco Cossiga, durante gli ultimi due anni del suo settennato: caro Presidente, sei andato oltre il senso della misura. Non per questa o quella tua picconata, ma perché ne hai date tante, servono dieci libri per ricordarle tutte. Una, passi, non si nega a nessuno. Due, forse, ma vacci piano. Decine e decine, no: il senso della misura. Che non dovrebbe essere superato da quella che una volta, tempi lontani, tempi dell’Assemblea Costituente, si chiamava la più alta magistratura morale del paese, il Capo dello Stato. | …Dove piuttosto la relativa previsione mi appare datata è rispetto al settore dei c.d. new media, ed in particolare dei social network, dove è sempre più frequente la presenza di voci di magistrati che esprimono le loro posizioni su provvedimenti legislativi o iniziative del governo o di partiti politici… |
Più o meno ci siamo: come il Capo dello Stato, così i giudici, esternando, dovrebbero sempre considerare il senso della misura. E non per tutelare l’autonomia e l’indipendenza del giudiziario, concetto che mi fa preoccupare, perché presuppone l’esistenza di un potere, che Vaclav Havel voleva avessero i senza potere. No, il senso della misura tutela prima di tutto il singolo mestiere di ogni singolo giudice. Se tutti i giudici (e i pubblici ministeri) usassero il calibro, mai paese avrebbe una magistratura più indipendente e autonoma.
Ad ogni modo, questa seconda domanda, immagino, era riferita a esternazioni, nel senso di interviste, interventi a convegni e via dicendo. Aggiungo uno spunto. Tema: il magistrato e i social network.
Se un magistrato commenta su Facebook l’ultima vittoria della Juventus, tutto bene (vittoria compresa). Dovremmo però concludere che, essendo al di fuori delle funzioni, su Facebook può fare ciò che vuole? Non saprei, certo il Capo dello Stato non mi sembra scriva molto su Facebook. Anche qui, meglio tenere i piedi a terra, piuttosto che elaborare grandi principi, talmente grandi che evaporano in tre secondi. Per ragionare concretamente sul tema, riporto la mia esperienza, di professore universitario. Magari qualche giudice troverà qualche spunto.
Quando uso Facebook mi sono auto imposto due regole. La prima: non concedo l’amicizia ad uno studente. Quando si laurea, è il benvenuto. Prima, anche no, grazie. Rifletto molto su questa regola. A volte grandi discussioni con colleghi (che studiosi!). Potrà sembrare una regola stupida, anche perché in Università ho a che fare con centinaia e centinaia di studenti ogni anno, mentre l’amicizia sul mezzo informatico al massimo mi è stata chiesta da una trentina di studenti.
A qualcuno potrà sembrano pazzesco parlare di queste cose e insieme parlare di giudici. A me, sinceramente, no, perché i giudici mai sono vissuti e mai vivranno sul pianeta Marte. I loro problemi di oggi sono i problemi di oggi, insieme a quelli di ieri. Non vogliamo ragionarci in termini di problemi di responsabilità disciplinare? Sono d’accordissimo, ma cerchiamo in tutti i modi di non arrivarci lì, alla disciplinare.
Ecco il perché (sincero) della prima stupida regola che mi sono auto imposta. Non concedo l’amicizia ad uno studente perché sono un professore. Vi è un qualcosa che mi impone misura, calibro. Sbaglierò, farò bene, non lo so, ma faccio così. Se un giudice decidesse di non dare un’amicizia su Facebook ad un avvocato in fondo lo capirei.
Non voglio essere frainteso. La corruzione è una cosa seria, l’amicizia su Facebook altra cosa. Ci mancherebbe. Ma non lo so, amicizie su Facebook ad uno studente non le concedo: sono un professore. Mi guida l’aneddoto che Isaiah Berlin raccontò a Avishai Margalit. Un uomo fu sorpreso a battere violentemente sopra un bollitore che fischiava. Gli fu chiesto cosa stesse facendo. Rispose che non sopportava le locomotive. Una volta fattogli presente che era di fronte ad un bollitore, non ad una locomotiva, l’uomo disse: “Sì, sì, lo so, ma le devi ammazzare da piccole”.
| … Decida il giudice cosa dire, non si scordi però il calibro, che non hai perché sei giudice, no. Il senso della misura lo devi coltivare prima come persona e poi, se il mestiere ti prende la vita, il gioco è fatto. Se il mestiere non ti ha preso la vita, “Houston…abbiamo un problema”. | Vediamo la seconda regola, sempre auto imposta: prima di commentare e scrivere qualcosa su Facebook penso sempre al mio mestiere. Lo giuro, sempre. E’ un difetto, lo so bene. Ma ci sono dei mestieri che ti prendono la vita, in senso positivo intendo. Leonardo Sciascia diceva che esistono tre mestieri con i quali ci nasci: il cornuto, lo sbirro, il prete. Ieri ho visto a Milano uno striscione: “alpino non diventi, alpino nasci”. Va bene, anche gli alpini. Ma a me sembra che, concorso pubblico permettendo, anche il professore e il giudice siano mestieri per così dire naturali, una volta che sei dentro. Non puoi fare qualsiasi cosa su Facebook e il giorno dopo svegliarti e andare bello e beato in università o in tribunale. |
Se commenti una ricetta di risotto, esprimi tutto il tuo pensiero. Non ti tenere, esprimi tutto ciò che pensi, a dismisura. Se commenti un discorso di un politico, un fatto di cronaca, certo che non stai esercitando le tue funzioni, ma ti dovresti ricordare che il giorno dopo devi andare in aula ad insegnare o a rendere giustizia. Io cerco sempre di usare il calibro, tutto qui. Non così fanno molti: ristoratori, oculisti, massaggiatori, idraulici. Decida il giudice cosa dire, non si scordi però il calibro, che non hai perché sei giudice, no. Il senso della misura lo devi coltivare prima come persona e poi, se il mestiere ti prende la vita, il gioco è fatto. Se il mestiere non ti ha preso la vita, “Houston…abbiamo un problema”.
Di questi tempi, sinceramente, preferisco ragionare in termini di senso della misura piuttosto che in termini di disciplina e onore. Ma certamente sbaglio io, mi preoccupo per niente.
Terza domanda
3) Marta Cartabia, in un suo recente saggio dedicato ad una riflessione a due voci con Luciano Violante su Antigone ed Edipo,individua, ricordando l’esperienza del Guido Calabresi “giudice” di una Corte federale americana, le possibili strade che il giudice deve percorrere per ricercare, reperire e inventare, per dirla con Paolo Grossi, soluzioni che impediscano l’applicazione di pene ingiuste. Quali suggerimenti si sente di dare ai giudici sul tema?
Gaetano Silvestri
Quando la pena si può considerare ingiusta? Le riflessioni di Marta Cartabia toccano il millenario problema dei rapporti tra diritto naturale e diritto positivo. Mi guardo bene dall’addentrarmi in questo mare magnum. Mi limito quindi a qualche rapida osservazione su punti specifici.
La scelta di sanzionare penalmente certi atti o comportamenti appartiene indubbiamente al legislatore. Quest’ultimo tuttavia non è assolutamente libero né quanto ai fini da perseguire – che devono poter essere ricondotti, direttamente o indirettamente, ad un principio costituzionale – né quanto alla misura delle pene, Ormai da tempo la giurisprudenza del giudice delle leggi ha individuato nel secondo comma dell’art. 25 il fondamento costituzionale del principio di offensività. Parlare di tale principio significa implicitamente riconoscere che deve esservi una ragionevole proporzione tra l’atto o il comportamento incriminato e la risposta repressiva dell’ordinamento. Nessun dubbio quindi che si debbano ritenere contrarie alla Costituzione scelte incriminatrici non rispondenti alla tutela di un bene oggetto di un diritto, individuale o collettivo. Nessun dubbio altresì che la pena debba essere commisurata alla gravità della violazione.
| Il problema sorge nell’individuazione del giusto equilibrio tra discrezionalità del legislatore e controllo di proporzionalità e di ragionevolezza. Quest’ultimo non spetta solo alla Corte costituzionale, ma a tutti i giudici, non foss’altro perché gli stessi sono tenuti all’interpretazione costituzionalmente orientata e, in caso di ostacoli testuali insormontabili, a sollevare questione di legittimità costituzionale. | … Il problema sorge nell’individuazione del giusto equilibrio tra discrezionalità del legislatore e controllo di proporzionalità e di ragionevolezza. Quest’ultimo non spetta solo alla Corte costituzionale, ma a tutti i giudici,… |
Come è noto, la giurisprudenza della Corte costituzionale è sempre più orientata ad eliminare gli automatismi in materia penale, ritenendo, a mio avviso giustamente, che, fermo il principio di legalità, la rigidità dell’effetto automatico sia inconciliabile con l’aderenza della misura della pena o del provvedimento restrittivo alla concreta situazione, oggettiva e soggettiva, emergente dal caso sottoposto alla valutazione del giudice. Esempio di questo progressivo avanzamento è la recente sentenza n. 222 del 2018, che trasforma una pena accessoria prevista in misura fissa dal legislatore in una pena che può essere modulata dal giudice entro un tetto massimo stabilito dalla legge. Del resto, anche quest’ultima pronuncia della Corte conferma quanto si osservò anni addietro, a proposito delle famose “rime obbligate”: se le rime sono obbligate, i versi sono liberi!
| …Non mi accodo a quanti si strappano le vesti per la “novità” procedurale introdotta da questa pronuncia. Da più di sessant’anni la Corte va avanti e la dottrina “rigorosa” si strappa le vesti. Forse verrà il momento in cui non ci saranno più vesti da strappare… | Ancora più significativo mi sembra il caso della decisione della stessa Corte sul reato di aiuto al suicidio. Non mi accodo a quanti si strappano le vesti per la “novità” procedurale introdotta da questa pronuncia. Da più di sessant’anni la Corte va avanti e la dottrina “rigorosa” si strappa le vesti. Forse verrà il momento in cui non ci saranno più vesti da strappare e prevarrà l’idea che il principale dovere del giudice delle leggi è apprestare tutela a beni costituzionalmente protetti, anche introducendo innovazioni nelle pieghe delle norme processuali vigenti, allo scopo di massimizzare il suo ruolo di custode dei princìpi costituzionali. Sarebbe illusorio aspettare innovazioni legislative in materie che non suscitano immediatamente emozioni nel pubblico. Anche se poi le conseguenze dei mancati interventi possono provocare le stesse emozioni. |
Per tornare al caso di cui sopra – e riallacciandomi ancora al Quesito n. 1- mi sembra che l’ordinanza n. 207 del 2018 contenga affermazioni di grande rilievo dal punto di vista etico, prima che giuridico, che si possono ricondurre a due fondamenti della cultura contemporanea della libertà: a) la tutela della «persona umana come valore in sé e non come […] semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi»; b) la dignità della persona medesima, non come frutto di condizioni imposte, ma come effetto della propria libera autodeterminazione. Si tratta, come appare evidente, di due valori collegati, che assumono la veste giuridica di princìpi per effetto della costituzionalizzazione dei valori dominanti nell’epoca del primato della persona sullo Stato e del pluralismo culturale.
| Non si tratta certo di valori universali ed eterni, scolpiti nel cuore dell’uomo o insiti in visioni religiose o comunque trascendenti della vita, ma di quel giusnaturalismo storico, di cui parla Norberto Bobbio, che riflette un certo tipo di civiltà sempre più condivisa, dopo gli orrori del XX secolo. Sarebbe troppo ottimistico pensare che questi valori di civiltà siano ormai incontrastati. Tutt’altro, come l’esperienza contemporanea ancora ci dimostra. L’importante è che ci rendiamo conto che tutela della persona e della sua dignità sono opzioni epocali, che implicano scelte responsabili, individuali e collettive. Né il valore della libertà può essere confuso con una ideologia di individualismo estremo, contraria all’ideale, altrettanto forte, della solidarietà. In tali valori i nostri Padri costituenti hanno creduto e li hanno trasformati in princìpi costituzionali. Gli stessi emergono nel faticoso processo di formazione di una Costituzione europea. | … tutela della persona e della sua dignità sono opzioni epocali, che implicano scelte responsabili, individuali e collettive… |
Attenzione! Non si tratta di scelte oggettivamente irreversibili, Per questo occorrerebbe evitare di irridere ai valori, facendo ricorso ad alibi pseudoscientifici, con il rischio di essere tragicamente…accontentati!
| … se la legge non è affetta da un semplice vizio di legittimità costituzionale, ma colpisce gangli importanti del sistema di libertà, di uguaglianza e di democrazia … se ancora le istituzioni costituzionali di garanzia non vogliono, o non possono, intervenire tempestivamente, non si può pretendere dai cittadini un atteggiamento passivo in attesa di tempi migliori… | Se si prende atto del capovolgimento storico, che ha sostituito il fondamento di valore al fondamento di autorità dello Stato, si deve trarre la conseguenza che oggi il problema non è quello del diritto naturale, ma, al contrario quello del diritto “non naturale”, come aveva ben capito un geniale – ma purtroppo poco conosciuto – filosofo del diritto, Rodolfo De Stefano, che ha insegnato nell’Università di Messina. Come può avere validità una legge contraria ai princìpi fondamentali, che stanno alla base del potere degli stessi organi che l’hanno approvata e promulgata? Ciò può di fatto avvenire, ma solo per il periodo che separa la sua entrata in vigore e la dichiarazione di illegittimità costituzionale. Ma – come diceva Temistocle Martines molti anni addietro – se viene dichiarata l’incostituzionalità di una legge, implicitamente viene affermata l’incostituzionalità dell’indirizzo politico che l’ha generata. |
| Mi permetto di aggiungere che se la legge non è affetta da un semplice vizio di legittimità costituzionale, ma colpisce gangli importanti del sistema di libertà, di uguaglianza e di democrazia – che la maggior parte dei popoli ha abbracciato dopo la fine della seconda guerra mondiale – se ancora le istituzioni costituzionali di garanzia non vogliono, o non possono, intervenire tempestivamente, non si può pretendere dai cittadini un atteggiamento passivo in attesa di tempi migliori. Locke parlava di “appello al cielo”, altri parlano di diritto di resistenza. Il fatto che tale diritto non sia stato incluso nella Costituzione – al di là delle motivazioni specifiche emerse dal dibattito in Assemblea costituente – non fa venir meno la possibilità che, in casi estremi, il popolo possa esercitarlo. Si tratterebbe di una “rivoluzione per la legalità”, quella legalità superiore che ha sconvolto le classificazioni della versione quietista del positivismo giuridico. Se ciò avvenisse, chi sarebbe l’eversore, il popolo o lo Stato? | … Locke parlava di “appello al cielo”, altri parlano di diritto di resistenza… |
Vincenzo Militello
| Il bel libro di Cartabia e Violante è ricco di spunti colti e stimolanti una visione non formalistica del diritto. Temo però che la praticabilità di soluzioni innovative per comporre l’eterna dialettica fra diritto positivo e giustizia non può che fare i conti con il contesto ordinamentale in cui si colloca la questione. Non è un caso che il riferimento operato è a un giurista che opera in una corte di un sistema di common law, dove inevitabilmente il formante giurisprudenziale assume un peso specifico e un ruolo di stimolo diverso dei sistemi a diritto codificato e di civil law. |
…Se mi sforzo di pensare ad un possibile strumento per affrontare il problema (come possa il giudice evitare l’applicazione di pene ingiuste) posto dalla domanda, almeno in relazione al nostro ordinamento, così come in ordinamenti consimili di civil law, mi pare che la soluzione meno fantasiosa – sebbene non priva di incognite – si rinvenga in quella che viene usualmente indicata come “formula di Radbruch… La proposta di Radbruch è quella di rispettare la legalità, salvo che il contenuto di ingiustizia di essa raggiunga un livello “insopportabile”. |
Non trascuro che nei due sistemi da tempo affiorano sempre più spesso note che li avvicinano reciprocamente, tanto che si potrebbe rintracciare una sorta di disgelo fra i due blocchi rispettivi di principi e regole ordinamentali. Al netto però del dato che il comune riconoscimento delle carte dei diritti umani costituisce un importante trait d’union fra ordinamenti appartenenti a diverse famiglie giuridiche, ritengo che le modalità per la relativa concretizzazione nel diritto vivente debba comunque essere in linea con i caratteri di fondo dei rispettivi sistemi giuridici.
Se mi sforzo di pensare ad un possibile strumento per affrontare il problema (come possa il giudice evitare l’applicazione di pene ingiuste) posto dalla domanda, almeno in relazione al nostro ordinamento, così come in ordinamenti consimili di civil law, mi pare che la soluzione meno fantasiosa – sebbene non priva di incognite – si rinvenga in quella che viene usualmente indicata come “formula di Radbruch”. Essa prende il nome del giurista tedesco Gustav Radbruch, penalista e filosofo del diritto tedesco della prima metà del secolo scorso, che fu Ministro di Giustizia durante la Repubblica di Weimar, e che dopo la tragica parentesi del nazionalsocialismo, durante il quale fu costretto a “vivere nelle catacombe” (come gli scrisse Thomas Mann, in una corrispondenza epistolare conservata nella casa – oggi museo – dei Mann a Lubecca), tornò all’insegnamento e riprese a partecipare al dibattito pubblico. In un suo scritto del 1946 il cui titolo “legge ingiusta e giustizia sovralegale” sintetizza il contrasto posto dalla domanda qui esaminata e la cui gravità era stata sperimentata negli anni del nazismo, si prospetta una soluzione che cerca di aprire una via al giudice costretto ad applicare norme anche penali che sono in contrasto con il suo senso di giustizia, pur nel rispetto di un sistema di sottoposizione del giudice alla legge. La proposta di Radbruch è quella di rispettare la legalità, salvo che il contenuto di ingiustizia di essa raggiunga un livello “insopportabile”.
L’idea di Radbruch ha avuto una sua fortuna nella riflessione collettiva e anche nella giurisprudenza successiva, non tanto nel dibattito connesso all’attività del tribunale di Norimberga, dove le conclusioni di condanna furono ricavata da una accezione di “rule of law” chiaramente influenzata dalla visione dei sistemi di “common law” (il che ne ha sempre comportato la connotazione come frutto di una “giustizia dei vincitori”), quanto piuttosto nella stessa storia giudiziaria successiva, quella cioè della Germania riunificata, quando venne utilizzata per giustificare le condanne nei confronti dei militari che avevano ordinato di sparare ai cittadini che tentavano di fuggire da Berlino est attraversando il muro. Non è questa la sede per esaminare nel dettaglio la tenuta in quel contesto del richiamo alla formula di Radbruch, e del resto chi fosse interessato può trovare un prezioso approfondimento nell’ultimo libro del nostro Giuliano Vassalli, che egli dedicò -all’età di 85 anni ma con entusiasmo giovanile - proprio al tema dei riflessi sul diritto penale della formula in questione.
| … Il punto che mi preme sottolineare è piuttosto quello direttamente attinente alla domanda in esame, ma anche di portata formidabile quanto a rilevanza sistematica. Si tratta cioè di cogliere l’indeterminatezza di quella soglia di “ingiustizia insopportabile” che legittimerebbe una ipotetica “disobbedienza del giudice” all’applicazione della legge… | Il punto che mi preme sottolineare è piuttosto quello direttamente attinente alla domanda in esame, ma anche di portata formidabile quanto a rilevanza sistematica. Si tratta cioè di cogliere l’indeterminatezza di quella soglia di “ingiustizia insopportabile” che legittimerebbe una ipotetica “disobbedienza del giudice” all’applicazione della legge. Troppo incerto essendo infatti il canone soggettivo definito dal singolo giudice, non rimarrebbe che affidarsi ad una soglia da definire in termini oggettivi, e dunque pur sempre definiti dall’ordinamento giuridico considerato. |
Se così è, la soluzione in questione non potrebbe che rifarsi o a carte sovranazionali di diritti fondamentali o alla stessa Costituzione, in un caso e nell’altro incanalando dunque la valutazione di ingiustizia non nei pur sempre “incerti sentieri del diritto naturale”, ma nel quadro degli strumenti di valutazione formalizzati dall’ordinamento di appartenenza, sia pure modernamente inteso in chiave “multilivello”.
Davide Galliani
| Domanda bellissima, difficilissima. Antichissima, attualissima. Lo stupendo libro di Guido Calabresi, Il mestiere di giudice, mi ricorda il non meno bello di Leonardo Sciascia, Porte aperte. Il piccolo giudice del maestro di Regalpetra – che contesta in termini di principio la pena di morte, che per il fascismo avrebbe dovuto permettere alle persone di dormire con le porte aperte – riesce a non condannare a morte. Il piccolo giudice, davvero il nostro piccolo giudice, era Salvatore Petrone, di Regalpetra come Sciascia. La storia è vera, tremendamente vera. |
… Lo stupendo libro di Guido Calabresi, Il mestiere di giudice, mi ricorda il non meno bello di Leonardo Sciascia, Porte aperte… |
Per farla breve. Come il Re Salomone, al centro della riflessione di Marta Cartabia in Giustizia e mito, anche il piccolo giudice di Sciascia non si ferma al contesto. Non si fa influenzare. Non si fa intimidire, dal fascismo. Insomma, non ci sta, vuole scavare e scavare, andare a fondo, perché il suo principio è contro la pena di morte. Riesce a non condannare a morte. Convince la giuria che i reati non erano in continuazione. Proprio così, due o più ergastoli, per reati in continuazione, avevano una pena: quella di morte. Era il Codice penale di allora…in questo oggi cambiato.
Alla fine della storia, il pubblico ministero fa questo ragionamento, al giudice: lo sai bene che hai solo prolungato lo strazio del condannato (alla pena perpetua), perché la tua sentenza sarà impugnata, la Cassazione riformerà, il collegio del rinvio farà quello che tu non hai fatto.
Ecco la riposta del piccolo giudice, piccolo per i grandi problemi che aveva di fronte: “E’ vero che in me la difesa del principio ha contato più della vita di quell’uomo. Ma è un problema, non un alibi. Io ho salvato la mia anima, i giurati hanno salvato la loro: il che può anche apparire molto comodo. Ma pensi se avvenisse, in concatenazione, che ogni giudice badasse a salvare la propria”.
E’ tutta scritta qui dentro la risposta che vorrei tentare di dare a questa terza domanda. In concatenazione, risponde il piccolo giudice al pubblico ministero. Io salvo la mia anima perché sono contrario alla pena di morte, non condanno a morire per pena. Chi lo ha detto che così non possano e non debbano fare anche tutti gli altri giudici, in concatenazione?
| … Il libro di Guido Calabresi è di una profondità straordinaria. Quando il mestiere del giudice e quello del professore si fondono, ecco il miracolo laico di un libro davvero profondissimo. | Il libro di Guido Calabresi è di una profondità straordinaria. Quando il mestiere del giudice e quello del professore si fondono, ecco il miracolo laico di un libro davvero profondissimo. La stessa cosa identica rispetto a Marta Cartabia e alla sua riflessione con Luciano Violante. |
Faccio presente un’altra cosa. Guido Calabresi si domanda cosa farebbe se per legge dovesse condannare a morte. Mai gli è capitato. Ne è contento. Ma potrebbe capitare, quindi ragiona su come potrebbe muoversi. Una delle sue ipotesi è la seguente: mi dimetto da giudice. Rinuncio alla carriera. Don Milani avrebbe avuto un sussulto di gioia nel leggere questa risposta.
Guido Calabresi, in ogni caso, non ritiene che sia la più persuasiva. Anzi non la ritiene giusta, ma il suo è un discorso che vuole affrontare tutte le ipotesi, senza in realtà arrivare ad una conclusione vera e propria. Infatti, questa è la sua conclusione. Spero di non doverlo mai fare, quando sarà il caso deciderò cosa fare: “si fa il proprio meglio e si chiede perdono”, è la conclusione del libro. Ma l’ipotesi è in discussione: mi dimetto da giudice.
| La pena di morte esiste nel tuo paese da sempre. Il caso non lascia dubbi: devi pronunciare la morte per pena. Non penso valga dire che ad uccidere è il boia. Troppo facile. Un giudice che se ne lava le mani (il “me ne frego”) è un giudice che si dimentica la sua coscienza, abbastanza vicino ad un giudice che non ha capito niente del suo mestiere. Che sia libero convincimento, che sia oltre ogni ragionevole dubbio, un giudice decide coscientemente. In ogni caso, Guido Calabresi, che di coscienza ne ha da vendere, discute l’ipotesi dimissioni e alla fine, da “combattente” quale è (da giudice quale è) fa capire che non sarebbe la sua. | … La pena di morte esiste nel tuo paese da sempre. Il caso non lascia dubbi: devi pronunciare la morte per pena. Non penso valga dire che ad uccidere è il boia. Troppo facile. Un giudice che se ne lava le mani (il “me ne frego”) è un giudice che si dimentica la sua coscienza, abbastanza vicino ad un giudice che non ha capito niente del suo mestiere… |
Parliamone, noi. Il politico dovrebbe comportarsi diversamente. Non perché deve avere qualità sovrannaturali, ma perché ha scelto nella vita di fare il politico. Se il suo partito lo obbliga a votare una legge che introduce la pena di morte e il prezzo da pagare, non votandola, è uscire dal partito, non vedo altre opzioni. Non per forza finisce la carriera, magari quel gesto ne apre un’altra. E poi c’è sempre il gruppo misto. Ma, insomma, non è che in Parlamento i principi devono evaporare, insieme alle coscienze: si dimetta dal partito, il politico-partitico.
| … Il giudice, a mio modo di vedere, non dovrebbe dimettersi, ma dovrebbe correre il rischio di non fare più carriera… | Il giudice, a mio modo di vedere, non dovrebbe dimettersi, ma dovrebbe correre il rischio di non fare più carriera (esattamente il rischio corso da Salvatore Petrone). Provo a spiegarmi. Conosco moltissimi giudici (anche qualche pubblico ministero) che non sono favorevoli alla pena dell’ergastolo. Ma esiste la legge. Cercasti giustizia, trovasti la legge, canta il poeta. Quindi? I giudici contrari all’ergastolo dovrebbero rischiare tutto quello che possono rischiare. Dopo, tiri i remi in barca, senza arrivare alle dimissioni. Ma devi fare tutto quanto puoi fare, per dire poi “le dimissioni no, non me la sento”. Concretamente, cosa significa? |
Primo. Sollevi la questione di costituzionalità. Secondo. Ti batti, sulle riviste che affrontano temi giuridici, per introdurre nel nostro ordinamento le opinioni separate. Vuoi fare sapere a tutti che tu non hai votato per quella pena, la pena perpetua. Come fai? Il mezzo esiste. Si chiama opinione separata. Pena di morte, ergastolo, si pensi ai temi eticamente sensibili. Le occasioni non mancano. Non è che in Italia le cose giuste si facciano in tre minuti. Probabile che le opinioni separate aspettino anni, se non decenni. E allora, terzo, il giudice, nella associazione alla quale è iscritto e nella corrente alla quale appartiene, intavola discussioni, progetta tavole rotonde, discute con i suoi colleghi del problema che lo affligge. Non discute di carriera, per andare chissà dove. Discute di quella corriera di problemi che sente dentro. E’ contrario alla pena perpetua, la giurisprudenza costituzionale la pensa diversamente, la legge è chiara, non riesce a capire cosa fare.
La speranza è l’ultima a morire. Magari la corrente comprende l’importanza delle opinioni separate, che certo non risolvono tutti i problemi, ma altrettanto certamente permettono, almeno, di fare sapere che hai votato contro. Se voti contro e la decisione è comunque unanime, per via della bellissima segretezza della camera di consiglio, non ti rimane che andare a dire il tuo voto alla persona condannata o scrivere un articolo sul giornale. Non grandi possibilità, a fronte della possibilità di mettere nero su bianco perché tu non hai concorso al voto per quella pena che ritieni contraria al senso di umanità. Che fai, altrimenti, ti appelli alla bontà di turno del presidente del collegio di turno, chiedendo almeno di non fare il redattore, dopo che hai perso da relatore? Tutto qui, non pare pochino?
Non mi pare chiedere moltissimo. Sollevi questione di costituzionalità, va male. Fai comprendere che sei favorevole alle opinioni separate, proprio per scrivere perché voti contro, per dare conto, come sempre deve fare un giudice. Scrivi un articolo, un post su una rivista che tratta di diritto, qualcosa insomma, così come condividi il tuo pensiero nella corrente, che è (o dovrebbe essere) momento di condivisione di questioni problematiche, per non fare appassire un senso di appartenenza a ideali e principi. Ecco, dopo che hai fatto tutto questo, sfiancato come pochi, puoi dire: ho fatto quel che dovevo, non posso però dimettermi.
Se fossi un giudice di fronte ad una pena che ritengo ingiusta, questo farei. E non avrei in realtà nemmeno il problema del piccolo giudice di Sciascia. Lui sì ha fatto tutto quello che ha fatto, mettendo seriamente a rischio la carriera: l’ammonimento che propose il Presidente della Corte di appello venne rifiutato da Arrigo Solmi, il Guardasigilli di Mussolini. Oggi andrebbe in modo differente: al massimo dicono che sei un rompiscatole, ma un ammonimento anche no. Anche per questo non dovresti fare calcoli e calcolini: non dico di dimettersi, di fronte alla pena ingiusta, ma fare di tutto, fino a sentirsi dire che sei un rompiscatole. Non dovresti neppure rischiare la carriera, in teoria. In pratica, rischi di ritardarla? Corri il rischio, hai scelto di fare il giudice, non il carrierista.
La terza domanda di Giustizia Insieme termina chiedendo quali suggerimenti dare ai giudici italiani. Una domanda che, una cinquantina di anni fa, sarebbe suonata del tutto fuori luogo, così come la Scuola di Formazione della Magistratura, invenzione italica che ti rendono fiero di essere italiano.
| Ad ogni modo, mi pronuncio sul chiesto, con umiltà, pari alla sincerità. Questo farei se fossi un giudice che si trova di fronte ad una pena che ritiene ingiusta. Mi batterei con gli strumenti a disposizione. Con il diritto per lo Stato di diritto, cercando di essere creativo, innovativo, non burocratico, non quantitativo. Mi guarderei a destra, a sinistra, in alto, in basso. Cercherei di inventare qualcosa nel diritto per il diritto. | …. Questo farei se fossi un giudice che si trova di fronte ad una pena che ritiene ingiusta. Mi batterei con gli strumenti a disposizione. Con il diritto per lo Stato di diritto, cercando di essere creativo, innovativo, non burocratico, non quantitativo. Mi guarderei a destra, a sinistra, in alto, in basso. Cercherei di inventare qualcosa nel diritto per il diritto… |
Elvio Fassone mi ha insegnato una cosa straordinaria. Altro non poteva fare un uomo straordinario. Tendo a vedere in ogni caso un gigantesco problema giuridico. Lui mi dice che, in realtà, esistono anche casi un attimo semplici. A volte il diritto è dritto, la strada è chiara. Se lo dice lui, chiunque si fiderebbe, io per primo.
Dico questo perché questa terza domanda parla di pene ingiuste. Non è che ogni giorno, la mattina, il pomeriggio, la sera, il giudice deve scrivere questioni di costituzionalità, rinvii pregiudiziali, interpretazioni le più sofisticate al mondo. Esiste una attività un attimo più lineare. In questi casi, non vi è bisogno di utilizzare arsenali atomici. Negli altri casi, però, ove ci si pone il problema di coscienza e di principio (pena perpetua, carcere duro, ossimori; fossi un giudice, qualsiasi automatismo sanzionatorio lo vivrei come usurpazione del mestiere), ecco quello che posso suggerire: il giudice usi passione, intelligenza, coraggio, voglia di realizzare un mondo migliore, che significa realizzarsi prima di tutto noi stessi, come persone migliori.
| … La burocratizzazione e la quantitativizzazione delle Università, degli Ospedali e della Giustizia è un disastro. E’ il disastro, la famosa madre di tutti i nostri problemi. Sta partorendo professori, medici e magistrati che perdono la passione per il loro mestiere, che senza passione diviene un lavoro… | La burocratizzazione e la quantitativizzazione delle Università, degli Ospedali e della Giustizia è un disastro. E’ il disastro, la famosa madre di tutti i nostri problemi. Sta partorendo professori, medici e magistrati che perdono la passione per il loro mestiere, che senza passione diviene un lavoro. Nessun eccesso. Nessuna rivoluzione. Tutto dentro il diritto, tutto per il diritto. Si prenda carta e penna e si faccia quel che si deve, poi accada quel che accadrà. Vero che la dottrina dovrebbe aiutare di più i giudici, magari pubblicando qualche articolo con allegata una questione di costituzionalità, non dico bella e pronta, ma quasi. Lo dobbiamo fare, non vi è dubbio. Ma anche quando lo facciamo, spesso troviamo magistrati manager, burocrati, standardizzati, stanchi. Il mestiere del giudice, di fronte alle pene ingiuste, non lo si può fare in questo modo. Mai dovrebbe andare così, meno che mai di fronte ad una pena ingiusta. |
Nessun eccesso. Nessuna rivoluzione. Tutto dentro il diritto, tutto per il diritto. Si prenda carta e penna e si faccia quel che si deve, poi accada quel che accadrà. Vero che la dottrina dovrebbe aiutare di più i giudici, magari pubblicando qualche articolo con allegata una questione di costituzionalità, non dico bella e pronta, ma quasi. Lo dobbiamo fare, non vi è dubbio. Ma anche quando lo facciamo, spesso troviamo magistrati manager, burocrati, standardizzati, stanchi. Il mestiere del giudice, di fronte alle pene ingiuste, non lo si può fare in questo modo. Mai dovrebbe andare così, meno che mai di fronte ad una pena ingiusta.
È giustissima la battaglia di alcuni giudici per avere diritto a delle ferie serie e in serie. Si differenzi, non tutte le scadenze per depositare le motivazioni sono eguali. Va bene, battaglia giusta, un giudice che solleva la quaestio un giudice prima o poi lo trova. Per ora, il giudice (amministrativo) non ha sollevato, ha rinviato al CSM, il quale rinvia ai Presidenti, i quali rinviano allo spirito santo. Non è che il migliore rinvio sarebbe quello alla Consulta, specie visto cosa hanno scritto i giudici per negare il giusto rinvio?
Tipico esempio, non certo unico: il giudice spiega talmente perché non è incostituzionale una legge, che fa diventare chiarissimo il dubbio di costituzionalità, così come disse Piero Calamandrei, nel 1956, a fronte delle Sezioni Unite penali che non rinviarono alla Consulta l’ergastolo (allora per legge) senza condizionale. Non era un grandissimo avversario dell’ergastolo. Leggendo perché le Sezioni Unite non avevano rinviato, Piero Calamandrei cambiò opinione.
Un po’, distanze siderali evidentissime, quello che a me è capitato leggendo il Consiglio di Stato sulla questione ferie (Sez. 5, 11 ottobre 2018. n. 2719). Non mi appassionava, trenta giorni non sono sessanta, ma nemmeno tre. Poi però ho letto e la questione di costituzionalità è evidente.
Ma, se andrà in porto, ogni giorno che si guadagnerà in ferie ad agosto, lo si utilizzi poi a settembre per ritrovare passione per il mestiere. Trovo drammatico leggere che tanti giudici vanno in pensione prima dell’età anagrafica, usando quella funzionale. Accade anche in Università. Non è la certificazione che la passione è esaurita, che sta vincendo la logica burocratico-quantitativa? Non è un SOS collettivo, un Save Our Souls, al quale dobbiamo rispondere?
Ovvio che ci saranno (ci sono!) giudici favorevoli alla pena perpetua, per i quali il carcere duro è una passeggiata, gli automatismi fanno comodo. Ma il diritto va avanti, non si può fermare. Le idee minoritarie di oggi, prima o poi, diventeranno maggioritarie domani. E domani le nuove idee minoritarie metteranno le basi per diventare, dopo, a loro volta, maggioritarie. E così via, così è sempre andato il mondo. Franco Basaglia diceva che le minoranze non vinceranno mai, ma quando persuadono è la più grande gratificazione che possano ottenere.
Dal punto di vista creativo, non vi è nulla di più pericoloso della sicurezza: così la scrittrice Jumpa Lahiri, In altre parole. E cosa pensiamo che sia il mondo, un insieme di persone che lo abitano e, dopo un poco di tempo, si salutano, così come sono arrivati se ne vanno? Oppure qualcosa da creare e ricreare ogni giorno, cercando ognuno di lasciare la propria impronta, piccola o grande che sia?
Vado verso la fine con Luigi Saraceni. Potrei richiamare Dante Troisi, Giuseppe Pera, Sonia Sotomayor, Alberto Marcheselli e tantissimi altri. Giudici che, ad un certo momento, hanno deciso di scrivere un libro sul mestiere del giudice. Metterei come obbligo, a fine carriera, per ogni giudice, quello di scrivere sul mestiere del giudice. Così si fa altrove, senza obbligo di doverlo fare.
| Scelgo Un secolo e poco più di Luigi Saraceni. Un libro fuori dal normale, che oggi mi sembra un grande complimento. In cosa consiste l’essenza del mestiere del giudice? Ecco la risposta: “In questo spazio tra leale interpretazione della legge e fedele ricostruzione del fatto, fare giustizia richiede passione civile, senza la quale il mestiere di giudice rischia di diventare burocratica routinaria applicazione della legge. (…) Nel mestiere del giudice succede quasi sempre: ti passa davanti tanta umanità, ti intrometti in un pezzo più o meno importante della vita degli altri, poi non ne sai più nulla, spariscono”. Eccezionale riassunto, di cosa deve e non deve fare il giudice che fa il suo mestiere. | …In questo spazio tra leale interpretazione della legge e fedele ricostruzione del fatto, fare giustizia richiede passione civile, senza la quale il mestiere di giudice rischia di diventare burocratica routinaria applicazione della legge. (…) Nel mestiere del giudice succede quasi sempre: ti passa davanti tanta umanità, ti intrometti in un pezzo più o meno importante della vita degli altri, poi non ne sai più nulla, spariscono… |
| … Quando ho finito di leggere Un secolo e poco più, mi è venuto in mente Nino Caponnetto. A 35 anni, in magistratura da appena un anno, da pretore di Prato, fu il primo giudice in Italia a sollevare una questione di costituzionalità, il 27 dicembre 1955… | Quando ho finito di leggere Un secolo e poco più, mi è venuto in mente Nino Caponnetto. A 35 anni, in magistratura da appena un anno, da pretore di Prato, fu il primo giudice in Italia a sollevare una questione di costituzionalità, il 27 dicembre 1955. Ringrazio Elisabetta Lamarque con la quale ne ho parlato. Oggi sarebbe sicuramente manifestamente inammissibile: erano tre capoversi che non riempivano mezza pagina.
Cosa dice il pretore di Prato? Non ignora, l’orientamento prevalente della Cassazione (lo conosce). Considera, che a questo orientamento si è giunti dopo diversi contrasti, non del tutto sopiti (che novità). Ritiene, che la materia sia quanto meno controversa: una persona, al mercato, con megafono, cercava di “attirare” altre persone alla propria bancarella, senza aver chiesto licenza all’autorità locale di pubblica sicurezza (come dargli torto?). |
Tre passaggi velocissimi: non ignora, considera, ritiene. Ecco tutta la quaestio del pretore di Prato, che accoglie (particolare importante) l’eccezione sollevata dalla parte:
“Ritenuto altresì che risponde ad un superiore interesse di Giustizia sollecitare ed ottenere dalla Suprema Corte Costituzionale, testè entrata in funzione, un sicuro e definitivo giudizio, circa la legittimità costituzionale della norma in oggetto”.
Di conseguenza, delibera di sospendere “a tempo indeterminato” il procedimento e rimette gli atti alla Corte costituzionale. Chiuso, finita, la questione è fatta.
Da lì è iniziato tutto: giudici e giudici costituzionali a fare Giustizia Insieme.
Dopo anni e anni, infaticabile, coraggioso, non più in servizio, Nino Caponnetto ha iniziato a girare l’Italia con la Costituzione in mano, insegnando a tutti cosa significa la parola magica, che tutto racchiude, se la comprendi bene: “Legalità vuol dire, non dimentichiamolo mai, rispetto della persona umana. Rispetto della persona umana, chiunque sia. (...). Porre la persona umana al centro dell’universo. Ecco quello che io credo essere il senso profondo della legalità”.
Quando ci ha lasciati, sulla toga due rose, una rossa e una bianca. A Palazzo Vecchio e in Chiesa, nessun rappresentante del governo. Molti colleghi, qualche professore, tanta gente comune, a sentire Don Luigi Ciotti che gridava: “non è finita, noi continueremo”. Da dove tutto è iniziato. Ecco da dove:
Ordinanza emessa il dì 27 dicembre 1955 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Catani Enzo di Giov. Battista.
IL PRETORE
Pur non ignorando come il prevalente orientamento della Corte Suprema suoni in favore della legittimità costituzionale dell’art. 113 del testo unico leggi di pubblica sicurezza in rapporto all’art. 21 della Costituzione.
In considerazione del fatto che a tale orientamento si è pervenuti dopo una serie di contrastanti giudicati, quali tuttora non di rado seguitano a provenire da magistrature di merito.
Ritenuto pertanto che, vertendosi in materia quanto meno controversa, non possa qualificarsi come “manifestamente infondata” a norma dell'art. l della legge 9 febbraio 1948, n. l, l’eccezione sollevata dal difensore.
Ritenuto altresì che risponde ad un superiore interesse di Giustizia sollecitare ed ottenere dalla Suprema Corte Costituzionale, testè entrata in funzione, un sicuro e definitivo giudizio, circa la legittimità costituzionale della norma in oggetto.
Letto ed applicato l'art. l della legge 9 febbraio 1948, n. l.
Delibera di sospendere a tempo indeterminato il presente procedimento e che siano rimessi gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione a norma delle disposizioni in materia.
Del che è verbale - Chiuso alle ore 12,10.
Il pretore: A. CAPONNETTO
Il cancelliere: G. CUTULI
3. Le repliche.
Gaetano Silvestri
Non ho molto da “replicare” agli acuti interventi di Davide Galliani e Vincenzo Militello, che in gran parte condivido Solo due brevissime considerazioni aggiuntive a quanto ho detto nelle mie risposte.
| Decidere tra interpretazione conforme e questione di legittimità costituzionale è il frutto della combinazione tra due responsabilità che gravano sul giudice, nel suo preliminare controllo di costituzionalità: quella verso le parti e quella verso l’ordinamento. Valuterà il giudice, di volta in volta, se l’interpretazione conforme si può ottenere con un processo ermeneutico semplice e lineare, oppure se si devono operare, per giungere allo stesso fine, troppe forzature. Ciò per poter preconizzare – con un minimo di attendibilità – che anche la maggioranza degli altri giudici giungerà alle medesime conclusioni. Se invece l’interpretazione conforme si presentasse come il frutto di complicate, se non addirittura tortuose, riflessioni personali, allora non sarebbe ragionevolmente prevedibile che molti altri giudici seguano lo stesso percorso. Nel primo caso, la responsabilità verso le parti non rischierebbe di compromettere quella verso l’ordinamento, giacché la diffusione prevedibile dell’interpretazione conforme si unirebbe all’immediatezza di tutela che la stessa assicura. Nel secondo, il giudice risolverebbe il caso secondo la sua coscienza di custode della Costituzione, ma lascerebbe probabilmente al loro destino molti altri cittadini alle prese con problemi simili. Non è un confronto facile; può essere angoscioso. Ma il mestiere del giudice non consente la tranquillità burocratica! | … Decidere tra interpretazione conforme e questione di legittimità costituzionale è il frutto della combinazione tra due responsabilità che gravano sul giudice, nel suo preliminare controllo di costituzionalità: quella verso le parti e quella verso l’ordinamento. Valuterà il giudice, di volta in volta, se l’interpretazione conforme si può ottenere con un processo ermeneutico semplice e lineare, oppure se si devono operare, per giungere allo stesso fine, troppe forzature… |
Quando vengono lesi i princìpi supremi il giudice dovrebbe esperire tutti i mezzi istituzionalmente utilizzabili per trovare un rimedio efficace. Se ciò non fosse possibile, egli rimarrebbe solo con la sua coscienza. Non pretendo di dare giudizi sulle debolezze umane, alle quali certamente non mi sento estraneo. Mi limito a dire che un imperativo etico, ma anche giuridico – a livello di macrolegalità – dovrebbe indurre il giudice, quanto meno, ad abbandonare la toga. Non è possibile infatti restare inerti di fronte all’abbattimento dei pilastri che sorreggono lo stesso esercizio della giurisdizione. Ma si sa, le vie dell’autogiustificazione sono infinite…
4. Le conclusioni.
Roberto Giovanni Conti
La tentazione di chiudere l’intervista con le parole dei tre intervistati è forte, tanto dense risultano le risposte offerte al pubblico dei lettori.
Solo per contornarne il senso e la portata può essere forse utile qualche riflessione estravagante sul tema della disobbedienza del giudice qui affrontato, essendo l’intervistatore una delle migliaia di gocce che compongono l’ordine giudiziario.
Carattere centrale – come è dimostrato dalle ulteriori preziose osservazioni finali espresse dal Presidente Silvestri – ha avuto il tema del controllo di costituzionalità che si fronteggia con quello dell’interpretazione costituzionalmente orientata che viene individuata coralmente come un elemento che il giudice deve sperimentare per riavvicinare, ove del caso, la legge alla giustizia.
In Galliani, anche se la lettura delle tre risposte rende meno netta l’affermazione espressa con riguardo alla prima, sembra prevalere una netta preferenza per il ricorso alla Corte costituzionale per le ragioni che lui stesso ha spiegato. Sarebbe dunque l’intervento erga omnes a costituire l’obiettivo massimo e preferibile, a tangibile dimostrazione del ruolo giocato dalla Corte costituzionale. Secondo Galliani è preferibile il giudice che dialoghi con la Corte costituzionale piuttosto che quello che si sobbarchi il compito di interpretare la disposizione in modo costituzionalmente, convenzionalmente ed eurounitariamente orientata. Se vai alla Corte costituzionale bonifichi, se interpreti in modo conforme a Costituzione igienizzi, ma lasci le incrostazioni nella condotta, che continuano pericolosamente a corroderla.
Ragionamento ineccepibile che il Presidente Silvestri ha completato con alcune indicazioni, anch’esse preziose.
Anche a proposito del rapporto fra interpretazione costituzionalmente orientata e sindacato di costituzionalità credo debba sempre valere il principio della cooperazione equilibrata e bilanciata.
A questa logica, tornando al tema del ruolo della Carta UE dei diritti fondamentali rispetto al giudice comune e costituzionale pure sfiorato da Galliani e affrontato, nelle precedenti interviste, dai costituzionalisti Trucco, Sciarabba e Martinico e dagli europeisti Nascimbene, Mastroianni e Mori, sembrano essere improntate le ultime pronunzie della Corte costituzionale – sent. nn. 20, 63 e 117 del 2019 – a fronte di orientamenti preannunciati o prospettati dalla sentenza n. 269/2017 che non lasciavano dormire sonni tranquilli ai giudici comuni.
Senza peraltro dimenticare che il ruolo del giudice comune è proprio quello di contribuire all’evoluzione dell’interpretazione rispetto ai casi volta per volta esaminati, di verificare la portata di una soluzione in relazione al contesto sociale, storico e politico ed all’accoglienza che ad essa viene fatta dalla comunità interpretativa di cui parla sapientemente Nicolò Lipari, proprio per imbastire quel diritto vivente sul quale la Corte costituzionale dovrebbe eventualmente essere chiamata a pronunziarsi.
Ed allora, l’individuazione di una linea di confine fra “controllo accentrato” e “interpretazione costituzionalmente orientata” va ben pensata e ponderata, dovendosi tendenzialmente limitare l’ipotesi che il primo venga esercitato in assenza di quel “diritto vivente” che costituisce, invece, la premessa ineludibile di un intervento radicale ed immodificabile – in caso di dichiarata incostituzionalità della legge – quale potrebbe essere quello del giudice costituzionale.
Per questo sono di straordinaria profondità le osservazioni di Silvestri che invocano il costante equilibrio tra i poteri, poiché “ogni grave turbamento dell’equilibrio costituzionale in un punto del sistema è destinato a ripercuotersi, prima o poi, in tutti i settori”. Il che porta a ritenere che il giudice comune e la Corte costituzionale, pur nei diversi ruoli svolti, sono entrambi i custodi della Costituzione ed entrambi sono chiamati a svolgere, pur con le intuibili differenze, i delicati bilanciamenti fra i valori fondamentali che vengono in gioco nell’attività decisoria a ciascuno riservata. Tema, quest’ultimo che si salda perfettamente con le riflessioni di Ruggeri e Bin già apparse nella prima intervista (Giudice o giudici nell’Italia postmoderna?)
La strada della reciproca fiducia e della “costruttiva e leale” cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia (Corte cost.n.267/2017 e n.117/2019) piena ed effettiva è dunque quella che va sempre di più battuta.
Ed è questo principio di cooperazione che deve altresì alimentare il tema della disobbedienza del giudice di merito alle decisioni della Cassazione e financo della Corte costituzionale e dei giudici sovranazionali.
Oggi il giudice comune può disobbedire alla giurisprudenza del giudice di legittimità – addirittura anche se su di essa si è formato il giudicato in sede di rinvio – quando in gioco vi è il diritto dell’Unione europea (cfr. Corte Giust., 5 ottobre 2010, causa C–173/09, Elchinov; Corte giust. 15 gennaio 2013, causa C–416/10, Križan; Corte giust., 20 ottobre 2011, causa C-396/09, Interedil; Corte giust.24 maggio 2016, causa C-353/15, Leonmobile srl). E può anche disobbedire alla giurisprudenza della Corte costituzionale che abbia assecondato una lettura della norma interna compatibile con quella della Carta dei diritti fondamentali dal medesimo non condivisa (v., da ultimo, Corte cost. n. 63/2019).
Ed è poi la stessa Corte costituzionale ad invitare i giudici comuni a disobbedire alla Corte edu quando l’indirizzo da questa patrocinato non sia “consolidato”, come affermato dalla sentenza n. 49 del 2015, con specifico riferimento al caso che possa altrimenti aversi un conflitto con la Costituzione. Una disubbidienza “funzionale” – come la definisce G. Martinico, Corti costituzionali (o supreme) e 'disobbedienza funzionale' Critica, dialogo e conflitti nel rapporto fra diritto interno e diritto delle Convenzioni (CEDU e Convenzione americana sui diritti umani – orientata a favorire un dialogo in nome della protezione di valori non tenutii n adeguata considerazione dalla Corte europea.
Peraltro, la disobbedienza alla giurisprudenza di legittimità da parte del giudice comune, anche fuori dal campo del diritto UE la rammentano gli stessi giudici della Cassazione con l’autorevolezza delle Sezioni Unite civili quando affermano che l’interpretazione da parte del giudice di legittimità mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva, trattandosi di attività consustanziale all’esercizio stesso della funzione giurisdizionale. Da ciò consegue che un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia è sempre suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito – Cass.S.U. n.4135/2019 –. Principio pienamente condiviso dalla Corte costituzionale. – Corte cost. n.230/2012 –.
In definitiva, varie forme di disobbedienza “buone” – con espressione che rischia di apparire un ossimoro – tutte imposte proprio dall’art.54 Cost. e perciò legali, legittime e dovute, purché realizzate attraverso la motivazione persuasiva dei provvedimenti che impone al giudice comune di dire “perché” la decisione non si è conformata a quella della Cassazione o a quella della Corte costituzionale che, magari, abbia escluso il contrasto fra diritto interno e norme della Carta UE immediatamente precettive, inducendo il giudice comune a disapplicare, andando “contro” la Corte costituzionale.
Bisogna dunque rifuggire da un sistema che si proietti verso il conformismo e si attesti sulla rassicurante idea della vincolatività dei precedenti delle giurisdizioni apicali come anche da meccanismi che premino con incarichi direttivi o semidirettivi in magistratura chi più si è uniformato alle decisioni anzidette, senza eventualmente scavare sulle ragioni che hanno condotto il giudice dell’impugnazione a riformare le decisioni da parte del giudice dell’impugnazione. Ragionando diversamente, sarebbe in pericolo quel dinamismo interpretativo che va, certo, sapientemente coniugato con le esigenze di prevedibilità, certezza ed eguaglianza ma in ogni caso favorito ed alimentato.
Non si tratta, certo, di caldeggiare un far west giudiziario, ma soltanto di salvaguardare il carattere dinamico del diritto giurisprudenziale, impedendo automatismi e meccanicismi che spesso mal si conciliano con l’ontologica diversità dei casi e dei contesti nei quali essi maturano e con il continuo circuito giurisprudenziale alimentato dalle Corti nazionali e sovranazionali.
Non è nemmeno disobbediente il giudice che si incunea nelle lacune del sistema cercando di inverarlo attraverso il ricorso ai principi espressi che sono alla base dello stesso ordinamento, in questo modo mostrandosi pienamente rispettoso della legge, rispetto alla quale offre il proprio contributo al fine di colmare i vuoti lasciati dal legislatore.
Una supplenza, questa, che se e quando si muove nell’ambito delle coordinate prefissate dal sistema, facendo ricorso ad istituti che pure l’ordinamento prevede ed ai principi fondamentali non sembra in alcun modo integrare un capovolgimento delle regole, ma al contrario una riaffermazione del vero significato del principio di legalità.
Vincenzo Militello fissa, peraltro, in modo mirabile il limite ontologico di siffatta operazione in ambito penalistico, individuandolo nel fatto che le soluzioni scelte dal giudice possono avere come unica direzione quella del favor rei, non potendo mai condurre ad un’espansione del diritto penale. Si tratta di un’affermazione che pare non solo – e finalmente – chiara e condivisibile, ma anche pienamente in linea con lo spirito che anima le fonti nazionali e sovranazionali che hanno a cuore i diritti fondamentali delle persone.
Il punto è semmai di mettere bene in chiaro che la ricerca di nicchie sempre più elevate di una tutela effettiva ed efficace dei diritti fondamentali non può mai essere imbrigliata o depotenziata magari brandendo lo spettro della responsabilità disciplinare. Tema, quest’ultimo, che meriterà una riflessione autonoma per quanto esso è avvertito soprattutto nelle fasce più giovani della magistratura.
Le risposte alla seconda domanda degli intervistati sono tutte da metabolizzare e nessun giudice credo possa pensare di prenderle sotto gamba.
Pollice verso rispetto a commenti sui processi in corso e non definiti da parte di chi se ne sia occupato.
Piena apertura, per converso, al fatto che il magistrato sia presente nel dibattito anche giuridico delle questioni che agitano la società, senza tuttavia superare la soglia, certamente difficile da fissare in astratto, che fa trasmodare il giudizio tecnico in esternazione che possa suonare, per le modalità, i toni, i luoghi ed i contesti, di natura anche velatamente politica.
Insomma, sembra emergere l’esigenza di un uso accorto dell’art. 21 Cost. che va, tuttavia, coniugata con un ulteriore valore rappresentato dal diritto all’informazione su fatti che, a volte, toccano la vita stessa democratica.
Vi è, infatti, un’esigenza di verità, sulla quale altra volta si è tentato di riflettere (R. Conti, Il diritto alla verità nei casi di gross violation nella giurisprudenza Cedu e della Corte interamericana dei diritti umani ) alla quale si coniuga inevitabilmente il diritto alla conoscenza dei contenuti di inchieste in corso pur nel rispetto del segreto investigativo e del giusto bilanciamento fra i valori in gioco, quando ad esempio vi è il rischio della delegittimazione del magistrato– cfr. Cass.S.U. n.6827/2014 –, come di recente ricordato da Donatella Stasio.
Massima espansione, per altro verso ancora, al diritto-dovere del giudice di esprimere la propria voce di fronte ai pericoli che possono correre i principi fondamentali “anche al di fuori dell’esercizio della funzione giurisdizionale”.
Ed è il dovere di fedeltà alla Repubblica, ci ricorda sempre il Prof. Silvestri, ad imporre un simile impegno al magistrato, ancor più qualificato in relazione al suo ruolo di garante della legalità ordinaria e costituzionale. Mai come in questi giorni queste parole sembrano utili e istruttive.
Il rapporto fra giudici e social media si inserisce nel medesimo contesto ed i tre intervistati non hanno mancato di offrire con garbo, ma con fermezza, i “suggerimenti” che erano stati loro sollecitati affinché i giudici possano apparire sempre autonomi e indipendenti senza per questo indietreggiare rispetto al ruolo che per Costituzione essi hanno.
Il nodo della pena ingiusta e dell’atteggiamento che rispetto ad essa debba avere il giudice non poteva che chiudere la riflessione dedicata alla disobbedienza, grazie ai preziosi spunti offerti dalla Professoressa Cartabia, sui quali si sono innestate le riflessioni dei tre intervistati, confermando in modo ancor più lampante quanto serva dialogare attorno ad un problema muovendo da sensibilità diverse.
Ed infatti, l’esperienza del giudice costituzionale che ha attivamente partecipato alla storia della giustizia costituzionale degli ultimi anni, quella di studioso raffinato e profondo del diritto penale, unita al pensiero appassionato del costituzionalista che si è speso e si spende per battaglie costruite attorno a diritti fondamentali, magari ancora non pienamente avvertiti dal corpo sociale, si sono qui armonicamente fuse. È così emersa la figura di un giudice coartefice nell’individuazione del giusto equilibrio tra discrezionalità del legislatore e controllo di proporzionalità e di ragionevolezza (Silvestri), di garante, Insieme alla Corte costituzionale, di un ordine giudiziario sempre in movimento, proteso alla salvaguardia della persona umana, di interprete di prossimità della soglia di ingiustizia insopportabile, purché l’attività ermeneutica sia sempre e comunque agganciata “agli strumenti di valutazione formalizzati dall’ordinamento di appartenenza, sia pure modernamente inteso in chiave multilivello” (Militello). Un giudice che si fa, d’altra parte, portiere del senso di ingiustizia rispetto a condotte che toccano i diritti fondamentali. L’accenno fatto da Silvestri alla vicenda che ha originato l’ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, alla quale hanno già dedicato le loro riflessioni D’Aloia, D’Amico e Repetto in questa Rivista (Quale futuro per il fine vita dopo Corte cost.n.207/2018?), merita di essere sottolineato non solo per la centralità che in esse assumono i valori della persona e della sua dignità quali “opzioni epocali, che implicano scelte responsabili, individuali e collettive”, ma proprio per la sinergia fra giudice comune e giudice costituzionale.
Tutti gli interventi, in definitiva, sono stati rivolti ad offrire una testimonianza di quanto non si possa fare a meno di un giudice rumoroso, appassionato ma al contempo a tratti silenzioso ed aperto a cogliere sempre di più la complessità del sistema e del proprio ruolo, centrale per la democrazia.
Un ruolo di notevole responsabilità nel quale la disobbedienza buona costituisce al tempo stesso limite ed obbligo del giudice, purché essa si muova sempre e comunque nei binari della Costituzione. Un giudice che non può rischiare di essere immiserito dalla ricerca di quella “tranquillità burocratica” alla quale ha fatto incisivamente riferimento Silvestri e che, ancora di più, evoca la figura di persona seria, intellettualmente onesta, scevra da logiche di baratto carrieristico, in una parola di un giudice solare e “fedele” alla Costituzione.
Può, allora, quel giudice o deve uscire dall’ordine giudiziario quando avverta di essere con il suo atto compartecipe di una rottura insanabile dei principi supremi dell’ordinamento che non dovesse riuscire ad eliminare con gli strumenti offertigli dalla Costituzione?
Nulla di più può dirsi rispetto a quanto illustrato dai nostri intervistati che, ancora una volta, hanno provato ad infiammare le coscienze dei lettori, giudici e non, con argomenti chiari e inequivoci. Ed il ricordo fatto da Galliani alla figura di Antonino Caponnetto si risolve in un monito che sta lì a suggellare la scelta della Rivista di camminare "Insieme" sui sentieri impervi di un millennio tutto da scoprire, nel quale il "giudiziario" ha il dovere di offrire, oggi più che mai, un’immagine specchiata di sé che sia, appunto, all'altezza di Caponnetto e di quanti hanno creduto e continuano a credere nel suo ruolo.