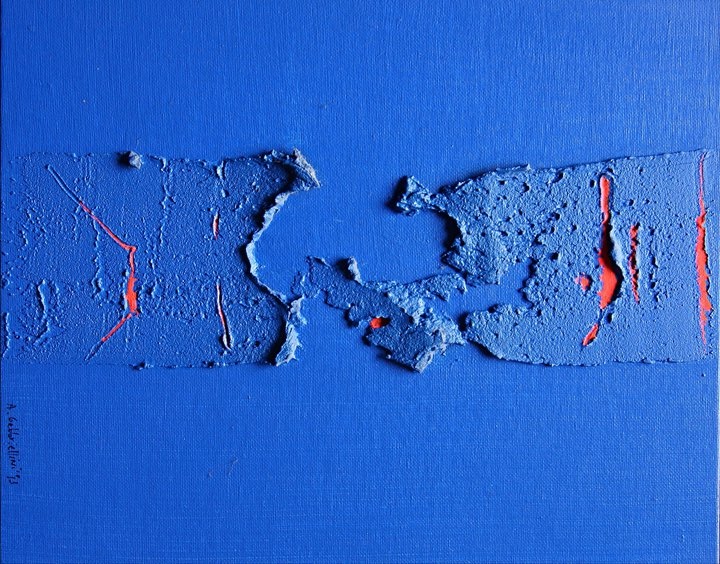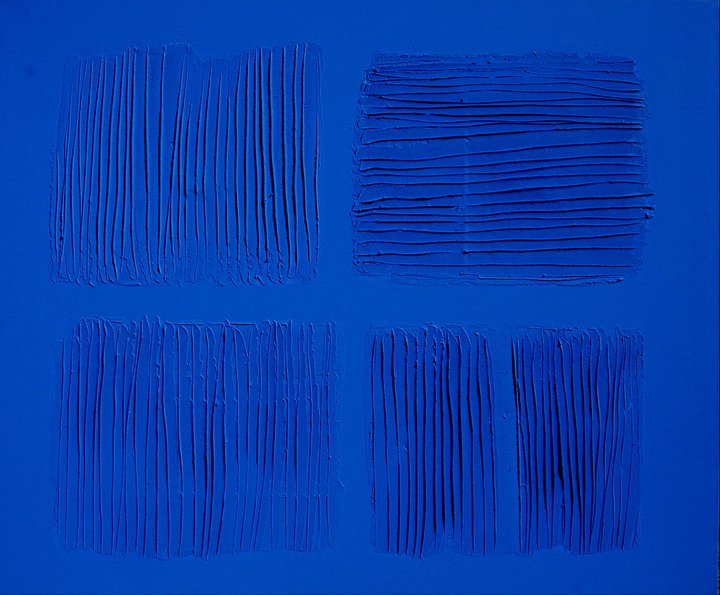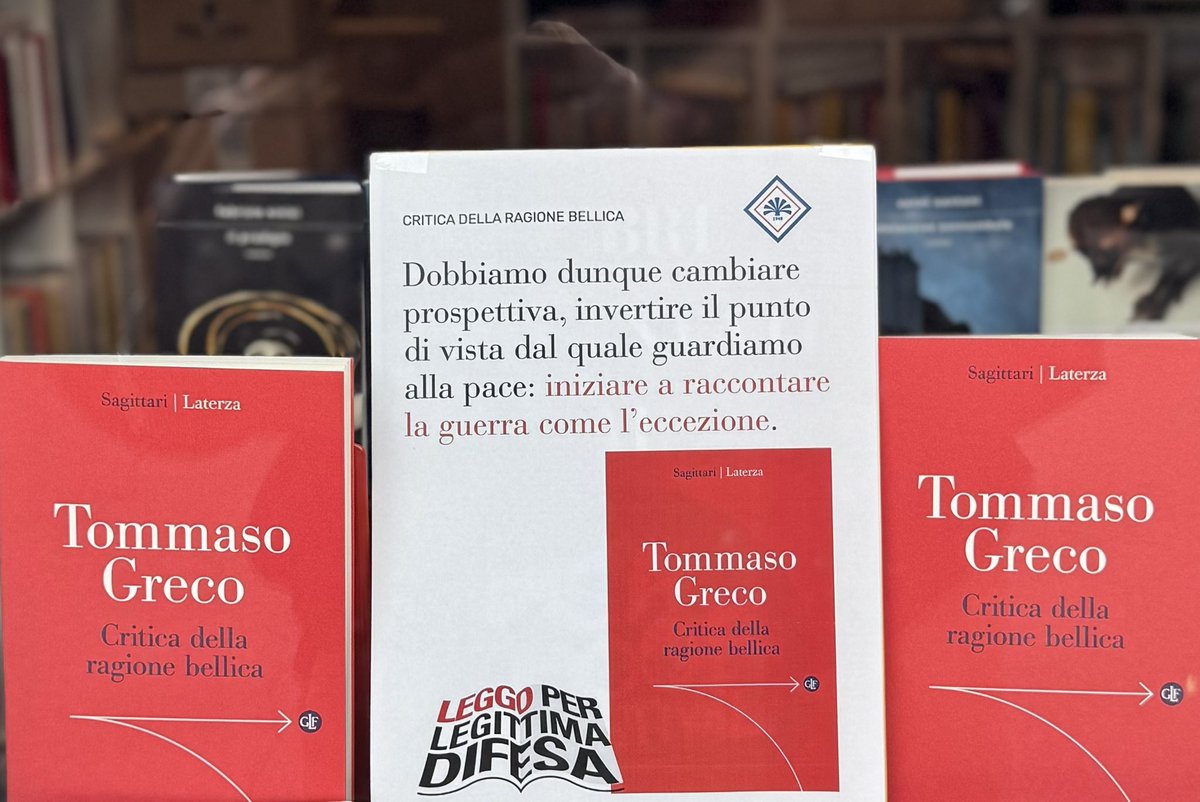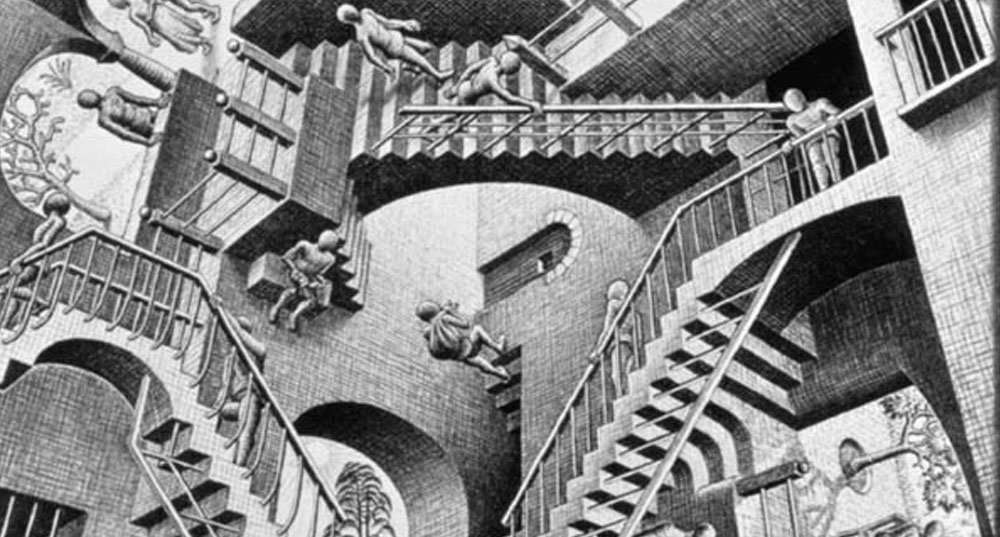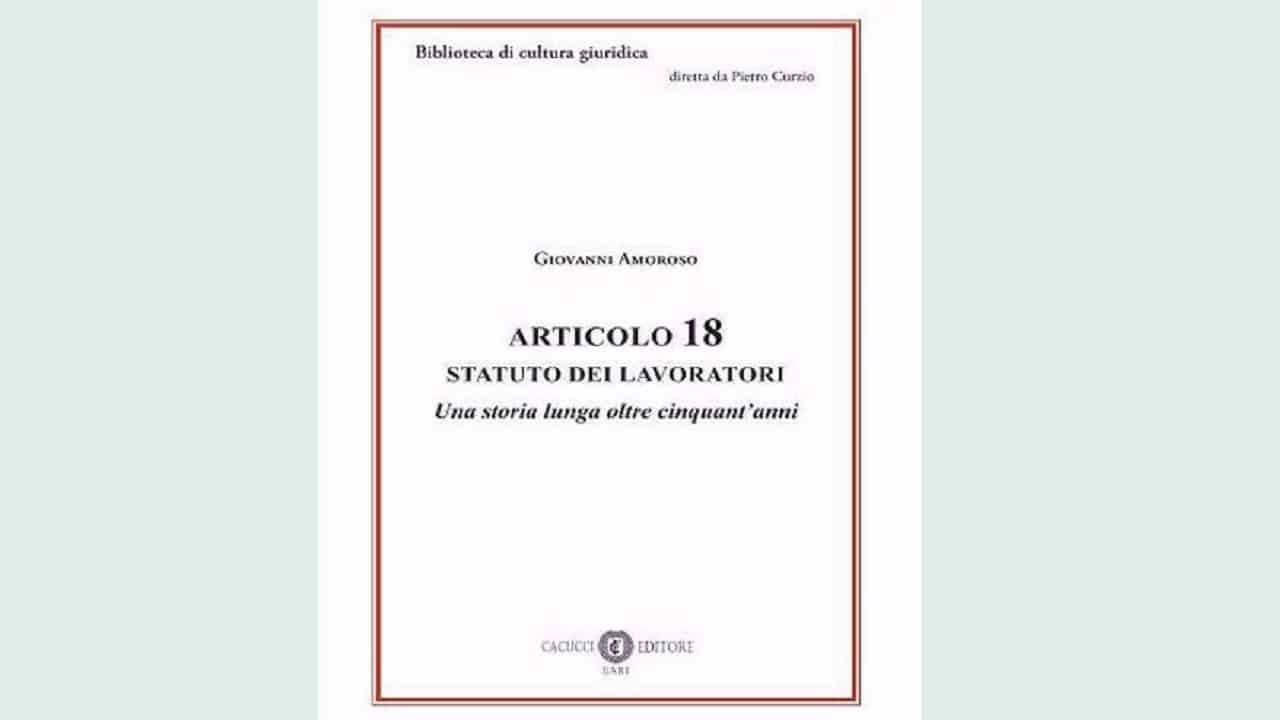Il referendum abrogativo del D. Lgs. 4 marzo 2025, n. 23 sui licenziamenti nell’ambito del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (c.d. Jobs Act)
V. A. Poso. Su iniziativa della CGIL sono stati promossi quattro referendum abrogativi di importanti norme lavoristiche (dopo la comunicazione in data12 aprile dell’iniziativa referendaria, l’annuncio delle richieste è stato pubblicato nella G.U. n. 87 del 13 aprile 2024).Il primo, sinteticamente denominato dai promotori “Reintegro-Licenziamenti” ha ad oggetto il seguente quesito: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?». Il manifesto pubblicitario di questo referendum, confezionato dalla CGIL, per realizzare il “lavoro tutelato”, è inteso, in estrema sintesi, ad ottenere la “reintegrazione” nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo con l’abrogazione totale del c.d. Jobs Act (d. lgs. n. 23/2015) in materia di licenziamenti, che si applica ai lavoratori (non tutti) assunti dopo il 7 marzo 2015. Dico in estrema sintesi perché anche il Jobs Act prevede, in alcuni casi e a determinate condizioni, la tutela reintegratoria piena, come quella statutaria dell’art. 18; e disciplina anche altri istituti, sempre connessi alla materia dei licenziamenti.
Chiedo, in particolar modo, ai giuslavoristi in cosa consiste la disciplina normativa oggetto di referendum. Innanzi tutto, un quadro sintetico dei soggetti ai quali si applica, spiegando, anche, le ragioni di politica del diritto poste a fondamento di questa riforma, che, a torto o a ragione, è stata definita “epocale”, considerata la resistenza, per oltre quarant’anni, della tutela, reale e piena, approntata dallo statuto dei lavoratori con l’art. 18, nonostante le modifiche introdotte dalla l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero).
M. T. Carinci. Con il cd. Jobs Act il Governo dell’epoca - Presidente del Consiglio on. Matteo Renzi - ha modificato profondamente le tutele previste per il licenziamento individuale per i dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015, superando in modo inequivocabile la centralità della tutela reale riconosciuta - a partire dall’entrata in vigore dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970 - come cardine del sistema rimediale per il licenziamento contra legem (nullo, ingiustificato o viziato dal punto di vista procedurale) da parte di datori di lavoro di dimensioni medio-grandi.
È vero che la cd. Legge Fornero del 2012, nel modificare l’art. 18 St.lav., aveva già inciso su quel principio, introducendo diverse ipotesi in cui il rimedio previsto è solo indennitario. Tuttavia, nella lettura poi fornitane dalla giurisprudenza - ed in coerenza con i principi insiti nel sistema - la tutela reale nell’art. 18 St.lav. post l. Fornero aveva continuato a rimanere centrale. Viceversa, nelle realtà di più piccole dimensioni fin dall’entrata in vigore della l. 604/1966, salvo il caso del licenziamento nullo, la tutela prevista per il licenziamento viziato è sempre stata ed è poi sempre rimasta solo di tipo economico.
Il Jobs Act, dunque, da una parte - opportunamente - riunifica in un unico testo normativo la disciplina del licenziamento individuale nel suo complesso, quale che siano le dimensioni occupazionali del datore di lavoro, superando così la separazione tra le discipline basata sul requisito dimensionale, dall’altra - con una scelta a mio parere discutibile e come subito dirò non idonea agli scopi che si prefiggeva - capovolge la prospettiva statutaria per i lavoratori assunti da datori medio-grandi dopo il 7 marzo 2015: la tutela riconosciuta dalla legge per il licenziamento individuale privo di giustificazione o affetto da vizi formali o procedurali è per tutti i lavoratori, anche se dipendenti da datori di lavoro con un maggior numero di occupati, una tutela esclusivamente economica e per di più molto contenuta.
Nel nuovo sistema, dunque, la reintegrazione diviene inequivocabilmente marginale, trovando applicazione solo nei casi più gravi in cui il licenziamento viene ritenuto (maggiormente) lesivo della dignità della persona del lavoratore: il licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale.
Perché dunque il legislatore del Jobs Act compie questa scelta “epocale”?
Due erano gli obiettivi dichiarati (come si evince dall’art. 1, co. 7, l. delega 183/2014): in primo luogo “fluidificare” il mercato del lavoro, rendendo meno costoso il turn over fra i lavoratori occupati e quelli in cerca di occupazione; in secondo luogo, ridurre la “segmentazione” (realizzatasi in particolare in conseguenza della “riforma Biagi”, D. Lgs. 276/2003) fra i lavoratori più tutelati assunti con il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e quelli meno tutelati, soprattutto giovani, assunti, di regola, con una miriade di contratti atipici e flessibili. Quegli obiettivi vengono perseguiti nella sostanza abbassando le tutele - ed i costi - del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soprattutto con riguardo al licenziamento (ma non solo: si pensi alla rivisitazione in senso “flessibilizzante” della disciplina dello ius variandi o dell’ampliamento del potere di controllo a distanza del datore di lavoro), e, al contempo, trasferendo parte dei costi connessi alla ricerca di un posto di lavoro sulla fiscalità generale (tramite il rafforzamento dei servizi per l’impiego, la previsione di un contratto di ricollocazione, ecc.).
Sullo sfondo della riforma aleggiava tuttavia un’ulteriore idea e cioè che l’abbassamento dei costi connessi al licenziamento potesse avere anche riflessi positivi sull’occupazione nel suo complesso, inducendo i datori di lavoro ad assumere di più, e potesse in definitiva stimolare, in uno con l’accresciuto potere di fatto del datore nell’ambito del rapporto, la produttività del lavoratore.
I fatti però hanno dimostrato che l’obiettivo occupazionale non poteva essere perseguito con quegli strumenti: le regole giuslavoristiche di per sé non possono certo creare nuova occupazione; per raggiungere un tale risultato servono infatti strumenti di politica economica.
D’altra parte, la produttività del lavoro dipende innanzitutto dal tipo di produzioni e servizi, a più o meno alto valore aggiunto, che caratterizzano un certo sistema economico, nonché dal tipo di professionalità posseduta dai lavoratori che operano in tali settori, da formare ed aggiornare costantemente con investimenti specifici da parte delle imprese. Insomma, neppure la produttività del lavoro è promossa o favorita dall’abbassamento delle tutele per il licenziamento, ma richiede di essere sostenuta con altri strumenti volti a stimolare investimenti sulla formazione del lavoratore ed a fidelizzarlo.
Il Jobs Act, dunque, non ha raggiunto gli obiettivi che dichiarava di perseguire, né poteva raggiungerli.
Al contrario, esso ha determinato una ulteriore segmentazione del mercato del lavoro (fra lavoratori più protetti, i “vecchi assunti” fino al 7 marzo 2015, e quelli meno protetti, i “nuovi assunti”) finendo per promuovere un modello di impiego il cui “cuore” non è la valorizzazione di chi lavora ma, piuttosto, una più spinta “precarizzazione” e soggezione ai poteri (di diritto e di fatto) del datore di lavoro.
In effetti parte della dottrina ha fin da subito rimarcato - a mio parere a ragione - che la riforma violasse il principio di uguaglianza posto dall’art. 3 Cost., poiché nessuna ragionevole giustificazione sorreggerebbe la scelta del legislatore di tutelare in modo più blando - a fronte dei medesimi vizi dell’atto di recesso - i lavoratori assunti, anche nella stessa azienda, prima o dopo una certa data. Com’è noto, però, C. Cost. 194/2018, ha respinto la questione di incostituzionalità dell’art. 3, c. 1, D. Lgs. 23/2015 (nel testo sia antecedente che successivo al d.l. cd. 87/2019, cd. “Decreto Dignità”) per violazione del principio di uguaglianza (una posizione analoga sarà poi assunta da C. Cost. 7/2024 con riferimento alla disparità di tutela in punto di violazione dei criteri di scelta nell’ambito dei licenziamenti collettivi fra lavoratori assunti fino o dopo il 7 marzo 2015).
La Corte costituzionale, pur dando atto che la tutela per il licenziamento ingiustificato posta dal D. Lgs. 23/2015 è deteriore rispetto a quella posta dall’art. 18 St.lav., ha ritenuto infatti che il criterio temporale prescelto dalla legge per l’applicazione delle tutele (la data di assunzione del lavoratore) trovi ragionevole giustificazione nello «scopo, dichiaratamente perseguito dal legislatore, di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione» (così C. Cost. 194/2018, punto 6), scopo che viene coerentemente perseguito favorendo coloro che a partire da una certa data possano effettivamente aspirare all’assunzione a tempo indeterminato.
Nonostante la presa di posizione della Corte - in qualche modo necessitata, a meno di non voler giungere alla demolizione dell’intera riforma - sul punto il dibattito non si è sopito, ed a ragione. La Consulta si è infatti limitata a valutare l’astratta corrispondenza fra lo scopo dichiarato dalla legge e la fissazione dello spartiacque temporale senza valutare però, da una parte, se lo scopo astrattamente perseguito sia stato poi raggiunto in concreto in modo ragionevole e, dunque, con strumenti adeguati (conclusione del tutto discutibile come ho già sottolineato) e, dall’altra - soprattutto -, senza considerare in alcun modo il vero nocciolo della questione e, cioè, se le disparità di trattamento sul piano sostanziale fra lavoratori assunti fino o dopo il 7 marzo 2015 - anche se tutti dipendenti da uno stesso datore di lavoro e dunque oggettivamente equiparabili - possa trovare esaustiva ed adeguata giustificazione in una astratta finalità di promozione dell’occupazione prescindendo da altri aspetti cruciali in gioco. In particolare, la questione che rimane ancora da sciogliere è se la tutela della persona del lavoratore, esposta al potere di diritto e di fatto del datore di lavoro nell’ambito di una medesima organizzazione, possa essere ragionevolmente differenziata dalla legge senza considerare la dimensione imprescindibile di potere propria dell’atto di licenziamento.
Alla luce di tutto ciò ritengo che il referendum promosso dalla CGIL per l’abrogazione del Jobs Act, ove accolto, possa determinare effetti positivi per il sistema nel suo complesso: la congiuntura economica, sociale e geopolitica che stiamo vivendo richiede, infatti, una forte coesione sociale e, dunque, una particolare attenzione a quella componente essenziale della nostra società costituita dai lavoratori subordinati.
Rafforzare le tutele del licenziamento - snodo cruciale per l’effettivo godimento di tutti i diritti di cui il lavoratore è titolare nel corso del rapporto - è a mio parere un segnale importante in questo momento storico per riaffermare la centralità della persona che lavora quale parte integrante e determinante del sistema economico-sociale del Paese.
B. Caruso. La collega Maria Teresa Carinci ha ben sintetizzato i presupposti di politica del diritto che hanno indotto la CGIL a indire un referendum popolare di abrogazione della parte relativa ai licenziamenti del Jobs Act. Va, però, ricordato che il Jobs Act costituisce un complesso di interventi ad ampio spettro (contratti flessibili, regolazione del mercato del lavoro, controlli a distanza ecc.) che hanno introdotto riforme, ancora vigenti, che non hanno riguardato soltanto il licenziamento, molte delle quali neppure i governi di segno politico diverso dal famigerato “governo Renzi” hanno mai provato ad abrogare.
Si può contestare, nei presupposti di policy e negli effetti, quella stagione legislativa, ma non si può negare il fatto che, soprattutto se si confronta con il piccolo cabotaggio delle politiche del lavoro attuali, il Jobs Act fu un tentativo organico di riforma della legislazione del lavoro, in parte riuscito in parte no, ma che ridurre a un tentativo di liberalizzazione del mercato del lavoro di stampo neoliberista appare un po’ riduttivo.
Come pure va ricordato che molti economisti che parteciparono alla stesura di quelle norme - non certamente di scuola neoliberista o neoclassica (per esempio M. Leonardi e T. Nannicini) - segnalano che il Jobs Act non ha prodotto l’ondata di licenziamenti che i giuristi apocalittici avevano pronosticato.
A dirla tutta, poi, i problemi che oggi affrontano le imprese, ma persino le pubbliche amministrazioni - anche in ragione di complesse ragioni strutturali di tipo economico, demografico e tecnologico - sono esattamente agli antipodi della maggiore o minore libertà di licenziare, e si concentrano sul versante dell’offerta di lavoro. È acclarata, infatti, statisticamente la situazione di grave carenza di forza lavoro che gli uffici di recruitment delle imprese devono gestire, sia relativamente alle professionalità ricercate e adeguate al mutamento tecnologico, sia in termini assoluti in ragione della riduzione progressiva, per la notte demografica che il sistema Italia sta attraversando ormai da anni, di persone disponibili ad essere assunte; e tale gap, come gli statistici e i demografi ci dicono, viene solo in parte colmato dagli immigrati. È questo il vero problema del mercato del lavoro e delle imprese, oggi.
A fronte di questa dura e concreta realtà non voglio dire che il referendum abrogativo del Job Act costituisca una “arma di distrazione di massa”, ma certamente se ne evidenziano le valenze politiche e simboliche piuttosto che i concreti effetti giuridici. Anche la formulazione del quesito molto semplificato rispetto al precedente sempre sui licenziamenti, ha una funzione suggestiva e quasi pedagogica rispetto all’elettorato.
Al contrario di altri referendum complessi e inintelligibili anche agli addetti ai lavori, e quindi di fatto “elitari”, il referendum sul Jobs Act, nella sua eccessiva semplificazione, più che un referendum popolare politicamente sembra essere un referendum populista (il populismo secondo note analisi politologiche non è solo di destra ma anche di sinistra).
Del resto, un grande sociologo del lavoro scomparso, come Aris Accornero, definiva la reintegrazione e l’art. 18 dello Statuto una sorta di tabù (A. Accornero, A. Orioli (con la collaborazione di), L’ultimo tabù. Lavorare con meno vincoli e più responsabilità, Laterza, 1999) sottolineandole le valenze ideologiche che, dopo la oceanica manifestazione di Roma del 23 marzo 2002 all’insegna del “giù le mani dall’art. 18”, si erano fortemente esaltate. La verità è che, dopo gli interventi ripetuti della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, pensare di abrogare il Jobs Act, come risposta ai problemi (enormi) del lavoro oggi, alcuni dei quali come quello che ho prima segnalato agli antipodi della libertà o meno di licenziare, equivale (gli animalisti mi passino la metafora) a un cacciatore miope che, in una battuta di caccia grossa, scambiasse un placido gattone con una tigre (probabilmente anche di carta).
Con questo non voglio dire che l’attuale quadro normativo sul sistema di sanzioni contro il licenziamento illegittimo non necessiti di una semplificazione e di una razionalizzazione normativa, anche per dare maggiore certezza agli operatori economici e agli stessi lavoratori (con i colleghi del “Gruppo Freccia Rossa” stiamo lavorando su questo); ma penso che tale compito debba essere, in un sistema normale, affidato al legislatore (già chiamato direttamente a intervenire dalla Consulta quanto meno sulla questione delle regime sanzionatorio nelle piccole imprese) e non ai giudici o al corpo elettorale; in una democrazia rappresentativa che funzioni, tale compito spetta agli organi di governo e al parlamento.
Oltretutto mi chiedo, e molti osservatori si sono concentrati su questo, se portare indietro le lancette alla legge “Fornero” (per altro non all’art. 18 dello Statuto come un cultore “duro e puro” della reintegrazione, come il segretario della CGIL Maurizio Landini, avrebbe dovuto pretendere), senza ulteriori aggiustamenti, sia davvero una mossa conveniente; e ciò anche in ragione del fatto che il Jobs Act è in alcuni passaggi (per esempio per il regime indennitario forte o, come ricorda la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 12/2025 sulla ammissibilità dei quesiti referendari al punto 4.5,) più favorevole ai lavoratori in materia di licenziamento per mancato superamento del comporto, per disabilità e nelle organizzazioni di tendenza, e posto pure che la differenza regolativa in ragione dell’entrata in vigore sta progressivamente attenuandosi, proprio per il trascorrere del tempo (si calcola che la legge Fornero si applichi ormai a una quota residuale di lavoratori).
Il dibattito, dunque, come sottolinea Maria Teresa, non si è sopito. Ma rispetto ai reali problemi in gioco esso è in parte artefatto, in parte ridondante, in parte troppo acceso nei toni se si guarda ai possibili effetti di natura tecnica, invero secondari soprattutto se riferiti a un quadro normativo già ampiamente rimaneggiato dai giudici. L’indizione del referendum è una legittima opzione politico-costituzionale, ma in tal caso, abbastanza irrilevante quanto ai mutamenti regolativi sostanziali che potrebbe produrre se il corpo elettorale si dovesse pronunciare positivamente; si configura invece come una scommessa politica, o un azzardo, dell’attuale gruppo dirigente della CGIL che soltanto l’esito dirà se fondata o meno.
Se volessi sintetizzare con riguardo agli effetti regolativi, direi con Shakespeare, Much ado about nothing.
M.T. Carinci. Vorrei replicare brevemente ad alcune delle osservazioni appena avanzate da Bruno Caruso, circa l’inutilità del referendum sulla scorta della duplice considerazione che altri sono i problemi del diritto del lavoro di oggi e che il risultato concreto che ne conseguirebbe dopo il riassetto della disciplina già compiuto dalle Corti sarebbe modesto, se non addirittura controproducente per i lavoratori.
Credo innanzitutto che non si possa imputare al referendum - la cui portata può essere solo abrogativa – di non rispondere agli “enormi problemi” del lavoro di oggi. Di ciò dovrebbe infatti farsi carico il legislatore, che invece non ha neppure iniziato a mettere mano al riordino della disciplina dei licenziamenti, nonostante le esplicite sollecitazioni della Corte costituzionale, in particolare per quanto riguarda le piccole imprese. Allo strumento referendario, dunque, non si può certo imputare di non fare ciò che non può fare!
Ben venga a mio parere invece una presa di posizione popolare su una questione cruciale come la disciplina del licenziamento che cerchi di rimettere al centro dell’agenda politica i problemi del lavoro.
In secondo luogo, penso che l’abrogazione del Jobs Act considerato nel suo complesso - con la conseguente riespansione dell’art. 18 post legge Fornero e della l. 604/1966 - comporti due risultati molto positivi: la riunificazione delle tutele senza distinzioni in conseguenza della data di assunzione ed un effettivo rafforzamento delle tutele per i lavoratori. È vero, come illustrerò meglio in seguito (in particolare v. risposta alla domanda 8), che per alcuni aspetti la tutela arretrerebbe, ma nel suo insieme essa risulta rafforzata specie con riguardo al licenziamento ingiustificato che costituisce l’ipotesi più frequente di illegittimità, con benefici effetti di sistema sull’effettività di tutti diritti riconosciuti al lavoratore nel corso del rapporto di lavoro. È infatti ben noto che la tutela del licenziamento costituisce la chiave di volta per assicurare l’effettivo esercizio da parte del lavoratore di tutti i diritti propri del rapporto di lavoro.
V. A. Poso. Nel testo originario della riforma come era configurato il sistema delle tutele?
M. T. Carinci. Come anticipato, nel sistema del Jobs Act, superando le ambiguità della legge Fornero, la tutela indennitaria diviene la regola e la tutela reintegratoria l’eccezione.
La prima, dunque, avrebbe dovuto trovare generale applicazione, salvi i casi in cui la legge non avesse espressamente disposto l’applicazione della tutela reale, nella versione “forte” (prevista per il licenziamento nullo: discriminatorio; “riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”; privo di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore; e - in virtù di una condivisibile lettura - irrogato in caso di mancato superamento del periodo di comporto) o “attenuata” (prevista nel solo caso del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo in cui “fosse direttamente dimostrato in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto al quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”).
Ogni altra ipotesi, incluse tutte quelle di licenziamento ingiustificato non eccettuate o del licenziamento “con violazione del requisito di motivazione” o della procedura prevista dall’art. 7 St.lav. ricadevano nell’alveo della tutela puramente economica.
Quanto a quest’ultima, divenuta appunto di generale applicazione, nella versione originaria del Jobs Act risultava assai ridotta per l’operare congiunto delle modalità di calcolo rigidamente fissate dalla legge, che ne determinavano la crescita automatica in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore, e della fissazione di importi minimi e massimi assai contenuti. L’esiguità dell’indennità risarcitoria risultante dall’applicazione di tali parametri ne faceva per questo, in molti casi, uno strumento inadeguato sia sul piano deterrente-sanzionatorio - per scoraggiare il datore dal commettere l’illecito e poi punirlo - che risarcitorio - per ristorare adeguatamente il lavoratore per il danno subito.
È noto come la Corte costituzionale abbia poi inciso in modo significativo su questo quadro, sia rivisitando le modalità di calcolo della indennità, sia ampliando - a mio parere del tutto condivisibilmente - i confini della tutela reale. Il Jobs Act, infatti, nella sua versione originaria, nel tentativo di rendere centrale la tutela indennitaria, violava per molti aspetti vincoli di sistema.
È bene ricordare comunque come la Corte in molte occasioni abbia ribadito al contempo che la tutela reale non è di per sé costituzionalizzata e, dunque, che la scelta fra tutela reale ed indennitaria è rimessa alla discrezionalità del legislatore (v. fra le tante C. Cost. 46/2000; C. Cost. 194/2018; C. Cost. 59/2020; C. Cost. 128 e 129/2024), purché però la tutela prescelta sia “adeguata” e “sufficientemente dissuasiva” (C. Cost. 128 e 129/2024), avendo riguardo alla singola forma di tutela in sé considerata (C. Cost. 194/2018 e 150/2020), e purché la graduazione delle tutele sia ragionevole in rapporto alle varie tipologie di vizi, tanto all’interno dello stesso disposto normativo (C. Cost. 59/2021 e 125/2022), quanto a fronte della disciplina dei licenziamenti nel suo complesso (C. Cost. 7/2024). A queste condizioni, dunque, la tutela indennitaria può essere scelta come “tutela regolare” dalla legge.
Se questo ha sempre costituito lo sfondo del ragionamento della Consulta, sono però proprio le scelte concretamente compiute dal Jobs Act nell’articolare la linea di distinzione fra tutela reale ed obbligatoria e nello strutturare quest’ultima a risultare in contrasto con principi cardine del nostro sistema costituzionale. Rimandando alle prossime risposte a questa intervista un più articolato richiamo alle pronunce della Corte costituzionale, si vuole qui sottolineare - a titolo di esempio delle enormi contraddizioni ed aporie insite del Jobs Act- l’insostenibilità sistematica della distinzione tracciata in punto di tutele fra licenziamento ingiustificato perché privo della ragione soggettiva - che avrebbe dato luogo in caso di insussistenza del “fatto” alla reintegrazione - e licenziamento privo della ragione oggettiva di tipo economico - che avrebbe dato luogo in caso di insussistenza del “fatto” solo alla tutela indennitaria (sul punto C. Cost. 128/2024). Come è infatti possibile a fronte di un licenziamento comunque privo di giustificazione (e dunque in ogni caso “acausale”) differenziare la sanzione in dipendenza unicamente della giustificazione formalmente addotta dal datore ma, in concreto, insussistente? Ciò non comporta rimettere al datore stesso la scelta della sanzione da applicare e, dunque, in ultima analisi svilire il principio di necessaria giustificazione del licenziamento?
È dunque proprio per la non linearità e coerenza delle scelte concretamente compiute che il Jobs Act è rimasto esposto agli “strali” della giurisprudenza ed alle pronunce della Corte costituzionale.
B. Caruso. Approfitto ancora della funzione civetta della risposta di Maria Teresa e mi aggancio alla sua per riflessioni ulteriori sulla domanda.
Il quadro sistemico delineato da entrambe le riforme della disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo si è assestato su un punto di non ritorno, come ho detto prima ormai accettato anche dai più radicali sostenitori della cultura della reintegrazione: dalla opzione statutaria del rimedio unico (l’antico art. 18), al sistema plurale: a “ogni licenziamento la sua sanzione”.
La dialettica tra indennizzo e reintegrazione, che il Jobs Act ha innescato in maniera più radicale della riforma Fornero, non ha dunque riguardato il criterio della disseminazione delle sanzioni in ragione della diversa fattispecie espulsiva; bensì la calibratura e la ponderazione tra i due rimedi; detto altrimenti, il reciproco rapporto di regola ed eccezione.
Se nel regime “Fornero” non era del tutto chiaro quale fosse la regola e quale l’eccezione, individuandosi per alcuni un sostanziale e armonico equilibrio tra i due rimedi (Riccardo Del Punta); per altri (Arturo Maresca) - e per una certa fase almeno anche per la Suprema Corte - l’indennizzo come regola e la reintegra come eccezione, proprio tale incertezza (anche in ragione delle prime interpretazioni “correttive” della giurisprudenza di merito), indusse il legislatore del Jobs Act a rompere l’equilibrio e a delineare, con maggiore nettezza, un regime di prevalenza dell’indennizzo sulla reintegrazione.
Quel che è avvenuto dopo è noto: la Cassazione stessa e soprattutto la Corte costituzionale hanno giocato non semplicemente di cacciavite ma anche di pialla, e l’equilibrio perduto con il Jobs Act - tra ipotesi di reintegra e di indennizzo - è stato in larga misura ripristinato, se non addirittura capovolto a favore della reintegra, al punto, ma questo è un altro discorso, che appare dubbio che possa ancora considerarsi attuale l’indirizzo della Corte di cassazione sulla prescrizione che considera la data cessazione del rapporto di lavoro come termine a quo della prescrizione sul presupposto che sarebbe venuto meno, per le riforme attuate, la tutela reale in via generalizzata e quindi il regime di stabilità.
Persino la summa divisio - che era l’imprinting del Jobs Act - tra licenziamenti disciplinari, ove poteva operare una ipotesi, ancorché residuale, di reintegra attenuata (l’insussistenza del fatto contestato) e tutta l’area dei licenziamenti economici (per giustificato motivo oggettivo e collettivi), assistiti soltanto dal rimedio indennitario ancorché forte (36 mensilità come tetto massimo), è stata messa in discussione dalla Corte Costituzionale (con la sentenza n. 128/2024, che ha reintrodotto la reintegra anche nella ipotesi acclarata di insussistenza del giustificato motivo oggettivo).
Certamente, ed è un dato da non trascurare, rimane indiscussa, anche per l’avallo della Corte costituzionale (sent. n. 7/2024), la scelta del Jobs Act di collocare l’intera disciplina dei licenziamenti collettivi nell’alveo della tutela indennitaria (ricordo che la legge Fornero prevedeva la reintegrazione nella ipotesi di violazione dei criteri di scelta). Onde sui licenziamenti collettivi l’eventuale abrogazione del Jobs Act avrebbe certamente un effetto ripristinatorio della reintegra almeno per l’ipotesi di violazione dei criteri di scelta.
Allo stato attuale, dopo l’ampio rimestio ortopedico, quale sia la regola e quale l’eccezione tra i due rimedi è davvero difficile da discernere.
Il quadro regolativo è ormai divenuto altamente frastagliato e complesso; esso è costituito da regole incerte, orientamenti giurisprudenziali antitetici e sentenze ortopediche dei giudici costituzionali che, a loro volta, potrebbero dare la stura a possibili orientamenti di merito difformi: si pensi ai problemi interpretativi che apre la sentenza n. 129/2024 con riguardo alla lettura delle clausole contrattuali sulle fattispecie disciplinari “aperte” ovvero dettagliate e precise nei contorni.
Risulta pertanto urgente un intervento razionalizzatore del legislatore, tecnicamente attrezzato, e non certo del corpo elettorale attraverso lo strumento referendario, inadeguato alla bisogna per la sua natura binaria: si/no.
Una dimostrazione in vitro, di quanto sostenuto, deriva proprio dall’osservazione di un effetto distorsivo e rifrangente di cui neppure i promotori si avvedono, e non potevano evidenziarlo anche in ragione dei limiti intrinseci dello strumento referendario. Una delle norme del Jobs Act lesiva dei diritti dei lavoratori ingiustamente licenziati e reintegrati - che riproduce tale e quale la norma della Fornero, per cui l’esito referendario non potrà comunque incidere - è quella che pone a loro carico l’alea della durata del processo; ciò al contrario dell’articolo 18 originario che la poneva, altrettanto ingiustamente, per intero a carico dei datori di lavoro: la norma che, nel caso di reintegra attenuata, pone il limite delle 12 mensilità come risarcimento massimo a favore del lavoratore reintegrato. Orbene, già con il rito Fornero, ma a maggior ragione dopo la sua abrogazione, è fatto notorio che una sentenza di reintegra interviene normalmente ben oltre 12 mesi dal licenziamento, persino in primo grado. Onde il rischio della lunghezza del processo è, oggi, a carico del lavoratore, per esperienza risultando un pallido surrogato del rito Fornero la norma processuale di accelerazione delle controversie in materia di licenziamento con richiesta di reintegrazione: art. 441bis cpc. Ciò perché in qualunque momento dovesse avvenire la reintegrazione, il datore di lavoro ha la certezza di un tetto di risarcimento (12 mensilità), mentre il lavoratore ingiustamente licenziato con reintegra attenuata, perderà, per probabilità statistica, una parte delle retribuzioni che sarebbero maturate senza il licenziamento.
Pare evidente che - senza necessariamente ripristinare un automatismo eguale e contrario e in assenza di dispositivi processuali finalizzati ad accelerare realmente la durata dei processi di licenziamento, come quello che, con tutte le aporie tecniche rilevate, era comunque costituito dal rito Fornero - si presenti l’esigenza di una riforma della disciplina che consenta almeno al giudice, discrezionalmente, di elevare la misura della indennità risarcitoria oltre le 12 mensilità magari sino a un tetto massimo in caso di reintegra “attenuata”, tenendo conto dei tempi del processo. In alternativa, riterrei più opportuno agire sul processo, abbreviandone i tempi strutturalmente: il rito Fornero andava migliorato ed emendato da alcune irrazionalità processuali, ma non semplicemente abrogato, come improvvidamente avvenuto.
M. T. Carinci. Vorrei aggiungere solo qualche parola circa l’osservazione - giustamente avanzata da Bruno - per cui anche nel nuovo sistema che si dovesse realizzare dopo il positivo esito referendario l’alea del processo tornerebbe a danno del lavoratore dal momento che l’art. 18 St.lav. oggi vigente pone il tetto di 12 mensilità al risarcimento che accompagna la reintegrazione “attenuata”.
Ricordo un suo articolo di diversi anni fa in cui si interrogava su quali modifiche fossero opportune a fronte dell’originario testo dell’art. 18 St.lav. (v. B. Caruso, Per un ragionevole, e apparentemente paradossale, compromesso sull’art. 18: riformarlo senza cambiarlo, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 140/2012). In quel contributo Bruno affermava che uno degli interventi cardine che avrebbe potuto evitare lo “smantellamento” dell’art. 18 St.lav. era da individuare nella previsione di meccanismi processuali che permettessero una definizione molto rapida delle cause in materia di licenziamento. Già allora avevo ritenuto assolutamente da condividere la sua posizione; quella soluzione avrebbe potuto evitare di imboccare la strada impervia dello “sfrangiamento” delle tutele, poi invece seguita in sede di riforme.
Concordo inoltre con lui sul fatto che per evitare l’esito di un risarcimento “inadeguato” sarebbe oltremodo opportuno che la legge demandasse al giudice il potere di calibrare l’indennità risarcitoria anche oltre il limite delle 12 mensilità, così da renderla effettivamente risarcitoria e adeguatamente dissuasiva a beneficio del lavoratore.
A ben vedere il problema della fissazione di un “tetto” alle indennità risarcitorie si pone, qui, come si è già posto in altri “snodi” della disciplina.
Mi riferisco in particolare al limite massimo dell’indennità risarcitoria prevista come “tutela regolare” ex art. 3 D. Lgs. 23/2015. Con riguardo a quella norma - con una presa di posizione a mio parere discutibile - C. Cost. 194/2018 ha ritenuto però la previsione di un “tetto” all’importo dell’indennità giustificabile alla luce del sistema, purché l’importo previsto sia “adeguato” (v. risposta alla domanda 5). A mio parere una disciplina che volesse essere coerente dovrebbe prevedere sempre la possibilità di adeguamento dell’importo dell’indennità da parte del giudice, sia nel caso in cui l’indennità affianchi la reintegrazione “attenuata”, sia - e tanto più - nel caso essa costituisca l’esclusiva forma di tutela prevista dalla legge.
V. A. Poso. Restava, comunque, la differenziazione delle tutele in base alle dimensioni del datore di lavoro, che si colloca in linea conseguente alla disposizione normativa dell’art. 18 e della l. 15 luglio 1966 sui licenziamenti individuali (ancora applicabile ai vecchi assunti).
M. T. Carinci. In effetti il Jobs Act conferma la scelta già compiuta dall’art. 18 St.lav. e dalla l. 604/1966 per i “vecchi assunti”, prevedendo che anche i “nuovi assunti” da datori di lavoro di più piccole dimensioni in ragione del numero di lavoratori occupati godano - salvo nel caso del licenziamento nullo - di una tutela esclusivamente indennitaria e per di più molto contenuta (l’importo infatti è dimezzato rispetto a quello previsto per i datori medio-grandi e non può comunque superare le 6 mensilità di retribuzione, cfr. art. 9 D. Lgs. 23/2015; viceversa l’art. 8 l. 604/1966 prevede un’indennità fra 2,5 e 6 mensilità elevabile fino 14 mensilità in dipendenza dell’anzianità del lavoratore).
Tale duplice scelta del legislatore - id est: l’esclusione della tutela reintegratoria e la previsione di una tutela indennitaria molto esigua - non è conforme alla Costituzione.
Quanto alla questione della esclusione per i datori di lavoro di più piccole dimensioni dalla tutela reintegratoria, è noto come la Corte costituzionale, più volte chiamata in passato a valutare sotto questo profilo la legittimità costituzionale dell’art. 18 St.lav., abbia ritenuto ragionevole alla luce della Costituzione quella disparità di tutele - radicata nel numero di lavoratori occupati dal datore di lavoro - , vuoi per non gravare i datori di più piccole dimensioni di oneri eccessivi, vuoi per la natura fiduciaria dei rapporti di lavoro che caratterizza queste organizzazioni, vuoi per le tensioni che un ordine di reintegrazione potrebbe ingenerare in tali contesti (C. Cost. 2/1986; C. Cost. 189/1973; C. Cost. 152/1975).
Sennonché nel sistema produttivo altamente tecnologizzato di oggi non è certo il numero dei lavoratori occupati che denota le capacità economiche di un’impresa: datori di lavoro con pochi dipendenti che sfruttino le nuove tecnologie ed operino in settori economici particolarmente ricchi possono realizzare performance economiche molto più significative (fatturato; ricavi; ammontare degli investimenti, ecc.) di altri che abbiano alle proprie dipendenze molti lavoratori. Rimane, certo, la questione della difficoltà di ricostituire un sereno rapporto fra il lavoratore illegittimamente licenziato e il datore di lavoro costretto a reintegrarlo, ma è una questione che si pone anche in altre situazioni (si pensi al licenziamento nullo, discriminatorio, ecc.) in cui l’ordinamento non esita a prevedere anche per i datori di lavoro con un minor numero di dipendenti la sanzione della reintegrazione.
In breve: il parametro del numero di occupati non può più costituire nel contesto produttivo odierno il criterio per escludere l’applicazione della tutela reintegratoria, come del resto statuito da C. Cost. 183/2022 (punto 5.3. cons. dir.).
Quanto poi all’importo dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 9 D. Lgs. 23/2015, con tutta evidenza essa è troppo esigua e pertanto non in grado di svolgere la propria duplice funzione al contempo deterrente/sanzionatoria e risarcitoria del danno patito dal lavoratore. Anche su questo punto appare a mio avviso inequivocabile ed assolutamente condivisibile la posizione espressa da C. Cost. 183/2022 (punto 4.2 cons.dir.).
Tuttavia, la Corte nella pronuncia appena citata - pur segnalando l’irragionevolezza della disciplina - ha dichiarato la questione d’illegittimità costituzionale dell’art. 9, c. 1, D. Lgs. 23/2015 inammissibile. Secondo la Corte, infatti, “rientra nella prioritaria valutazione del legislatore la scelta dei mezzi più congrui per conseguire un fine costituzionalmente necessario”. Al contempo, però, la Corte ha rivolto un monito al legislatore affinché si affretti a fornire adeguata tutela anche ai lavoratori delle realtà di più piccole dimensioni: “la Corte non può conclusivamente esimersi dal segnalare che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e la indurrebbe, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente, nonostante le difficoltà qui descritte” (v. C. Cost. 183/2022 punto 7 cons.dir.).
Occorre inoltre ricordare che di recente il Tribunale di Livorno (con ord. 240 del 24 dicembre 2024) ha nuovamente investito la Corte della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, c. 1, D. Lgs. 23/2015.
Se dunque il referendum non avrà successo, la Consulta sarà nuovamente chiamata a pronunciarsi sul punto e, considerata la posizione tranchant già assunta, nonostante le difficoltà di rinvenire nel sistema i criteri cui il giudice dovrà poi attenersi, è prevedibile che finisca per dichiarare la norma incostituzionale.
Se viceversa il referendum dovesse avere successo gli esiti possibili sono due.
Il primo, legato all’abrogazione referendaria unicamente del Jobs Act, avrebbe come conseguenza l’applicazione alle imprese di minori dimensioni (individuate sulla base sempre del numero dei dipendenti) dell’art. 8 l. 604/1966: il lavoratore avrebbe dunque diritto ad una indennità il cui importo massimo sarebbe più alto di quello oggi previsto dal Jobs Act (fino a 14 mensilità per i lavoratori con maggiore anzianità di servizio). Viceversa, se venisse contemporaneamente approvato anche il quesito referendario rivolto all’abrogazione di parte dell’art. 8 l. 604/1966, l’esito sarebbe l’eliminazione tout court per i lavoratori delle imprese minori di ogni limite massimo al risarcimento.
B. Caruso. Il tema del rafforzamento del sistema di tutele contro il licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, come segnala Maria Teresa, è certamente all’ordine del giorno di un possibile intervento di ritorno della Corte costituzionale - che ha già lanciato un monito in tal senso - nel caso in cui il legislatore dovesse rimanere inerte (a maggior ragione dopo la rinnovata sollecitazione del Tribunale di Livorno).
Ci sono due diverse possibilità tecniche per rafforzare la tutela dei lavoratori nelle imprese minori, lo ricorda bene la Corte costituzionale nella sentenza n. 13/2025 di ammissione del quesito. Una prima è quella tranchant, sottoposta dai promotori del referendum al corpo elettorale, e consiste nel non porre limite alcuno alla indennità risarcitoria nel caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese.
Occorre però precisare che il calcolo dei promotori del referendum, per raggiungere tale risultato, è basato su due convergenti abrogazioni, il Jobs Act per intero e l’art. 8 della 604/1966; perché se il corpo elettorale si esprimesse, cosa improbabile ma non astrattamente impossibile, in maniera asimmetrica - per esempio abrogando l’art. 8 ma non l’art. 9 del Jobs Act - l’abrogazione del primo articolo sarebbe inutiliter data, rimanendo in vigore la norma di minor favore del Jobs Act che sarebbe destinata con il tempo ad applicarsi a tutti i lavoratori. Quindi un effetto, anche se solo potenziale, boomerang.
Ma a parte questi possibili cortocircuiti connessi allo strumento referendario a cui si affidano i promotori, osserviamo da vicino i diversi dispositivi di tutela dei lavoratori nelle imprese minori.
Dicevo che il primo meccanismo è quello di un rafforzamento dell’indennizzo, escludendosi per scelta ormai consolidata nelle imprese minori la reintegra. Tale rimedio è stato ontologicamente scartato per le ragioni pragmatiche a suo tempo evidenziate dalla Corte cost.: al di là delle intrinseche difficoltà organizzative di ripristinare un rapporto di lavoro in un contesto organizzativo minore, la rottura del vincolo fiduciario è certamente più netta nelle imprese minori anche sul versante del lavoratore licenziato. È vero come dice Maria Teresa che, in astratto, l’eventuale qualificazione come nullo del licenziamento consente la reintegra anche nel contesto dell’impresa minore; ma sfido chiunque a portare un caso pratico di un lavoratore che accetta la reintegra in un micro ambiente lavorativo dopo la dichiarazione di nullità del proprio licenziamento in un contesto di relazioni personali, gomito a gomito, definitivamente deteriorate.
Detto questo, si può pensare a rafforzare la portata dissuasiva dell’indennizzo come abbiamo provato a fare come “Gruppo Freccia Rossa” (all’art. 6, comma 3, del nostro progetto è prevista “una indennità commisurata all’ultima retribuzione di cui all’art. 2121 c.c., determinata in un importo non inferiore a quattro mensilità e non superiore a dodici mensilità, nel caso di anzianità di servizio non superiore a dieci anni, e fino a diciotto mensilità, nel caso di anzianità di servizio superiore a dieci anni”). Ma ci deve essere un tetto massimo all’indennizzo, al contrario di quel che propongono i promotori, se non si vuole penalizzare eccessivamente il sistema delle piccole imprese che regge l’economia italiana, già sotto stress per i dazi di Trump.
Accarezzare, pertanto, il sogno di una indennità senza limite, lasciata soltanto alla valutazione solipsista del giudice, è opzione irrealista per un verso, e pregiudizialmente anti impresa per l’altro, che è cultura diffusa tra una parte degli intellettuali, giudici e dottrina giuslavorista italiana (come ho sottolineato altrove in un saggio a doppia firma – con Corrado Caruso, Licenziamento e «politiche» giurisdizionali del lavoro. Riflessioni interdisciplinari a partire dalle sentenze nn. 128 e 129/2024 della Corte Costituzionale), RIDL,3, 2024, I,323 e ss. (parte prima) e 4, 2024, I, 531 e ss. (parte seconda).
L’altra possibile strada di intervento a favore dei lavoratori delle piccole imprese è rivedere i criteri di individuazione della impresa minore per meglio definirne i confini allo scopo dell’applicazione dei diversi regimi di tutela: obbligatorio e reale si diceva un tempo. Suggerimenti in tal senso provengono pure dalla sentenza monito della Consulta, la n. 183/22.
Anche in ragione di ciò il “Gruppo Freccia Rossa” ha provato a trovare una soluzione congrua e realistica per una riqualificazione degli indici di accertamento della dimensione imprenditoriale che andasse oltre il numero dei dipendenti: fatturato, ricavi, investimenti e capitale ammortizzato, EBITDA, MOL, ecc. Abbiamo preso in considerazione altri contesti normativi ove la definizione di impresa minore è affidata a indici economico-finanziari, ma essi sono risultati tutti inadatti, nel contesto della disciplina dei licenziamenti. Nessuno funziona: l’unico che dà certezza è quello del numero dei dipendenti che traccia una linea di distinzione certa e relativamente immediata, perché individua una soglia netta e non finanziariamente opaca o quanto meno fluida.
Rendere più complessi gli indici di accertamento, avrebbe, come unico probabile effetto, il blocco sine die o quasi delle controversie in cui preliminarmente si eccepirebbe l’applicabilità della disciplina in ragione della dimensione d’impresa e con aumenti di costi dovuti alla necessità che il giudice avrebbe di ricorrere a onerose consulenze finanziarie specialistiche. Sull’altare del diverso accertamento della soglia di applicazione del regime di licenziamento si sacrificherebbero, allora, le ragioni di celerità dell’accertamento della illegittimità del licenziamento.
V. A. Poso. Il testo originario del d. lgs. n. 23/2015, risulta modificato ad opera di successivi interventi legislativi, ma anche per i corposi interventi della Corte Costituzionale.
Chiedo, innanzitutto, a Maria Teresa Carinci di tracciare un quadro sintetico delle riforme legislative intervenute sino alla data della comunicazione dell’iniziativa referendaria e una breve valutazione delle stesse.
M. T. Carinci. È così: il Jobs Act è stato modificato in punto di disciplina del licenziamento dapprima, in parte, dallo stesso legislatore e poi, soprattutto, da alcune importantissime pronunce della Corte costituzionale.
Quanto alle modifiche legislative, il riferimento è soprattutto al cd. “Decreto Dignità” (d.l. 87/2018 conv. in l. 96/2018), approvato dal primo Governo presieduto da Giuseppe Conte, con l’intento dichiarato di tutelare la dignità delle persone, dando un “colpo mortale al precariato” (dalla Conferenza stampa del Ministro del lavoro Luigi Di Maio del 3 luglio 2018).
Ulteriori interventi normativi, che non hanno intaccato in alcun modo la struttura del Jobs Act, hanno riguardato, invece, il raccordo fra le tutele da esso previste in tema di licenziamento collettivo ed il Codice della crisi d’impresa (art. 10 D. Lgs. 23/2015).
Soffermandosi sul “Decreto Dignità”, è noto come esso si sia limitato ad elevare (per vero in modo significativo) gli importi minimo e soprattutto massimo dell’indennità risarcitoria già prevista dal Jobs Act per il licenziamento ingiustificato (rispettivamente da 4 a 6 mensilità e da 24 a 36 mensilità di retribuzione). L’intervento è stato indubbiamente opportuno, in quanto l’importo dell’indennità che caratterizzava l’originaria versione del decreto era decisamente inadeguato per assolvere le plurime funzioni assegnatile dalla legge: risarcitoria - cioè fornire adeguato ristoro ai danni patiti dal lavoratore illegittimamente licenziato - e deterrente/sanzionatoria - cioè prevenire e punire il datore che ponesse in essere un licenziamento viziato.
Tuttavia, il “Decreto Dignità” ha, al contempo, lasciato intoccato ogni altro aspetto: non solo non ha inciso sulla scelta di porre al centro del sistema la tutela indennitaria, ma, quanto alla tutela economica, non ne ha modificato né gli importi in caso di vizio di motivazione o di procedura, né il meccanismo di calcolo, vero punto critico di questa parte della disciplina, che è pertanto rimasto ancorato in modo automatico all’anzianità di servizio del lavoratore.
In breve, l’impianto della riforma non è stato messo in alcun modo in discussione.
V. A. Poso. È, questa, una valutazione condivisibile?
B. Caruso. La prima valutazione che mi viene sul quesito posto (il quadro dello stato dell’arte della disciplina sino alla prova referendaria) è in qualche modo preliminare e di tipo politico-istituzionale: se il governo Renzi ha compiuto le nefandezze neoliberiste di cui si dice, veicolate per altro da dispositivi tecnici improbabili, non si capisce perché nessuno dei governi multicolori e arcobaleno che si sono succeduti, abbia posto mano ad una radicale riforma di quella riforma, reintroducendo la reintegra pervasiva.
Anzi il “Decreto Dignità”, richiamato da Maria Teresa, conferma una convinzione probabilmente subliminale degli stessi riformatori anti Jobs Act: e cioè che la reintegrazione, come rimedio, non è quel totem da adorare irrazionalmente, il tabù intoccabile per ragioni simboliche e politiche, potendo costituire anche l’indennizzo un rimedio alternativo, altrettanto ripristinatorio e dissuasivo.
A questo punto bisogna chiarire un passaggio: molti cultori della reintegra, senza se e senza ma, ammantano tale idolo con la tesi dell’ossequio ai sacri principi del diritto civile: se la sanzione civilistica tipica per l’inadempimento è la restitutio in integrum, scostarsi dal rimedio integralmente ripristinatorio nell’ipotesi del licenziamento illegittimo significa invertire la relazione antica tra diritto primo e diritto secondo (per cui quest’ultimo nasce storicamente non solo per specializzare ma per integrare le carenti strutture rimediali del primo nei rapporti di lavoro). Onde la reintegra non solo come rimedio normale, ma come panacea per i lavoratori, che dovrebbe soffrire al più limitatissime eccezioni (per esempio le piccole imprese).
In disparte che tecnicamente, anche in chiave di pura applicazione dei principi civilistici, questo assunto non è vero perché dogmatico in senso tecnico (non posso dilungarmi in questo); e in disparte che se così fosse non si capisce come mai in nessun sistema comparato, anche a tradizione civilistica, la reintegrazione abbia assunto questo valore taumaturgico e totalizzante che ha avuto invece in Italia; ricordo, per inciso, che la stagione dello Statuto aveva una sua ratio storica formidabile; non ontologica o dogmatica, dunque, ma socialmente e politicamente contingente, come spiegò Massimo D’Antona nella sua basilare monografia.
Dico questo perché la visione pan-reintegrazionista dei rimedi contro il licenziamento illegittimo non è condivisa neppure dai lavoratori in carne e ossa che affrontano il contenzioso giudiziale. È esperienza di qualunque avvocato (anche degli avvocati della CGIL), che si confronta con controversie in materia di licenziamento, che i clienti, nove volte su dieci, preferiscono soluzioni monetarie indennitarie, sia in fase di conciliazione stragiudiziale sia a fronte a una sentenza che consente loro la scelta se accettare la reintegra giudiziale o optare per l’indennità sostitutiva.
E tale atteggiamento non è certo espressione dell’abdicazione della classe lavoratrice alle magnifiche e progressive sorti leopardiane e all’adesione alla religione del dio denaro (i segnali di tale decadimento culturale delle classi subalterne sono altrove, basta studiare con attenzione i flussi elettorali nell’America di Trump o la base di consenso di cui gode l’attuale compagine governativa sovranista e anti europeista); ma è espressione di un approccio realistico e pragmatico. Chiudere una esperienza lavorativa ormai anche psicologicamente esaurita (la rottura del contratto psicologico) con un compenso monetario, è un atteggiamento non utilitaristico ma assolutamente ragionevole: finire per ricominciare e rimettersi in gioco altrove, a partire tuttavia da una compensazione economica non umiliante ma, appunto, equilibrata e positiva.
M. T. Carinci. Vorrei obiettare a Bruno che non mi pare che la questione sul tappeto sia se il legislatore possa scegliere fra tutela reale o obbligatoria: come ho già sottolineato è la stessa Corte costituzionale ad affermare a più riprese che la tutela reale contro il licenziamento non è costituzionalizzata.
Quello che mi sembra il referendum voglia mettere in questione è, da una parte, la coerenza delle discipline e, dall’altra, l’opportunità in questo momento storico di tutelare con forza la posizione dei lavoratori.
Il referendum intreccia questi due snodi: vuole da una parte ricomporre la “frattura” fra vecchi e nuovi assunti e dall’altra riportare al centro del discorso politico la tutela del lavoro.
V. A. Poso. Chiedo, invece, a Bruno Caruso di tracciare un quadro sintetico della giurisprudenza della Consulta nel primo “miniciclo” dal 2018 al 2021. Anche quelle che hanno rigettato le questioni di legittimità costituzionale, per completezza.
B. Caruso. Presto detto. Nel saggio a quattro mani sulla RIDL a cui ho fatto cenno, si è partiti da un quadro sinottico delle pronunce della Consulta che facilitasse anche una lettura in chiave di metodo realista del suo itinerario. Non vi è alcun dubbio che le sentenze sino al 2021, nel segno della redattrice, l’autorevole collega e amica Silvana Sciarra, hanno una impronta di policy chiara.
Dico subito che, in questo ideale primo miniciclo di sentenze della Corte, inserirei anche la n.125/2022 che ha eliminato con riguardo alla legge Fornero la qualificazione di “manifesta” con riguardo alla insussistenza del giustificato motivo oggettivo allo scopo della reintegra attenuata.
In questo primo miniciclo la Corte si muove ovviamente sulla base degli input provenienti dai giudici rimettenti, attraverso un dialogo diretto che le consente di contrastare, in prima battuta, le maggiori “durezze” regolative del Jobs Act: in particolare quel po’ di firing cost ideology a cui la riforma si ispirava con riguardo alla predeterminazione del costo del licenziamento attraverso una forma di automatismo nel calcolo dell’indennizzo entro la forbice prevista dalla legge. Ricordo, a tale proposito, che nella teorizzazione originaria del premio Nobel Jean Tirole, non avrebbe dovuto essere comunque il magistrato a fissare il costo del licenziamento; l’economista francese considerava questa una “missione impossibile” (Economia del bene comune, Mondadori, 2017, p. 263), onde tale compito sarebbe spettato direttamente alla legge o all’autorità amministrativa.
Nel Jobs Act il calcolo veniva invece affidato al giudice (e qui lo scostamento dalla firing cost theory ortodossa), ma in guisa notarile o ragionieristica; su questo vulnus alla tradizionale discrezionalità giudiziale dell’accertamento del quantum di danno (l’automatismo del calcolo), affonda il bisturi la Corte costituzionale con le due sentenze abbrivio della complessiva manipolazione ortopedica: la n. 194 del 2018 e la n. 150 del 2020. La Corte si spinge anche sino a una valutazione di merito, certamente condivisibile, circa la scarsa dissuasività e la pochezza del rimedio indennitario, soprattutto per i neoassunti.
In questo miniciclo, tuttavia, la Corte introduce pure due ragionamenti, non a caso stigmatizzati dai cultori della reintegra, che invece rendono, almeno politicamente, bilanciata l’operazione ortopedica.
Il primo relativo ai licenziamenti collettivi, ove (sentenza n. 254/20) la Corte dichiara brutalmente inammissibili le ordinanze di illegittimità relativamente alle nuove regole del Jobs Act mirate ad eliminare ogni ipotesi di reintegrazione nei licenziamenti collettivi (personalmente avevo avuto modo di criticare già le ordinanze dei giudici di Napoli e di Milano in un saggio, Il contratto a tutele crescenti nella tenaglia della doppia pregiudizialità, DML, 3, 2019, p. 381 e ss.). Il secondo argomento, in seguito più volte ripreso, va nella direzione di salvare la scelta legislativa del doppio regime in ragione del trascorrere tempo (la famosa cesura del 7 marzo 2015 per i due diversi trattamenti).
L’argomento utilizzato dalla Corte, in tale ultimo caso, non è particolarmente potente né sotto il profilo dell’argomentazione giuridica, né della finezza in punto di teoria economica: vale a dire la dichiarata, dal Governo, funzionalizzazione del discrimen temporale agli obiettivi di incremento occupazionale.
Ma la Corte manda un messaggio di carattere generale per giustificare l’operazione di bilanciamento complessiva: se un governo giustifica esplicitamente una scelta di differenziare i trattamenti (e i diritti) ratione temporis, sulla base di risultati economici attesi dalla propria misura di natura occupazionale, questa scelta non può essere contestata e va considerata costituzionalmente legittima; ove gli echi della celeberrima sentenza Mangold della Corte di giustizia dell’UE sono evidenti (CGE 22 novembre 2005, C-144/04, Mangold).
Nella seconda parte del miniciclo la Corte invece si rivolge non più al Jobs act ma alla legge Fornero. Sembrerebbe un incedere sistematico rispondente ad un ordito logico e di policy: prima le discrasie costituzionali più evidenti dove operare con l’accetta; poi il lavorio affidato al bisturi o al cacciavite; se non fosse che la cronologia degli interventi è fissata dai giudici che sollevano le questioni di costituzionalità. Fatto è che nella seconda fase del miniciclo, la Corte, e la sua autorevole redattrice, si dedicano a “ripulire” la legge Fornero dagli elementi di imperfezione, imprecisione tecnica e corriva mediazione del legislatore che, pur tali, finiscono per restringere un ideale perimetro di “giusta tutela” contro il licenziamento illegittimo.
Faccio riferimento alle sentenze (la n. 59 del 2021 e la n. 125 del 2022) più debitrici delle lezioni di Gianrico Carofiglio sul lessico e sull’ecologia del linguaggio: notoriamente la Consulta cassa l’avverbio “manifestamente” riferito all’insussistenza del GMO; ma poi inopinatamente se la prende con la discrezionalità del giudice, che aveva prima difeso a proposito della determinazione del quantum dell’indennità, allorché sostituisce al verbo “potere” (nell’accezione di possibilità, libertà) il verbo “dovere” (nell’accezione obbligato a), sempre a proposito della decisione di reintegrazione nel caso del GMO semplicemente insussistente e non più manifestamente tale. Due pesi e due misure, si potrebbe dire con riguardo al valore della discrezionalità giudiziale; ma quando si tratta di strategie sostanziali di tutela - potrebbe essere questo il metro di valutazione dell’operato della Consulta - il criterio logico della coerenza può pure trascurarsi: ma sempre di manifesta illogicità si tratta.
V. A. Poso. Sono condivisibili queste osservazioni di Bruno Caruso?
M. T. Carinci. C’è del vero nella ricostruzione che Bruno propone con riferimento alle pronunce della Corte costituzionale che in questa prima fase hanno investito il Jobs Act.
La Corte demolisce, infatti, una delle scelte più dirompenti del Jobs Act relativa alle modalità di calcolo di quell’indennità risarcitoria che è stata fatta assurgere, almeno nelle intenzioni, a tutela “regolare” del licenziamento viziato - nella sostanza una sorta di firing cost destinato ad operare però solo in caso di licenziamento illegittimo e non in presenza di qualunque licenziamento anche legittimo - ritenendola in contrasto con il sistema, ma non giunge fino a mettere in discussione l’intero impianto della riforma, come invece avrebbe potuto fare se fosse stata coerente con le proprie stesse premesse e con il sistema.
Da una parte, infatti, C. Cost. 194/2018 e C. Cost. 150/2020 hanno dichiarato incostituzionale il meccanismo di calcolo automatico dell’indennizzo secondo la progressione lineare dell’anzianità di servizio e hanno rimesso di conseguenza al giudice, nell’esercizio della sua discrezionalità e sulla base di parametri già presenti nel sistema (art. 8, l. 604/1966; art. 18 St.lav.; art. 30, l. 183/2010), la concreta individuazione dell’importo dovuto al lavoratore in una forbice tra il minimo e il massimo fissato dalla legge. L’indennità risarcitoria, già significativamente elevata nei suoi importi dal c.d. “Decreto Dignità” e rimessa ora a seguito della pronuncia della Corte ad una modulazione in concreto da parte del giudice, riacquista così la possibilità di esplicare effettivamente la propria funzione al contempo risarcitoria e sanzionatorio-deterrente.
Incidendo su tale meccanismo la Corte ha dunque rafforzato significativamente questa forma di tutela in linea con i principi costituzionali, che come anticipato, pur lasciando il legislatore libero di effettuare una scelta fra tutela reale e tutela obbligatoria, gli impongono però di congegnare tutele “adeguate” e “ragionevoli”.
Rimane però sul tappeto la questione del limite massimo fissato dalla legge all’importo dell’indennità: in alcune ipotesi (per es. in presenza di un’elevata anzianità del lavoratore, quando vengano in considerazione datori di lavoro di grandi dimensioni, in ipotesi in cui il danno patito dal lavoratore sia elevato, ecc.) il “tetto” posto dalla legge potrebbe costituire ostacolo al pieno dispiegarsi della funzione risarcitoria e sanzionatorio/deterrente che caratterizzano l’indennità. È con riferimento a questo aspetto che, a mio avviso, la Corte non porta il ragionamento fino alle sue estreme (ma coerenti) conseguenze le quali avrebbero richiesto che, pur con adeguata motivazione ed in casi estremi, quel limite potesse essere ritenuto superabile dal giudice.
C. Cost. 194/2018, infatti, pur ritenendo di non essere stata investita dal giudice remittente della questione, afferma però esplicitamente che la misura massima prevista dalla legge (nel testo originario pari a 24 mensilità ed a seguito del “Decreto Dignità” pari a 36 mensilità) realizza in ogni caso un “adeguato” contemperamento degli interessi in gioco, bilanciando adeguatamente il diritto al lavoro, da una parte, e la libertà di iniziativa economia, dall’altra. L’affermazione non è motivata e lascia dunque perplessi. Né la Corte ha ritenuto di valorizzare l’art. 24 della Carta Sociale Europea pure invocato dal giudice remittente come intrepretata dal Comitato europeo dei diritti sociali (l’organo deputato ad interpretare la Carta) che ritiene l’indennizzo per il licenziamento “adeguato” solo qualora ristori il lavoratore da tutte le perdite economiche patite dal momento del licenziamento a quello della sentenza e non sia soggetto a limiti massimi che ne pregiudichino l’integrale ristoro.
Per quanto riguarda l’altro passaggio compromissorio di C. Cost. 194/2018 si è già detto (v. riposta alla domanda 1) e concerne la ritenuta legittimità costituzionale, con riferimento al principio di uguaglianza, dello “spartiacque temporale” per l’applicazione del Jobs Act costituito dalla data di assunzione del lavoratore, (ritenuto dalla Corte, con una motivazione non convincente, giustificato dallo «scopo, dichiaratamente perseguito dal legislatore, di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione»).
Tuttavia, è evidente che l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale su questo punto avrebbe comportato la demolizione dalle fondamenta del Jobs Act.
B. Caruso. Mi limito a replicare che in altri sistemi (per esempio quello francese ma pure quello spagnolo) non è che i limiti massimi siano molto più alti, anzi; e comunque il discorso è chiuso dal c.d. “Decreto Dignità” che porta questo limite a 36 mensilità, tendenzialmente per tutti. Se sono queste le preoccupazioni di Maria Teresa, per paradosso, dovrei invitarla a votare contro l’abrogazione del Jobs Act, ma credo che in tal caso non gradirebbe il ragionamento per paradossi e preferirebbe quello tutto politico Landiniano…
V. A. Poso. Ci sono, poi, le pronunce del secondo “miniciclo” dal 2022 al 2024 (anche oltre la data di presentazione della richiesta referendaria). Chiedo, questa volta, a Maria Teresa Carinci di tracciare un quadro sintetico di queste decisioni della Corte Costituzionale.
M.T. Carinci. Anche in questa seconda “stagione” la Corte mette pesantemente in discussione le scelte del Jobs Act soprattutto con riguardo alle tutele da riconoscere al licenziamento individuale viziato. Tuttavia, in questa fase lo fa riespandendo in più ambiti la tutela reale a scapito della tutela indennitaria, senza però giungere a smantellarne l’impianto dalle fondamenta (come invece a mio parere avrebbe richiesto una lettura coerente del sistema), anzi, tentando al contrario di ricondurre a coerenza e razionalità l’impianto dell’intera disciplina dei licenziamenti individuali posto dal Jobs Act e dall’art. 18 St.lav. post legge Fornero.
Nel far ciò tuttavia la Corte, adotta soluzioni interpretative discutibili, contraddittorie rispetto alla propria precedente giurisprudenza e, a mio parere, nemmeno coerenti con il sistema.
La rassegna è assai complessa e articolata.
La prima pronuncia su cui intendo soffermarmi non pone a dire il vero i problemi segnalati, ma si mostra coerente con l’impianto dell’ordinamento. C. Cost. 22/2024, infatti, dichiara incostituzionale per eccesso di delega l’art. 2 D. Lgs. 23/2015 includendo così - sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale già affermatosi come prevalente - nello spettro della tutela reintegratoria “piena” tutte le ipotesi di nullità dell’atto di licenziamento “espressamente” (nullità testuali) o non “espressamente previste” (nullità virtuali): le prime si realizzano quando la disposizione imperativa violata contempla l’espressa e testuale sanzione della nullità; le seconde ricorrono quando sia possibile rinvenire, comunque, dal carattere imperativo della norma violata la conseguente sanzione di nullità. All’esito di tale pronuncia non solo il campo di applicazione della tutela reale “forte” si amplia significativamente, inglobando ipotesi prima incerte o discusse (si pensi al licenziamento ritorsivo, al licenziamento per motivo illecito, al licenziamento per frode alla legge, al licenziamento pretestuoso) ma, soprattutto, si allinea a quanto previsto dall’art. 18 St.lav.
C. Cost. 22/2024 realizza dunque in punto di nullità quel riassetto complessivo del sistema cui prima facevo cenno.
In seguito, C. Cost. 128/2024, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 2, del Jobs Act nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria “attenuata”, riservata dalla norma alle sole ipotesi di licenziamento disciplinare fondato su un fatto insussistente, statuisce che essa debba essere riconosciuta, in luogo di quella meramente indennitaria originariamente prevista, anche nelle ipotesi di licenziamento per g.m.o. di tipo economico “in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale rimane estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore”.
L’ipotesi del “fatto materiale insussistente” cui si applica la tutela reale “attenuata”, dunque, viene identificato dalla Corte nella carenza di due dei tre elementi che per costante orientamento della giurisprudenza compongono la fattispecie del g.m.o. di tipo economico: la riorganizzazione dichiarata dal datore di lavoro, ma poi non effettivamente realizzata, ed il nesso causale fra la riorganizzazione e mansioni del lavoratore. Per la Corte rimane, invece, estranea all’area di applicazione della tutela reintegratoria “attenuata” l’ipotesi di insussistenza del cd. repêchage.
C. Cost. 128/2024 - tanto più se letta congiuntamente alla sentenza “gemella” 129/2024 - a mio parere è sorretta dall’intento politico di ricondurre per quanto possibile ad armonia il sistema di tutele del licenziamento nel suo complesso, mantenendo al contempo fra i due plessi normativi (id est: lo Statuto, da una parte, ed il Jobs Act, dall’altra) quel décalage di tutele voluto dal legislatore del 2015 per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro degli outsider.
A questo obiettivo di fondo però le due sentenze “gemelle” del 2024 sacrificano la coerenza della disciplina del licenziamento.
Partendo dalla prima delle due pronunce va osservato come C. Cost. 128/2024 - pur chiarendo in modo del tutto condivisibile che il licenziamento per g.m.o. per “fatto materiale insussistente” è in realtà un licenziamento acausale (o pretestuoso), cioè privo di una qualunque ragione giustificatrice prevista dalla legge ed indistinguibile come tale da un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo privo di giustificazione - non ritiene poi, contraddittoriamente, di riconoscere per l’ipotesi di insussistenza del g.m.o. comprensivo di tutti i suoi elementi costitutivi (riorganizzazione, nesso causale e repêchage) sempre la medesima tutela reintegratoria, escludendo dal raggio della tutela reale “attenuata” l’insussistenza del repêchage.
Ma com’è possibile sanzionare diversamente un licenziamento in ogni caso acausale, quale che sia l’elemento strutturale del g.m.o. che risulti carente, se è vero, come la stessa Corte aveva in precedenza affermato (v. C. Cost. 59/2020 e 125/2021) che, sulla scorta del diritto vivente (v. Cass. 4509/2016), il g.m.o./causa/ragione dell’atto di recesso è composto in modo inscindibile da quei tre elementi consustanziali e fra loro inestricabili: la riorganizzazione, il nesso causale e il cd. repêchage?
D’altra parte, penso fermamente che il legislatore non possa modulare a suo piacere la nozione di g.m.o. di tipo economico, adottandone una più incisiva a fronte dell’art. 18 St.lav. ed una più blanda a fronte del Jobs Act, così da riconoscere nei due casi differenti tutele. Se infatti è vero che la ragione che caratterizza il licenziamento per ragioni economiche è di tipo tecnico-organizzativo (così anche C. Cost. 128/2024, punto 5.1 cons. dir.) - nel senso che l’ordinamento consente al datore di recedere dal contratto al fine di modificare la componente personale della propria organizzazione, licenziando quei lavoratori le cui mansioni si dimostrino non più utili nella sua nuova struttura (art. 3 l. 604/1966 ed art. 41 Cost.) - il repêchage non può che costituirne elemento consustanziale, necessario ed ineliminabile. Esso infatti non aggiunge alcunché alla ragione tecnico-organizzativa voluta dalla legge, ma ne denota unicamente l’effettività, imponendo al datore che dichiara la sussistenza di una ragione tecnico-organizzativa di dimostrare, poi, che essa ricorre nel caso concreto e, cioè, che le mansioni dei lavoratori licenziati, come dal datore stesso dichiarato, effettivamente non possono più essere impiegate nella nuova struttura da lui stesso liberamente predisposta, perché nessuna posizione a cui quel lavoratore possa essere adibito risulta in quel momento vacante. Che le cose stiano così lo testimonia del resto – seppur in modo contraddittorio - anche C. Cost. 128/2024 laddove afferma che il cd. repêchage “trova la sua giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro, che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale” (C. Cost. 128/2024 punto 5.3 cons. dir.).
Dunque, anche C. Cost. 128/2024 – come già C. Cost. 22/2024 - riespande la tutela reale nel Jobs Act, in parallelo con le previsioni dell’art. 18 St.lav., senza però in questo caso ricalcarne appieno l’estensione.
Anche C. Cost. 129/2024 - sentenza interpretativa di rigetto - con un percorso simile a quello della sua “gemella” opera un’estensione, questa volta in via interpretativa, della tutela reale ad un’ipotesi originariamente non contemplata dall’art. 3, c. 2, D. Lgs. 23/2015.
La Corte, infatti, respinge la questione di costituzionalità dell’art. 3, c. 1, D. Lgs. 23/2015 nella parte in cui non prevede la tutela reintegratoria attenuata anche per il licenziamento disciplinare irrogato per un “fatto materiale” in relazione al quale la contrattazione collettiva preveda al contrario sanzioni conservative (come invece esplicitamente previsto dall’art. 18 St.lav.), fornendone però un’interpretazione adeguatrice. Contrariamente all’interpretazione consolidata in giurisprudenza, infatti, per la Corte il “fatto materiale contestato” la cui carenza determina l’applicazione della tutela reale non solo ricomprende il fatto giuridico dell’inadempimento (cd. “fatto materiale legale”), ma ad esso va equiparata l’ipotesi d’inadempimento sussistente e specificamente tipizzato dalla contrattazione collettiva con previsione di una sanzione solo conservativa (“fatto materiale convenzionale”). Ciò per evitare il contrasto della norma con l’art. 39 Cost. di cui il codice disciplinare è assai spesso espressione.
L’equiparazione fra art. 18 St.lav. e Jobs Act però anche su questo punto non è completa. Per la Corte infatti non ogni licenziamento irrogato in violazione di clausole del codice disciplinare contrattuale va ricondotto ai sensi del Jobs Act all’area di applicazione della tutela reale, ma unicamente quel licenziamento che violi clausole che tipizzino in modo specifico la condotta inadempiente del lavoratore punendola con sanzioni conservative; ne rimarrebbero escluse, viceversa, i casi di licenziamenti disciplinari irrogati in violazione di clausole generali o elastiche del contratto collettivo. Ciò perché l’art. 3, c. 1, D. Lgs. 23/2015 - come si evince dalla specificazione per cui è preclusa ogni valutazione di proporzionalità - vuole che la sanzione più grave, la reintegra, si applichi solo nei casi in cui il datore consapevolmente violi la legge o il contratto collettivo, vuoi perché licenzi il lavoratore in assenza di un qualunque inadempimento, vuoi perché lo licenzi in presenza di un inadempimento esplicitamente considerato dal codice disciplinare convenzionale meno che “notevole”, anzi - secondo le parole della Corte - “fatto assai lieve” (punto 9.3 cons. dir.).
Ancora una volta la Corte costituzionale, dunque, ricrea un parallelismo fra Jobs Act e art. 18 St.lav., mantenendo però al contempo un gap fra i due plessi normativi e le tutele da ciascuno assicurate al lavoratore. A mio parere l’interpretazione qui adottata dalla Corte ancora una volta non è condivisibile: come si può sostenere, alla luce del principio di ragionevolezza, che solo la violazione di clausole puntuali del codice disciplinare pattizio può dar luogo alla tutela reale e non anche la violazione di clausole generali o elastiche? Le clausole generali o elastiche, infatti, non solo sono a pieno titolo espressione dell’autonomia negoziale collettiva protetta dall’art. 39 Cost., ma risultano assai spesso imprescindibili per predisporre un codice disciplinare adeguatamente articolato a fronte di obblighi del lavoratore a loro volta individuati tramite disposizioni ampie o generali (quali per es.: la diligenza, la buona fede, ecc.). Ragionare nei termini indicati dalla Corte implica, dunque, una drastica compressione dell’autonomia delle parti sociali in pieno contrasto con l’art. 39 Cost., autonomia che verrebbe incanalata e costretta verso un modello regolativo non voluto dagli agenti negoziali ed in molti casi neppure praticabile in concreto.
Insomma, la Corte costituzionale con queste pronunce compie a mio parere una chiara operazione di salvataggio del Jobs Act in punto di disciplina dei licenziamenti individuali anche a costo di forzare i limiti del sistema.
Al “miniciclo” 2022-2024 vanno ascritte - oltre alla pronuncia “monito” C. Cost. 183/2022 sui piccoli datori di lavoro di cui si è già detto - anche due ulteriori sentenze di rigetto, una ancora dedicata alle tutele previste per i licenziamenti individuali e la seconda ai licenziamenti collettivi. Entrambe respingono le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici remittenti alla luce della ratio del Jobs Act, cioè delle finalità occupazionali perseguite con la riforma. Ritengo - come ho già rilevato con riferimento a C. Cost. 194/2018 - che la posizione della Corte sia discutibile, sia perché lo strumento prescelto per raggiungere lo scopo di incrementare l’occupazione (diminuire le tutele del licenziamento per i “nuovi assunti”) non è di per sé adeguato, sia perché la Corte omette di considerare la dimensione di potere dell’atto di licenziamento e di valutare la soluzione legislativa anche in questa prospettiva. Una osservazione, quest’ultima, che ha tanto più rilievo quando a fronte di una stessa procedura di licenziamento collettivo due lavoratori, ugualmente licenziati in violazione dei criteri di scelta, siano passibili di diverse tutele in ragione della data di assunzione.
C. Cost. 44/2024, si pronuncia ancora una volta sulla legittimità costituzionale del Jobs Act in punto di disciplina dei licenziamenti individuali, respingendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’art. 3, c. 1, D. Lgs. 23/2015 per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., ritenendo conforme alla ratio della legge delega l’estensione della disciplina del Jobs Act anche ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 da datori di lavoro di più piccole dimensioni, datori che però dopo quella data in virtù di nuove assunzioni abbiano raggiunto le soglie occupazionali proprie dei datori medio-grandi. Per la Corte la scelta discrezionale compiuta sul punto dal legislatore è in linea con lo scopo perseguito dalla legge delega (quello di incentivare l’occupazione) dal momento che “per il datore di lavoro di una piccola impresa la prospettiva che, superata la soglia dei quindici dipendenti nell’unità produttiva, la disciplina dei licenziamenti individuali fosse la stessa (quella del decreto legislativo) per tutti i suoi dipendenti - sia neoassunti, sia già in servizio - rappresentava uno stimolo (o il venir meno di un freno) alle nuove assunzioni” (punto 11).
C. Cost. 7/2024 respinge le questioni di costituzionalità proposte con riferimento alla disciplina dei licenziamenti collettivi, ritenendo in particolare conforme a Costituzione la scelta compiuta dal Jobs Act di prevedere la sola tutela indennitaria per la violazione dei criteri di scelta di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. Com’è noto l’art. 3, c. 1, D. Lgs. 23/2015, dispone infatti per tutti i licenziamenti effettuati per “motivi economici” la tutela meramente indennitaria, con la conseguenza che in caso di violazione dei criteri di scelta mentre i “vecchi assunti” godono ancora della tutela reale prevista dall’art. 18 St.lav., i “nuovi assunti” beneficiano invece solo della tutela indennitaria posta dal Jobs Act. Ne deriva che lavoratori coinvolti in una medesima procedura di licenziamento collettivo, in ipotesi di violazione dei criteri di scelta, beneficeranno ora della tutela reale (“vecchi assunti”), ora della tutela indennitaria (“nuovi assunti”) a seconda del puro dato estrinseco costituito dalla data di assunzione.
Questa pronuncia ha fatto molto discutere ed a ragione: la disparità di trattamento fra “vecchi” e “nuovi assunti” è qui particolarmente evidente e ancor più difficilmente giustificabile.
V. A. Poso. Bruno Caruso, condividi queste valutazioni di Maria Teresa Carinci?
B. Caruso. Ho già avuto modo di confrontarmi a fondo con le due sentenze (la n. 128 e la 129 del 2024) che caratterizzano il secondo miniciclo, i cui snodi decisionali sono stati bene descritti da Maria Teresa e pertanto non li ripercorro. Lasciami però dire che le critiche che formula ad alcune posizioni della Corte sono espressione in vitro della “cultura della reintegra”. Essa suona più o meno, salve varianti più o meno radicali, nel seguente modo: occorre riportare le lancette della storia ai tempi della reintegrazione se non come rimedio unico, tendenzialmente tale; ogni accomodamento mediatorio, ancorché al rialzo come quello effettuato dalla Corte nel secondo miniciclo, è da rifiutare; per cui ben venga il referendum spazzatutto.
Anziché, dunque, plaudire all’operazione della Corte, la cultura della reintegra indugia, invece, sulle difformità, a questo punto residuali, rispetto all’obiettivo di integrale ripristino del regime Fornero, criticando, il non pieno ossequio della Consulta al diritto vivente giurisprudenziale precedente, quello almeno considerato più garantista: la posizione sul repêchage e l’orientamento restrittivo sulle clausole contrattuali. È chiaro allora che quando la Consulta concede il dito all’opzione ipergarantista, i cultori di quest’ultima finiscono per pretendere tutta la mano.
Eppure, nel secondo miniciclo (il ciclo del Giudice Giovanni Amoroso che succede al ciclo della Giudice Silvana Sciarra) il tentativo di operare un bilanciamento complessivo “al rialzo”, vale a dire, a favore della reintegrazione come regola, è ancor più evidente. Lo riconosce pure Maria Teresa: le tre sentenze simbolo di questo miniciclo, tutte del 2024, (la 22, la 128 e la 129) altro non sono che un tentativo abbastanza riuscito (anche se certamente foriero di aporie) di riaccorciare le distanze tra legge Fornero e Jobs Act, intaccando punti qualificanti della riforma Renzi molto di più di quanto sia avvenuto nel miniciclo Sciarra; in particolare: a) la distinzione netta dei rimedi tra licenziamenti per ragioni soggettive (ove opera il doppio regime di reintegra) e licenziamento economico, dove scompare la reintegra; b) la eliminazione della doppia ipotesi di reintegra attenuata nel licenziamento soggettivo; c) la previsione solo delle nullità manifeste e non di quelle virtuali.
Ci sarebbe stato materiale per essere più che soddisfatti con riguardo all’opzione del rientro nel regime di reintegrazione come regola; eppure i cahiers de doléances si spingono sino al punto di rivendicare l’intangibilità di un dogma dottrinale e giurisprudenziale (perché tale è la teorizzazione del repêchage come elemento integrativo della fattispecie GMO è quindi generatore di insussistenza del fatto organizzativo), onde la critica alla Consulta per averlo espunto dal perimetro del fatto insussistente e ad averlo inserito, a mio avviso correttamente, tra le ipotesi di ingiustificatezza semplice; e poi la critica all’adesione della Corte all’orientamento della Cassazione restrittivo sulle clausole tipizzate e non elastiche, che, prima facie, appare molto più razionale ed equilibrato dell’altro, più lasco, che prese il sopravvento nel torno del secondo decennio (al punto che qualcuno si è spinto a teorizzare che la Consulta non ha mai affermato una cosa del genere e che, se mai l’avesse fatto, la Cassazione dovrebbe operare un fin de non-recevoir).
Detto questo, non è che le aporie nell’itinerario della Consulta non siano evidenti; ma a mio avviso sono da considerare l’effetto di risulta del ruolo di decisore politico che si è auto attribuita, piuttosto che un risultato che promana dalle singole decisioni. Aporie di sistema più che della singola decisione.
Così è evidente che la Corte ha finito per rendere nuovamente opaca e incerta una scelta sistematica del legislatore, di fissare cioè una linea netta di demarcazione dei rimedi nell’ipotesi di licenziamenti che incidono sulla dignità della persona e licenziamenti dettati da ragioni economiche. Ha evitato di confrontarsi con il fatto che, per ragioni che è inutile qui ribadire, il recesso datoriale non è una fattispecie unica (come indulge a pensare invece anche la Corte), ma licenziamento soggettivo ed economico hanno strutturalmente rationes diverse che ne giustificano una diversa modulazione funzionale dei rimedi.
Essendo stata contestata dalla Corte costituzionale questa razionale linea di faglia individuata dal legislatore - una ragione di policy, contrabbandata per irragionevolezza intrinseca di trattamento dei due regimi di insussistenza del fatto - diventa poi difficile comprendere sul piano logico e degli interessi, e in questo Maria Teresa ha ragione, per quale motivo la Corte confermi la scelta del Jobs Act di sottrarre ad ogni ipotesi di reintegra i licenziamenti collettivi.
V. A. Poso. Qual è, in proposito, l’opinione di Andrea Morrone?
A. Morrone. Personalmente penso che la disciplina del Jobs Act sia stata manipolata dalla giurisprudenza in maniera profonda e, data la sua casualità e frammentarietà, che questa giurisprudenza abbia aumentato i margini di incertezza e di irrazionalità del diritto vivente. Gli appelli del giudice delle leggi, per una razionalizzazione della disciplina, sono importanti, ma non devono fare dimenticare quel dato, oltre al fatto che un giudice, neppure quello costituzionale, può sostituirsi al legislatore rappresentativo, né tantomeno imporgli di intervenire sulla base delle sue sollecitazioni. Come dirò più avanti, nel nostro caso questi ripetuti interventi manipolativi sul Jobs Act e sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi non solo hanno cambiato la sostanza della disciplina vigente, ma hanno giocato anche un ruolo centrale nella valutazione di ammissibilità del referendum sul d.lgs. n. 23/2015. Il punto è capire in che senso lo hanno fatto.
V. A. Poso. Come giudicate, nel merito, la richiesta referendaria sul Jobs Act? Lo slogan utilizzato dalla CGIL per questo quesito è che “Il lavoro deve essere tutelato perché è un diritto costituzionale”. L’abrogazione totale del Jobs Act tutela in misura maggiore i lavoratori e realizza un mercato del lavoro più equilibrato?
M. T. Carinci. A mio parere la richiesta referendaria, ove accolta, avrebbe innanzitutto il pregio di ricondurre a maggiore ragionevolezza un sistema di tutele del licenziamento che, come ho già sottolineato, pur dopo le pronunce della Corte costituzionale, è ancora fortemente squilibrato e contraddittorio. Tutti i lavoratori, infatti, risulterebbero soggetti ad un’unica disciplina, diversificata al suo interno solo in ragione del tipo di licenziamento irrogato (individuale o collettivo) e delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro (piccolo o medio-grande) senza il discrimen costituito dalla data di assunzione. Peraltro, come già detto, sarebbe oltremodo opportuno che il legislatore - non solo a fronte del Jobs Act, ma anche dell’art. 18 St.lav. - ripensasse il criterio discretivo del numero dei dipendenti, assolutamente non più adeguato, oggi, per modulare le tutele fra piccoli e grandi datori di lavoro.
È difficile, tuttavia, dare una risposta secca alla domanda se l’abrogazione del Jobs Act comporti un miglioramento delle tutele nella prospettiva dei lavoratori. Considerando le singole disposizioni il risultato che emerge infatti è “in chiaroscuro”, dunque non esclusivamente migliorativo, ma in parte anche peggiorativo per i lavoratori rispetto alla disciplina attualmente vigente; se invece si pongono a confronto nel loro complesso i due sistemi normativi (il D. Lgs. 23/2015, da una parte, e l’art. 18 St.lav. e la l. 604/1966, dall’altra) il risultato finale mi sembra decisamente favorevole per i lavoratori.
Volendo però esaminare la situazione nel dettaglio, se si guarda ai lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro medio-grandi il risultato finale conseguente all’abrogazione del Jobs Act appare a mio parere, nel complesso, migliorativo in conseguenza della riespansione della tutela reale. Infatti, i lavoratori non solo godrebbero in caso di licenziamento nullo della tutela reale piena come del resto già oggi accade (a seguito di C. Cost. 22/2024), ma beneficerebbero altresì della tutela reale attenuata (a differenza di quanto previsto dal Jobs Act) sia in ogni ipotesi licenziamento privo di g.m.o. di tipo economico (inclusa l’ipotesi di mancato rispetto del cd. obbligo di repêchage), sia - senza che si possano porre dubbi di sorta, v. C. Cost. 129/2024 - in caso di licenziamento disciplinare posto in essere in violazione di clausole del codice disciplinare pattizio che prevedano sanzioni conservative (siano esse elastiche o puntuali). Tuttavia, al contempo, quei lavoratori non godrebbero più della tutela reale piena nel caso di licenziamento irrogato in violazione dell’art. 2110 c.c. o per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore perché, a differenza del Jobs Act, l’art. 18 St.lav. in questi casi prevede testualmente la sola tutela reintegratoria attenuata.
Viceversa, nelle altre ipotesi di licenziamento individuale ingiustificato passibili della sola tutela economica, l’importo dell’indennità è più cospicuo nel Jobs Act (fra 6 e 36 mensilità) rispetto all’art. 18 St.lav. (fra 12 e 24 mensilità), almeno nel suo importo massimo. La norma statutaria, però, confina la tutela indennitaria nel caso del licenziamento ingiustificato in ipotesi del tutto residuali (nel licenziamento individuale plurimo per motivo economico nell’ipotesi di violazione dei criteri di scelta; nel licenziamento disciplinare quando l’inadempimento sussista e però non risulti violata una clausola, elastica o puntuale, del contratto collettivo che contempli una sanzione conservativa), cosicché la diminuzione dell’importo massimo dell’indennità che ne conseguirebbe appare ampiamente compensato dall’espandersi dell’area della tutela reintegratoria.
Quanto ai vizi di motivazione (esclusa l’ipotesi di assenza di motivazione che dà luogo in ogni caso alla tutela reale piena) e di procedura, l’art. 18 St.lav. contempla una tutela indennitaria più alta nel minimo (fra 6 e 12 mensilità) rispetto a quella prevista dal Jobs Act (fra 2 e 12 mensilità).
Se si considera poi la tutela prevista per i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro di più piccole dimensioni, l’applicazione della l. 604/1966 conseguente all’abrogazione del Jobs Act comporterebbe un innalzamento dell’importo massimo dell’indennità nel caso di licenziamento ingiustificato (fino a 14 mensilità in dipendenza dell’anzianità del lavoratore, contro le 6 mensilità massime previste dall’art. 9 D. Lgs. 23/2015), mentre il licenziamento affetto da vizi procedurali - in particolare per violazione dell’art. 7 St.lav. - dovrebbe a rigore essere considerato nullo con applicazione della tutela reale di diritto comune. Anche per i datori di lavoro di piccole dimensioni, dunque, l’abrogazione del Jobs Act comporterebbe un innalzamento delle tutele per i lavoratori.
Una notazione merita anche la disciplina applicabile ai lavoratori alle dipendenze di aziende di tendenza, che viceversa vedrebbero un peggioramento delle tutele loro riconosciute: mentre oggi infatti sono soggetti alla disciplina generale applicabile a tutti i datori di lavoro (art. 9, c. 2, D. Lgs. 23/2015) con l’abrogazione del Jobs Act potrebbero godere unicamente della tutela indennitaria prevista dall’art. 8 l. 604/1966 (ex all’art. 4 l. 108/1990).
Infine, con riferimento alla disciplina prevista in materia di licenziamenti collettivi, l’accoglimento del quesito referendario comporterebbe l’applicazione a tutti i lavoratori della tutela reale nel caso di violazione dei criteri di scelta; viceversa, la violazione delle procedure determinerebbe il riconoscimento di una indennità che, come per il licenziamento individuale, è (almeno nel massimo) meno cospicua (v. supra).
Alla luce di tutto ciò mi pare di poter concludere che, nel complesso, la riespansione della tutela reale e gli importi più cospicui della tutela indennitaria prevista per i piccoli datori di lavoro garantiscano effettivamente ai lavoratori una maggiore tutela.
D’altronde un assetto assolutamente coerente della disciplina dei licenziamenti non può certo essere raggiunto tramite lo strumento del referendum abrogativo - che ha il differente compito di premettere l’espressione della volontà popolare su temi che toccano da vicino la vita dei cittadini; spetta al legislatore.
B. Caruso. Mi limito a rispondere con una breve considerazione. Con tutti i distinguo sottili di Maria Teresa appare evidente come l’abrogazione del Jobs Act lungi da semplificare, razionalizzare e rendere sistematico il quadro normativo e quindi tutelare il lavoro, aggiungerebbe altre dosi di complessità a quanto già procurato dall’opera di rammendo, ricucitura e dal patchwork di risulta operato dalla Corte.
Già è complicato razionalizzare con una opera accurata e diuturna di riscrittura complessiva dei testi come abbiamo provato a fare come “Gruppo Freccia Rossa”, figuriamoci se possa avere una parvenza di sistematicità una riscrittura affidata al quesito si/no. Tutelare il lavoro come diritto costituzionale attraverso il referendum sul Jobs Act è, allora, esattamente quel che tu dici: uno slogan politico, non una seria opzione regolativa di tutela del lavoro. Il mercato del lavoro, i lavoratori in carne ossa e le stesse imprese, come dicevo all’inizio, hanno da affrontare diversi (la carenza di professionalità e di manodopera) che non uscire dal presunto inferno neoliberista procurato dal Jobs Act. Per non dire che con Trump e le politiche dei dazi, Putin e le sue guerre di annessione e i sovranismi nazional-populisti, la globalizzazione neoliberista e internazionalista è quasi persino da rimpiangere…
V. A. Poso. Passo, ora, ad illustrare, anche a beneficio dei lettori, l’ordinanza dell’Ufficio Centrale per il Referendum della Corte di Cassazione pubblicata il 12 dicembre 2024, che ha dichiarato conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul quesito dell’intero d.lgs. n. 23/2025, nel testo vigente, tenuto conto delle modifiche apportate dal legislatore e delle pronunce della Corte Costituzionale, di cui abbiamo detto sopra. Anche a seguito di interlocuzione con i promotori, alla denominazione del quesito è stato assegnato il seguente titolo sintetico, che meglio definisce l’iniziativa referendaria: “Contratto di lavoro a tutele crescenti- disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”.
L’Ufficio Centrale per il Referendum ha rilevato - a me pare correttamente - che non sussiste la condizione ostativa prevista dall’art. 38 della l. n. 352 del 25 maggio 1970, in ragione della riproposizione del quesito referendario già dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 gennaio 2017, n. 26, « posto che il citato articolo limita, per il periodo di cinque anni, la possibilità di promuovere nuovamente la medesima iniziativa referendaria solo nel caso in cui i cittadini si siano effettivamente espressi per il mantenimento della normativa sottoposta al loro sindacato, ovvero nell’ipotesi in cui la consultazione abrogativa sia risultata invalida ai sensi dell’art. 75, quarto comma, Cost. (n.d.r.: che ritiene necessari i requisiti del voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto e della maggioranza dei voti validamente espressi, limitazioni entrambe non presenti nel caso di specie (vd. ordinanze dell’Ufficio Centrale per il Referendum dell’11 dicembre 1996 e del 7 dicembre 1999, in ipotesi di quesiti referendari dichiarati inammissibili dalla Corte Costituzionale)».
M. T. Carinci. Si tratta, anche a mio avviso, di conclusioni assolutamente lineari e condivisibili.
B. Caruso. Credo che il dato della legittimità della richiesta referendaria sia ormai in ogni caso tratto, perché ci apprestiamo a votare o a non votare, esprimendo la scelta che la Costituzione e la legge ci riservano come elettori. Per i commenti tecnici dell’ordinanza mi affido alle risposte dei colleghi giuscostituzionalisti.
A. Morrone. Quella dell’Ufficio Centrale per il Referendum è una precisazione del tutto superflua, nel caso di specie. Il quesito promosso dalla Cgil nel 2016 non solo non era formalmente identico a quello presente (che riguarda integralmente il d.lgs. n. 23/2015) ma, soprattutto, non aveva superato il giudizio di ammissibilità (sent. n. 26/2017). Quindi la fattispecie era totalmente diversa, rispetto a quella descritta dall’art. 38, l. n. 352/1970, che, appunto, si riferisce a un referendum celebrato e all’esito confermativo della disciplina sottoposta al voto, nella cui circostanza è vietata la ripresentazione della “medesima” domanda di abrogazione popolare. Perché sia stata fatta quella precisazione dall’Ufficio Centrale per il Referendum è incomprensibile: forse per dire che il quesito presente non è il medesimo quesito precedente? Cosa del tutto ovvia.
V. A. Poso L’Ufficio Centrale per il Referendum, a pag. 5 e ss. della sua ordinanza, ha dato correttamente conto di tutti gli interventi di modifica e integrazione, normativi e costituzionali, successivi alla emanazione del decreto legislativo oggetto della richiesta di abrogazione, al fine di procedere alla verifica della vigenza del testo sottoposto a referendum abrogativo (è del tutto evidente e scontato che si tratti di atto avente forza di legge, rientrante, per sua natura, nella previsione dell’art. 75, Cost. (nell’ordinanza viene richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale n. 251 del 22 dicembre 1975), compito ad esso spettante ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, l. n. 352/1970 (in tal senso anche Corte Cost. n. 251/1975 sopra citata). Vi chiedo se la Corte di Cassazione ha bene interpretato e applicato l’art. 39, l.cit., alla luce anche della pronuncia della Corte Costituzionale 17 maggio 1978, n. 68, tenuto conto che la richiesta referendaria ha ad oggetto il d. lgs. n. 23/2015 nel testo originario.
M. T. Carinci. A mio parere la Corte di Cassazione ha ben interpretato l’art. 39 l. 352/1970 dal momento che il quesito referendario mirava sì all’abrogazione della versione originaria del D. Lgs. 23/2015, tuttavia il testo oggi vigente - quale risultante dalle modifiche normative successivamente intervenute e dalle pronunce della Corte costituzionale sopra richiamate - non costituisce una disciplina nuova. Essa, infatti, ricalca (come riconosciuto da C. Cost. 68/1978) gli stessi principi ispiratori e gli stessi contenuti essenziali dei singoli precetti del testo originario: il Jobs Act, nella versione originaria ed in quella oggi vigente, limita la tutela reale e ridimensiona quella indennitaria (v. Cass. Ufficio centrale del referendum, ord. 12 dicembre 2024). Per tutte queste ragioni ritengo che la Corte di Cassazione correttamente abbia ritenuto legittimo il quesito referendario pur se volto ad abrogare il testo originario del Jobs Act.
B. Caruso. Anche su questo mi affido ai commenti dei colleghi giuscostituzionalisti, in ogni caso non mi pare che si possa far marcia indietro anche a non essere d’accordo con quel che dice Maria Teresa.
A. Morrone. La legge n. 352/1970 affida all’Ufficio Centrale per il Referendum il compito di verificare – oltre al numero delle sottoscrizioni necessarie per sostenere una richiesta abrogativa – la “vigenza” della disciplina oggetto della domanda. In linea di principio possono essere oggetto di abrogazione popolare solo “leggi vigenti”; non avrebbe senso sottoporre a referendum abrogativo una legislazione già abrogata. Dico in linea di principio, perché, come sappiamo, v’è almeno un precedente in cui il contenuto di tale regola non è stato seguito: mi riferisco al referendum promosso dal Partito comunista – l’unico presentato da quel partito politico nella storia dell’istituto – sulla “scala mobile”, che aveva ad oggetto una disciplina non vigente (perché il “taglio” cui si riferiva l’abrogazione popolare del cd. decreto di San Valentino riguardava i punti di contingenza già riconosciuti: sent. n. 35/1985).
Il controllo sulla vigenza della legge si è affermato in via di prassi. Esso riguarda modifiche giuridiche relative alle disposizioni oggetto della domanda popolare. Nel concetto di “modifica giuridica” vanno ricomprese sia – com’è ovvio – quelle derivanti da atti legislativi successivi all’entrata in vigore delle norme oggetto del quesito, sia fatti normativi che possono essere considerati analoghi negli effetti caducatori a quelli di un atto legislativo. In quest’ultima categoria, per prassi della giurisprudenza dell’Ufficio Centrale per il Referendum, vi cadono le decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: la motivazione deriva dall’art. 136 Cost., laddove la previsione della nostra Carta fondamentale stabilisce, com’è arcinoto, che le pronunce di accoglimento producano l’effetto della cessazione dell’applicazione delle disposizioni dichiarate contrarie alla Costituzione (ex tunc, con le note eccezioni, derivanti dall’art. 30, l. n. 87/1953, come interpretato e applicato dalla giurisprudenza costituzionale unanime).
Ora, ogni qualvolta l’Ufficio Centrale per il Referendum riscontra che le disposizioni inserite nel quesito referendario siano state interessate da fenomeni di ius superveniens deve verificarne la perdurante vigenza. Se abrogate o dichiarate illegittime, detto Ufficio deve stabilire se esiste ancora un oggetto della richiesta referendaria e dichiarare in caso di esito positivo, in tutto o in parte, la cessazione delle operazioni referendarie. A questo proposito sorgono diversi problemi.
Il primo riguarda l’esile disciplina positiva di questo potere dell’Ufficio centrale per il Referendum. L’art. 32 non ne fa menzione, limitandosi a parlare e della correzione di eventuali “irregolarità” e della possibile “concentrazione” delle richieste referendarie che, nella medesima tornata, avessero il medesimo contenuto (letteralmente “uniformità o analogia di materia”). L’art. 39, invece, si riferisce alla “cessazione delle operazioni referendarie” susseguenti alle sole novelle legislative sopravvenute fino alla “data di svolgimento del referendum”, senza menzionare atti assimilabili, come le sentenze di accoglimento della Corte.
Su questa disposizione è intervenuta la sentenza manipolativa della Corte costituzionale (n. 68/1978) che ha stabilito, in via pretoria, l’importante regola secondo la quale non qualsiasi modifica sopravvenuta determina la cessazione delle operazioni, ma solo quelle che ne modificano i principi ispiratori o i contenuti essenziali dei singoli precetti. Se la novella non ha queste caratteristiche, l’Ucr opera il “trasferimento” del quesito dalle originarie disposizioni a quelle successive abrogative, ma solo formalisticamente e non materialmente, di quelle inserite ab origine nella domanda popolare.
La giurisprudenza dell’Ucr si è mossa in modo ondivago. Non distingue, come andrebbe fatto, tra novelle precedenti il deposito in Cassazione della richiesta referendaria (corredata delle sottoscrizioni o delle delibere regionali necessarie a sostenerla) e novelle intervenute dopo il medesimo deposito. Nel primo caso, è onere dei promotori farsi carico di formare un quesito referendario su una “legge vigente”, tenendo conto di tutte le modifiche nel frattempo intervenute (non potendosi ritenere afferente alla mera “irregolarità” la mancata menzione di novelle legislative o addirittura sentenze di accoglimento che hanno modificato il contenuto della disciplina positiva interessata dall’abrogazione popolare).
Nel secondo caso, poiché le novelle intervengono quando il procedimento di controllo è ormai avviato, grazie al deposito di una richiesta formale in Cassazione, esse sfuggono alla responsabilità dei promotori, per dipendere integralmente dall’autore della novella o dalla giurisprudenza: qui andrebbe applicato l’art. 39 della legge n. 352/1970. L’Ucr, in secondo luogo, non distingue tra novella legislativa e sentenza di accoglimento della Corte costituzionale: l’una e l’altra possono determinare la cessazione delle operazioni referendarie o la correzione del quesito. Quando corregge il quesito nella fase immediatamente successiva al deposito della richiesta, di fronte allo ius superveniens (precedente lo stesso deposito e non considerato dai promotori), si limita a riscriverlo, se l’intervento modificativo non elimina l’oggetto della domanda, facendo riferimento alle “successive modificazioni” intervenute per via legislativa (indicando gli estremi nel quesito), o i termini di riconoscimento delle sentenze manipolative della Corte costituzionale. Il trasferimento è dichiarato allorché le novelle legislative e giurisprudenziali sono intervenute dopo l’ordinanza dello stesso Ucr dichiarativa della legittimità di una richiesta referendaria, nella fase che va da quel momento sino alla “data di svolgimento” del referendum.
Detto tutto ciò, in questa tornata, l’Ucr ha arricchito la sua giurisprudenza con un nuovo “primo” precedente. Nell’ordinanza sul regionalismo differenziato (12 dicembre 2024), l’Ucr ha ritento di dover dichiarare la cessazione delle operazioni referendarie con riferimento al quesito parziale della legge n. 86/2024, per effetto di una pronuncia interpretativa di rigetto, contenuta nel lunghissimo dispositivo della sent. n. 192/2024 della Corte costituzionale.
Il fatto singolare è che l’Ucr ha ritenuto “vincolante”, al pari di una decisione di accoglimento, parificandone anche gli effetti positivi, l’affermazione secondo la quale, la devoluzione delle competenze statali a favore della regione richiedente in una materia “no-Lep” alla sola condizione che le stesse non riguardassero diritti fondamentali (civili o sociali), perché, come riconosciuto in linea di principio dalla Consulta, nessuna devoluzione è possibile senza previa definizione dei Lep da parte dello Stato se le singole funzioni trasferibili interessino un diritto fondamentale.
Qui l’Ucr ha ritenuto pienamente soddisfatto il quesito referendario parziale, che chiedeva di abrogare la previsione sulle materie “no-Lep”, che la legge n. 86/2024 sottraeva dall’applicazione della regola generale sulla determinazione previa dei Lep nei soli casi previsti dalla legge stessa.
Al di là della questione di merito, il fatto nuovo sta proprio nella circostanza, mai vista prima, dell’equiparazione, ai fini della verifica della “legge vigente”, di una decisione interpretativa di rigetto alla sentenza di accoglimento. La cosa singolare è che, nella stessa ordinanza, l’Ucr aveva ritenuto legittima e, quindi, sottoponibile al voto il referendum totale sulla legge n. 86/2024, argomentando che, nonostante l’ingente intervento demolitorio della Consulta, permanesse un “contenuto minimo” normativo che giustificava il permanere della legge, consentendone la sottoposizione al voto popolare.
Come sappiamo, però, la Consulta nella sent. n. 10/2025 ha avuto un’opinione esattamente opposta a quella dell’Ufficio Centrale per il Referendum, ritenendo, dal punto di vista materiale, che ciò che rimaneva della legge n. 86/2024, dopo la sua decisione n. 192/2024, fosse insuscettibile di essere sottoposto al voto popolare, perché il quesito era diventato oscuro, tale da confondere l’espressione del voto. A suo dire (ma in maniera del tutto implausibile), s’è aggiunto che il referendum era divenuto una sorta di plebiscito sulla previsione costituzionale stessa, disciplinante l’autonomia differenziata (l’art. 116.3 Cost.). Cosa, quest’ultima, che rendeva inammissibile la domanda popolare, perché sull’an di quella disposizione, l’unico procedimento attivabile avrebbe dovuto essere la revisione costituzionale della prescrizione.
Nel caso del referendum sul Jobs Act, inoltre, va ricordata un’altra circostanza: le modifiche operate dalla legislazione successiva e, soprattutto, dalla stessa giurisprudenza costituzionale, avevano una portata innovativa notevole. La Corte costituzionale aveva sostanzialmente riscritto il Jobs Act, rovesciandone il criterio di base (l’automatismo legale fondato sul solo indice dell’anzianità), adeguando la disciplina secondo il criterio del parallelismo delle tutele tra licenziamento discriminatorio e per ragioni economiche. La situazione, da questo punto di vista, era molto prossima a quella della disciplina dell’autonomia differenziata, riscritta dall’unica sent. n. 192/2024. Tutto questo non ha avuto rilievo nel giudizio di ammissibilità: nel caso del d. lgs n. 23/2015 la Consulta ha ritenuto ammissibile il voto, nonostante le modifiche apportate alla disciplina dal legislatore e dalla sua stessa giurisprudenza; e, va aggiunto, nonostante la disomogeneità contenutistica delle tutele apprestate dal Jobs Act nelle diverse situazioni (come dalla Consulta stessa rilevato, ma ritenuto del tutto irrilevante). Ha, viceversa, dichiarato inammissibile il referendum sull’autonomia differenziata, ritenendo che la propria sentenza avesse sostanzialmente modificato oggetto e finalità della legge n. 86/2024, rendendo, come detto, non chiaro e diverso il contento della domanda popolare.
Due pesi e due misure, per situazioni sostanzialmente analoghe.
V. A. Poso. Bisogna, allora, fare un passo indietro ed entrare nel merito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 26/2017, sopra richiamata, che ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo dell’intero d. lgs. n. 23/2015 oltre che di plurime disposizioni dell’art. 18, st. lav.
M. T. Carinci. A me pare che il quesito referendario oggi proposto sia molto diverso rispetto a quello dichiarato inammissibile da C. Cost. 26/2017.
Allora la domanda referendaria mirava, infatti, all’abrogazione non solo dell’intero D. Lgs. 23/2015, ma anche di parole, frasi, commi contenuti nell’art. 18 St.lav. nell’intento non solo di eliminare dal sistema la disciplina del Jobs Act, ma anche (interpolandone il testo) di ampliare la tutela reale prevista dalla norma statutaria ben oltre il suo ambito di applicazione originario con riferimento sia ai lavoratori coinvolti, sia alle fattispecie considerate sia, soprattutto, ai datori di lavoro di più piccole dimensioni. Proprio alla luce di ciò C. Cost. 26/2017 ritenne allora inammissibile quel quesito, considerandolo in primo luogo non abrogativo, ma propositivo (poiché, tramite l’utilizzo della tecnica del “ritaglio” di parti dell’art. 18 St.lav., mirava ad introdurre nel sistema norme non previste) e ritenendolo in secondo luogo non univoco né omogeneo (dal momento che unificava e sovrapponeva al suo interno questioni diverse - quali l’espansione della tutela reale a: diversi gruppi di lavoratori id est “vecchi” e “nuovi assunti”; un novero più ampio di vizi del licenziamento; datori di lavoro di minori dimensioni - con la conseguenza di coartare la libertà dell’elettore costretto ad esprimere un voto bloccato su tematiche non sovrapponibili).
Il quesito referendario oggi proposto - che chiede l’abrogazione di un unico testo normativo: il D. Lgs. 23/2015 nella sua interezza -, al contrario mi pare unicamente abrogativo, omogeneo e coerente se è vero che mira alla integrale abrogazione del Jobs Act, cioè di quel testo normativo che ha ridotto le tutele per il licenziamento viziato per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. Nel caso di approvazione del quesito referendario si riespanderà, dunque, la disciplina attualmente vigente per i soli dipendenti assunti fino al 7 marzo 2015, cioè l’art. 18 St.lav. e la l. 604/1966, che diverrà applicabile a tutti i lavoratori a prescindere dalla data di assunzione.
B. Caruso. Sono d’accordo con le considerazioni di Maria Teresa, il quesito di oggi è molto più chiaro e conforme con la disposizione costituzionale, che presuppone che esso sia tale da rendere evidente all’elettore da dove si parte (il quadro vigente) e dove si vuole arrivare con l’abrogazione (l’effetto di risulta). Il quesito del 2017 era “furbo”, non solo poco chiaro. Si voleva riscrivere il sistema attraverso una, comprensibile solo agli esperti, operazione di taglio, cucito e ricamo, degno di una sartoria di pizzi e merletti giuridici e non di una consultazione popolare. Si mirava ad un abito sartoriale di haute couture di rigidità garantista e ben ha fatto a suo tempo la Corte costituzionale ad impedirlo.
A. Morrone. Come ricordato, il quesito Cgil promosso nel 2016 era diverso non solo contenutisticamente, ma anche formalmente. Aveva una portata fortemente manipolativa perché pretendeva, attraverso un chirurgico ritaglio di singole parole, di applicare a tutte le imprese con più di cinque dipendenti (come le agricole) il rimedio della reintegra. Un classico caso di “taglia e cuci” non vietato in generale, ma inammissibile – stando alla giurisprudenza costituzionale pregressa (come detto nella sent n. 36/1997) – allorché tenda a costruire una disposizione del tutto artificiosa, frutto della manipolazione referendaria e non della “espansione” di una regola positiva già esistente nella legislazione vigente, la cui applicazione derivi automaticamente (per i noti fenomeni di auto-integrazione dell’ordinamento giuridico) dall’abrogazione popolare.
Nella fattispecie, il quesito pretendeva di applicare a tutte le imprese la regola speciale valevole solo per le agricole (ipotesi, questa, del tutto singolare nella stessa giurisprudenza sui referendum abrogativi).
Va ricordato, anche, che, l’esito del giudizio, è stato traumatico, portando alla rinuncia, da parte della giudice relatrice, Silvana Sciarra, al compito di redigere la motivazione assunta dalla maggioranza del Collegio, scritta, invece, da Giorgio Lattanzi. Il quesito, allora, era nettamente diverso da quello promosso, in passato, dall’estrema sinistra, che pretendeva, invece, di abrogare qualsiasi criterio dimensionale al fine di generalizzare la reintegra a tutte le imprese (comprese le piccole). Soluzione, questa, che la Corte costituzionale aveva ritenuto ammissibile dal punto di vista della disciplina del referendum abrogativo (sent. n. 41/2003).
V. A. Poso. L’Ufficio Centrale per il Referendum (pagg.16 e 17 dell’ordinanza più volte citata) ha affermato che «la fattispecie razionalmente unitaria, richiamata nel quesito qui in esame (e cioè il principio abrogativo sotteso al procedimento referendario) consista nella intera disciplina del d. lgs. n. 23 del 2015, in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, laddove “limita la tutela reale e ridimensiona quella indennitaria soprattutto per i lavoratori con anzianità di servizio non elevata». E in coerenza con questa impostazione il quesito è stato riformulato con riferimento a tutte le fonti, normative e costituzionali, successivamente intervenute, con riferimento a queste ultime, anche dopo il formale deposito della iniziativa referendaria (trattasi della sentenza n. 128/2024, della quale abbiamo detto sopra).
Condividete il percorso motivazionale dell’ordinanza alla quale facciamo riferimento?
A. Morrone. Come ho spiegato in precedenza, la decisione dell’Ufficio Centrale per il Referendum di ritenere legittima la richiesta e di riformulare il quesito è coerente con i suoi precedenti. La verifica sulla vigenza della legge è sempre stata molto superficiale, quindi, non mi stupisce la velocità in cui, pure stavolta, gli Ermellini abbiamo risolto la questione, limitandosi a richiamare le novelle e la giurisprudenza costituzionale intervenuta sulla disciplina del Jobs Act, senza addentrarsi nel dettaglio sui contenuti materiali dello ius superveniens.
In questo caso, come ho precisato sopra, la superficialità dell’Ucr ha facilitato il controllo di ammissibilità della Consulta (sent. n. 12/2025). Anche se, tuttavia, per la Corte costituzionale l’onere di motivazione avrebbe dovuto essere più rigoroso: il giudizio sull’esistenza di una matrice razionalmente unitario è stato basato, esclusivamente, sulla prevalenza della “forma” sulla “sostanza” (l’esatto opposto di quanto fatto nell’inammissibilità del quesito totale sul regionalismo differenziato, dove la “sostanza” ha prevalso sulla “forma”, ma tornerò sul punto).
M. T. Carinci. Non mi sembra ci sia nulla da eccepire al percorso argomentativo dell’ordinanza della Corte di Cassazione: il quesito proposto relativo all’abrogazione integrale del D. Lgs. 23/2015 nel testo originario mirava ad eliminare dal sistema un complesso normativo che nel suo insieme emarginava la tutela reintegratoria e riduceva la tutela indennitaria. Le modifiche in seguito intervenute al testo del Jobs Act, sia quelle operate dalla legge, che quelle conseguenti alle pronunce della Corte costituzionale, non ne hanno intaccato l’impianto di fondo, dal momento che quel testo, oggi come allora, conserva comunque una propria unitarietà, omogeneità ed un proprio comune principio ispiratore (Corte di Cassazione, Ufficio centrale del referendum 11 dicembre 1996) e, cioè, la limitazione della tutela reale a favore di quella obbligatoria e la riduzione di quest’ultima (come ho già cercato di porre in luce rispondendo alla domanda 8).
B. Caruso. Non concordo con il giudizio di Maria Teresa e ho già detto pure perché. Dopo le manipolazioni subite, il Jobs Act è ridotto a una tigre di carta neoliberista se mai si dovesse ritenere che sia stata quella l’ideologia originaria dei redattori del testo normativo. Dopo gli interventi ortopedici delle Alte Corti, la verità è che nel sistema attuale non si sa quale sia la regola e quale l’eccezione rimediale, anzi a volte domina l’incertezza pura e semplice di quale sia la regola da applicare e come.
Il referendum non risolve alcun problema; aggiungo che rischia di screditare ulteriormente questo strumento di democrazia diretta se ancora una volta si dovesse arrivare a un nulla di fatto per mancato raggiungimento del quorum di validità. Tale risultato costituirebbe un bell’assist a chi intende oggi, da altri punti di vista, screditare gli istituti procedurali della democrazia classica, in questo caso quella diretta. Servirebbe, invece, una riscrittura del Parlamento, mirata alla semplificazione e alla razionalizzazione sistemica della disciplina.
V. A. Poso. Con la sentenza n. 12 del 7 febbraio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione del Jobs Act relativo ai licenziamenti illegittimi approvato con il D. Lgs n. 23/2015, nel testo che risulta vigente all’esito delle modifiche legislative e delle pronunce della Stessa Corte, così come stabilito dall’Ufficio Centrale per il Referendum costituito presso la Corte di Cassazione.
Dopo aver delineato la cornice normativa di riferimento, questa è l’argomentazione centrale della Corte Costituzionale: «L’odierno quesito referendario […] punta a rimuovere dall’ordinamento l’intero d.lgs. n. 23 del 2015, frutto di una discrezionale opzione di politica legislativa, senza che dalla vis abrogans possa scaturire una, preclusa, reviviscenza del quadro normativo preesistente: la disciplina dettata dal suddetto decreto legislativo si è affiancata a quella dettata dall’art. 18 statuto lavoratori e dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, dando così luogo a «un duplice e parallelo regime» (sentenza n. 44 del 2024).
L’effetto innovativo sulla disciplina vigente, connaturale alla abrogazione referendaria, consisterebbe quindi nella «fisiologica espansione della sfera di operatività» (sentenza n. 50 del 2000) di norme già presenti nell’ordinamento, tuttora vigenti, anche se compresse, per effetto della applicabilità delle disposizioni oggetto del referendum, su un ambito di efficacia limitato ai soli licenziamenti individuali dei lavoratori già in servizio alla data del 7 marzo 2015».
Quali sono le Vostre osservazioni, di carattere generale, in merito? È, quella di ammissibilità, una pronuncia attesa?
A. Morrone. Nella sent. n. 12/2025, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo complesso, il Jobs Act viene connotato come una nuova disciplina della materia, rispetto alla “riforma Fornero”, all’art. 18 e alla legge n. 604/1966 (dando conto di una stratificazione normativa tra discipline applicabili a seconda di un differente “tempo giuridico”). Si sottolinea, in aggiunta, la disomogeneità materiale del Jobs Act in ragione dei contenuti della tutela, diversificata mediante un giudizio di valore in melius e in peius rispetto alla previgente disciplina.
Su questi due punti la motivazione presenta un cortocircuito argomentativo.
La sent. n. 12/2025 ha escluso l’esistenza di cause di inammissibilità del quesito. In particolare, l’oggetto non era né una disciplina “costituzionalmente necessaria” o “a contenuto costituzionalmente vincolato”, né priva di una “matrice razionalmente unitaria”. In entrambe le evenienze, era necessario vincere la prova opposta: si doveva, per un verso, dimostrare che l’eventuale abrogazione non avrebbe esposto il lavoratore a “una lacuna nella tutela del fondamentale diritto al lavoro” e, per altro verso, superare l’obiezione che la domanda avesse un contenuto eterogeneo proprio perché la disciplina recava tanto un “arretramento” quanto un “ampliamento” delle tutele.
Sul primo punto si afferma – vale la pena riportare il passo integrale – che il quesito “punta a rimuovere dall’ordinamento l’intero d.lgs. n. 23 del 2015, frutto di una discrezionale opzione di politica legislativa, senza che dalla vis abrogans possa scaturire una, preclusa, reviviscenza del quadro normativo preesistente: la disciplina dettata dal suddetto decreto legislativo si è affiancata a quella dettata dall’art. 18 statuto lavoratori e dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, dando così luogo a «un duplice e parallelo regime» (sentenza n. 44 del 2024). L’effetto innovativo sulla disciplina vigente, connaturale alla abrogazione referendaria, consisterebbe quindi nella «fisiologica espansione della sfera di operatività» (sentenza n. 50 del 2000) di norme già presenti nell’ordinamento, tuttora vigenti, anche se compresse, per effetto della applicabilità delle disposizioni oggetto del referendum, su un ambito di efficacia limitato ai soli licenziamenti individuali dei lavoratori già in servizio alla data del 7 marzo 2015”.
Sul secondo punto, la Corte ricorda che l’art. 75 Cost. permette “l’abrogazione anche totale”, compresa “anche la possibilità che il referendum investa un testo articolato e complesso, ed escludendo di conseguenza che tali caratteri di un atto siano pregiudizialmente motivo di inammissibilità del quesito”. Riconoscere che, nel caso, esiste una matrice razionale unitaria equivale ad ammettere che sussiste una finalità unitaria, “mirante all’abrogazione di un corpus organico di norme e funzionale alla reductio ad unum, senza più la divisione tra prima e dopo la data del 7 marzo 2015, della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi, con la riespansione della disciplina pregressa, valevole per tutti i dipendenti, quale che sia la data della loro assunzione”.
Individuato il verso dell’abrogazione popolare, è stato possibile superare la contraddizione interna al Jobs Act laddove prevede tanto un “arretramento di tutela” quanto un “ampliamento delle garanzie per i lavoratore”. Detta circostanza, infatti, “non assume una dimensione tale da inficiare la chiarezza, l’omogeneità e la stessa univocità del quesito”, perché la domanda “chiama, infatti, il corpo elettorale a una valutazione complessiva e generale, che può anche prescindere dalle specifiche e differenti disposizioni normative, senza perdere la propria matrice unitaria, che resta quella di esprimersi a favore o contro l’abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015 nella sua articolata formulazione” (enfasi non testuale). Il fine unitario giustificherebbe, quindi, il risultato di un abbassamento dei livelli di protezione. La Corte lo spiega così: i limiti costituzionali al referendum (impedire, da un lato, “la distorsione in senso plebiscitario del precipuo strumento di democrazia diretta contemplato dalla Costituzione”; e, dall’altro, “l’incisione sulla libertà del voto dell’elettore, che potrebbe maturare «convincimenti diversi» rispetto a una pluralità di questioni profondamente difformi e insuscettibili di essere ricondotte ad unità”) “non precludono l’abrogazione totale di un testo normativo che contempla soluzioni differenti (…) qualora rimanga comunque salvaguardato un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario” (enfasi non testuali).
Come si evince, in definitiva, la Corte ha ammesso che, in tale caso, la forma prevale sulla sostanza: se il quesito presenta una matrice razionale unitaria – l’abolizione di un intero corpus normativo – non rileva la materiale diversità delle garanzie apprestate nelle fattispecie astratte.
Il risultato è, quindi, esattamente opposto a quello conseguito dalla sent. n. 10/2025 sull’autonomia differenziata. Lì la sostanza ha prevalso sulla forma e per tale ragione la decisione è stata di inammissibilità. Qui, viceversa, nessun rilievo ha avuto la circostanza che la disciplina dei licenziamenti del JA fosse stata più volte modificata successivamente, soprattutto da parte della Consulta stessa (l’ultima delle pronunce sul Jobs Act, la sent. n. 128/2024, è stata pubblicata nello stesso tempo del deposito della richiesta, avvenuta il 19 luglio 2024, mentre la decisione è stata pubblicata sulla G.U. il 17 luglio, quindi, sono “coeve”) E non s’era trattato di modifiche di contorno, ma di aggiustamenti sostanziali che, per utilizzare il medesimo giudizio di valore della Consulta, sono andate verso un “avanzamento” delle tutele, la cui abrogazione, a rigor di logica, avrebbe comportato un loro “arretramento”.
Una nutrita giurisprudenza costituzionale, come abbiamo ricordato, aveva ridefinito i contenuti materiali del Jobs Act, se non di più, almeno altrettanto incisivamente come la sent. n. 192/2024 aveva fatto sulla “legge Calderoli”. Come detto, la sent. n. 194/2018 aveva svuotato la nota essenziale della “riforma Renzi”, rovesciando il criterio legale di determinazione dell’indennizzo, passato da un meccanismo automatico (la sola anzianità di servizio), ad uno discrezionale (la valutazione caso per caso del giudice sulla base di plurimi criteri oltre l’anzianità), ritenuto più adeguato a Costituzione. Le pronunce intervenute dopo quella decisione di riferimento hanno seguito una stessa linea demolitrice, modificando profondamente la disciplina del d.lgs. n. 23/2015. Ciò nonostante, la Consulta ha dato rilievo differente a questo ius superveniens nei due casi comparati. Sia detto per chiarezza. Sottolineare questi profili mi serve per mettere in evidenza le aporie argomentative e la disomogenea valutazione di due referendum molto simili per la comune confluenza, sull’oggetto del quesito, di norme positive e di norme giurisprudenziali. Non voglio, cioè sostenere che anche il referendum sul JA fosse inammissibile. Era, come correttamente riscontrato, pienamente ammissibile, solo che, a mio giudizio, era ammissibile anche quello sul regionalismo differenziato che, però, la Corte costituzionale ha ritenuto di non sottoporre al voto popolare.
M. T. Carinci. La posizione assunta oggi da C. Cost. 12/2025 nel dichiarare ammissibile il referendum non mi ha sorpreso. I soggetti promotori, memori della dichiarazione d’inammissibilità da parte di C. Cost. 26/2017, hanno attentamente ed opportunamente formulato l’attuale quesito, che risulta omogeneo, coerente, chiaro. Esso, infatti, chiede l’abrogazione integrale del D. Lgs. 23/2015, disciplina applicabile solo ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015; ne consegue, come giustamente ritiene la Corte costituzionale, che la sua abrogazione non determinerà la reviviscenza di norme abrogate, ma la mera espansione del campo di applicazione di norme attualmente vigenti, cioè l’art. 18 St.lav. e la l. 604/1966.
B. Caruso. Confermo quanto detto in precedenza. Il quesito attuale è molto più chiaro e meno subliminale o furbo di quello precedente, ma l’effetto che ne deriverebbe con riguardo alla disciplina rimediale del recesso non aiuterebbe a risolvere i nodi ancora da sciogliere.
V. A. Poso. La Corte Costituzionale ( richiamando anche la sentenza n. 56 del 2022) ha ricordato, nelle sentenze pronunciate il 7 febbraio 2025 che il referendum abrogativo non si deve trasformare «– insindacabilmente – in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie» (v. sentenza n. 16 del 1978, richiamata nella sentenza n. 56 del 2022), trattandosi di «un’ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può “introdurre una nuova statuizione, non ricavabile dall’ordinamento” referendum ex se (v. sentenza n. 36 del 1997)».
Ritenete rispettato questo limite?
A. Morrone. Su questo punto la giurisprudenza costituzionale è molto oscillante e impossibile da riassumere anche perché ondivaga e contraddittoria. Il principio generale è che il referendum sia diretto all’abrogazione totale o parziale di leggi e atti aventi forza di legge. Fuori quadro dovrebbe essere qualsiasi consultazione popolare che non avesse queste caratteristiche, senza necessariamente arrivare al “plebiscito” (la cui configurazione astratta è molto controversa), escludendo pure referendum “propositivi” (che, pure, sono molto ambigui: in che senso una domanda è “propositiva”?). Ma questo contenuto minimo costituzionale (la lettera dell’art. 75.2 Cost.) è stato riscritto in concreto dalla giurisprudenza.
La più importante innovazione del diritto vivente è il “quesito manipolativo”, l’abrogazione di disposizioni finalizzata a modificare la legislazione vigente al fine di introdurre una disciplina diversa dalla precedente e in questo senso “nuova”. Del resto, il più attento costituzionalista dei fenomeni normativi aveva notato che anche soltanto “abrogare” implica “innovare”, perché l’abrogazione non equivale a un “non disporre” ma a un “disporre diversamente” (Vezio Crisafulli nelle sue Lezioni di diritto costituzionale, Cedam, 1984).
La giurisprudenza sui referendum in materia elettorale, dopo una iniziale e problematica chiusura (che non trova nessun appiglio nell’art. 75 Cost.) almeno nei confronti di referendum abrogativi “totali” (sent. n. 29/1987 sulla legge elettorale del Consiglio superiore della Magistratura), aveva ritenuto ammissibili quesiti elettorali al ricorrere di alcune condizioni (sentt. nn. 47/1991 e 32/1993 poi sempre confermate in seguito): 1) che i quesiti fossero necessariamente “parziali”, ovvero su singole disposizioni o frammenti di disposizione (e quindi “manipolativi”); 2) che dall’abrogazione parziale o manipolativa conseguisse necessariamente una “normativa di risulta” di carattere “autoapplicativo” (che, nel caso, fosse sufficiente al rinnovo dell’organo la cui legge elettorale era interessata da una richiesta di abrogazione popolare).
La conseguenza di questa giurisprudenza – estesa a tutti i quesiti parziali o “manipolativi” – è che il referendum da “abrogativo” è (pretoriamente) diventato necessariamente “propositivo”, almeno nel senso che l’abrogazione è in funzione della innovazione normativa. Chi chiede un referendum non vuole solo abolire una disciplina ma (soprattutto) sostituire quella abrogata con un’altra legislazione. Ecco, dunque: la principale responsabile della trasfigurazione del referendum, della sua originaria versione prescritta nell’art. 75 Cost., è stata la Consulta che, per evitare o limitare i referendum elettorali, ha finito per legittimare i referendum manipolativi diretti a introdurre norme mediante l’abrogazione di norme. Da qui la necessità di “correre ai ripari”, ossia la giurisprudenza successiva che esige che il referendum popolare non si trasformi in un “inammissibile” e “distorto strumento di democrazia rappresentativa”. Che il popolo sovrano non possa, mediante un referendum (abrogativo), farsi legislatore rappresentativo è scontato. Quale sia – una volta ammessi dal punto di vista della legittimità costituzionale quesiti parziali e manipolativi – il confine tra legislazione popolare e legislazione rappresentativa è impossibile da stabilire. O, meglio, dipende dalla giurisprudenza costituzionale e dalle sue volubili nuances.
I precedenti ci consegnano degli indici sintomatici, spesso rivisti, aggiustati, modificati e, quindi, tutt’altro che sicuri. Tra questi il criterio della “assoluta” novità della “norma popolare” frutto del ritaglio referendario: assoluta rispetto all’ordinamento vigente e alle sue evoluzioni positive. Non rispetto al materiale normativo esistente nell’ordinamento. Per riprendere il parallelo con il quesito Cgil del 2016, allora la volontà di applicare la reintegra a tutte le imprese commerciali con più di cinque dipendenti come per le imprese agricole è stata ritenuta inammissibilmente diretta a introdurre una regola mai esistita nell’ordinamento dei licenziamenti, attraverso vieppiù l’estensione, del tutto artificiosa, di una previsione speciale sempre riferita alle imprese agricole (in ragione delle specialità dell’organizzazione e dell’attività economica propria di queste ultime).
Nel caso del quesito presente, l’abrogazione del d.lgs. n. 23/2015 ha come obiettivo positivo l’applicazione della disciplina, da esso sostituita a partire dal 7 marzo 2015, dalla “riforma Fornero”. Una legislazione, quest’ultima, non solo esistente (ancorché non applicabile a nuovi assunti dopo quel crinale temporale), ma ritenuta utilizzabile giuridicamente proprio per colmare il “vuoto” conseguente al referendum. Come si vede, anche in questa sent. n. 12/2025, la Corte costituzionale dice che il referendum sul Jobs Act non crea in modo non consentito un vuoto, perché quel vuoto viene colmato con la “riforma Fornero”; e, si può aggiungere, è proprio questo motivo che rende ammissibile il quesito. Altrimenti – e, cioè, una mera abrogazione del Jobs Act – avrebbe lasciato privi di tutela i diritti del lavoratore ingiustamente licenziato. Il che conferma che, per la Corte costituzionale, i referendum hanno (rectius: non possono non avere) una forza manipolativa della legislazione vigente, nel senso che l’abrogazione deve mirare necessariamente all’innovazione, specie quando sono in gioco diritti fondamentali. Un altro modo per superare le colonne d’Ercole del dettato dell’art. 75 Cost.
B. Caruso. Certamente in tutta la vicenda che ha inizio con la sentenza n. 194 del 2018, e, a prescindere dall’ultima di ammissione del referendum, la Corte ha giocato nella materia una partita in proprio. Quale sia stato il ruolo della Consulta, l’hanno sintetizzato bene i colleghi costituzionalisti e con uno di loro ne abbiamo scritto nel saggio a quattro mani.
M. T. Carinci. Penso che il quesito referendario dichiarato ammissibile da C. Cost. 12/2025 non rivesta alcuna valenza propositiva che possa trasformarlo in “un distorto strumento di democrazia rappresentativa” dal momento che si limita a chiedere l’abrogazione integrale del D. Lgs. 23/2015. Né l’abrogazione del Jobs Act determinerà l’introduzione di nuove statuizioni non presenti nel sistema, bensì la mera espansione del campo di applicazione di norme vigenti, cioè dell’art. 18 St.lav. e della l. 604/1966.
B. Caruso. Su questo punto dissento da Maria Teresa. La Corte non ha svolto il ruolo di “anima bella”, custode dei valori laburisti e dei principi costituzionali, come si tende a presentarlo nella vicenda. Tutt’altro: si è “sporcata le mani” nella contesa politica, giuridica e giudiziaria; ha menato a destra e manca degli schieramenti, dettando la linea e il compromesso politico ritenuto giusto e sorbendosi, a volte, e a mio raro ricordo, anche critiche e valutazioni pesanti che ritengo ingiuste, ingenerose e a volte sopra le righe da parte di colleghi; ha bacchettato in alcuni casi i giudici rimettenti (i giudici di Napoli); altre volte li ha quasi incoraggiati ad andare oltre (il dialogo con il Tribunale di Ravenna, rimettente compulsivo ma intelligente); ha “ammonito” il legislatore quando ha ritenuto di farlo (sentenza sulle piccole imprese), si è erta a soggetto arbitratore di contrasti di indirizzi della Corte di Cassazione, come nel caso delle clausole elastiche e ne ha inteso correggere indirizzi consolidati (la posizione sul repêchage). Chiederei retoricamente a Maria Teresa ovviamente in modo assolutamente bonario e richiamando, mi si passi la dissacrazione, un famoso slogan pubblicitario di un noto amaro: cosa vuoi di più dalla vita?
V. A. Poso. Prendo a prestito le parole chiare utilizzate dalla Consulta nella sentenza n. 10 del 7 febbraio 2025 che si è espressa per l’inammissibilità della richiesta referendaria relativa alla l. 26 giugno 2024,n.86, sulla c.d. autonomia differenziata: «Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio sull’ammissibilità della richiesta referendaria è volto a «verificare che non sussistano eventuali ragioni di inammissibilità sia indicate, o rilevabili in via sistematica, dall’art. 75, secondo comma, della Costituzione, attinenti alle disposizioni oggetto del quesito referendario; sia relative ai requisiti concernenti la formulazione del quesito referendario, come desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 174 del 2011, n. 137 del 1993, n. 48 del 1981 e n. 70 del 1978): omogeneità, chiarezza e semplicità, completezza, coerenza, idoneità a conseguire il fine perseguito, rispetto della natura ablativa dell’operazione referendaria» (sentenze n. 59 del 2022 e n. 17 del 2016)».
Sussiste, a Vostro avviso, qualcuna delle cause di inammissibilità indicate nell’art.75, c. 2, Cost., in ragione dell’oggetto del quesito riconducibile alle categorie di leggi ivi elencate, anche in via di interpretazione logico-sistematica?
M. T. Carinci. Ritengo che tutti i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale sussistano.
B. Caruso. Concordo con Maria Teresa. Il percorso motivazionale, su questo punto, della Corte Costituzionale è coerente con la sua precedente giurisprudenza e coerente con le altre sentenze del 7 febbraio 2025.
A. Morrone. Nel caso del quesito sul Jobs Act non ritengo esistenti motivi di inammissibilità. Il quesito riguarda un decreto legislativo nella sua interezza, non ci sono ritagli di disposizioni, il contenuto non rientra nei limiti dell’art. 75 Cost. o in quelli creati, in via pretoria, dal giudice dell’ammissibilità. Come ho cercato di dire, i problemi erano altri: quelli derivanti dalla stratificazione normativa e soprattutto della giurisprudenza successiva che aveva più volte modificato il testo di quella disciplina; nonché, le contraddizioni derivanti comparando la sent. n. 12/2025 con la 10/2025 sull’autonomia differenziata.
Il punto, lo dico diversamente, è che, oggi, ancora non sappiamo il valore che possono avere le modificazioni sopravvenute della disciplina oggetto di un referendu, ai fini del controllo tanto dell’Ufficio Centrale per il Referendum quanto della Corte costituzionale. Il dato che emerge, è l’insignificanza dello ius superveniens, nel senso che ciò che conta sembra essere soltanto la disciplina positiva, quasi che delle novelle o delle modifiche poi intervenute (per abrogazione o per caducazione integrale delle norme oggetto) si dovesse tenere conto solo ai fini della correzione del quesito, dandone conto. Invero, sappiamo bene che non può essere così, e non è così: nel referendum sull’autonomia differenziata, anche se la Corte non lo dice apertamente, l’inammissibilità consegue alla sent. n. 192/2024 che, essa sì, proprio a seguire il ragionamento della decisione, ha reso incerto ex post l’oggetto della domanda di integrale abrogazione della relativa regolazione positiva.
V. A. Poso. Come sapete, la giurisprudenza della Corte Costituzionale – ci è stato ricordato anche nelle sentenze del 7 febbraio 2025 - ha ritenuto preclusa al referendum l’abrogazione di leggi costituzionalmente necessarie od obbligatorie (sentenze n. 57, n. 56 e n. 50 del 2022, n. 10 del 2020, n.15 e 16 del 2008, n. 49 del 2000 e n. 35 del 1997). Il decreto delegato oggetto di referendum incontra questo limite? Nella sentenza in esame la Consulta lo ha escluso «dal momento che l’eventuale esito positivo del referendum non determinerebbe una lacuna nella tutela del fondamentale diritto al lavoro: dall’abrogazione del d.lgs. n. 23 del 2015 deriverebbe l’applicabilità, anche ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, della disciplina dettata dall’art. 18 statuto lavoratori e dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966».
A. Morrone. Come ho cercato di dire nelle risposte precedenti, la domanda corretta, in proposito, è la seguente. Il referendum pone in questione una “lacuna di tutela” del diritto al lavoro o, piuttosto, rileva una problematica disomogeneità di tutele interne al Jobs Act? Più che la prima, è la seconda questione che avrebbe dovuto essere ponderata nel caso presente, al fine di apprezzare le conseguenze dell’abrogazione del Jobs Act, anche ai fini dell’ammissibilità. Come ho accennato e come dirò nella successiva risposta, qui la Corte ha ritenuto di accentuare il primo profilo, con la risposta che il preteso vuoto sarebbe risolto attraverso l’applicazione della disciplina della “riforma Fornero”. Mentre sulla seconda, la Corte ha solo sfiorato il nodo, anzi lo ha minimizzato, ritenendo che, nonostante la disomogeneità delle tutele esistenti nel Jobs Act, messe in chiaro anche dai colleghi giuslavoristi, la matrice razionalmente unitaria della domanda (abolire l’intero decreto legislativo n. 23/2015), fosse sufficiente a sciogliere quel nodo.
M. T. Carinci. Ritengo condivisibile la posizione espressa dalla Corte: l’abrogazione del Jobs Act non lascerebbe privo di tutele il lavoratore illegittimamente licenziato in quanto, a seguito di tale abrogazione, si riespanderebbe il campo di applicazione dell’art. 18 St.lav. e della l. 604/1966 anche ai lavoratori assunti fino al 7 marzo 2015. Tale disciplina garantisce non solo una tutela al lavoratore illegittimamente licenziato, come richiesto dalla Costituzione, ma una tutela nel complesso più incisiva di quella assicurata attualmente dal Jobs Act (v. risposta alla domanda n. 8).
B. Caruso. Ho l’impressione di aver già risposto e quindi passo per non appesantire l’intervista.
V. A. Poso. Secondo la Corte Costituzionale - premesso che l’art. 75, Cost. consente la richiesta referendaria per l’abrogazione anche totale di una legge o di un atto avente valore di legge – la matrice razionalmente unitaria è salvaguardata anche dalla presenza di un testo articolato e complesso (v. sentenza n.56 del 2022), a condizione che «il quesito incorpori «l’evidenza del fine intrinseco all’atto abrogativo, cioè la puntuale ratio che lo ispira (sentenza n. 29 del 1987), nel senso che dalle norme proposte per l’abrogazione sia dato trarre con evidenza “una matrice razionalmente unitaria” (sentenze n. 16 del 1978; n. 25 del 1981), “un criterio ispiratore fondamentalmente comune” o “un comune principio, la cui eliminazione o permanenza viene fatta dipendere dalla risposta del corpo elettorale” (sentenze n. 22, n. 26, n. 28 del 1981; n. 63, n. 64, n. 65 del 1990)» (sentenza n. 47 del 1991)».
Nel caso di specie che ora ci occupa viene valorizzato il profilo teleologico che mira all’abrogazione di un corpus organico di norme, funzionale alla reductio ad unum del sistema sanzionatorio applicabile a tutti i dipendenti, a prescindere dalla data di assunzione del 7 marzo 2015.
Condividete questa interpretazione della Consulta?
A. Morrone. Questa affermazione della Corte costituzionale conferma che, nella sent. n. 12/2025 (a differenza della sent. n. 10/2025), la “forma” prevale sulla “sostanza”. Quello che conta è se la richiesta referendaria abbia un fine chiaro ed evidente e che vi sia una coerenza tra l’oggetto e lo scopo dell’abrogazione popolare. Il contenuto non conta. Se così fosse stato, nulla quaestio. La giurisprudenza, tuttavia, ha fatto un’applicazione sincopata e apodittica di questo dato. Nella sent. n. 10/2025, infatti, la “sostanza” ha prevalso sulla “forma”. La Consulta ha smentito l’Ufficio Centrale per il Referendum, che aveva ritenuto esistente un fondo positivo vigente nonostante la sent. n. 192/2024, ritenendo che, proprio per effetto di quella decisione, il contenuto della disciplina positiva non fosse più tale da rendere chiaro su cosa l’elettore sarebbe stato chiamato a votare. Nella decisione sul JA è l’unità formale dell’atto oggetto di abrogazione che legittima l’ammissibilità di un voto popolare. Nonostante quel contenuto, non solo sia stato sostanzialmente riscritto, ma contenga ab origine, forme di tutela differenziate nei confronti di categorie di lavoratori interessati dalla sua applicazione.
M. T. Carinci. Mi sembra che, in linea con quanto ritiene la Corte, il quesito referendario nel chiedere l’abrogazione integrale del Jobs Act possegga quella “matrice razionalmente unitaria” data innanzitutto dalla riconduzione ad unità della disciplina dei licenziamenti per i lavoratori assunti fino e dopo il 7 marzo del 2015. A mio parere il quesito referendario - nonostante i “chiaroscuri” già evidenziati - possiede anche un’altra “ratio unitaria” che lo sorregge e, cioè, quella di rafforzare nel complesso le tutele dei lavoratori, soprattutto riespandendo l’area della tutela reale. Un profilo, quest’ultimo, però non valorizzato dalla Corte.
B. Caruso. Anche su questo punto mi limito a rinviare alle mie risposte precedenti.
V. A. Poso. Al punto 4.5. della sentenza la Corte Costituzionale prende in esame tutte le ipotesi in cui il decreto delegato comporta un ampliamento delle tutele (in controtendenza rispetto al complessivo arretramento delle garanzie a favore della flessibilità in uscita), che verrebbe meno con l’approvazione referendaria. Nonostante ciò, resterebbero comunque confermati i requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito posto al corpo elettorale chiamato ad esprimersi a favore o contro l’abrogazione dell’intero decreto delegato, a prescindere dalla differente regolamentazione di alcune fattispecie. Scrive la Corte che nel caso di specie «riman[e] comunque salvaguardato un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario: in tal caso non si concreta un uso artificioso del referendum abrogativo (ancora, sentenza n. 16 del 1978), tale da eccedere le previsioni dell’art. 75 Cost.».
Leggete anche Voi questa linea di coerenza? Lo chiedo perché, in contrario avviso a quanto affermato dalla Corte, utilizzando le sue stesse parole, potrebbero ritenersi violati i limiti costituzionali al referendum «essenzialmente preordinati a evitare, da un lato, la distorsione in senso plebiscitario del precipuo strumento di democrazia diretta contemplato dalla Costituzione (sentenze n. 56 del 2022 e n. 16 del 1978) e, dall’altro, l’incisione sulla libertà del voto dell’elettore, che potrebbe maturare «convincimenti diversi» rispetto a una pluralità di questioni profondamente difformi e insuscettibili di essere ricondotte ad unità (ex plurimis, sentenza n. 12 del 2014)».
B. Caruso. Lascio la risposta ai colleghi giuscostituzionalisti che possono ovviamente con la loro autorevolezza dialogare direttamente con la Corte sulle questioni che poni. Dal punto di vista di noi giuslavoristi, la sentenza è ormai un dato; dobbiamo concentrarci sull’esito ed eventualmente sul dopo.
M. T. Carinci. Condivido la posizione della Corte. Come ho già illustrato in precedenza, nel suo complesso l’abrogazione del Jobs Act comporta un rafforzamento delle tutele per i lavoratori; scelta a mio avviso auspicabile.
A. Morrone. Ho già risposto: la forma prevale sulla sostanza, e la Corte riconosce la coerenza tra il mezzo e il fine. Si tratta di una soluzione “lineare” (rispetto a quelle, molto più problematiche, del passato, e a quella della sent. n. 10/2025): che sembrerebbe farci intendere che il referendum abrogativo sia una sorta di “contrarius actus”, diretto ad abolire (solo in negativo) ciò che ha posto il legislatore rappresentativo. La realtà, come ho cercato di dire, è molto più complessa di quanto appare anche da questa schematica motivazione. Condivido questa linea, ma la Corte non l’ha quasi mai seguita.
V. A. Poso. Meditando sulle precedenti risposte date da Andrea Morrone, faccio questa considerazione. La Corte Costituzionale non ha argomentato a sufficienza (come invece ha fatto nella sentenza gemella n. 10/2025 in tema di autonomia differenziata, in ragione della intervenuta sentenza n. 192 del 3 dicembre 2024, che ha dichiarato l’incostituzionalità di diverse disposizioni, rimandando al legislatore ogni opportuno intervento, nel quadro riformatore intrapreso dalla maggioranza parlamentare ora al governo) sul «massiccio effetto demolitorio» che si è riversato sul testo del decreto delegato oggetto di richiesta referendaria, in parti essenziali modificato a seguito degli interventi legislativi e delle sue stesse pronunce. Con tutto ciò che ne consegue in termini di chiarezza e semplicità del quesito referendario, sufficienti a consentirne l’ammissibilità, quanto alla possibilità di esprimere un voto libero e consapevole da parte degli elettori.
A. Morrone. Come ho precisato, proprio dal confronto delle due decisioni emergono le contraddizioni più evidenti della giurisprudenza costituzionale, in questa, e nelle tornate precedenti. Rimando alle precedenti risposte date per i dettagli.
V. A. Poso Dopo la sentenza della Corte Costituzionale gli scenari che si possono prospettare mi sembrano problematici, anche in ragione dei tempi ristretti, per evitare il voto popolare. Innanzitutto – si fa per ragionare a voce alta - quale potrebbe essere l’intervento del legislatore (escluderei quello demolitorio, ovviamente, anche in ragione della attuale maggioranza parlamentare al governo) sufficiente ad evitare il referendum abrogativo?
M. T. Carinci. Come dici, anche a me sembra decisamente improbabile che il legislatore intervenga in questo momento. Infatti, quello che sarebbe necessario per evitare il referendum - a parte l’abrogazione del Jobs Act - sarebbe la rimodulazione complessiva della disciplina dei licenziamenti per tutti i lavoratori, assunti fino e dopo il 7 marzo 2015, riconducendo ad unità il sistema delle tutele. Ciò, tuttavia, comporterebbe scelte politicamente assai delicate: decidere se posizionare il discrimen fra tutela reale ed obbligatoria nel punto fissato dall’art. 18 St.lav. o dal Jobs Act o fare scelte ancora diverse; decidere se rimodulare l’importo della tutela indennitaria; definire quali datori di lavoro debbano essere soggetti all’una o all’altra tutela, ecc.
Voglio qui ricordare l’esercizio teorico compiuto dai colleghi del “Gruppo Freccia Rossa” che di recente hanno redatto un testo di riforma offerto al dibattito della comunità accademica: quel “progetto di legge”, pur sicuramente ben congegnato sotto il profilo tecnico e completo, presta però il fianco (ed ha prestato il fianco nel convegno tenutosi presso l’Università di Bologna il 21 febbraio 2025) a molte critiche perché decisamente sbilanciato a sfavore dei lavoratori.
Su un punto in ogni caso un intervento del legislatore sarebbe urgente ed importante: nell’individuazione di nuovi criteri per segnare la distinzione fra grandi e piccoli datori di lavoro. Diversamente sarà la Corte costituzionale, nuovamente investita della questione dall’ordinanza del Tribunale di Livorno del 24 novembre 2024, a dover definire la questione (rinvio, sul punto, alle mie risposte alle precedenti domande).
B. Caruso. Ormai a votare si va, è deciso. Semmai il problema è il dopo.
A prescindere dall’esito del referendum credo che sia opportuno che il Legislatore ponga mano alla disciplina dei licenziamenti e dei suoi rimedi, anche se prevedo che questo non avverrà nel breve medio-periodo, salvo che, soprattutto sul regime delle piccole imprese, la Consulta non scuota in maniera decisiva l’atteggiamento di inerzia opportunistica del parlamento.
Dal punto di vista della razionalità di risulta del quadro normativo post referendum, prescindendo dalla razionalizzazione normativa necessaria, non so quale sia il risultato migliore, se l’abrogazione del Jobs Act o il suo mantenimento (anche ottenuto con il mancato raggiungimento del quorum che equivale, per l’effetto, alla prevalenza del no). Dico questo non in termini di opzione a favore dell’uno o dell’altro esito, ma proprio interrogandomi su quale sia la soluzione migliore sotto il profilo del valore della certezza e della razionalità sistemica del quadro regolativo.
In astratto, su questo insiste molto Maria Teresa, l’esito abrogativo potrebbe comportare un quid pluris di razionalità e certezza in ragione dell’unificazione normativa che si otterrebbe: non più due regimi, ratione temporis, ma uno soltanto. Ma se questo esito per così dire “asettico”, al di là delle diverse regole di merito, fosse l’obiettivo dei promotori, il risultato auspicato non cambierebbe molto perché il tempo andrebbe comunque verso l’unificazione dei regimi ancorché con il prevalere del Jobs Act sulla Fornero, che è invece l’esito opposto perseguito.
Ribadisco però che il referendum non è la soluzione, ma semmai il problema, meglio è un problema che aggroviglia il problema esistente e non lo risolve.
Onde l’esercizio teorico a cui ci siamo dedicati come “Gruppo Freccia Rossa” e a cui accennava prima Maria Teresa.
Non entro nel merito dei contenuti e delle proposte e rinvio i lettori di questa intervista alla lettura del testo che sarà presto pubblicato ma che è stato già fatto circolare in occasione del convegno Bolognese, anche se la nuova versione tiene conto dei rilievi tecnici costruttivi che sono stati proposti da molti colleghi in quella sede. Dico solo che il giudizio di Maria Teresa, di essere un testo sbilanciato a sfavore dei lavoratori, mi sembra non solo esso stesso sbilanciato, ma soprattutto ingeneroso nei confronti dei componenti del “Gruppo Freccia Rossa”, certamente più vicini alle posizioni pro referendum e che hanno raggiunto rispetto a coloro, come il sottoscritto, meno schierati con esse, un compromesso che ritengo ragionevole e tecnicamente adeguato. A dimostrazione che il metodo deliberativo e l’arte dell’ascolto reciproco, non scevra da ragionevoli confutazioni, serve a trovare incroci virtuosi, pur partendo da posizione distanti e apparentemente inconciliabili.
A. Morrone. Anche io ritengo ormai improbabile un intervento legislativo, è più facile contare sull’astensionismo (molto probabile anche in questa tornata, venuto meno il referendum con maggiore appeal mediatico, quello sul regionalismo differenziato). Il fatto è, per rispondere in positivo, capire quale dovrebbe essere un intervento legislativo “utile” al fine di evitare il referendum. In questo caso vale l’art. 39 della legge n. 352/1970, che chiede modifiche sostanziali (relative ai “principi fondamentali” o ai “contenuti essenziali”). Nella giurisprudenza si desume che l’intervento legislativo successivo, per bloccare il referendum dovrebbe soddisfare l’obiettivo (soggettivo? oggettivo? È incerto!) della domanda referendaria. Nel nostro caso, il minimo sufficiente, sarebbe la mera abrogazione del d.lgs. n. 23/2015.
V. A. Poso. Sono così ovvi e scontati gli scenari che si prospettano in caso di esito positivo del voto popolare? Mi sono chiesto, ad esempio, e lo chiedo a Voi, se si risolve tutto con l’azzeramene della normativa del 2015, con la semplice reviviscenza della normativa precedente anche per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. Sarebbe, quantomeno, necessaria una norma transitoria.
M. T. Carinci. L’abrogazione del Jobs Act non richiede a mio parere una disciplina transitoria. Infatti, l’esito positivo del referendum non determina nel nostro caso alcun vuoto di tutela: tutti i licenziamenti irrogati dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto che attesta l’esito positivo del referendum (art. 37, c. 2 l. 352/1970) saranno infatti soggetti ad un sistema di tutele esaustivo e completo già vigente e dunque immediatamente operativo: l’art. 18 St.lav. e la l. 604/1966.
Ove si ravvisasse, però, l’opportunità politica di dar tempo ai datori di lavoro di adattarsi alla modifica normativa, l’art. 37, c. 2 l. 352/1970 contempla comunque la possibilità che, su proposta del Ministro del Lavoro e previsa delibera del Governo, il Presidente della Repubblica, con il decreto che attesta l’avvenuta abrogazione del Jobs Act, fissi un termine, non superiore a 60 giorni, per l’entrata in vigore dell’abrogazione (art. 37, c. 2, l. 352/1970).
B. Caruso. Ritengo altamente improbabile l’esito positivo della prova referendaria e la conseguente abrogazione del Jobs Act. Gli osservatori tendono a pronosticare un nulla di fatto conservativo per mancato raggiungimento del quorum.
A. Morrone. Non ho le idee chiare, proprio perché la ricostruzione del quadro normativo dipende essenzialmente dall’interpretazione, in assenza di un intervento di razionalizzazione del legislatore. Io penso che, all’esito positivo della consultazione, resti ferma la confusione normativa che caratterizza questa materia, dopo i ripetuti interventi positivi, le numerose pronunce della Corte costituzionale. Che, va ricordato, ha denunciato la confusione normativa della materia e, più volte, ha sollecitato l’intervento del legislatore. Un referendum abrogativo, anche letto nella direzione dell’applicazione della “riforma Fornero” in luogo della disciplina abrogata dagli elettori, non farebbe chiarezza. Penso, in particolare, che il risultato sarà quello di vedere crescere il ruolo e il protagonismo creativo del giudice del lavoro, cui, nei fatti, viene riconsegnata questa materia nelle coordinate larghe e confuse delle leggi vigenti. Sul piano della politica del diritto non vedo molte luci. Quali saranno gli effetti sul mercato del lavoro? Quali i risultati per la Cgil in termini di “forza politica”? Quali, soprattutto, i vantaggi effettivi per i lavoratori di fronte alle sfide dell’economia e della politica presenti?
V. A. Poso. Quali potrebbero essere le ripercussioni sul mercato del lavoro e, più in generale, sul tessuto sociale ed economico, in caso di esito positivo del referendum? Credo che siano maturi i tempi per realizzare una regolamentazione, organica e semplificatoria, della materia dei licenziamenti come richiesto anche dalla Corte Costituzionale nelle sentenze di monito al legislatore.
A. Morrone. L’unica conseguenza del referendum è di avere posto all’attenzione dell’opinione pubblica la necessità – che non nasce col referendum – di una profonda riforma della disciplina dei licenziamenti illegittimi, da riscrivere pienamente in linea, nell’incertezza del quadro economico generale (e non solo), con i principi della Costituzione. In questa direzione molto va fatto. I protagonisti di questa stagione sono all’altezza? Nei limiti della politica (legislativa e sindacale), quel che resta è l’egemonia della giurisdizione. Ma è questa la strada costituzionale per una tutela “eguale” del lavoratore contro i licenziamenti illegittimi?
B. Caruso. Ho già risposto a questa domanda. Mi limito a richiamare lo sforzo riformatore compiuto dal “Gruppo Freccia Rossa”, anche in termini di dignitoso compromesso tra le diverse posizioni.
M. T. Carinci. Come anticipavo, diverse indagini sul campo hanno dimostrato - dopo le modifiche dell’art. 18 St.lav. ad opera della cd. “Legge Fornero” (l. 92/2012) e dell’ulteriore arretramento della disciplina ad opera del Jobs Act - che la diminuzione delle tutele per il licenziamento non determina di per sé un incremento dell’occupazione; dubito, dunque, che un irrobustimento di quelle tutele possa bloccare la crescita occupazionale con un impatto negativo sul mercato del lavoro.
Penso, invece, che l’esito positivo del referendum sarebbe un segnale importante nella direzione di una maggiore tutela del lavoro e di una rinnovata attenzione verso una componente fondamentale della nostra società: i lavoratori. Il momento storico richiede una forte coesione sociale per fronteggiare le difficili sfide che provengono da un quadro geopolitico in movimento, che richiederà prevedibilmente l’uso di ingenti risorse per la difesa.
Le leggi a tutela del lavoro - e del licenziamento in particolare - possono dare un contributo importante affinché i lavoratori possano percepirsi ed essere percepiti per quello che in realtà sono: una parte fondamentale del Paese, da proteggere e valorizzare per il loro contributo essenziale al benessere collettivo.
Immagine: Honoré Sharrer, Lavoratori e dipinti, 1943, Moma, New York.