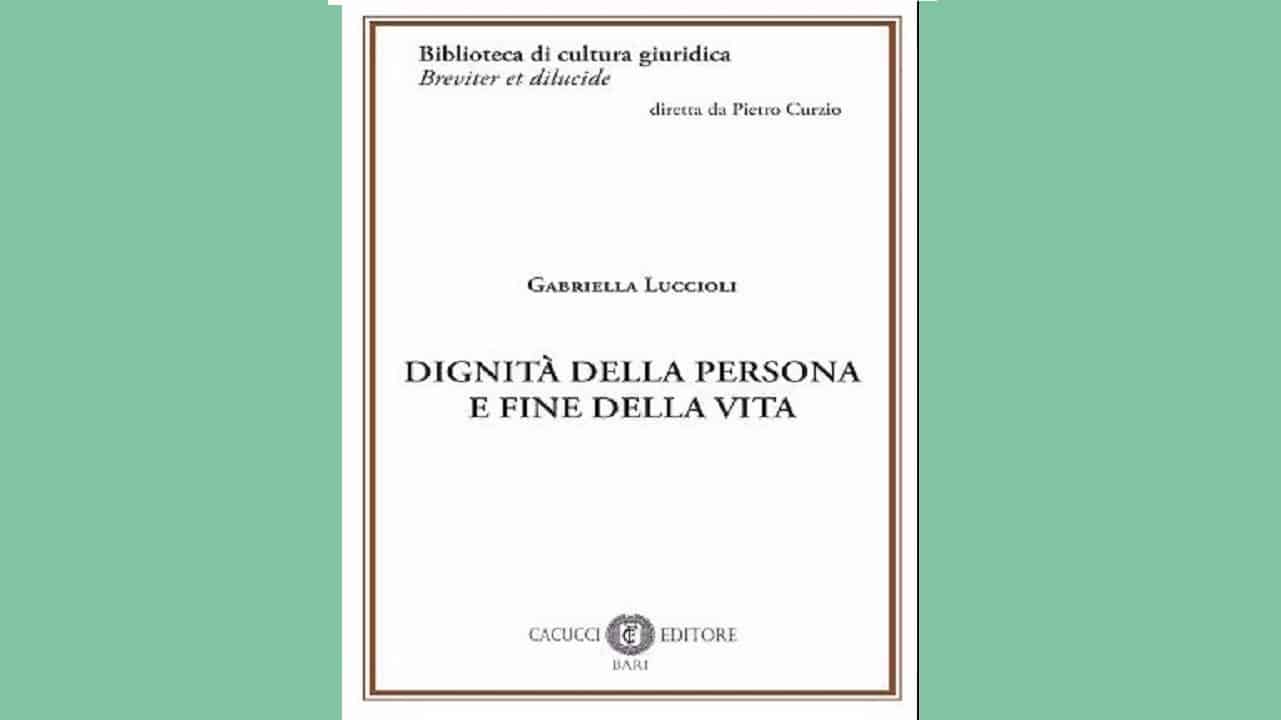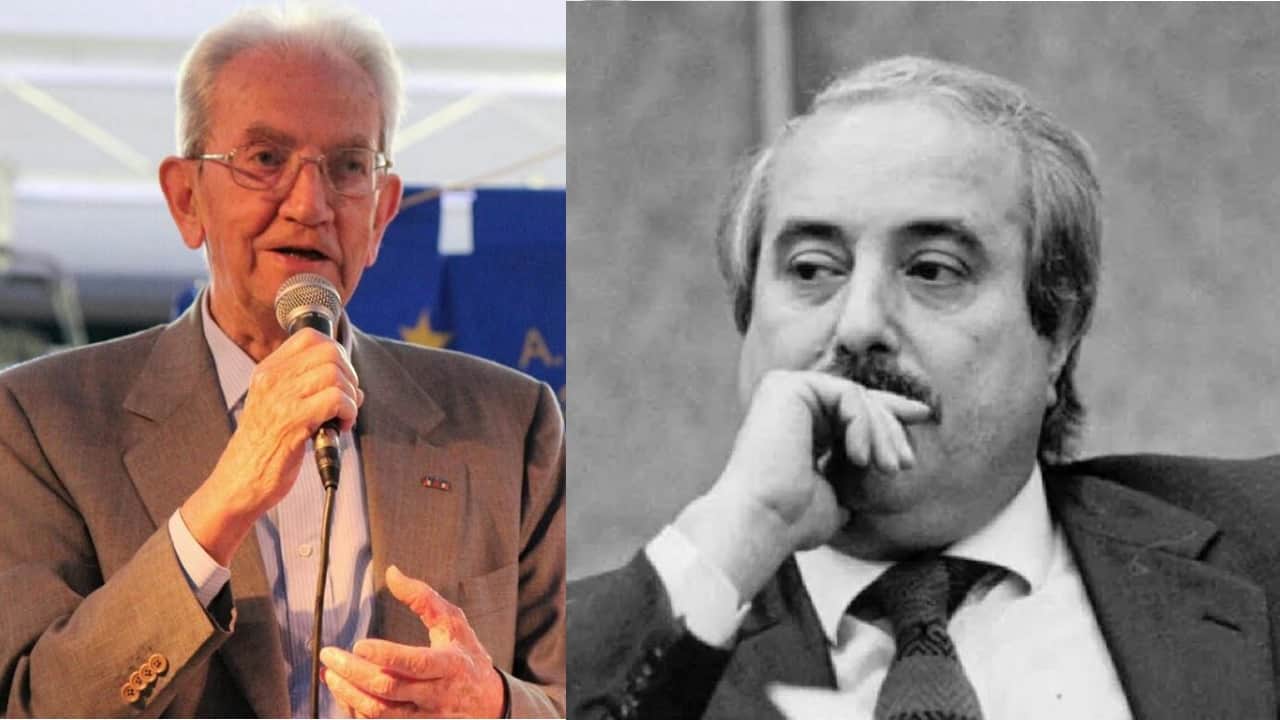Intervista a cura di Roberto Giovanni Conti con Antonio D’Aloia ( prof. ord. dir.cost.Univ.Parma), Giacomo D’Amico (prof. ass.dir.cost. Univ.Messina) e Giorgio Repetto (prof. ass. dir. cost.Univ.Perugia)
1. Dopo la sentenza n.207/2018 si attende l’eventuale intervento legislativo e, soprattutto, la decisione della Corte costituzionale sul c.d. caso Cappato. Quale pensa possa essere, nell’attesa, il ruolo del giudice comune, civile e penale, rispetto a casi simili a quelli che hanno coinvolto dj Fabo? Pensa che il rimedio cautelare possa essere sperimentato in ambito civile per offrire una tutela richiesta dal soggetto che versi in condizioni di salute irreversibili e, se si, in che misura?
2. La decisione resa dalla Corte costituzionale ha riaperto numerosi interrogativi sugli effetti della questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice comune, domandandosi se in casi simili una diversa autorità giudiziaria sia tenuta a sua volta a sollevare analoga questione, ovvero a sospendere il giudizio in attesa della definizione della questione pendente, ovvero ancora possa adottare una “terza via”- cioè percorrere una diversa soluzione- decidendo nel merito la vicenda processuale pendente. Qual è il suo avviso sul tema?
3. La Corte costituzionale ha richiamato, nella ordinanza n. 207/2018, numerose volte il concetto di dignità, secondo taluni propendendo per una nozione soggettiva che l’identificherebbe con il diritto all’autodeterminazione dalla quale deriverebbe il riconoscimento della legittimità di pratiche volte a determinare la prematura chiusura della propria esistenza. Pensa che tale ricostruzione della dignità sia condivisibile e, più in generale, ritiene che il ricorso al canone della dignità umana possa rappresentare un elemento utile per la decisione dei casi che si porranno all’attenzione del giudice comune e, se sì, in che misura?
Repliche
Giacomo D’Amico:
In sede di repliche ritengo necessario svolgere solo due osservazioni.
La prima trae spunto da quanto affermato da Antonio D’Aloia nella sua risposta alla prima domanda. Scrive D’Aloia: «Sul piano dei contenuti, l’ordinanza 207 “annuncia” (per ora), e anzi prepara, un vero e proprio overruling del diritto vivente in tema di end-of-life decisions. Finora, il punto di consolidamento della riflessione giuridica era rappresentato dalla sentenza “Englaro”, i cui contenuti sono stati in un certo senso “stabilizzati” nella legge 219/2017».
Devo confessare che non mi trovo d’accordo con quanto sopra riportato e in particolare con l’individuazione di un overruling del diritto vivente, per una serie di ragioni che provo a riassumere brevemente.
Innanzitutto, si tratta di casi decisamente diversi. Nel caso Englaro i trattamenti consistevano nella alimentazione e idratazione artificiale ed erano fondamentali per mantenerla in vita. Anche nel caso di Fabiano Antoniani vi era la somministrazione di un trattamento vitale ma la morte di quest’ultimo non è stata determinata dall’interruzione di questo trattamento, che gli avrebbe provocato grandissime sofferenze e un’agonia di qualche giorno. Inoltre, la volontà di Fabiano è stata espressa chiaramente e convintamente dallo stesso al momento della decisione, mentre quella di Eluana è stata dedotta dai suoi comportamenti e dalle frasi da lei pronunciate in occasione di un incidente analogo (al suo) occorso a un suo amico. Comportamenti e frasi, che sono state ricostruite dai giudici a distanza di molti anni grazie alla testimonianze delle amiche e delle sue insegnanti.
Se proprio devo dirla tutta, queste considerazioni sembrano semmai dimostrare che la decisione della Cassazione del 2007 è stata più incisiva di quella della Corte costituzionale del 2018.
Antonio D’Aloia sottolinea il fatto che nel caso di Fabiano si sia trattato di una pratica eutanasica, mentre per Eluana si sia sostanzialmente trattato dell’interruzione di un trattamento necessario per il mantenimento in vita. Non vi è dubbio che questo dato sia incontrovertibile, ma – come accennato sopra – non bisogna dimenticare che anche Fabiano era mantenuto in vita artificialmente. La sua scelta di non interrompere il trattamento vitale e di optare per una pratica eutanasica è stata determinata solo dalla legittima e comprensibile volontà di non subire ulteriori sofferenze (come quelle che avrebbe dovuto sopportare se avesse scelto di interrompere i trattamenti che lo tenevano in vita).
Al riguardo, si rinvia a quanto affermato dalla Corte: «Secondo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, nel caso oggetto del giudizio a quo l’interessato richiese l’assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata prospettata), proprio perché quest’ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, totalmente dipendente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo» (punto 9 cons. dir.).
Quanto poi all’overruling di cui discute D’Aloia, a mio avviso, se si pongono a confronto le motivazioni delle due decisioni sono più numerosi gli elementi comuni del percorso argomentativo piuttosto che quelli di differenza.
Così la Cassazione nel caso Englaro (limitatamente al principio di diritto):
«Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona. Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità della vita stessa»
Così la Corte costituzionale nel caso Fabiano Antoniani:
«8.– Da quanto sinora osservato deriva, dunque, che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione.
Occorre, tuttavia, considerare specificamente situazioni come quella oggetto del giudizio a quo: situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali.
Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. […]».
Il mero confronto tra le condizioni poste dalla Cassazione nel 2007 e quelle individuate dalla Corte costituzionale nel 2018 (patologia irreversibile, mantenimento in vita a mezzo di trattamenti vitali, manifestazione di volontà implicita o esplicita) dimostra, a mio avviso, come quest’ultima decisione sia in assoluta continuità con la pronunzia sul caso Englaro.
La seconda considerazione che intendo svolgere riguarda la specifica tecnica decisoria (sia pure interlocutoria) utilizzata dalla Corte: ordinanza con rinvio a data fissa.
Sebbene non sia mia intenzione sottovalutare le peculiarità della decisione adottata nel caso di Fabiano Antoniani, posso solo rilevare che nella giurisprudenza costituzionale non mancano alcuni (pochi) casi in cui la Corte ha disposto il rinvio di una causa con ordinanza numerata e pubblicata (ordd. 284 e 257 del 2014, 90 del 2010, 165 del 2004, 388, 387 e 386 del 1993, 54 del 1992, 246 del 1982, 169 del 1981 e 38 del 1980). In un altro caso, poi, la Corte ha disposto il rinvio a data fissa (ord. 1040 del 1988).
Si tratta di casi in cui il rinvio è stato disposto per ragioni significativamente diverse da quelle che hanno spinto la Corte a operare in questo modo nel caso Antoniani ma resta il fatto che non mancano i precedenti.
Antonio D'Aloia:
Una breve replica alla replica di Giacomo D’Amico. Non c’è dubbio che i casi Englaro e Dj Fabo sono molto diversi tra di loro, sia sul piano della condizione oggettiva dei due ragazzi, sia sul piano delle modalità di espressione/ricostruzione della volontà. E ha ragione Giacomo D’Amico quando segnala l’esistenza di una traccia argomentativa comune tra le due decisioni.
Perché allora io ho parlato di un ‘overruling’, in modo forse non totalmente corrispondente al significato tecnico dell’istituto (e infatti ho messo la parola tra virgolette)?
Nella decisione Englaro la Corte mantiene una chiara distinzione tra rifiuto di cure e suicidio assistito/eutanasia, potremmo dire (riprendendo una terminologia americana) tra letting die (sebbene con le peculiarità della condizione di SVP) e killing. Lo dice chiaramente in un passaggio della sentenza del 2007, e riprende questo concetto (sempre la Cassazione) sulla inammissibilità giuridica del suicidio assistito nella sent. del 2015 sulla nascita indesiderata (ragionando in parallelo sul valore supremo della vita).
In questo senso, secondo me, il ‘passo in avanti’ (al di là di come vogliamo definire questo ‘avanzamento’), c’è, ed è chiaramente espresso dalla Corte Costituzionale nella dichiarazione di insufficienza degli strumenti ex l. 219/2017, e nella ritenuta necessità costituzionale di ‘dare’ la morte in modo più rapido di quanto non si possa avere con il distacco dalle macchine accompagnato da sedazione permanente continua.
Forse non c’è una netta discontinuità, anche perché il caso Englaro e la condizione di SVP sono già nella cd. ‘zona grigia’ tra autodeterminazione astensiva e intervento eutanasico; non credo però si possa parlare di ‘assoluta continuità’ tra le due pronunce.
Conclusioni di Roberto Giovanni Conti
Il limbo nel quale ha lasciato l’ordinanza n.207/2018 è notevole e pare sia destinato a rimanere tale anche dopo l’ulteriore risposta che, inevitabilmente, verrà offerta dal giudice costituzionale alla scadenza del termine concesso al Parlamento, essendo improbabile che l’attuale Parlamento possa riuscire in così limitato lasso temporale a trovare un’intesa su uno dei temi più divisivi dal punto di vista etico che l’esperienza dei nostri giorni ci consegna.
Un tema che va ben oltre la vicenda Englaro nella quale l’intervento della Corte di Cassazione venne qualificato, da alcuni commentatori, come “omicidio per sentenza” e che, verosimilmente, con riguardo alle vicende di accelerazione di un percorso volto a far cessare la propria esistenza da parte del malato terminale, esporranno ancora di più il giudice investito del caso concreto non solo a scelte estremamente difficili, ma anche a campagne mediatiche di vario tipo che egli dovrà essere in grado di fronteggiare.
Ed è proprio il rapporto tra l’ordinanza n.207/2018 e la vicenda Englaro ad avere diviso i nostri interlocutori.
Antonio D’Aloia ha sottolineato un passo di discontinuità fra le due vicende, al punto di intravedere nella pronunzia della Corte costituzionale un – sia pur tra virgolette – overulling nell’intervenuto riconoscimento di giuridicità alla condotta attiva che conduce a morte il malato in condizioni irreversibili ed affetto da gravi turbamenti. Ciò che avrebbe innovato – con un percorso motivazionale affatto lineare – i principi espressi dalla sentenza Englaro e recepiti dalla l.n.219/2017 in tema di rifiuto di cure, valorizzando il concetto di dignità rapportato al dolore provato da chi lo subisce e da chi sta accanto al malato, al punto da inferire un diritto al raggiungimento della morte in un lasso di tempo ridotto. Da qui la prospettata parziale incostituzionalità della previsione dell’aiuto al suicidio che limita irragionevolmente il principio di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, vulnerando altresì il principio di dignità umana. Dunque un slittamento dal mero rifiuto di cure, espressivo del lasciarsi morire, al provocare la morte con l’aiuto esterno di un terzo sul e con il quale, dice D’Aloia, dovremo confrontarci.
In effetti, il passaggio dalla vicenda Englaro a quella odierna è palpabile avendo la prima sezione civile della Cassazione a suo tempo garantito il diritto a rifiutare i trattamenti vitali ad un soggetto che, quando era capace di intendere e di volere aveva manifestato, secondo gli elementi raccolti e ponderati dall’autorità giudiziaria, ai propri congiunti la volontà di non rimanere in vita in caso di condizione meramente vegetale, autorizzando il suo rappresentante a chiedere l’interruzione dei trattamenti.
Per converso, nelle vicende suscitate dalla vicenda del dj Fabo la differenza più evidente è rappresentata dalla circostanza che si discute della condotta di accelerazione alla fine della vita con un trattamento farmacologico capace di interrompere prima del suo corso naturale la vita stessa, non limitandosi la richiesta alla sfera del rifiuto delle cure che tenevano in vita il malato. In mezzo alle due vicende, la legge n.219/2017 che in effetti nulla sembra dire sulla seconda.
In una prospettiva in parte diversa si collocano Giorgio Repetto e Giacomo D’Amico. Il primo, nel sottolineare che la differenza fra comportamento omissivo e attivo, astrattamente ben catalogabile, lascia il posto a “casi” nei quali il confine fra le due vicende si assottiglia enormemente, in guisa da rendere problematica la rilevanza dell’autodeterminazione e del parametro di cui all’art.32 Cost. solo nei casi di rifiuto.
È stato, invece, Giacomo D’Amico a sottolineare nelle repliche quanto siano marcati i tratti di continuità, anche di natura testuale e lessicale, fra la sentenza Englaro e quella che ha originato l’ordinanza n.207/2018, con ciò intendendo valorizzare un filo rosso fra le due vicende – pur evidentemente diverse – soprattutto in ragione della volontà manifestata dal dj Fabo di non volere proseguire il trattamento che pur lo manteneva in vita in ragione della scelta di non subire ulteriori sofferenze correlate al lasso temporale che sarebbe decorso fra l’interruzione dei trattamenti di sostegno ai quali era sottoposto e la morte che sarebbe sopravvenuta.
A stare alla Corte costituzionale le vicende sembrerebbero meno lontane di quanto possano apparire, avendo la legge n.219/2017 normativizzato i principi espressi dalla sentenza Englaro, riconoscendo piena dignità al diritto all’autodeterminazione ed al consenso informato al trattamento sanitario, al punto di garantire il diritto al rifiuto delle cure, pur con la precisazione, sottolineata da D'Amico, che alla base della tutela che il giudice costituzionale intende riconoscere non vi sarebbe la generica autodeterminazione della persona, ma la specifica «autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze».
Proprio il riconoscimento del diritto all’interruzione delle cure attraverso il distacco dei macchinari che tengono in vita il malato, pienamente lecito se considerato alla luce della l.n.219/2017 non tollera, secondo Corte cost.n.207/2018, che l’ordinamento risponda con la previsione di una condotta penalmente rilevante a carico di chi aiuta il malato “a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale”.
Ed è Repetto a sottolineare che proprio la legge n.219/2017, nell’occuparsi del rifiuto alle cure praticato con interruzione delle terapie, abbia costituito una sorta di tertium comparationis utilizzato dalla Corte costituzionale per manifestare l’irragionevolezza di una previsione che punisca penalmente chi accelera il processo di morte reso irreversibile in relazione alla patologia per ridurre le sofferenze che deriverebbero dalla persistenza di quella condizione, contrarie al suo senso di dignità, a fronte della condotta pienamente lecita, sulla base della l. n.219/2017, di chi interrompe il trattamento che tiene in cura il paziente.
Passando agli effetti dell’ordinanza n.207/2018 i tre accademici concordano, in buona sostanza, sul fatto che l’ordinanza n.207/2018 rende assai problematico ammettere che in una vicenda speculare a quella che ha suscitato la decisione della Corte costituzionale il giudice di merito possa decidere in sede interpretativa ipotizzando la persistente rilevanza penale della condotta di assistenza al suicidio.
La via del nuovo ricorso al giudice costituzionale, anche per salvaguardare il pieno diritto di difesa dei soggetti coinvolti, sembra essere la soluzione maggiormente suggerita, a fronte della scelta di sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale alla scadenza del termine di un anno al Parlamento. Ciò sempreché la vicenda sia identica a quella presa in considerazione da Corte cost.n.207/2018 e comunque in astratto rimanendo nel perimetro delle opzioni del giudice comune la possibilità di discostarsi dalle indicazioni programmatiche offerte dal giudice costituzionale.
Il punto è semmai appunto quello di verificare gli effetti ulteriori ed “indiretti” dell’ordinanza n.207/2018 su vicende contigue ma non sovrapponibili a quella presa a base dal giudice costituzionale.
Proviamo a fare il punto della situazione. Secondo Corte cost.n.207/2018 il malato: a) capace di intendere e volere e di prendere decisioni libere e consapevoli; b) che versi in una condizione di “non ritorno” a causa di una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche e psichiche intollerabili; c) che è mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale; d) che non è in condizioni di autonomamente realizzare il proprio proposito, ha diritto ad accelerare la propria fine con l’intervento di un terzo.
Se questo fosse il senso dell’ordinanza laddove esprime una prospettata incostituzionalità della disciplina penalistica di riferimento, oggi ci si interroga su come si tutela questo diritto che, nelle parole di Antonio D’Aloia, è già oggi un significato costituzionale per il quale lo stesso giudice costituzionale si impegna a predisporre le possibili linee di intervento normativo, introduzione di una disciplina ad hoc per regolare le vicende del fine vita, innesto di una novella alla l.n.219/2017, riformulazione delle ipotesi delittuose.
Ma Corte cost.n.207/2018 è consapevole del fatto che l’assenza di un intervento normativo “lascerebbe del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in condizioni irreversibili, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi”.
Dunque la Corte ha ben chiara la prospettiva che la futura pronunzia di incostituzionalità andrebbe ad incidere su un complesso coacervo di questioni, correlate all’accertamento della condizione di irreversibilità, delle modalità di raccolta del consenso del malato, della posizione dei medici chiamati ad assistere il malato verso una situazione che si pone in apparente contrasto con i doveri deontologici dei sanitari, suscitando quasi naturalmente la necessità di opporre una obiezione di coscienza da parte del medico eventualmente richiesto di attuare la volontà del paziente tesa a congedersi dalla vita.
Rispetto a tutto questo la Corte costituzionale ha rimandato a settembre l'esame della questione ed ha riservato ai giudici comuni, negli altri giudizi, di “valutare se alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l’applicazione stessa in parte qua”.
D'Aloia, D’Amico e Repetto si sono soffermati con preziose indicazioni sul che fare, oggi, dopo Corte cost.n.207/2018, offrendo indicazioni sulla scelta del giudice, civile e penale per i casi simili – sollevare nuova questione di legittimità costituzionale , sospendere il giudizio in attesa della nuova pronunzia, operare un’interpretazione “conforme” o “difforme” a Corte cost. n.207/2018 –. Tale problematica si confonde, poi, con l’ulteriore tema della rilevanza sulle vicende tragiche di cui qui si è discusso del ricorso a strumenti processuali di tipo cautelare per garantire, in attesa della definizione del giudizio costituzionale, la protezione immediata dei beni primari che vengono in giuoco.
Per altro verso, se la decisione della Corte costituzionale, alla scadenza del termine annuale, non si confronterà con un tessuto normativo introdotto dal legislatore come dalla stessa suggerito, ancora una volta, la pronunzia di probabile incostituzionalità – con le forme dell’additiva di principio – potrebbe aprire le porte all’intervento in parte suppletivo del giudice chiamato a sagomare, sulla base del quadro giuridico vigente e dei principi fondamentali ivi riconosciuti, una sorta di “statuto del fine vita”.
Si tratta di temi estremamente delicati che chiamano in campo, ancora una volta, i delicati rapporti fra legislatore e ordine giudiziario, in mancanza di “rime obbligate” provenienti dal legislatore ed alla luce della giurisprudenza costituzionale che non ha mancato di individuare il ruolo della giustizia costituzionale e del giudice comune d fronte ad un vulnus alla Costituzione, scrutinando altresì gli esiti del mancato intervento del legislatore in esito a pronunzia di incostituzionalità – cfr., per es. Corte cost.n.88/2018, successiva a Corte cost.n.30/2014, dove si è esplicitamente affermato che «[p]osta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio: e ciò, indipendentemente dal fatto che la lesione dipenda da quello che la norma prevede o, al contrario, da quanto la norma [...] omette di prevedere. [...] Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione”; cfr, ancora, Corte cost.n.113/2011, p.8, par.7 del cons. in diritto.–
Passiamo dunque a tratteggiare qualcuno dei possibili scenari futuri.
Può oggi un malato che versi nelle condizioni sopra descritte pretendere un aiuto al suicidio da terzi o dalla struttura sanitaria nella quale si trova in cura o da altro soggetto che si attivi nella direzione auspicata dal malato, ma da quest’ultimo impossibile da realizzare senza il contributo esterno di un altro soggetto o struttura? Può alla stesso quesito rispondersi in modo diverso se si guarda alla situazione che verrà a porsi all’indomani della pronunzia di incostituzionalità “quasi certa”?
A questi due quesiti se ne aggiunge uno ad essi ancillare, correlato alla possibilità o meno di attivare la tutela cautelare per evitare che proprio quelle sofferenze nelle quali versa il malato possano perpetuarsi e dunque consentire un’immediata tutela, sia pure interinale, ai principi fondamentali che sono sottesi alla situazione costituzionale di cui si è detto.
Esiste, dunque, il diritto del malato in condizioni di malattia irreversibile ad anticipare la sua fine e può un giudice porre in essere un provvedimento che tuteli questo diritto anche in forma cautelare?
Ad un primo approccio potrebbe rispondersi in maniera radicalmente e recisamente negativa.
Se la Corte costituzionale ha “deciso di non decidere”, auspicando l’intervento legislativo, come sarebbe pensabile che un giudice possa sostituirsi al legislatore in questa delicatissima materia, nella quale, si è già detto, fortissime sono le componenti etico-socio-deontologiche dei tanti soggetti coinvolti?
Ed ancora, come sarebbe possibile utilizzare lo strumento cautelare se dall’utilizzo dello stesso derivino effetti irreversibili non più emendabili nell’ambito del successivo giudizio di merito al quale il primo rimane pur sempre strumentale?
A queste prime provocazioni, che sembrano convergere verso una risposta in senso negativo a tutti i quesiti posti, potrebbero peraltro opporsene altre di non minore spessore, quanto meno per alcune delle ipotesi sopra esposte.
Se, si è già detto, siamo in presenza di un diritto già prospettato a livello costituzionale, con parametri già ben individuati – dignità, salute, autodeterminazione – come sarebbe possibile pensare che questo diritto rimanga in un non cale in attesa di un intervento legislativo o della stessa Corte costituzionale? Come sarebbe possibile lasciare insoddisfatto un diritto talmente forte da reclamare una risposta giudiziaria immediata quale forse solo la tutela cautelare potrebbe rispondere in maniera appagante?
Quanto alla praticabilità del ricorso alla tutela cautelare in attesa della decisione della Corte costituzionale – o, più in generale, all’indomani del nuovo atteso intervento della Corte costituzionale in materia – a tale prospettiva non sembrano favorevoli, sia pur con accenni non completamente sovrapponibili, né Repetto, né D’Aloia.
Ed il suggerimento è assolutamente da tesaurizzare, in relazione alla situazione liquida che da qui al nuovo intervento della Corte costituzionale continuerà a caratterizzare l’attuale assetto.
Ma la riflessione sul cautelare credo debba essere fatta, poiché l’intervento giudiziale in materia non potrà che necessariamente passare da tale forme di tutela giudiziaria, imponendosi “di fatto” come luogo nel quale i valori in gioco e gli interessi facenti capo a diversi centri d’imputazione richiederanno il maggior grado di attenzione in un tempo ragionevolmente contenuto.
Ed allora, si è proprio sicuri che l’irreversibilità dell’effetto prodotto dalla concessione della cautela impedisca il ricorso allo strumento cautelare, sia nelle more della decisione della Corte costituzionale che quando sarà dichiarata la parziale incostituzionalità della disciplina penale?
Non è forse superfluo ricordare che nell’ambito del processo amministrativo il tema della cautela irreversibile è già stato studiato ed affrontato, trovando addirittura una soluzione normativa (art.55 cod.proc.amm. – che non parrebbe indirizzare verso una chiusura del sistema alla tutela cautelare ad effetti irreversibili, anzi escludendo specificamente il rimedio della cauzione “quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale”.
Dunque in quel contesto il legislatore si è preso cura di chiarire non solo l’ammissibilità del ricorso alla misura cautelare anche se ad effetto irreversibile, addirittura impedendo che possa essere imposta una cauzione quando la domanda “attenda a diritti fondamentali della persona”.
Sembrerebbe confermato da tale quadro normativo che il riferimento, spesso contenuto nelle pronunzie della Corte costituzionale, alla circostanza che la misura cautelare possa essere adottata in pendenza del giudizio di costituzionalità “purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale il giudice fruisce in tale sede” non potrebbe impedire al giudice civile – almeno in astratto – l’adozione di misure cautelari anche ad effetto irreversibile che non fanno comunque venir meno la potestà decisoria in sede di merito né la provvisorietà della misura cautelare – M. Bove, La tutela cautelare nel processo amministrativo, in www.judicium.it e, in generale, sul problema della tutela cautelare ad effetto irreversibile –.
Il che, all’evidenza, non significherebbe in alcun modo aprire in modo indifferenziato a forme di tutela cautelare in materia, ma semmai unicamente sottolineare, da un lato, la circostanza che in casi molto ristretti proprio i beni “vitali” in gioco ( nel caso di specie la dignità che, come suol dirsi, non tollera bilanciamenti o degradazioni, se di questa se ne intende parlare in termini di super-valore non bilanciabile e incomprimibile) e il particolare stato nel quale essi vengono presi in considerazione renderebbe quasi naturale pensare a forme di protezione giudiziale capaci di offrire pronta tutela ai diritti in gioco, soprattutto se il legislatore lascerà integralmente alla Corte costituzionale il compito di depurare il sistema dalla disposizione contenuta nel codice penale. Ed in questa prospettiva non può non ricordarsi la vicenda esaminata da Cass., S.U., n.1946/2017 a proposito del diritto alla conoscenza delle origini esaminato dalle Sezioni Unite dopo che il legislatore aveva omesso di introdurre una disciplina apposita successiva alla declaratoria di incostituzionalità dell’art.28 c.7 l. adoz.
Non pare allora inutile procedere a quale esemplificazione per chiarire meglio il concetto qui espresso a proposito del ricorso alla tutela cautelare.
Occorrerebbe, anzitutto, isolare il caso dell’aiuto che il malato potrebbe ottenere da parte di un soggetto non sanitario a realizzare il suo desiderio di porre fine alla propria esistenza in un luogo a ciò abilitato che non potrebbe raggiungere se non con l’ausilio di un'altra persona. Un’ipotesi, quest'ultima, sostanzialmente sovrapponibile a quella della vicenda nella quale rimase coinvolto il povero dj Fabo.
Dunque, l’interessato o il malato o entrambi potrebbero chiedere al giudice di essere autorizzati al trasferimento in una struttura all’uopo attrezzata ma, vigendo la previsione penale oggetto dell’incidente di costituzionalità, il giudice chiamato a provvedere sulla domanda dovrebbe porsi il problema di sollevare egli stesso questione di legittimità costituzionale, evidenziando che l’attuale quadro normativo impedisce l’aiuto al suicidio al malato terminale che rispetti le ulteriori indicazioni di cui si è detto. Salvo a verificare la ricorrenza dei presupposti per provvedere in sede cautelare.
Beninteso, il giudice potrebbe ritenere di discostarsi dal percorso seguito dal giudice costituzionale ed orientarsi nel senso di negare in radice la legittimità della richiesta, in assenza di un quadro normativo che abiliti a riconoscere quanto allo stesso richiesto, specificamente motivando le ragioni della sua dissenting opinion. Al malato ed a chi intende aiutarlo non resterà, a quel punto, che comportarsi nel modo che riterrà opportuno, con il rischio di incorrere nella stessa incriminazione contestata al deputato Marco Cappato.
Altra ipotesi è quella che verrebbe a porsi se, nelle more della decisione, un malato dovesse chiedere alla struttura sanitaria presso la quale è in cura l’adozione di un trattamento rivolto ad accelerare la sua morte.
I problemi appaiono estremamente delicati.
Al di là della motivazione espressa dalla Corte costituzionale, è ben evidente che l’assenza di una specifica disciplina normativa renderebbe oltremodo complessa l’adozione di una risposta giudiziaria favorevole alla richiesta del malato.
Non è infatti difficile sostenere che in tale ipotesi entri in gioco il margine di apprezzamento dello Stato e che il giudice non potrebbe attivarsi nella direzione auspicata dal paziente, in questo senso, del resto, essendosi espressa l’ordinanza n.207/2018, come hanno puntualmente osservato gli accademici intervistati.
Un’ulteriore ipotesi potrebbe risultare quella del sanitario che si dichiara pronto a dare esecuzione alla volontà del malato di accelerare la propria fine e che chiede all’uopo l’autorizzazione al giudice, d’intesa con il paziente. Tale opzione non può dirsi sovrapponibile a quella appena descritta, anche se presente dagli aspetti di affinità non marginali.
Ancora diverso il caso, al quale si accennava e che pure Repetto ha prospettato nella sua riflessione, dell’amministratore di sostegno che chieda al giudice l’autorizzazione ad accompagnare il malato in condizioni irreversibili presso una struttura sanitaria straniera che pratica la c.d. dolce morte, avendo il paziente rappresentato, quando era in condizioni di coscienza, una simile volontà ovvero questa volontà emergendo da un disposizione anticipata di trattamento, ancorché l’art.4, c.1 della l.n.219/2017 non contempli, ovviamente, tale ipotesi. Quid iuris?
E chissà quanti altri casi peculiari potranno porsi da parte di malati che invocano la dignità di ciascuno per accelerare la loro fine.
Non a caso gli intervistati si sono tutti soffermati sul tema della dignità e sul ruolo da tale concetto giocato nella decisione della Corte costituzione, anzi mostrando di propendere per accezioni assai diverse, consentendo a chi legge di farsi un’idea su quanto la pluralità delle posizioni e degli orientamenti offra, ancora una volta, sul piatto dell’interprete una nozione tutta da svolgere e da riempire di contenuti nei singoli casi che vengono all’attenzione del giudice o dell’operatore di turno.
Ed è, del resto, la stessa Corte cost.n.207/2018 a dimostrarlo in modo evidente quando essa allo stesso tempo mostra di non potere e volere tutelare la dignità della persona che chiede un contributo al suicidio mentre ritiene di doverla garantire al massimo ove ci si trovi al cospetto di condizioni di salute irreversibili e gravide di sofferenze. Dunque, una dimensione plurale, quella della dignità, più volte evocata anche nella legge n.219/2017, che si offre all’interprete per essere compresa prima e poi usata e che non può non avere un ruolo essenziale nelle vicende in cui vi è in gioco la vita.
Ed è proprio questa prospettiva a dimostrare l’estrema complessità e delicatezza del ruolo affidato al giudice, per svolgere il quale egli deve essere all’altezza della situazione, soprattutto se dovesse mancare un pur assolutamente auspicabile intervento legislativo rivolto a riempire le lacune evidenziate dalla Corte costituzionale.
Allo stato, peraltro, come ha puntualmente osservato Giorgio Repetto, la Corte costituzionale non sembra affatto avere inteso introdurre un diritto al suicidio assistito.
Ma si è proprio certi che sia realmente così?
Il quesito appena posto è, infatti, nelle corde preoccupate di quanti guardano con occhio assai critico la posizione assunta dalla Corte costituzionale che, pur avendo preso il via da una vicenda individuale dai contorni umani altamente dolorosi, ha poi realizzato uno slittamento di piano (come sembra profilare D'Aloia) che potrebbe condurre, nella pratica giudiziaria, a riconoscere il diritto all’eutanasia con modalità non coerenti con il sistema valoriale interno, addirittura orientando verso l’adozione di misure acceleratorie della morte che lo Stato dovrebbe impedire e non garantire.
Il tutto in una prospettiva che, pur muovendo dall’individuazione di alcuni paletti, si presterebbe ad un’applicazione in sede giudiziaria tendenzialmente pronta ad estenderne la portata ad ipotesi similari, magari attraverso i canoni, anch’essi costituzionali, dell’eguaglianza e della ragionevolezza.
Insomma, i temi sono di una delicatezza estrema, proprio perché vanno a toccare un segmento dell’esistenza umana tutto da esplorare.
La verità in materia – una delle poche – sembra essere quella che di fronte a vicende nelle quali è coinvolta la vita sono maggiori gli interrogativi che non le risposte e le certezze.
Del resto, il caso di Vincent Lambert - infermiere francese divenuto tetraplegico a causa di un incidente - che sta in questi giorni scuotendo le coscienze dei congiunti e dell’opinione pubblica francese ne è piana testimonianza.
Caso davvero paradossale, nel quale il mondo sanitario che per statuto non sembra propenso a valutare favorevolmente il proprio coinvolgimento nelle scelte di fine vita del paziente diventa, invece, il responsabile della morte di persona in condizioni di irreversibile malattia. Ed è così che la storia si ripete, dall'omicidio per sentenza del caso Englaro al quale si gridò in Italia, all'omicidio per atto del sanitario che viene oggi invocato dai sostenitori del diritto alla vita del povero Lambert.
Avrebbero potuto i medici curanti francesi agire diversamente dopo avere condotto un’istruttoria particolarmente penetrante che aveva coinvolto n modo collegiale parenti, medici specialisti ed eticisti?
La dignità umana del malato ha trovato nelle decisioni dei giudici nazionali e sovranazionali susseguitesi la tutela incondizionata e assoluta che essa meritava secondo i suoi intrinseci caratteri di indefettibilità, indissolubilità e incomprimibilità in quanto supervalore costituzionale?
Il mancato affiancamento al medico dell'autorità giurisdizione (prima che questa fosse chiamata a verificare la legittimità della decisione adottata nei confronti del Lambert) avrebbe consentito un’istruttoria più completa?
La mancanza dell’unanimità di intenti fra i parenti sull’inutilità o superfluità dei trattamenti vitali avrebbe potuto giustificare una scelta di interruzione dei medesimi o sarebbe stato più opportuno il raggiungimento dell’unanimità dei consensi?
La circostanza che, in epoca successiva alla decisione della Corte europea, le autorità giudiziarie francesi siano state nuovamente investite della questione per effetto dei permanenti contrasti tra i parenti ha depotenziato il valore della decisione dei giudici europei ovvero ancora una volta ha ribadito la centralità del principio di sussidiarietà e, con esso l'inludibilità dell'intervento giudiziale?
La decisione sull'interruzione delle cure del malato affidata ai medici piuttosto che ai parenti può ritenersi accettabile ancorché i criteri, le procedure, i limiti siano assai diversi rispetto al caso in cui la scelta sia affidata ai parenti?
Ma d'altra parte, sulla base di quale legittimazione i parenti potrebbero decidere, in una situazione di incoscienza, della vita altrui? E, ancora, quale ruolo può e deve giocare la volontà del malato espressa in vita e chi può dirsi legittimato a rappresentarla o esternarla?
L'espropriazione del potere decisionale che sembra realizzarsi in danno di alcuni dei soggetti che rappresentano, almeno dal punto di vista degli affetti, la persona malata in favore di altri congiunti può essere totale o rappresenta una risposta difficile, se si vuole tremenda, ma comunque dotata di un certo grado di razionalità rispetto al mistero della vita e della morte?
La – tanto parziale quanto significativa – "delega" alla scienza medica su queste materie – alle quali puntualmente fa riferimento, sul piano interno, Corte cost.n.162/2014 – è accettabile, auspicabile, dovuta?
Ed ancora, e non da ultimo, la scelta di ritenere coerente e corretto l'iter seguito dai sanitari in attuazione di una legge francese che aveva realizzato un certo bilanciamento fra gli interessi coinvolti costituisce espressione del riconoscimento di un margine di apprezzamento che la Corte europea ammette , in piena osservanza del canone della sussidiarietà?
La complessità degli interrogativi dà la misura di quanto sia delicato l'ambito esaminato dagli intervistati e di quanto risulti comunque necessario l'intervento giudiziale nel singolo caso, pur affiancato con un compendio normativo composto di di principi destinati ad essere applicati elasticamente in relazione alla singola vicenda.
Mai come in queste circostanze il bene della vita viene in gioco nella sua proiezione più tragica qual è quella della fine dell’esistenza, definito come “diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto” dalla Corte di Cassazione (Cass.n.10424/2019), che sottolinea come la lesione della libertà di scelta su come “affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita” sia meritevole di tutela al di là di qualunque considerazione soggettiva sul valore, la rilevanza o la dignità, degli eventuali possibili contenuti di tale scelta”.
Insomma, sostiene la Cassazione, la peculiare condizione della persona che non viene informata della propria malattia ad esito infausto perde la possibilità di affrontare la prospettiva della fine ormai prossima che si compone non solo dell’eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all’attivazione di una strategia terapeutica, ma anche della ricerca di possibili alternative d’indole meramente palliativa e persino di “vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all’ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine”. Scelte, sostiene la Cassazione, che si annoverano tutte, con il proprio valore e la propria dignità, tra le alternative esistenziali.
La Cassazione sottolinea come proprio le leggi nn.38/2010 e 219/2017 siano intervenute per garantire sia l’accesso alle cure palliative che la possibilità di esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, pure consentendo la nomina di un fiduciario con la predisposizione di disposizioni anticipate di trattamento rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Per questo il giudice è chiamato, all'atto di verificare le conseguenze dannose prodotte da condotte negligenti di sanitari, ad individuare e selezionare segmenti di vita assai peculiari, anche quando essi si caratterizzino per la predeterminazione di un percorso che porti a contenere la durata della vita o la mera accettazione della propria condizione” e ad “entrare nella morte ad occhi aperti” per “dare rilievo e tutela estrema, a tale libertà dell’individuo”.
Ora, l’aspetto che Corte cost. n.207/2018 ha voluto sottolineare è quello, ulteriore rispetto alla prospettiva valorizzata da Cass.n.10424/2019, che nelle parole di Giorgio Repetto attiene proprio al diritto alla salute in una sua particolare declinazione, correlato cioè alla capacità di proteggere anche le rivendicazioni del malato terminale a porre fine alla propria sofferenza quando ricorrano i presupposti indicati dalla Corte costituzionale.
Insomma, scenari ancora una volta in grande movimento che coinvolgeranno inevitabilmente i giudici, ma che si potranno affrontare nel modo che essi meritano solo con la cooperazione di chi per mestiere studia in modo sistematico i fenomeni giuridici, non avendo i primi a volte il tempo, a volte la voglia e a volte la competenza adeguata – in ragione della complessità e specificità delle questioni – per fornire le risposte che invece la collettività si attende . Cooperazione che, d'altra parte, non può che coinvolgere, come si è visto, il mondo sanitario, chiamato per funzione ad accompagnare le persone durante la malattia ed a svolgere un ruolo ineliminabile nella relazione di cura col paziente, sempre di più persona e anima, come ha di recente ricordato il Presidente della Repubblica.
Di questa volontà di cooperazione i tre intervistati hanno dato impareggiabile testimonianza e per questo va a loro il ringraziamento corale di Giustizia Insieme.