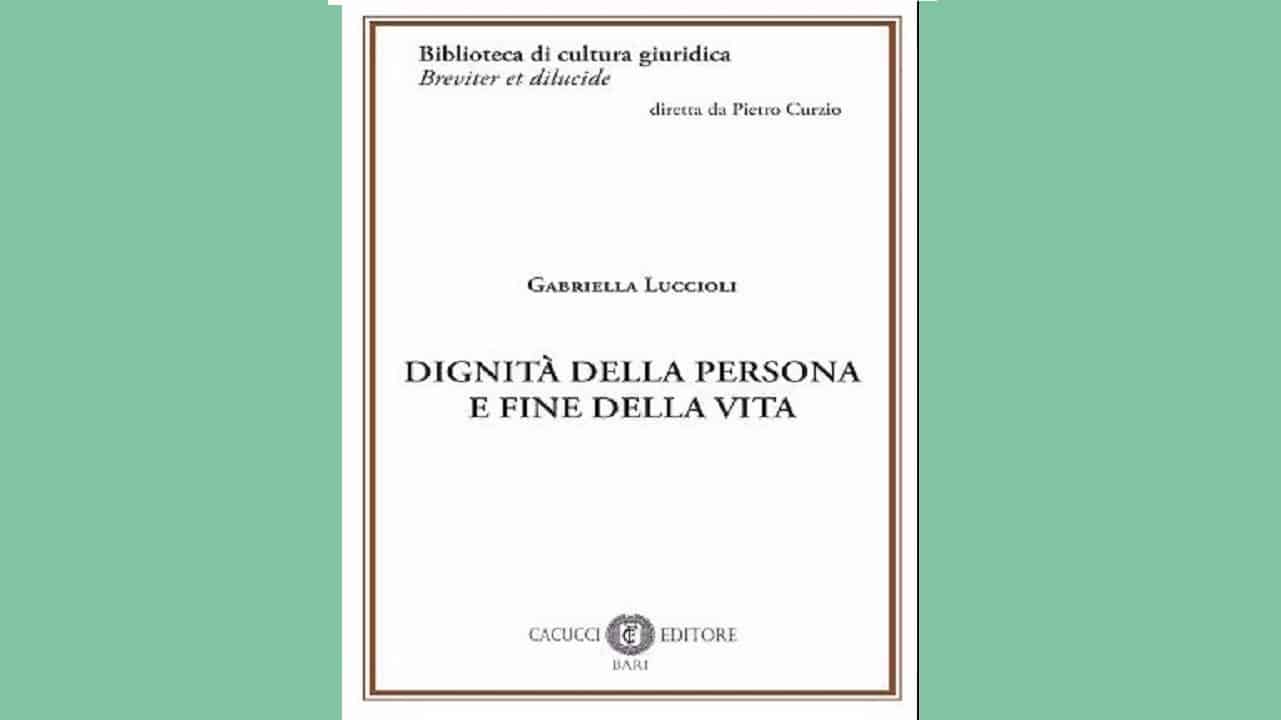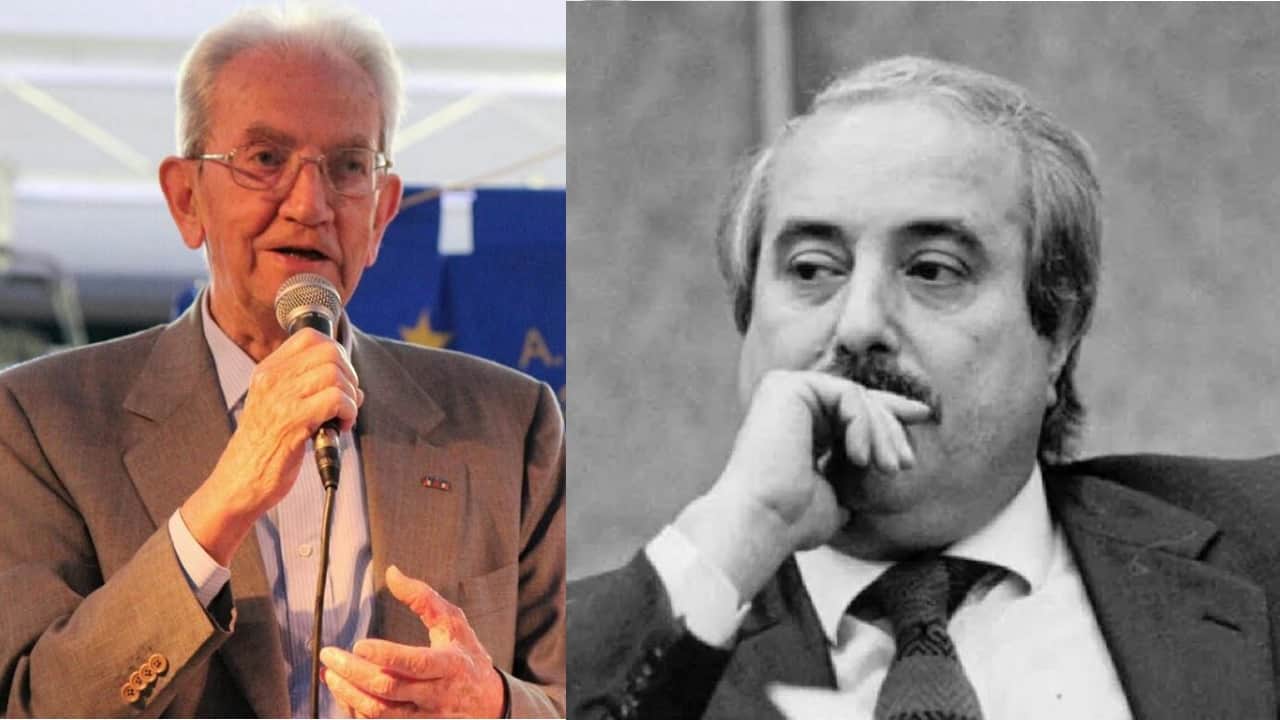Quale futuro per il fine vita dopo Corte cost.n.207/2018.
Intervista a cura di Roberto Giovanni Conti con Antonio D’Aloia (prof. ord.dir.cost.Univ.Parma), Giacomo D’Amico (prof. ass.dir.cost. Univ.Messina) e Giorgio Repetto (prof. ass.dir.cost.Univ.Perugia).
1. Dopo la sentenza n.207/2018 si attende l’eventuale intervento legislativo e, soprattutto, la decisione della Corte costituzionale sul c.d. caso Cappato. Quale pensa possa essere, nell’attesa, il ruolo del giudice comune, civile e penale, rispetto a casi simili a quelli che hanno coinvolto dj Fabo? Pensa che il rimedio cautelare possa essere sperimentato in ambito civile per offrire una tutela richiesta dal soggetto che versi in condizioni di salute irreversibili e, se si, in che misura?
2. La decisione resa dalla Corte costituzionale ha riaperto numerosi interrogativi sugli effetti della questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice comune, domandandosi se in casi simili una diversa autorità giudiziaria sia tenuta a sua volta a sollevare analoga questione, ovvero a sospendere il giudizio in attesa della definizione della questione pendente, ovvero ancora possa adottare una “terza via”- cioè percorrere una diversa soluzione- decidendo nel merito la vicenda processuale pendente. Qual è il suo avviso sul tema?
3. La Corte costituzionale ha richiamato, nella ordinanza n. 207/2018, numerose volte il concetto di dignità, secondo taluni propendendo per una nozione soggettiva che l’identificherebbe con il diritto all’autodeterminazione dalla quale deriverebbe il riconoscimento della legittimità di pratiche volte a determinare la prematura chiusura della propria esistenza. Pensa che tale ricostruzione della dignità sia condivisibile e, più in generale, ritiene che il ricorso al canone della dignità umana possa rappresentare un elemento utile per la decisione dei casi che si porranno all’attenzione del giudice comune e, se sì, in che misura?
La scelta del tema
La centralità dell’analisi volta ad esaminare le ricadute dell’ordinanza della Corte costituzionale n.207/2018 resa a margine della vicenda del povero dj Fabo e della condotta del deputato Marco Cappato è drammaticamente dimostrata dal caso Lambert che sta infiammando in questi giorni la società francese. Casi dilemmatici che suscitano prese di posizione opposte e confermano ancora di più il convincimento che il giurista dei nostri tempi è necessariamente chiamato a sottrarsi alla logica del comparto e della materia, invece allo stesso richiedendosi un approccio che tenda a superare lo steccato rappresentato dall' inquadramento di un caso con la lente puntata sulle tradizionali discipline giuridiche settoriali e guardi al bene che viene in discussione nelle sue poliedriche dimensioni, attingendo elementi utili di confronto per cercare di offrire risposte coerenti ed adeguate rispetto ad un panorama ordinamentale sempre più complesso e articolato.
In questa prospettiva alla specificità dell’ambito (civile, penale o amministrativo) nel quale viene in gioco il tema del fine vita si affiancano gli elementi di complementarietà, per buona parte rappresentati dai diritti fondamentali, nella loro multiforme dimensione, naturalmente destinati ad intersecare i vari settori scompaginando il tradizionale assetto degli studi e delle riflessioni.
Diritti che stanno lì ad indicare il dato aggregante dal quale il giurista di qualunque estrazione deve oggi muovere, con un incedere al contempo umile ma mai timoroso, proprio perché in gioco vi è la persona umana e la necessità che essa venga protetta nel modo che essa merita, anche quando mostra i segni più evidenti della sua vulnerabilità.
Da qui il filo rosso fra le interviste odierne e quelle appena concluse che hanno visto come protagonisti studiosi orientati a riflettere in varie forme sui diritti dell’uomo anche in chiave UE – e su come essi vanno declinandosi nelle aule giudiziarie.
Se, dunque, il giurista che specula sulla rilevanza penale di una condotta di sostegno al suicidio o di omicidio del consenziente prende in considerazione il momento necessariamente successivo all’evento morte del soggetto che aveva espresso il convincimento di porre fine alla propria esistenza dolorosa e si prende cura di valutare gli effetti della condotta che ha eventualmente agevolato l’evento stesso, il civilista scruta ciò che accade prima dell’evento morte, guarda agli effetti che derivano dall’inerzia o dalla condotta attiva di chi intende offrire un contributo al fine di realizzare la volontà suicidaria del malato irreversibile per comprendere se l’ordinamento debba occuparsi di tale condizione ed eventualmente in che modo. I due percorsi, dunque, sono solo in apparenza distinti e tra loro impermeabili venendo, invece, inevitabilmente a “scontrarsi” non solo per gli aspetti procedurali e gli interrogativi – che l’ordinanza n.207/2018 suscita, ma anche sui modi, sulle tecniche di protezione e sugli effetti che l’intervento giudiziale potrebbe produrre sulla vita umana.
Le interviste che seguono intendono scandagliare alcuni dei tanti problemi sorti all’indomani dell’ordinanza n.207/2018 vedono come protagonisti tre studiosi del diritto costituzionale – Antonio D’Aloia, Giacomo D’Amico e Giorgio Repetto –. Il che non sembra contraddire le premesse qui fissate a proposito della necessità di uno studio interdisciplinare del problema, anzi confermandole in relazione alla centralità dei diritti e valori fondamentali in gioco, attestando ancora una volta che i maggiori nodi problematici sul tappeto sono, almeno oggi, più che mai intrinsecamente collegati alla assai peculiare tipologia del provvedimento adottato dalla Corte costituzionale ed alle ricadute che esso è destinato a produrre sui diritti in gioco, nella loro intrinseca dimensione nazionale e sovranazionale.
Come di consueto, alla pubblicazione odierna della scelta del tema e della risposte, seguiranno domani 23 maggio le repliche e conclusioni con l’intervista integrale in pdf.
1) Dopo la sentenza n.207/2018 si attende l’eventuale intervento legislativo e, soprattutto, la decisione della Corte costituzionale sul c.d. caso Cappato. Quale pensa possa essere, nell’attesa, il ruolo del giudice comune, civile e penale, rispetto a casi simili a quelli che hanno coinvolto dj Fabo? Pensa che il rimedio cautelare possa essere sperimentato in ambito civile per offrire una tutela richiesta dal soggetto che versi in condizioni di salute irreversibili e, se si, in che misura?
Antonio D’Aloia
1. Può essere opportuno fare una breve premessa prima di affrontare i quesiti posti.
Non c’è dubbio che la decisione (ordinanza) n. 207/2018 sarà ricordata come una delle ‘svolte’ più significative della giurisprudenza costituzionale(Vedi in tal senso A. Ruggeri, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte Cost. ord. n. 207 del 2018), in Consulta online, 1/2019, 92.). E’ una decisione che ha ‘spiazzato’ il campo delle opinioni e del dibattito sul fine vita e più in generale sui temi bioetici, al tempo stesso inaugurando una modalità procedurale effettivamente inedita, che può rinvenire un precedente ‘parziale’ nella decisione della Corte Suprema del Canada sul caso Carter, sempre in tema di suicidio medicalmente assistito (Un ‘atto piuttosto singolare’ lo ha definito G. Razzano, La Corte Costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?, in DirittiFondamentali.it, 1/2019, 1).
| …l’ordinanza 207 ‘annuncia’ (per ora), e anzi prepara, un vero e proprio overruling del diritto vivente in tema di end-of-life decisions... |
Questo sembrerebbe confermare una difficoltà intrinseca delle Corti (anche Costituzionali o Supreme) ad intervenire su un terreno estremamente sensibile e controverso, e la ricerca di una collaborazione (sostanzialmente ‘imposta’) al Parlamento: nel caso canadese, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di suicidio medicalmente assistito; nel caso italiano allo scopo di prevenire un accertamento di incostituzionalità e di definire un intervento legislativo che riesca ad operare un bilanciamento ragionevole tra i diritti e gli interessi coinvolti in una questione che è tra le più complesse che possano porsi all’attenzione del diritto.
Sul piano dei contenuti, l’ordinanza 207 ‘annuncia’ (per ora), e anzi prepara, un vero e proprio overruling del diritto vivente in tema di end-of-life decisions. Finora, il punto di consolidamento della riflessione giuridica era rappresentato dalla sentenza ‘Englaro’, i cui contenuti sono stati in un certo senso ‘stabilizzati’ nella legge 219/2107.
| …In sintesi, viene riconosciuto in modo pieno un diritto di rifiutare le cure, anche ‘life sustaining’ |
In sintesi, viene riconosciuto in modo pieno un diritto di rifiutare le cure, anche ‘life sustaining’ (comprese le tecniche di nutrizione e idratazione artificiale). Questo diritto può essere esercitato sia prima che durante il percorso terapeutico, e la volontà di non curarsi può essere contenuta anche in una DAT con le formalità prevista dalla legge 219.
Rimaneva fuori da questo ‘contenitore’ la questione del suicidio medicalmente assistito e dell’eutanasia; e la sentenza Englaro lo faceva in modo netto, definendo un confine che sembrava spesso e solido: <>( Si legge ancora nella sentenza, che <<…. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio –nel quadro dell’alleanza terapeutica che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno- per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza […] >>.)
Anche nel parere del CNB sulla sedazione palliativa profonda continua (del 29 gennaio 2016), che può essere considerato un ulteriore punto di avanzamento del discorso sul rifiuto di cure e sull’accompagnamento nel morire, viene tracciata una linea distintiva che ribadisce la classica dicotomia tra ‘lasciar morire’ (nel senso di accompagnare, e anche accelerare, il processo naturale della morte) e ‘determinare’ la morte di un soggetto, con un intervento eutanasico diretto o aiutandolo materialmente a realizzare il proposito suicidiario.
Secondo il Comitato, «per l'obiettivo, le procedure e gli esiti, la sedazione è un atto terapeutico che ha come finalità per il paziente alla fine della vita quella di alleviare o eliminare lo stress e la sofferenza attraverso il controllo dei sintomi refrattari, mentre l'eutanasia, secondo la definizione oggi prevalentemente accolta, consiste nella somministrazione di farmaci che ha come scopo quello di provocare con il consenso del paziente la sua morte immediata [...] La sedazione profonda, quindi, non è indicata come un trattamento che abbrevi la vita, se applicata in modo appropriato, e non può essere ritenuta un atto finalizzato alla morte». Sul piano pratico poi, aggiunge il parere, non è affatto vero (questo almeno dicono i dati statistici) che i pazienti sedati in modo profondo e continuo abbiano una sopravvivenza minore rispetto a quelli non sedati.
Non ho difficoltà ad ammettere che questa era (e per certi versi è ancora) la mia posizione.
Pur nella consapevolezza che esistono situazioni in cui il confine prima ricordato scolora, diventa più difficilmente percepibile (e difendibile), nella mia visione delle questioni bioetiche (e biogiuridiche) di fine vita, la distinzione tra rifiutare le cure (anche fino alle estreme conseguenze, a lasciarsi morire) e chiedere di essere uccisi o aiutati a morire, conserva una sua rilevanza, almeno ‘ordinaria’. Scegliere di non lottare più, di abbandonarsi alla forza inguaribile di una malattia, interrompendo o rifiutando presidi terapeutici, non è la stessa cosa che chiedere la somministrazione (o la dazione) di un farmaco che sia in grado, direttamente e ‘da sé’, di provocare la morte.
Ci sono differenze oggettivamente plausibili tra le due ipotesi, che riguardano sia il dato oggettivo (vale a dire i ‘mezzi’ usati, la struttura ontologica del fatto, il rapporto tra malattia, intervento ‘esterno’, morte del malato) che il dato soggettivo (relativo all’atteggiamento psicologico dei soggetti agenti, e in particolare del medico, della specifica finalizzazione della condotta).
2. La decisione della Corte Costituzionale invece spariglia le carte; e con questo nuovo contesto dobbiamo fare i conti.
L’andamento del ragionamento della Corte è, invero, tutt’altro che lineare. Il confronto tra la prima parte, che culmina con l’espressione secondo cui “l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione”, e lo svolgimento successivo costruito attorno al caso concreto oggetto del giudizio di legittimità costituzionale(Si rinvia soprattutto al par. 8 dell’ordinanza.), sembra evidentemente testimoniare non solo la complessità dei temi affrontati, quanto la difficoltà della Corte di pervenire ad un esito largamente condiviso.
| …il tema del dolore del paziente subisce a sua volta un doppio slittamento: perché da un lato la lentezza o la rapidità del processo del morire diventano un elemento da considerare in rapporto alla visione della dignità del paziente; dall’altro, diventa rilevante anche il profilo della ‘maggiore’ sofferenza per chi sta accanto al malato nel vederlo subire un più lento processo di indebolimento progressivo delle funzioni organiche fino alla morte... |
Questo è uno di quei casi in cui vedrei con molto favore la previsione nel nostro ordinamento dell’istituto della dissenting opinion: non solo perché ne risulterebbe una maggiore chiarezza della motivazione della decisione alla fine adottata, ma soprattutto perché il confronto diretto tra opinioni diverse da parte dei giudici della Corte consentirebbe di mantenere aperto il dibattito nel mondo degli operatori giuridici e più in generale nell’opinione pubblica; e, nel caso specifico, di offrire al legislatore indicazioni più complete, ed utili alla definizione di una scelte che rispecchi il più possibile l’equilibrio prefigurato dalla decisione costituzionale.
Proviamo a fare un riepilogo, utile a dare una prima risposta ai quesiti posti, dei passaggi argomentativi della Corte.
La premessa si appunta su quello che possiamo considerare ‘consolidato’, vale a dire ‘diritto vivente’, nell’Italian way sulle decisioni di fine vita.
Per la Corte, la legge 219 –che “recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria – in particolare a seguito delle sentenze sui casi Welby (Tribunale ordinario di Roma, 17 ottobre 2007, n. 2049) ed Englaro (Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748) – nonché le indicazioni di questa Corte riguardo (sent. 438/2008 e sent. 253/2009) al valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico: principio qualificabile come «vero e proprio diritto della persona», che «trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione”- permette già, al malato, di prendere la decisione di lasciarsi morire, “con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua”.
Inoltre, sempre la legislazione vigente (in questo caso la legge 15 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”), riconosce la terapia del dolore come elemento fondamentale nel percorso di tutela della salute e della dignità della persona, al punto da inserire le cure palliative e la terapia del dolore tra i livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Questo può essere considerato lo snodo sul quale la Corte costruisce il suo ‘cambio di passo’ rispetto alla giurisprudenza precedente; tuttavia, il tema del dolore del paziente subisce a sua volta un doppio slittamento: perché da un lato la lentezza o la rapidità del processo del morire diventano un elemento da considerare in rapporto alla visione della dignità del paziente; dall’altro, diventa rilevante anche il profilo della ‘maggiore’ sofferenza per chi sta accanto al malato nel vederlo subire un più lento processo di indebolimento progressivo delle funzioni organiche fino alla morte.
Così parla la Corte: “La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte. In tal modo, si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. Secondo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, nel caso oggetto del giudizio a quo l’interessato richiese l’assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con contestuale sottoposizione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata prospettata), proprio perché quest’ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, totalmente dipendente dal respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo”.
Da questa premessa, che qualche perplessità solleva (almeno dal mio punto di vista) proprio per questa sovrapposizione di piani (la sofferenza del paziente e quella dei suoi cari; la liberazione dal dolore e la rapidità del processo del morire), la Corte deriva l’incostituzionalità del divieto assoluto di aiuto al suicidio, come elemento che “finisce … per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.: parametro, quest’ultimo, peraltro non evocato dal giudice a quo in rapporto alla questione principale, ma comunque sia rilevante quale fondamento della tutela della dignità umana)”.
| ...la Corte decide di oltrepassare il confine (a volte effettivamente assai labile, devo ammetterlo) rappresentato dalla differenza tra lasciare (o lasciarsi) morire e provocare (o darsi) la morte (ovvero ‘farsi aiutare a morire), “letting die or killing”... |
L’argomento dell’omogeneità delle situazioni serve a completare il quadro giustificativo dell’opinione della Corte. Una volta ammesso il diritto del malato di chiedere l’interruzione dei trattamenti sanitari ‘life sustaining’ (“anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore”), “non vi è ragione per la quale il medesimo valore (cioè la protezione della vita) debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale”.
In questo modo, consapevolmente, la Corte decide di oltrepassare il confine (a volte effettivamente assai labile, devo ammetterlo) rappresentato dalla differenza tra lasciare (o lasciarsi) morire e provocare (o darsi) la morte (ovvero ‘farsi aiutare a morire), “letting die or killing”: un confine che non ha a che fare solo con una visione ‘naturalistica’ o religiosamente orientata’ della vita e dei suoi ‘processi’, ma è anche un connotato essenziale di definizione dell’attività e del ruolo professionale del medico.
Non posso soffermarmi su questo tema, ma è tutt’altro che scontata l’accoglienza che questa decisione ha generato nell’ambito della professione medica. L’effetto di spiazzamento è stato forte e non è nascosto, ponendosi anche un problema di compatibilità (sicuramente improprio ora che l’aiuto al suicidio è assurto al livello di un diritto costituzionalmente protetto) con la normativa deontologica che continua a vietare al medico ogni adempimento che procuri la morte del paziente (art. 17 C.D.).
Il risultato del pronunciamento del Giudice delle leggi appare chiaro nella sua declinazione costituzionale. Esiste un diritto di essere aiutati a morire, in alcuni casi anche mediante un intervento diretto a provocare la morte; e non soltanto attraverso il riconoscimento del rifiuto o della rinuncia alle cure.
Sicuramente, siamo di fronte ad una ‘ricollocazione’ del ragionamento costituzionale, su un profilo che finora, anche la dottrina aperta a considerare in termini estensivi l’autodeterminazione del malato nelle vicende di fine vita, riteneva non coperto da una chiara indicazione costituzionale(Per C. Tripodina, Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”, in Biolaw Journal, 3/2018, § 4, la Costituzione “non dice” (in modo netto, aggiungo io) sul diritto di morire per mano di altri.)
La casistica viene definita in termini rigorosi, almeno apparentemente.
Secondo la Corte, “Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”.
Certo, patologia ‘irreversibile’ non significa necessariamente ‘terminale’ (e questo è un ulteriore scivolamento rispetto al dibattito classico – e ad alcuni precedenti legislativi (penso alle leggi di Stati americani come Oregon e Washington) – sulla legittimità del suicidio assistito o dell’eutanasia, che avvicina la soluzione ‘italiana’ ai modelli olandese e belga); e, d’altro canto, le ‘sofferenze psicologiche’ sono un contenitore difficile da circoscrivere, e da capire quando siano o diventino “assolutamente intollerabili”. La patologia rilevante poi, è solo fisica o anche psichica, o può avere caratteristiche combinate?
Alla fine, forse, l’elemento oggettivamente più idoneo a limitare l’ambito di esplicazione di questo ‘nuovo diritto’ resta il riferimento alla condizione della persona di essere tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale.
Di questi problemi applicativi la Corte è perfettamente consapevole. E infatti, la sua pronuncia prende la forma inedita del monito al legislatore ad intervenire con il rinvio dell’udienza di trattazione a data fissa.
La presa d’atto che il divieto di aiuto al suicidio in alcune condizioni particolari produce un vulnus costituzionale lascia il campo ad una serie di complessi e sensibili bilanciamenti e scelte applicative che solo il legislatore può, in prima battuta, adottare; a cominciare dalla decisione se modificare l’art. 580 c.p., intervenire in senso integrativo sull’impianto della legge 219/2017, ovvero approvare una disciplina specifica per questi casi ‘estremi’.
La semplice e diretta dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto generale di aiuto al suicidio “lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi”.
| ...Troppi nodi non hanno un’unica possibilità di soluzione… |
Troppi nodi non hanno un’unica possibilità di soluzione: le modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale (o al medico in senso stretto, come è in Belgio), la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura (che personalmente vedrei come necessaria(In tal senso v. ancora A. RUGGERI, Fraintendimenti concettuali, cit., 107.
). Ma soprattutto, la Corte non vuole che l’ammissibilità del suicidio assistito finisca col diventare uno strumento ‘ordinario’, che travolge i presidi di assistenza e di terapia del dolore che invece devono continuare ad essere la prima e principale risposta dell’ordinamento e dei suoi apparati al bisogno di dignità e di liberazione dal dolore delle persone malate. Per la Corte, “Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative dovrebbe costituire, infatti, un pre-requisito della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente”.
3. Questa premessa sui contenuti della ordinanza 207, e soprattutto la parte finale, mi consente ora di affrontare il tema posto dalla prima domanda.
Mi sembra difficile che qualche Giudice possa ritenere ancora applicabile, in situazioni analoghe a quelle descritte dalla Corte, l’art. 580 c.p., meno che mai nella sua versione più ‘dura’, tale cioè da comprendere ogni possibile forma di agevolazione o assistenza al suicidio.
| ...Mi sembra difficile che qualche Giudice possa ritenere ancora applicabile, in situazioni analoghe a quelle descritte dalla Corte, l’art. 580 c.p.,... |
Al di là della forma ‘al momento’ della pronuncia della Corte (una dottrina molto autorevole ha parlato di ‘ircocervo’, di ‘decisione ibrida’(A. Ruggeri, op. cit., 108.[7), non c’è dubbio che il Giudice costituzionale abbia identificato, come punto di confluenza di molteplici principi e implicazioni costituzionali, un diritto di essere aiutati a porre fine alla propria vita, quando sia l’unico modo per rispettare la propria dignità e la propria esigenza di essere liberati da sofferenze insopportabili collegate ad una malattia irreversibile, contrastata solo da strumenti di sostegno vitale.
Questo diritto rappresenta ormai, un ‘significato’ costituzionale, una ‘norma’ costituzionale. Nonostante il fatto che la disposizione limitativa o impeditiva di questo diritto sia formalmente ancora ‘in piedi’, l’accertamento di incostituzionalità in certe condizioni è stato chiaro ed è secondo me un esercizio meramente teorico immaginare un cambio (o un aggiustamento) di rotta da parte della Corte alla scadenza del termine concesso al legislatore, o addirittura più avanti se il giudizio dovesse essere ulteriormente rinviato.
La Corte dice qualcosa anche su questo aspetto legato, per così dire, al ‘seguito’ giurisprudenziale della decisione.
Nel par. 11 del Considerato in diritto, spiega innanzitutto che l’uso di questa discussa tecnica decisoria serve proprio ad “evitare che la norma possa trovare, in parte qua, applicazione medio tempore, lasciando però, pur sempre, al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse in linea di principio alla sua discrezionalità”.
Aggiunge poi, ed è la parte più interessante in rapporto alla questione in esame, che “Negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l’applicazione della disposizione stessa in parte qua”.
Dunque, non si prospettano automatismi: in linea teorica, non si può escludere che i giudici comuni decidano di non sollevare la questione di costituzionalità, agganciandosi al giudizio costituzionale già ‘aperto’ (e provvisoriamente definito con l’ord. 207/2018); e nemmeno che decidano di portare avanti percorsi interpretativi differenti, persino disarmonici rispetto alle motivazioni della Corte Costituzionale.
Ritengo tuttavia, anche per la forte complessità etico-sociale del tema, e la condivisibile necessità che ci sia un intervento del legislatore, che sia opportuno muoversi in una logica di leale collaborazione con il Massimo Organo di garanzia costituzionale.
In questo senso, la soluzione più ‘ordinaria’ (e qui anticipo una parte della risposta alla seconda domanda) sarebbe quella di sospendere il processo davanti a sé, e sollevare la questione di costituzionalità inserendosi nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale già in corso. In questo modo, il nuovo giudice potrebbe dare il suo contributo alla migliore definizione dei termini sostanziali del giudizio costituzionale, al tempo stesso consentendo alle parti private del ‘suo’ processo di intervenire in quest’ultimo, ampliando le relative possibilità di difesa.
In passato, qualche Giudice si è anche limitato a sospendere il processo pendente davanti a sé in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale. Tale soluzione però è oggi ritenuta impraticabile o comunque insufficiente dalla più autorevole dottrina e anche dalla Corte di Cassazione proprio perché non assicura quelle esigenze prima evidenziate.
Sulla possibilità invece di utilizzare rimedi cautelari (se ho capito bene, al fine di ammettere e di rendere praticabile legittimamente una richiesta di aiuto o assistenza al suicidio), ho qualche perplessità, alla luce delle cautele che la Corte mostra di avere nella sua decisione.
Innanzitutto, cerchiamo di definire bene questa ipotesi teorica. Si pensa evidentemente ad una persona malata, nelle condizioni di DJ Fabo o analoghe a quelle indicate dalla Corte come ‘legittimanti’ il suicidio assistito.
Le questioni che pone la Corte come bisognose di un intervento legislativo sono serie e non eludibili attraverso un provvedimento cautelare di qualche Giudice, che rischierebbe proprio di aprire il varco a quei possibili abusi che la Corte Costituzionale ha voluto evitare con la sua decisione ‘progressiva’.
Inoltre, una prospettiva quale quella adombrata come ipotesi teorica nel quesito solleva un paradosso che investe il nucleo teleologico stesso della tutela giurisdizionale cautelare. Che senso (logico prima ancora che giuridico) potrebbe avere, per impedire che un diritto subisca un danno grave ed irreparabile, eliminare ‘irreversibilmente’ il presupposto di ogni diritto o rivendicazione?
| ...Le questioni che pone la Corte come bisognose di un intervento legislativo sono serie e non eludibili attraverso un provvedimento cautelare di qualche Giudice… |
Posso immaginare l’obiezione: se il diritto di cui si discute è quello di morire dignitosamente (secondo la propria idea di dignità), è possibile che questo diritto diventi non più disponibile in attesa dell’intervento legislativo o del nuovo –‘più diretto’- intervento del Giudice costituzionale in caso di inerzia del legislatore.
Il tema è davvero spinoso e non è facile dare una risposta che vada bene per tutte le situazioni astrattamente ipotizzabili.
Resto convinto tuttavia che la sede cautelare, proprio per le sue caratteristiche (di rapidità e ‘sommarietà’ delle valutazioni) non sia adatta a trattare casi in cui la linea di discrimine tra ciò che è (già) ammissibile e ciò che (ancora) non lo è, è affidata ad elementi che richiedono bilanciamenti e configurazioni molto complessi, non a caso rimessi alla discrezionalità del legislatore, anche affinché –nel frattempo- maturi un dibattito pubblico e professionale che possa fornire possibili indirizzi nelle scelte che andranno fatte.
Giacomo D’Amico
Non vi è dubbio che il ruolo del giudice comune, in casi simili a quello di dj Fabo, risenta e sia condizionato dalla peculiarità della decisione adottata dalla Corte con l’ord. n. 207 del 2018. Di ciò, d’altra parte, è consapevole lo stesso Giudice delle leggi che, al riguardo, così scrive: «Negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l’applicazione della disposizione stessa in parte qua» (ord. 207 del 2018, punto 11 Cons. dir.).
La frase sopra riportata contiene una apparente e inevitabile contraddizione: per un verso, la Corte riconosce – e non avrebbe potuto fare diversamente – ai giudici il compito di valutare la sussistenza della rilevanza e della non manifesta infondatezza di eventuali questioni di legittimità costituzionale, ma per altro verso precisa che ciò dovrà avvenire «alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia».
La contraddizione è apparente perché la stessa Corte sa che non spetta a lei limitare il potere del giudice comune di valutazione delle condizioni per la rimessione di eventuali questioni di legittimità costituzionale; questa contraddizione è, al tempo stesso, inevitabile perché la Corte non può non ricordare al giudice comune che comunque l’ord. n. 207 reca una sorta di «incostituzionalità prospettata» (secondo l’espressione utilizzata dal Presidente Lattanzi nell’annuale relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2018, svolta il 21 marzo 2019).
Da quanto fin qui detto è evidente che la stessa Corte “caldeggi” e “auspichi” la rimessione della questione in casi analoghi a quello di dj Fabo. Non sembri azzardato dire che, con la decisione in esame, la Corte ha “messo in mora” il legislatore e “diffidato” il giudice comune dall’applicare l’art. 580 c.p. in casi simili.
È chiaro che siffatto argomentare offre il fianco a obiezioni e critiche anche condivisibili, che, però, a mio avviso sottovalutano i possibili effetti di una diversa decisione del Giudice delle leggi. Tra le soluzioni astrattamente ipotizzabili, alternative a quella assunta, vale la pena di prenderne in esame due:
1) inammissibilità con monito al legislatore: questa è la soluzione che la stessa Corte dichiara di aver assunto «in situazioni analoghe a quella in esame»; in questo caso, al legislatore è “recapitato” un invito – il più delle volte inascoltato – a disciplinare una certa materia, mentre il giudice comune può continuare a fare applicazione della norma censurata. Nel caso in esame questa soluzione avrebbe portato alla condanna di Marco Cappato e, probabilmente, della compagna e della madre di dj Fabo, in virtù di un’applicazione teoricamente coerente ma (almeno a mio avviso) ingiustamente rigorosa dell’art. 580 c.p. (mi verrebbe da dire: summum ius summa iniuria).
2) rinvio della causa a data da fissare con decreto del Presidente della Corte: questa seconda soluzione non è, per lo più, considerata dalla dottrina che ha commentato l’ord. 207 del 2018 ma si deve ritenere che sia stata adottata in altri casi in cui la Corte ha affrontato questioni che ponevano delicati problemi di equilibrio con la discrezionalità del legislatore (si pensi ad es. ai provvedimenti presidenziali di anticipazione e poi di rinvio dell’udienza di discussione della legge elettorale nota come Italicum). In questo caso la Corte avrebbe raggiunto il medesimo obiettivo perseguito con la decisione poi assunta, ma in modo meno trasparente e diretto. In altre parole, il mero rinvio della causa ad altra udienza sicuramente sarebbe stato letto dai commentatori più avveduti come un segno di deferenza nei confronti del legislatore ma probabilmente avrebbe avuto una scarsa eco.
Se si confronta la decisione assunta con l’ord. 207 del 2018 con queste possibili soluzioni, a mio avviso si ridimensiona la portata di talune critiche e forse ci si rende conto che la strada intrapresa dalla Corte si segnala, quanto meno, per la trasparenza del percorso e delle argomentazioni svolte.
Tornando al ruolo del giudice comune in casi simili a quello di dj Fabo, francamente mi viene difficile immaginare una soluzione diversa dalla rimessione della questione di legittimità costituzionale. In questa prospettiva anche il ricorso al rimedio cautelare in ambito civile non mi parrebbe praticabile, posto che la stessa Corte ha ritenuto inevitabile e necessario l’intervento del legislatore.
| …così facendo il giudice comune finirebbe con il “costruire” da sé un percorso che consenta al malato di porre fine alle sue sofferenze… |
In altre parole, così facendo il giudice comune finirebbe con il “costruire” da sé un percorso che consenta al malato di porre fine alle sue sofferenze, a fronte di una precisa presa di posizione della Corte che ha invece inteso salvaguardare le prerogative del legislatore.
Peraltro, vale la pena di sottolineare che nell’ord. 207 del 2018 non si riconosce affatto il “diritto a morire”; si sottolinea, piuttosto l’irragionevolezza («…non vi è ragione…») di una normativa in base alla quale il valore della vita si traduca «in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale» (punto 9 Cons. dir.).
Giorgio Repetto
Per rispondere a questa e alle successive domande, penso sia necessario premettere alcune considerazioni generali sul valore e sul significato della ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, anche al fine di offrire un quadro ricostruttivo plausibile del suo “impatto” nell’ordinamento, in vista delle novità dei prossimi mesi (legislative e/o giurisprudenziali che siano).
La formula decisionale prescelta dalla Corte è quella di un’inedita ordinanza che accerta un vulnus derivante dall’irragionevolezza del trattamento subito da chi (come Fabiano Antoniani) non poteva sottoporsi al protocollo disposto dalla l. n. 219/2017 (sedazione profonda e interruzione dei trattamenti vitali) senza andare incontro a sofferenze ritenute inaccettabili, e non aveva a disposizione una via alternativa per accelerare il decorso della propria malattia. Impossibilità aggravata dal fatto che, a presidiare il proprio mantenimento in vita, il malato terminale vedeva eretta una “cintura protettiva” (così la chiama la Corte) rappresentata dalle disposizioni del codice penale che puniscono l’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), nonché, indirettamente, l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.). La Corte ritiene una simile situazione in contrasto con l’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza) e con l’art. 32 Cost., ma non la colpisce con una dichiarazione di incostituzionalità, perché una pronuncia meramente ablatoria non terrebbe conto dell’esigenza, costituzionalmente imprescindibile, di dettare una disciplina che regoli presupposti e modalità di accesso ai trattamenti comunque idonei a realizzare l’intento suicidiario. Tali presupposti e modalità, pur in un passaggio adombrati dalla Corte (v. p. 10 Cons. in dir.), non sono ritenuti costituzionalmente obbligati, al punto da indurre la Corte stessa a dettarne allo stato l’introduzione per il tramite di una sentenza additiva (“secca” o “di principio”). È in questo quadro, quindi, che si spiega la scelta della Corte di rinviare la trattazione del giudizio al 24 settembre 2019, così da consentire al Parlamento di dettare una disciplina che si faccia carico di sanare il vulnus riscontrato e di introdurre un’apposita disciplina. Aggiungo subito, anche alla luce delle posizioni dottrinali emerse in alcuni commenti, che ove ciò non dovesse avvenire (come, al momento, tutto lascia pensare) difficilmente la Corte potrebbe sottrarsi all’onere di essere conseguente rispetto al proprio pronunciamento. Il che potrebbe tradursi, nelle modalità che essa riterrà opportune, nella caducazione in parte qua del precetto penale (affiancata da una ricostruzione del dettato operativo della disciplina) o comunque nel sancire sua inoperatività rispetto alle fattispecie come quella da cui ha avuto origine il giudizio a quo.
| ...La mia impressione è che la Corte costituzionale non abbia fatto propria l’idea che, da oggi in poi, nel nostro ordinamento esista un “diritto al suicidio assistito”… |
Accanto all’esito processuale (provvisorio) della vicenda, merita di premettere anche due parole per inquadrare sommariamente i termini del diritto sostanziale fatto valere. La mia impressione è che la Corte costituzionale non abbia fatto propria l’idea che, da oggi in poi, nel nostro ordinamento esista un “diritto al suicidio assistito”, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 3 e 32 Cost. Innanzi tutto perché – ma è un argomento non dirimente, lo ammetto – l’intervento legislativo auspicato dalla Corte consiste con tutta verosimiglianza nell’individuazione di un protocollo idoneo più che altro a operare quale “scriminante procedurale” rispetto ai soggetti (familiari, medici, personale sanitario) che concorrono a realizzare l’intento del malato terminale. Al diritto alla salute, quindi, si attribuisce la capacità di proteggere anche la rivendicazione del malato terminale a porre fine alle proprie sofferenze quando ricorrano i presupposti indicati dalla Corte, senza però con questo erigere una simile rivendicazione (pur costituzionalmente meritevole di protezione) in un diritto vero e proprio al suicidio assistito, ma unicamente elidendo l’antigiuridicità delle condotte poste in essere da soggetti terzi. Si tratta, a mio avviso, di un obbligo di protezione scaturente dal combinato disposto dei parametri costituzionali evocati, che non necessariamente si traduce nella configurazione di un “nuovo” diritto a morire rapidamente o nelle modalità ritenute conformi alle proprie aspettative.
Si dirà poi – e questo mi sembra il punto decisivo – che dall’art. 32 Cost. non si può far derivare la legittimità di un comportamento che, diversamente dalle ipotesi di cui alla l. n. 219 del 2017, non si traduce in un rifiuto delle cure, ma nel comportamento attivo volto a procurare la morte.
Non sono però convinto fino in fondo della bontà di un simile argomento.
Se pure è vero, infatti, che in linea di massima la differenza tra comportamento omissivo (letting die) e attivo (nelle forme dell’eutanasia indiretta o, tanto meno, diretta) nel conseguimento dell’evento morte deve essere tenuta ferma, resta il fatto che essa non perimetra due condotte sempre nettamente separabili. Ci possono ben essere dei casi, infatti, in cui interrompere i trattamenti vitali non vuol dire “lasciare che la malattia faccia il suo corso”, perché – come ha notato per tempo Antonio D’Aloia (voce Eutanasia (dir. cost.), in Digesto disc. pubbl., Agg. V, Torino 2012, 323) – il sopraggiungere della morte può avvenire nelle fattispecie “omissive” con una “rapidità che si avvicina molto alla immediatezza causale dell’atto eutanasico in senso stretto”. Nulla esclude, pertanto, che una severa delimitazione delle ipotesi di suicidio assistito ponga tale pratica in una situazione di prossima contiguità con il rifiuto di trattamenti vitali, con la conseguenza che esasperare oltre misura la differenza tra le due ipotesi potrebbe risultare scarsamente convincente.
Che così, nel caso di specie, stiano le cose, lo si desume del resto dall’art. 2, co. 2, della l. n. 219 del 2017, che individua quale presupposto per il rifiuto dei trattamenti di life sustaining una “prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte”. Ritenere, di conseguenza, che l’art. 32 Cost. impedisca sempre e comunque forme di intervento attivo in casi del genere mi sembra un esito non giustificato, purché però (ma la Corte questo lo ha precisato) si parli di ipotesi che si pongano in immediata prossimità con quelle contenute nella l. n. 219 cit. E proprio in questo senso mi pare che debba essere colto l’auspicio, formulato nell’ord. n. 207, di una disciplina della materia che si realizzi in quella medesima sedes, così da valorizzare la prossimità delle due fattispecie, come se dal seno dell’una (il rifiuto di trattamenti vitali) si possa generare, in virtù di una lettura costituzionalmente guidata, l’introduzione dell’altra (il suicidio assistito con i caratteri tratteggiati nell’ordinanza).
| ...stabilire quale possa essere nel frattempo il ruolo del giudice comune chiamato a occuparsi, dalle varie angolazioni immaginabili, di casi simili non è facile… |
Alla luce di questo quadro, stabilire quale possa essere nel frattempo il ruolo del giudice comune chiamato a occuparsi, dalle varie angolazioni immaginabili, di casi simili non è facile. Nel disporre il rinvio della trattazione e in attesa della sentenza, la Corte ha infatti disposto il perdurare della sospensione del giudizio a quo (come era doveroso) ma ha anche chiarito che “negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l’applicazione della disposizione stessa in parte qua” (p. 11 Cons. in dir.).
Nel prossimo punto mi soffermerò sulla questione se da ciò si possa fa discendere per gli altri giudici un obbligo di sospensione e/o anche di sollevazione della questione di legittimità costituzionale.
Si può però intanto rilevare che il significato dell’inciso appena riportato, saggiamente vergato in termini che escludono qualsiasi automatismo, è quello di chiarire a tutti i giudici che dovessero trovarsi ad applicare la normativa de qua che, in ipotesi analoghe a quelle che hanno riguardato Fabiano Antoniani e Marco Cappato, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. non è manifestamente infondata. E non lo è in virtù di un accertamento operato dall’organo istituzionalmente deputato a controllare la costituzionalità delle leggi: quindi deve ritenersi un’indicazione assistita dalla massima autorevolezza.
Da essa non si può tuttavia ricavare per certo un generale obbligo giuridico alla non applicazione medio tempore della disposizione in questione.
Lo spazio di applicazione della norma di cui all’art. 580 c.p. non viene infatti in considerazione alla luce del suo solo tenore testuale, come se dalla ordinanza della Corte si possa ricavare una preclusione all’applicazione della disposizione censurata in quanto tale. Essa non può, infatti, che venire in discussione alla luce della situazione normativa concreta con cui il giudice ha a che fare, e che potrebbe ben non coincidere (per i contorni del caso e le circostanze applicative) con quello preso in esame dall’ordinanza n. 207 cit. Situazione che si identifica nel fatto che il soggetto agevolato sia una persona “ (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”
Cosa dire, ad esempio, rispetto a casi di malati terminali che, pur trovandosi nelle stesse (disperate) condizioni fisiche di Fabiano Antoniani, non siano poi in condizione di manifestare chiaramente la loro volontà, potendo quest’ultima venire ricostruita a posteriori sulla base di elementi più o meno convergenti? Si può escludere la punibilità del comportamento di chi aiuta nel suicidio una persona incapace di prendere decisioni libere e consapevoli?
Quello che voglio dire, in altre parole, è che se l’accertamento della non manifesta infondatezza è operato dalla Corte e da esso difficilmente il giudice può prescindere (ad esempio ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata da chi versi nelle medesime condizioni di Antoniani), resta a questi comunque da valutare se la questione meriti di essere sollevata alla luce delle concrete coordinate fattuali su cui si trova a pronunciarsi (non potendosi così a priori escludere, al variare delle circostanze, un esito diverso dalla sospensione del giudizio e dalla sollevazione della questione, ad esempio per difetto di rilevanza).
Problema ulteriore è poi quello relativo alla possibilità per il giudice di provvedere in sede cautelare per farsi carico delle indifferibili esigenze di tutela dei malati terminali.
Non penso possa darsi a questa domanda una risposta univoca, dovendosi anche qui fare i conti con la pluralità delle diverse situazioni ipotizzabili oltre che, ovviamente, con l’estrema delicatezza e complessità dei bilanciamenti richiesti.
| …Tanto più, quindi, le circostanze fattuali oggetto del giudizio cautelare sono affini a quelle oggetto del giudizio della Corte, tanto più si deve ritenere che sul giudice gravi un onere (non un obbligo coercibile, ma pur sempre un onere) di sospensione del giudizio e di sollevazione della questione di legittimità costituzionale…. |
Una prima ipotesi potrebbe essere quella di un malato terminale che si trova in condizioni in tutto e per tutto affini a quelle in cui si trovava Fabiano Antoniani e che chiede di essere ammesso alla somministrazione dei farmaci letali. In una situazione del genere, ritengo che lo spazio a disposizione del giudice per pronunciarsi favorevolmente in sede cautelare sia oggi molto ristretto, per non dire nullo. Benché, come anticipato prima e come cercherò di spiegare più avanti, dall’ord. n. 207 cit. non si possa ricavare un obbligo generale per il giudice alla sospensione del giudizio, mi pare altrettanto indubitabile che questi, in sede cautelare, non possa non tener conto del fatto che il complesso bilanciamento tra interessi confliggenti che la materia richiede non solo non ha un esito predeterminato, ma anche che esso è stato ora affidato, in prima battuta, al legislatore e, in prospettiva, alla stessa Corte costituzionale al momento della eventuale prosecuzione del giudizio. Benché la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. sia stata ritenuta non manifestamente infondata (se non, addirittura, manifestamente fondata), tale norma non è stata espunta dall’ordinamento e ciò pertanto non autorizza, come non autorizzava in passato, ad aggirarne i precetti: se così è stato, si deve anche al fatto che la Corte ha ritenuto come in questa materia ragioni di cautela e di meditata presa in carico degli interessi confliggenti prevalgano, in attesa della soluzione definitiva, sulle ragioni (pur meritevoli) di chi invoca l’accesso a una morte dignitosa.
Tanto più, quindi, le circostanze fattuali oggetto del giudizio cautelare sono affini a quelle oggetto del giudizio della Corte, tanto più si deve ritenere che sul giudice gravi un onere (non un obbligo coercibile, ma pur sempre un onere) di sospensione del giudizio e di sollevazione della questione di legittimità costituzionale. Sospensione del giudizio e sollevazione della questione che appaiono difficilmente compatibili, nel caso di specie, con la concessione della misura cautelare tesa a porre fine una volta per tutte alla situazione di sofferenza di un malato irreversibile.
Va anche detto che una conclusione del genere mi pare l’unica compatibile con gli orientamenti che guidano i rapporti tra incidente di costituzionalità e tutela cautelare. Dopo una lunga fase di incertezza, infatti, oggi le coordinate fondamentali di questo rapporto si sono assestate nel senso che al giudice in sede d’urgenza non è impedito di sollevare questione di legittimità costituzionale, purché ciò non determini un esaurimento del suo potere decisionale, ad esempio nell’ipotesi in cui la sospensione di un provvedimento non abbia carattere provvisorio o temporaneo ma determini effetti irreversibili o comunque produca una consumazione della potestas iudicandi del giudice (sentt. nn. 59/2014, 96/2015, 84 e 133/2016). L’adozione di misure cautelari in questa materia, quindi, in tanto potrebbe risultare ammissibile, in quanto non determini effetti comunque irreversibili, perché essi produrrebbero (tra le altre cose) un non giustificato aggiramento degli effetti dell’ordinanza. Una soluzione del genere, a mio avviso, si ricava anche da quanto la Corte costituzionale ha deciso nel “caso Stamina” (sent. n. 274/2014), quando ha ritenuto ammissibile la quaestio sollevata in sede d’urgenza, con contestuale ammissione del malato a partecipare alla sperimentazione di una nuova (discussa) terapia.
In tutti gli altri casi – quando cioè le condizioni di salute del malato presentino delle differenze con quelle oggetto del giudizio della Corte ovvero vengano chieste al giudice misure non irreversibili – non si può a priori escludere che il giudice medesimo (anche al di là della sospensione del giudizio e dell’eventuale rimessione della questione alla Corte) provveda con misure interinali: ma si tratta di ipotesi comunque da verificare in concreto e per le quali si potrebbe parlare comunque di casi di scuola o poco più.
| …all’imperativo costituzionale di tutela della vita… non si contrappone un vero e proprio diritto al suicidio assistito… |
Ad ogni modo, non mi nascondo l’estrema difficoltà e complessità delle valutazioni sottese a provvedimenti di tal fatta, attenendo essi a beni di primario rilievo costituzionale, il cui bilanciamento richiede grande misura e cautela, e con esse estremo rigore argomentativo. La Corte, a mio avviso, ha chiarissimamente (e condivisibilmente) offerto una ricostruzione dei valori in gioco per cui all’imperativo costituzionale di tutela della vita, anche di chi si trova in condizioni di fragilità e di vulnerabilità, non si contrappone un vero e proprio diritto al suicidio assistito (come qualcuno ha ritenuto) ma il diritto ad accedere, a determinate condizioni, a prestazioni che escludano il protrarsi di inutili sofferenze come aspetto intrinsecamente connesso alla tutela della salute.
2. La decisione resa dalla Corte costituzionale ha riaperto numerosi interrogativi sugli effetti della questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice comune, domandandosi se in casi simili una diversa autorità giudiziaria sia tenuta a sua volta a sollevare analoga questione, ovvero a sospendere il giudizio in attesa della definizione della questione pendente, ovvero ancora possa adottare una “terza via”- cioè percorrere una diversa soluzione- decidendo nel merito la vicenda processuale pendente. Qual è il suo avviso sul tema?
Antonio D’Aloia
1. In parte, ho già anticipato la risposta a questo secondo quesito.
Peraltro, il caso che abbiamo di fronte è insolito anche da questo punto di vista: la questione infatti non è semplicemente pendente, in attesa che la Corte la definisca in qualche modo.
La Corte Costituzionale si è espressa, con tutte le critiche che è possibile fare a questa inedita forma di decisione di ‘incostituzionalità accertata ma non (ancora) dichiarata’.
Per il Giudice costituzionale l’attuale assetto normativo provoca un vulnus nei confronti di interessi costituzionalmente protetti che sarebbero idonei a sostenere un diritto a morire per mano di altri (o a farsi aiutare a morire). Per questo, la questione è si pendente, ma al tempo stesso molto ‘orientata’ nell’esito.
In un contesto siffatto, come ho avuto modo di dire, lo schema preferibile appare essere la proposizione, anche da parte degli ‘altri’ giudici, dell’analoga questione. Certamente, mi sentirei di escludere l’alternativa prospettata nel quesito, vale a dire la sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione.
Nel ribadire le considerazioni già svolte sub 1), mi limito a riportare il ragionamento assolutamente condivisibile di Gustavo Zagrebelsky nel suo Manuale di Giustizia Costituzionale: “nulla sembra imporre la sospensione degli altri procedimenti pendenti, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, e nemmeno sembra che la pendenza del giudizio costituzionale ne costituisca una causa di sospensione facoltativa, a norma dell'art. 295 c.p.c., norma certamente derogata dalla disciplina speciale della pregiudizialità costituzionale. (...) A ragionar diversamente, si giungerebbe a conclusioni inaccettabili. L'obbligo di sospensione attribuirebbe a un qualunque giudice, magari con un'iniziativa pretestuosa, di interferire in generale sull'amministrazione della giustizia nonché sull'autonoma decisione di tutti gli altri giudici; la mera facoltà di sospensione (senza proposizione della questione) priverebbe le parti del giudizio comune del diritto di partecipare al giudizio costituzionale; né, d'altra parte la riproposizione di numerose questioni identiche potrebbe dirsi sempre inutile, contribuendo invece – quando esista un problema di determinazione della portata normativa della legge impugnata - a “fissare” la questione, e a concretizzare il “diritto vivente” al quale la Corte si attiene (Gustavo Zagrebelsky, “La giustizia Costituzionale”, Il Mulino, 1977, pag. 218).
2. Vengo alla seconda parte del quesito. Si può immaginare che il Giudice comune (diverso da quello che ha sollevato la questione al momento definita con l’ord. 207) scelga una “terza via” –tra proposizione della questione e sospensione del giudizio- definendo nel merito la vicenda processuale pendente analoga a quella su cui è sorto il giudizio costituzionale in corso?
Come ho detto prima, la Corte non sembra chiudere ogni spazio (e probabilmente nemmeno potrebbe farlo) alla libertà di convincimento del Giudice che, è bene ricordare, secondo la Costituzione “è soggetto soltanto alla legge” (art. 101/2).
Nella sostanza, l’ordinanza 207 potrebbe essere letta alla stregua di una decisione di accoglimento ‘in linea di principio’, e questo potrebbe aprire la possibilità al Giudice di dispiegare la sua attività ‘inventiva’ (nel senso in cui ne parla Paolo Grossi), adattando ed estraendo soluzioni applicative dal principio elaborato dalla Corte Costituzionale; e in fondo questo è il suo lavoro.
Venendo ad un piano più concreto, il Giudice potrebbe interpretare la norma in modo da evitarne l’applicazione a casi come quelli descritti dal Giudice costituzionale, ad esempio lavorando sul concetto di aiuto al suicidio e sull’assenza di interferenza o condizionamento del terzo rispetto alla volontà suicidiaria; oppure, potrebbe ritenere, in alcuni casi ‘limite’, che il principio sancito dal Giudice costituzionale sia già suscettibile di applicazione.
| …Quello che credo sarebbe difficile accettare, alla luce del chiaro (per quanto inedito nelle forme) ‘dictum’ del Giudice costituzionale, è ammettere che i Giudici comuni possano applicare la disposizione in esame così come è, nel significato che la Corte ha giudicato sostanzialmente incostituzionale…. |
Quello che credo sarebbe difficile accettare, alla luce del chiaro (per quanto inedito nelle forme) ‘dictum’ del Giudice costituzionale, è ammettere che i Giudici comuni possano applicare la disposizione in esame così come è, nel significato che la Corte ha giudicato sostanzialmente incostituzionale. O meglio, possono in teoria farlo(Come nota A. Ruggeri, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta online, 20 novembre 2018, 575, “il divieto di applicazione di una norma incostituzionale consegue unicamente alla dichiarazione della sussistenza del vizio con le forme per essa prescritte e non può perciò farsi discendere da una decisione che è, e resta, per forma ed effetti, di rinvio della decisione”.)[8] (e ci sono stati effettivamente casi in cui i giudici comuni hanno ‘reagito’ conflittualmente alle posizioni della Corte Costituzionale), tuttavia l’ordinamento avrebbe gli strumenti per superare il conflitto e riportare il confronto su un piano di collaborazione e di unità, eventualmente ‘forzata’ (si pensi alla possibilità stessa della Corte Costituzionale di sollevare davanti a sé stessa il conflitto di attribuzioni per menomazione delle sue competenze nel caso di decisioni della magistratura che palesemente contrastassero l’indirizzo della ord. 207).
Giacomo D’Amico
La risposta a questa domanda è stata già anticipata sopra. In sintesi può dirsi che, pur non venendo meno il potere di decisione del giudice, quest’ultimo non può sottovalutare il fatto che la norma di cui deve fare applicazione è – diciamo così – fortemente sospettata di essere incostituzionale. D’altra parte, la mancata adozione di una decisione di accoglimento da parte della Corte è determinata dalla volontà di quest’ultima di non sostituirsi al legislatore nell’assunzione di scelte “tragiche” e “divisive”. Certo, si potrebbe obiettare ed è stato obiettato, che la tragicità di queste scelte non viene meno dopo un anno (cioè in occasione dell’udienza del 24 settembre 2019, alla quale è stata rinviata la discussione sul caso dj Fabo) ma è altrettanto vero che la Corte, a fronte di una persistente inerzia del legislatore, non può tollerare la lesione di una libertà costituzionale, rinvenibile – si badi – non nella generica autodeterminazione della persona (formula, questa, spesso abusata) ma nella specifica «autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze» (ord. n. 207 del 2018, punto 9 Cons. dir.).
Giorgio Repetto
Ho indicato quelli che a me sembrano i termini fondamentali della questione nella risposta alla domanda precedente.
La domanda coglie però in generale un punto essenziale e ancora non del tutto risolto rispetto alla natura dell’incidentalità costituzionale e del collegamento tra giudizio a quo e giudizio costituzionale, vale a dire la posizione del giudice che si trovi a dover applicare una norma rispetto alla quale pende, al momento della decisione, un giudizio di costituzionalità. In particolare, il problema si è posto rispetto ai casi di c.d. “sospensione impropria”, quando cioè il giudice che si trovi ad applicare una norma sub iudice ritenga di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, senza provvedere egli stesso a sollevare la questione.
| ...il problema si è posto rispetto ai casi di c.d. “sospensione impropria”, quando cioè il giudice che si trovi ad applicare una norma sub iudice ritenga di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, senza provvedere egli stesso a sollevare la questione… |
Non si può non osservare, a riguardo, come dopo un lungo periodo in cui la prassi della sospensione impropria non è stata adeguatamente contrastata, prevale oggi in dottrina l’idea che si tratti di una pratica che tradisce lettera e spirito dell’incidentalità, per come essi si desumono dal combinato disposto dell’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948 e dall’art. 23 della l. n. 87 del 1953 (elementi in tal senso potrebbero ricavarsi anche dalle recenti sentt. n. 77 e 180/2018). Quest’ultimo articolo, in particolare, prevede al comma 2 un dovere per il giudice di simultanea sospensione del giudizio e di sollevazione della quaestio laddove sussistono i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza, il che dimostra innanzi tutto come tale previsione sia da intendersi come speciale rispetto alla generale ipotesi di sospensione di cui all’art. 295 c.p.c.
Ma il punto essenziale è un altro, e non è formale: limitarsi a sospendere il giudizio senza sollevare la questione alla Corte priva le parti del potere di costituirsi in giudizio dinnanzi a quest’ultima e di esercitare così il loro diritto costituzionalmente garantito di agire e resistere in giudizio (art. 24 Cost.).
Seppure quindi è doveroso ritenere che il giudice non possa, dopo aver valutato positivamente la sussistenza dei requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza della quaestio, limitarsi a sospendere il giudizio senza sollevare alla Corte costituzionale la relativa questione, è anche vero che tale obbligo, come accennavo prima, è relativo non tanto all’applicazione della disposizione come tale oggetto di esame alla Corte, ma alla situazione normativa che da tale disposizione discende, vale a dire dal contenuto di essa che il giudice ritiene di dover applicare al caso e che, quindi, rende il relativo dubbio di legittimità rilevante e non manifestamente infondato. Ripeto: non in generale, ma alla luce delle caratteristiche concrete del giudizio e del modo in cui, in esso, si saldano nel momento interpretativo contenuti normativi e circostanze di fatto.
Cercando di calare questo discorso (inevitabilmente sommario) sulla fattispecie oggetto del giudizio nel caso Cappato e alla luce della domanda che viene rivolta, tutto sta quindi a capire cosa debba intendersi per “casi simili”. Non avrei dubbi, infatti, a ritenere che il giudice chiamato ad applicare l’art. 580 c.p. in un caso in tutto e per tutto affine a quello che ha visto come protagonisti Marco Cappato e Fabiano Antoniani non possa far altro che sospendere il giudizio e sollevare esso stesso la questione, così da consentire al o ai soggetti imputati di addurre di fronte alla Corte costituzionale le proprie argomentazioni a supporto della incostituzionalità in parte qua del precetto penale. Così come, allo stesso modo, non esiterei a ritenere che allo stesso risultato si debba giungere se a venire in gioco non è solamente la responsabilità penale di chi abbia aiutato il malato ai sensi del predetto articolo del codice penale, ma anche del medico che ne abbia materialmente determinato indirettamente la morte, ove questi sia chiamato a rispondere del reato di omicidio del consenziente, previsto e punito dall’art. 579 c.p. Si tratta, infatti, di una fattispecie che di per sé non è stata evocata nell’ord. n. 207/2018 (perché non veniva in discussione), ma la cui sfera di operatività è evidentemente collegata a quella oggetto del giudizio, con la conseguenza che ove dovesse giungere a maturazione (per via legislativa o giurisprudenziale) l’adeguamento del sistema ai contenuti dell’ord. n. 207 cit., a vedere limitato l’ambito materiale penalmente rilevante non sarà solamente la condotta di aiuto nel senso auspicato dalla Corte, ma anche quella che attualmente integra la fattispecie di cui all’art. 579 cit. Fattispecie di cui, altrimenti, continuerebbe a rispondere il medico o il personale sanitario della struttura dove si è posta in essere l’attività che ha condotto al suicidio, vanificando così il modello della “scriminante procedurale” prefigurato dall’ordinanza resa nel caso Cappato.
Non allo stesso esito, quindi, sembra doversi giungere nel caso in cui le circostanze concrete divergano da quelle che hanno dato origine alla quaestio sfociata (per ora) nell’ordinanza 207 e che, di fatto, coincidono nella sostanza con i quattro presupposti che la Corte stessa ha individuato nella drammatica situazione di Antoniani, prima ricordati.
Il venire meno anche di uno solo di quei quattro presupposti varrebbe, nell’attesa di una risposta legislativa o giurisprudenziale più articolata, a rendere un giudizio penale relativo all’applicazione degli artt. 579 e 580 c.p. “non simile” a quello oggetto del giudizio, il che trasformerebbe la sospensione del giudizio e la rimessione della questione alla Corte da “doverosa” a meramente “eventuale” perché scaturente, con tutta evidenza, da un diverso (e nuovo) apprezzamento dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
In definitiva, ritengo che la scelta tra sospensione del giudizio, sollevazione della quaestio e prosecuzione del giudizio non possa che essere connessa alle caratteristiche strutturali della situazione normativa che il giudice si trova davanti, nel senso anzidetto. Pur ribadendo, quindi, che su di esso non può essere fatto gravare un obbligo alla sospensione per il solo fatto che questi si trovi a dover applicare la norma de qua, ritengo tuttavia: a) che non vi sia margine per una sospensione del giudizio senza contestuale sollevazione della questione alla Corte, se la fattispecie è da ritenersi simile a quella oggetto del giudizio della Corte; b) che, ove la fattispecie sia diversa, non può escludersi affatto l’applicazione dell’art. 580 c.p. (oltre che, a fortiori, dell’art. 579 c.p.), essendo le questioni di costituzionalità che in tale caso possono emergere strutturalmente diverse (seppur non estranee) a quanto la Corte ha stabilito nell’ord. n. 207/2018.
Si allude nella domanda, infine, a una “terza via” a disposizione del giudice, oltre alla sospensione e alla sollevazione dell’incidente di costituzionalità. La intendo come possibilità che il giudice risolva in sede interpretativa il problema, adeguando il contenuto della norma sanzionatoria penale (o delle altre che potenzialmente intervengono nella materia de qua) alla Costituzione, ovvero alla declinazione che dei principi costituzionali ha operato l’ordinanza n. 207 cit., al fine di recepire comunque i contenuti in essa adombrati al fine di realizzare una maggiore tutela del diritto alla salute del malato terminale.
Anche a questa domanda ritengo non si possa dare una risposta diversa da quella data alle domande precedenti: una risposta, conseguentemente, non univoca.
Aggiungo solamente che, anche non potendolo a priori del tutto escludere, anche lo spazio per soluzioni di adeguamento interpretativo – tanto più se riferite alla normativa penalistica – mi sembra estremamente ristretto.
Lo è sicuramente per l’ipotesi interpretativa che era stata ventilata all’indomani della rimessione della questione da parte della Corte d’assise di Milano, vale a dire la possibilità di riferire la fattispecie di aiuto al suicidio unicamente a quelle condotte e attività immediatamente antecedenti all’evento morte intese come “fase finale a se stante” rispetto alle attività o condotte invece meramente preparatorie, quali quelle poste in essere dagli imputati in altri giudizi (in tal senso GUP del Tribunale di Vicenza del 14.10.2015 e Corte di appello di Venezia, sent. n. 9 del 10.5.2017). Rispetto a ciò, si può aggiungere come la Corte costituzionale abbia condivisibilmente ritenuto che avvalorare un esito del genere (peraltro contraddetto in passato da Cass., sez. I pen., sent. n. 3147 del 6.2.1998) l’avrebbe spinta sul terreno di un’interpretazione conforme destinata a generare reazioni non del tutto prevedibili da parte dei giudici, per di più in una materia in cui sono evidenti le ragioni che impongono di addivenire a soluzioni quanto più possibile coerenti col principio di legalità e di prevedibilità delle fattispecie penali. Si tratta quindi di un ammonimento, quello contenuto nel p. 2 delle Cons. in dir., che sebbene utilizzato per escludere l’inammissibilità della questione in replica a una censura dell’avvocatura erariale, ha un chiaro significato volto a escludere la percorribilità di un esito interpretativo di tal genere.
Ritengo, pertanto, che dopo l’ord. n. 207 cit., battere la via di un’interpretazione conforme dell’art. 580 c.p. intesa a distinguere la rilevanza causale delle condotte di aiuto rispetto all’evento morte, al fine di sostenerne la non punibilità, mi sembra una soluzione che – ammesso che fosse percorribile prima – è sicuramente preclusa oggi dopo l’ordinanza in questione.
Può esserci spazio per ulteriori soluzioni interpretative? Difficile dirlo in astratto.
Non vedo, innanzi tutto, come soluzioni del genere possano maturare sul terreno dell’art. 579 c.p. (omicidio del consenziente), visto lo spettro più ridotto di condotte materiali idonee a integrare la fattispecie di reato rispetto all’ipotesi di aiuto (o di agevolazione).
E anche ove si volesse fare leva, in tale ultima ipotesi, sulla non perfetta sovrapponibilità delle condizioni fisiche del malato rispetto a quelle menzionate dalla Corte in riferimento al caso di specie per addivenire ad esiti ritenuti “costituzionalmente conformi” – facendo così valere la diversità tra le due situazioni e, di conseguenza, l’inoperatività del protocollo prefigurato nell’ordinanza Cappato (sospensione-rimessione della questione) – mi sembra anche qui che si tratti di un esito vieppiù da scongiurare. Si tratterebbe, infatti, di argomento formalistico che condurrebbe, per quanto è più significativo, a conseguenze difficilmente prevedibili sulla base di un potere che non vedo come possa attribuirsi al giudice, in una fase del genere.
Al fondo, la mia impressione è che con la soluzione adottata dalla Corte (che la si condivida o meno e al di là degli esiti cui essa giungerà) si sia realizzato anche un equilibrio istituzionale nella fase transitoria, che riflette quel bilanciamento cui alludevo in chiusura della risposta alla precedente domanda. Un equilibrio secondo il quale: a) il Parlamento è chiamato a decidere adottando le scelte necessarie per disciplinare un tema del genere alla luce delle coordinate costituzionali di fondo “somministrate” dalla Corte costituzionale; b) la Corte costituzionale si riserva il potere di dire l’ultima parola, ove il Parlamento non dovesse intervenire o dovesse farlo in un modo che lede l’equilibrio tra i principi costituzionali richiamati; c) i giudici comuni sono chiamati a collaborare con la soluzione elaborata dalla Corte costituzionale, veicolando ad essa le questioni di costituzionalità che sorgono in casi simili oppure dando applicazione ai precetti penali nei casi diversi da quello oggetto dell’esame della Corte.
3. La Corte costituzionale ha richiamato, nella ordinanza n. 207/2018, numerose volte il concetto di dignità, secondo taluni propendendo per una nozione soggettiva che l’identificherebbe con il diritto all’autodeterminazione dalla quale deriverebbe il riconoscimento della legittimità di pratiche volte a determinare la prematura chiusura della propria esistenza. Pensa che tale ricostruzione della dignità sia condivisibile e, più in generale, ritiene che il ricorso al canone della dignità umana possa rappresentare un elemento utile per la decisione dei casi che si porranno all’attenzione del giudice comune e, se sì, in che misura?
Antonio D’Aloia
| ...L’argomento della dignità è sicuramente ‘decisivo’ nell’opinione della Corte Costituzionale. |
1. L’argomento della dignità è sicuramente ‘decisivo’ nell’opinione della Corte Costituzionale. E’ sufficiente riprendere alcuni dei passaggi più significativi della motivazione dell’ordinanza 207 per rendersene conto. Il Giudice costituzionale parla di “ipotesi nelle quali l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost.”; e ancora, “In simili casi (la Corte fa riferimento alla situazione di Fabiano Antoniani), la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò, segnatamente in forza della recente legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento): legge che si autodichiara finalizzata alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 1, comma 1)”. Infine, la legislazione vigente viene censurata proprio laddove “non consente, invece, al medico che ne sia richiesto di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte. In tal modo, si costringe il paziente a subire un processo più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care”; alla luce di questa premessa, la conclusione –riportata anche prima- è che “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive”.
2. Ora, mi sembra evidente che la dignità cui allude la Corte sia ricostruita in una forte connessione con la situazione individuale e soggettiva di Dj Fabo. E’ la ‘sua’ dignità che viene in gioco, come ‘raccontata’ nella vicenda processuale da cui ha preso le mosse il giudizio costituzionale.
Per certi versi, si tratta di una prospettiva inevitabile.
Sarebbe impossibile, e anche inutile, espungere da concetti come ‘dignità’, o ‘vita’, o ‘salute’, i significati autenticamente personali, quello che rappresenta il modo ‘soggettivo’ in cui ciascuno di noi guarda a (e vive) queste nozioni nella sua esperienza (singola e relazionale).
La verità è che l’appello a questi concetti non risolve il conflitto etico; lo sposta su un piano dove, dietro le formule normative, che hanno un’evidente impronta valutativa, premono orientamenti ‘pregiuridici’ (morali, filosofici, religiosi) ed esperienze (i fatti che cambiano il nostro modo di percepire le situazioni, di rapportarci ad esse), ed è fatale che questi due fattori rendano i principi (e le clausole indeterminate nelle quali essi sono ‘raffigurati’) suscettibili di prestarsi a schemi di ragionamento e a linee di interpretazione /attuazione distanti e, a volte, persino inconciliabili(Come afferma G.U. RESCIGNO, Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico, in Dir. Pubbl., n. 1/2005, “i giuristi, che lo sappiano o no poco importa, non possono non affrontare discorsi filosofici, e trarne modi conseguenti di pensare ed agire”.)[9].
Una frase di G. Zagrebelsky rende perfettamente questa condizione: “il diritto è pur sempre diritto positivo […] una cosa è la statuizione diretta, altra quella indiretta che opera rinvii a qualcosa che sta al di fuori delle sue determinazioni specifiche positive, […]. Guardiamo le argomentazioni dei nostri tribunali Costituzionali: quando essi trattano grandi questioni (ad esempio quelle relative agli status personali, ai problemi della nascita, della vita e della morte), esse assomigliano più a trattazioni in “diritto naturale” che a dimostrazioni in “diritto positivo”. Il richiamo a un principio scritto nella costituzione è spesso solo il modo per aprire una discussione che si sposta altrove […]”. Anche M. Sandel, nel suo “Giustizia. Il nostro bene comune” (Milano, 2013, 282 ss.), dice una cosa analoga quando sostiene che “molte delle principali controversie bioetiche, come quelle sull’aborto e sulle cellule staminali, non possono essere risolte senza prendere posizione sulla controversia etica e religiosa ad esse sottesa. […]l’apparente neutralità delle posizioni liberali in realtà non è veramente neutrale. [...] La tesi che mira ad autorizzare l’aborto è altrettanto poco neutrale quanto lo è la tesi che intende vietarlo: entrambe le posizioni presuppongono che sia stata risolta in qualche modo la controversia etica e religiosa sottostante”.
3. In questo senso, la parola ‘dignità’, proprio per la sua incontenibile polisemia, potrebbe valere a poco per affrontare questi dilemmi; come scrive Cass Sunstein, “provide too little help”(Come afferma G.U. RESCIGNO, Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico, in Dir. Pubbl., n. 1/2005, “i giuristi, che lo sappiano o no poco importa, non possono non affrontare discorsi filosofici, e trarne modi conseguenti di pensare ed agire”.( Cass. R. SUNSTEIN, The Right to Die, in Yale Law Journal, 1997, (106), 1136.)
Non è un caso che spesso serva a sostenere anche posizioni diametralmente opposte, proprio nel dibattito sulle decisioni di fine vita(Vedi N. RAO, Three concepts of dignity in Constitutional Law, in Notre Dame L. Rev., n. 86/2011, 232, che nota appunto come “intrinsic human dignity has been sometimes associated with the autonomy to make one’s own end-of-life decisions, including access to assisted suicide. Similarly, human dignity has been associated with the sanctity of life and not affirmatively acting to end life, no matter how delibitated”.), sebbene, negli ultimi anni, la cultura giuridica ‘pratica’ (il diritto ‘in action’, ma anche quello legislativo) tenda in modo sempre più consistente ad avvicinare il concetto di dignità alla possibilità di scegliere cosa fare nelle fasi finali della propria vita (pensiamo alla legge dell’Oregon, intitolata Death with Dignity Act, del 1994; alla sentenza Carter della Corte Suprema del Canada sull’incostituzionalità del divieto di suicidio medicalmente assistito; e, ora, alla ord. 207/2018).
Insomma, la dignità contiene certamente una dimensione oggettiva, ‘comune’, che può avere riflessi condivisi e prescrittivi anche sul terreno dei dilemmi bioetici e biogiuridici. A questa dimensione si richiamano (in base all’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani, a cui possiamo aggiungere il divieto di discriminare una persona (sul piano lavorativo, assicurativo, dei contratti bancari) sulla base della sua condizione genetica.
Ma non è solo questo. Dentro la categoria della dignità c’è anche l’autodeterminazione, l’autonomia morale di un soggetto, i suoi convincimenti più intimi e profondi, la sua ‘unicità’ di percezione esistenziale(Vedi Rex D. Glensy, The Right to Dignity, 66, secondo cui “the basis of dignity can be said to lie in the autonomy of self and a self-worth that is reflected in every human being’s right to individual self-determination”). Come sottolinea una sensibile dottrina(S. PRISCO, La dignità del malato tra pluralismo delle morali ed etica di Stato, in A. D’ALOIA (ed.), Il diritto alla fine della vita, cit., 22 dell’estratto. Cfr. anche S. STAIANO, Legiferare per dilemmi sulla fine della vita: funzione del diritto e moralità del legislatore, in A. D’ALOIA (ed.), Il diritto alla fine della vita, cit., 7 dell’estratto, per il quale “La dignità, …, è percezione personale del proprio benessere, del rispetto di sé, della permanenza di senso nella propria vita, nell’ambito dei rapporti interpersonali in cui il singolo è coinvolto. La dignità è dunque concepibile solo come connessa al perdurare della propria persona nella sua unicità e irripetibilità …: solo la singola persona potrà valutare se questo orizzonte di senso –per essa e solo per essa- resti aperto in ipotesi di perdita di consapevole capacità di relazione con il mondo o di prosecuzione artificiale delle funzioni vitali”.), “…-nel prisma della dignità- confluiscono sentimenti di se stessi non oggettivabili nella medesima e cioè per tutti unica misura, […], in ragione della pesatura dei propri affetti e impegni umani che si ritenga di valutare liberamente, gli unici verso cui si è in effetti davvero responsabili e i soli che possono correlativamente giocare un ruolo dialettico nell’opzione tra la cura (medica) e il prendersi cura (umano), nell’accompagnare cioè gli ultimi momenti della vita di una persona in condizione terminale e/o meramente vegetativa”.
La ricerca di significati della dignità, in un ambiente costituzionale dominato dall’opzione metodologica della ragionevolezza e dal pluralismo etico come condizione di pensabilità stessa del fenomeno costituzionale(Cfr. G. ZAGREBELSKY, Fragilità e forza dello Stato costituzionale, Napoli, 2006, 28, secondo cui “il punto di aggancio più fecondo della teoria dello Stato costituzionale, la sua condizione storico-materiale fondamentale, è oggi la democrazia pluralista”; e ancora “Pluralismo e Costituzione si implicano tra di loro […] Pluralismo e principialismo sono i due lati (quello sociale e quello giuridico) della stessa medaglia. Tutto ciò è denso di significati, al di là della Costituzione, per la concezione del diritto, in generale”.), non può prescindere, da un lato, dall’adattamento del principio alle diverse situazioni concrete, e dall’altro, dalla rilevanza nella sua ricostruzione dell’autonomia personale di ciascun soggetto(Sul rapporto tra dignità e autonomia personale, vedi F. SACCO, Note sulla dignità umana nel “diritto costituzionale europeo”, in S. PANUNZIO (ed.), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005, 587), di quelle concezioni di sé stessi che Dworkin ha identificato nel concetto di ‘interessi critici’, che rappresentano “quanto di speciale c’è” in ogni uomo, e che non può non riguardare soprattutto le scelte sui momenti finali, giacchè, se è vero “che viviamo l’intera vita all’ombra della morte. E’ anche vero che moriamo all’ombra della nostra intera vita”( R. DWORKIN, Life’s dominion, trad. It. Il dominio della vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale, Milano, 1994, 274, 291 ss., 294. Per G. ZAGREBELSKY, Intorno alla legge, Bologna, 2009, 108-109, “Tutti sottoscrivono il principio di difesa della dignità umana. Ma la dignità umana postula, permette, oppure vieta che i malati terminali decidano in libertà se richiedere l’eutanasia? …”).
In altre parole, la dignità non può significare per tutti e in tutte le circostanze la stessa cosa; altrimenti finirebbe col contraddire il suo fondamento più autentico nella capacità del soggetto di sviluppare e determinare sé stesso liberamente(Cfr. R. ALEXY, A Theory of Constitutional Rights, Oxford, 2004, 234, secondo cui la dignità si basa sulla comprensione dell’essere umano come una creatura intellettuale e morale capace di determinare e sviluppare se stesso liberamente. Analogamente, v. C.R. CASABONA, The end of life: final remarks, in A. D’ALOIA (ed.), Il diritto alla fine della vita, cit., 3 dell’estratto.).
Dire cosa corrisponde o meno alla dignità umana diventa così un’operazione inevitabilmente priva di ancoraggi univoci, o almeno non riducibile ad una pretesa dimensione ‘oggettiva’ o ‘innata’(In tema di fine vita, non credo che possa valere come riferimento il caso celebre (nella giurisprudenza francese) del ‘lancio del nano’, su cui v. M. RUOTOLO, Appunti sulla dignità umana, in AA.VV., Scritti in onore di F. Modugno, vol. IV, Napoli, 2011, 3144 ss., che appunto parla di una dignità ‘innata’ come fondamentale presupposto dell’autodeterminazione. In quel caso, l’uso ‘autonomo’ e ‘volontario’ della propria condizione era in funzione di una sorta di ‘divertimento discriminatorio’ (perché basato sulla diversità fisica) da parte del pubblico. La scelta di non curarsi, o di lasciarsi morire, da parte di un paziente in stato terminale, appare una situazione assolutamente lontana e differente, anche solo per il fatto che non è l’affermazione di un’autodeterminazione contro la dignità, ma di una volontà che è al tempo stesso espressione di dignità.). Dentro la categoria della dignità operano fattori di configurazione che appartengono alle dinamiche sociali e culturali, e alle convinzioni più intime e profonde di ciascuno, alla sua sfera di autonomia.
Posso allora condividere, da un lato, la tesi, espressa con grande coerenza e profondità di argomenti(Da ultimo da A. Ruggeri, Fraintendimenti concettuali, cit., 99-100.), che la dignità non sia solo un valore solo individuale, che al suo interno ci sia un nucleo oggettivo che ha a che fare con l’esistenza stessa della persona (e che comincia a manifestarsi “ancora prima che l’individuo venga alla luce... e perdura persino dopo la morte”); non credo tuttavia che questa convinzione possa arrivare fino al punto da fondare una sorta di indisponibilità della vita (e delle scelte di fine vita), o di dovere di vivere, in quei contesti in cui la prosecuzione della vita si trasforma in una condizione ‘artificiale’ o gravata da sofferenze estreme e senza speranze (o addirittura ‘terminale’).
4. Per chiudere allora questi brevi note, penso che la dignità possa avere un ruolo nelle scelte di fine vita, certamente nel senso di consentire –alla stregua di un vero e proprio diritto- che un soggetto (direttamente e ‘contestualmente’, o attraverso una DAT, o una modalità di decisione ‘sostitutiva’ che sia davvero idonea a legare la scelta alla volontà del malato interessato) rifiuti o chieda di interrompere trattamenti terapeutici, anche life-sustaining; anche cioè quando questo comporta una accelerazione, anche immediata, della progressione mortale della condizione patologica.
| …Nel caso qui in esame, siamo andati oltre questa linea. Non è più semplicemente …lasciare che una malattia “take its course”, ma chiedere di essere aiutati a morire, a darsi la morte… |
Nel caso qui in esame, siamo andati oltre questa linea. Non è più semplicemente (ma in realtà non è mai ‘semplice’) lasciare che una malattia “take its course”, ma chiedere di essere aiutati a morire, a darsi la morte; ovvero chiedere un intervento che determini ‘direttamente’ la morte.
E’ vero che non è sempre facile tracciare un confine tra queste situazioni. Ci sono molte ‘zone grigie’ dove questa distinzione si assottiglia. La differenza però c’è, tuttavia non credo che possa riflettersi o risolversi sul tema della dignità.
A mio parere, l’equilibrio raggiunto con la sentenza Englaro, la l. 219/17, l’ammissibilità della sedazione palliativa profonda continua, il riconoscimento (almeno teorico) della rilevanza fondamentale delle cure palliative e della terapia del dolore, costituiva, nel complesso, una risposta ragionevole – e coerente con i principi costituzionali – alla esigenza di un maggiore controllo individuale sulle fasi finali della propria vita nelle situazioni patologiche estreme.
Ammettere che si possa chiedere (e ottenere) di essere aiutati a morire, o di essere uccisi, è uno slittamento rispetto a questo stadio del dibattito etico-giuridico, non altrettanto solido sul piano degli agganci costituzionali (almeno in rapporto all’art. 32), che al tempo stesso irrompe in modo tutt’altro che pacifico e incontroverso sul terreno dell’autonomia (e dell’identità) professionale e deontologica del medico.
La dignità a sua volta è tante cose insieme, una condizione di equilibrio anch’essa tra elementi oggettivi ed esperienze personali. Il modo di vivere la fine della propria vita è certamente un pezzo fondamentale della propria autentica e irriducibile visione della dignità.
Questo non significa che tutto possa giustificarsi in nome della dignità individuale, pur astrattamente riconoscibile come parametro della questione. La scelta delle modalità di tutelare la dignità umana si incrocia con altri elementi e valori, e deve trovare con essi un bilanciamento ragionevole. E’ così, del resto, per ogni principio-valore costituzionale.
Ho qualche perplessità che questa ricerca di un ragionevole equilibrio tra i “fondamentali beni costituzionali” (secondo la formula usata da Corte Cost., ord. 334/1988) coinvolti sia stata mantenuta nell’ordinanza 207/2018.
Credo che la questione sia ancora aperta, e molto dipenderà da ciò che il legislatore riuscirà a fare in questi mesi. In un modo o nell’altro, la re-azione del legislatore, soprattutto se si concretizzerà in un intervento normativo di modifica del quadro attualmente valutato dalla Corte Costituzionale, potrebbe consentire al Giudice costituzionale (a seguito dell’udienza del 24 settembre 2019) di ‘affinare’ e precisare i termini della sua interpretazione costituzionale.
Giacomo D’Amico
Innanzitutto, mi pare preliminare una precisazione. Nella domanda si afferma che «secondo taluni» la Corte propenderebbe «per una nozione soggettiva» di dignità. Anch’io sono di questa opinione e anzi ritengo che non ci siano particolari dubbi sul fatto che la Corte abbia sposato questa accezione del concetto di dignità. Ciò si desume – a mio avviso chiaramente – da vari passaggi della motivazione («proprio concetto di dignità»: punto 8 Cons. dir.; «propria idea di morte dignitosa» e «alternativa reputata [dal soggetto] maggiormente dignitosa»: punto 9 Cons. dir.).
| …il concetto di dignità non possa che essere inteso in un’accezione soggettiva… |
A dirla tutta, sono convinto che il concetto di dignità non possa che essere inteso in un’accezione soggettiva, altrimenti bisognerebbe rimettere ad altri la definizione di cos’è dignitoso e soprattutto occorrerebbe stabilire chi e come possa definire dignitosa la vita di un singolo individuo. Mutuando le parole di Papa Francesco formulate a proposito di altri temi: chi sono io per poter stabilire cos’è dignitoso per un altro?
Da questo punto di vista faccio mia la riflessione del prof. Vincenzo Scalisi, il quale nella sua ultima fatica, così scriveva: «La costruzione della propria individuale personalità non può che fondarsi su una scelta di libertà e dunque il principio di dignità, in piena consonanza e sintonia anche con il principio costituzionale pluralista, non può che passare attraverso il più ampio riconoscimento dell’autodeterminazione del singolo, non coercibile da ingerenze, impedimenti o imposizioni provenienti dall’esterno (pubblici poteri o altre entità legittimate a intervenire)» (V. Scalisi, L’ermeneutica della dignità, Giuffrè, Milano, 2018, p. 33). Al contempo, non vi è dubbio che la libertà, «anche nella costruzione della nostra individuale personalità, non può essere assoluta e incondizionata» (op. cit., p. 38).
Per questa via Scalisi giunge ad affermare che «il principio di dignità nel mentre esalta l’autodeterminazione individuale al tempo stesso la limita, allorché la stessa dovesse ledere o mettere in pericolo interessi di terzi o della collettività […] o interessi, che, benché attinenti alla sfera personale, costituiscono però prerogative della intera umanità».
A mio avviso sta in queste poche parole il significato più profondo del principio di dignità, che – ribadisco – non può che essere declinato in un’accezione soggettiva, sia pure con i limiti sopra evidenziati. D’altra parte, non è casuale che la Corte costituzionale pochi mesi dopo l’ord. n. 207 del 2018 sul caso dj Fabo abbia deciso in modo solo apparentemente opposto (rispetto al pieno riconoscimento dell’autodeterminazione individuale) la questione relativa al favoreggiamento della prostituzione, ritenendo evidentemente che in quest’ultimo caso prevalesse un interesse diverso da quello della singola prostituta.
In conclusione, mi sia consentito di aggiungere che leggere in un’accezione oggettiva il concetto di dignità e quindi eterodeterminare cos’è dignitoso e cosa non lo è rischia di legittimare derive paternalistiche dell’ordinamento, in cui l’autorità politica, scientifica o religiosa di turno si sostituisce al singolo nell’adozione delle scelte che competono solo a quest’ultimo. Con un gioco di parole, mi verrebbe da dire che francamente proprio questo atteggiamento non è dignitoso.
Giorgio Repetto
| … Non penso tuttavia che ciò sia sufficiente a dire che la Corte costituzionale abbia fatto propria una nozione soggettivistica della dignità in termini di autodeterminazione… |
È verissimo che il richiamo alla dignità è molto presente nella parte motiva dell’ordinanza e che questa dignità è il più delle volte impiegata per qualificare in termini soggettivi la pretesa fatta valere dal soggetto malato (“propria visione della dignità nel morire”, “propria idea di morte dignitosa”). Non penso tuttavia che ciò sia sufficiente a dire che la Corte costituzionale abbia fatto propria una nozione soggettivistica della dignità in termini di autodeterminazione, né a maggior ragione che in quest’ultima debba essere ravvisata la ratio essendi della preannunciata incostituzionalità.
Innanzi tutto perché la Corte costituzionale ha chiarito al di là di ogni ragionevole dubbio che una nozione forte di autodeterminazione, come era quella fatta propria dalla Corte rimettente nel momento in cui mirava a veder dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 580 c.p. per la parte relativa al reato di aiuto al suicidio, non ha ingresso nel nostro ordinamento, perché ad essa si contrappone (e su di essa prevale) la tutela del diritto alla vita, che mantiene un’inalterabile componente (anche) oggettiva, ad esempio nel momento in cui la Corte costituzionale ribadisce l’obbligo di protezione a favore dei soggetti deboli, vulnerabili o malati rispetto a scelte irreversibili riguardo alla propria vita.
Se la Corte costituzionale ha quindi richiamato il canone della dignità umana, ciò è avvenuto (al di là dei richiami agli argomenti di parte) in una prospettiva volta a saldarne l’impiego e le applicazioni con altri principi fondamentali, primo fra tutti il principio di uguaglianza e quel peculiarissimo modo d’essere di questo che è, nel nostro ordinamento, il principio di ragionevolezza.
Quello che viene censurato dalla Corte è il fatto che il divieto di aiuto al suicidio non tolleri alcuna eccezione e che pertanto, in virtù di questa sua assolutezza, esso condizioni la libertà personale nel senso di imporre al malato terminale “un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile” (p. 9 Cons. in dir., in fine). La posizione di chi, come Fabiano Antoniani, invocava la possibilità di mettere fine ai propri giorni senza esporsi a una condizione di sofferenza estrema come quella che gli sarebbe derivata dal “semplice” rifiuto delle cure, quindi, non è ricostruita dalla Corte nei termini di una pretesa assoluta, di una “signoria della volontà” in ipotesi identificantesi con un’idea della dignità umana tutta e solamente tarata sulla pretesa individuale. Se così fosse stato, si sarebbe potuto allora parlare di una “tirannia” della dignità, coincidente in tutto e per tutto con una visione individualistica, se non soggettivistica, di essa.
Ma così, lo ripeto, non è stato. La dignità viene in gioco, a leggere la sentenza, in termini di ripercussione nella sfera individuale di una lesione determinata in primo luogo da un’irragionevole scelta legislativa, quella cioè operata dal legislatore nel 2017 allorché, nel legiferare in tema di consenso informato, direttive anticipate di trattamento e terapia del dolore, ha previsto la possibilità di addivenire all’evento morte come rimedio a una situazione di malattia irreversibile unicamente per il tramite di uno strumento (il rifiuto delle cure variamente disciplinato negli artt. 2 e ss. della l. n. 219/2017), senza in alcun modo farsi carico della diversa condizione di chi di quello strumento non può avvalersi pur trovandosi in condizioni del tutto simili, e si trova al contrario preclusa ogni via alternativa, per di più vedendo tale assenza di alternative presidiata dalla presenza di numerose disposizioni sanzionatorie penali.
All’equivalenza funzionale tra interruzione dei trattamenti vitali e condotte che coadiuvano la scelta suicidaria in casi determinati non corrispondono, in altre parole, strumenti e discipline di analogo tenore, in grado comunque di condurre all’evento morte nel rispetto dei principi di dignità e di autodeterminazione e su una base di uguaglianza rispetto a situazioni di partenza accomunate da una medesima condizione di vulnerabilità.
Il centro (se così posso dire) dell’incostituzionalità è quindi rappresentato dall’irragionevolezza della disciplina introdotta nel 2017, che oggi la Corte costituzionale indirettamente utilizza al fine di far valere l’incostituzionalità in parte qua della disposizione di cui all’art. 580 c.p. È legittimo pensare, quindi, che ove tale novum legislativo non fosse intervenuto, la Corte si sarebbe trovata priva di un tertium comparationis su cui innestare l’incostituzionalità e al quale “agganciare” la disciplina del suicidio assistito nei termini della “scriminante procedurale” di cui parlavo prima.
Ove, al contrario, la Corte costituzionale avesse inteso fare propria una dignità declinata in termini soggettivi e intesa in senso forte, non avrebbe avuto motivo di arrivare a un esito del genere: sarebbe forse bastato accogliere la quaestio sollevata dalla Corte milanese, tutt’al più delimitando gli effetti dell’incostituzionalità al fine di correggere alcuni eccessi della questione prospettata nell’ordinanza di rimessione. Qui, invece, la dignità mostra una maggiore ed evidente natura relazionale, perché essa è sì riferita alla compressione dello spazio di libertà e di autodeterminazione del soggetto malato terminale, ma tale compressione non rileva come tale, ma alla luce della diversità di trattamento che essa subisce rispetto a situazioni analoghe.
Se questa lettura è plausibile e non mi inganno, devo confessare che la trovo convincente.
Trovo convincente, in particolare, il rifiuto della Corte costituzionale a scendere sul terreno della proclamazione di una dignità umana intesa in senso forte e assorbente, verso la quale ho una qualche esitazione, sia che essa venga intesa in senso soggettivo, sia (e forse ancora di più) allorché essa venga impiegata per veicolare valori/principi in senso obiettivo sottratti al bilanciamento con altri beni di rilievo costituzionale.
Innanzi tutto perché, come si sa bene, nel nostro sistema costituzionale il richiamo alla dignità non è mai operato in termini analoghi a quanto avviene nell’ordinamento tedesco all’art. 1 della Legge fondamentale, vale a dire in un senso tendenzialmente irrelato da altri principi costituzionali. La “nostra” dignità viene in gioco come “pari dignità sociale” nell’art. 3 cpv. Cost. o come limite all’iniziativa economica privata nell’art. 41 Cost. In entrambi i casi (e negli altri che si potrebbero fare, ad es. l’art. 36 Cost.), la dignità esprime il valore originario e non comprimibile che la Costituzione assegna alla persona umana nel quadro delle molteplici relazioni che essa instaura nel contesto di concrete relazioni di vita. “Pari dignità sociale”, in particolare, vuol dire reciproco riconoscimento (“pari”) di quel patrimonio di caratteristiche e qualità individuali (“dignità”) che le persone operano nel mutare delle relazioni e dei contesti di vita (“sociale”). Tutto questo non designa, quindi, un’entità posta al di là della storia e del concreto svolgimento degli assetti sociali, ma obbliga questi ultimi a svolgersi nel rispetto della dignità, intesa di volta in volta secondo direttrici di sviluppo diverse: c’è sicuramente una dignità-autodeterminazione (ricavabile dall’art. 2 Cost.), ma c’è anche una dignità-eguaglianza (ricavabile dall’art. 3 Cost.), come anche una dignità che si esplica nell’assunzione di ciascuno e del corpo sociale nel suo insieme di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale” di cui parla ancora l’art. 2 cpv. Cost. Tutto questo, in definitiva, sta a testimoniare (benché riconosco che il punto meriterebbe ben altri approfondimenti) che nel nostro quadro costituzionale non esistano principi di per sé sottratti al bilanciamento, perché tutti i principi/valori in esso proclamati (inclusa la dignità nel senso anzidetto) si completano reciprocamente e determinano di volta in volta diversi equilibri espressivi a loro volta di mutevoli bilanciamenti tra essi.
Se dal piano dell’interpretazione costituzionale e della ricostruzione del significato della ordinanza della Corte costituzionale nel caso Cappato ci spostiamo sul terreno dell’interpretazione giudiziaria, le cose non cambiano poi di molto.
Una delle più grandi trasformazioni che hanno investito l’ordinamento costituzionale nelle ultime decadi consiste proprio nel consolidamento di un indirizzo volto a fare della Costituzione, delle sue regole e dei suoi principi, una fonte in grado di incidere direttamente, per il tramite dell’interpretazione giudiziaria, nella vita delle persone e negli equilibri sociali. Se oggi possiamo parlare di “Stato costituzionale” lo dobbiamo anche al fatto che la Costituzione, come norma giuridica, può essere oggetto di diretta applicazione da parte del giudice, nelle diverse forme e con le molteplici tecniche in cui questa può essere realizzata (v. sul punto le significative riflessioni di un grande storico delle costituzioni come M. Fioravanti, La costituzione democratica. Modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo, Milano 2018, 426 ss.). Il pensiero, su questo, non può che andare alla sentenza resa dalla Prima sezione civile della Corte di cassazione nel caso Englaro e alla scomposta reazione della classe politica di allora, che si rivolse contro quel pronunciamento alla Corte costituzionale, che chiarì (ove mai ce ne fosse stato ancora bisogno) che l’applicazione della Costituzione non comporta alcuna menomazione delle prerogative del Parlamento quando manchi una legge regolatrice del caso, e tanto meno una violazione della soggezione del giudice alla legge (ord. n. 334 del 2008).
In questo senso, il ricorso al canone della dignità da parte del giudice subisce senz’altro gli inevitabili condizionamenti che ad esso derivano per il fatto di doversi pronunciare in ambienti normativi sempre più complessi e stratificati, ma in linea di massima non è qualitativamente diverso da quello che, nel suo ambito, impegna la Corte costituzionale. In fondo, si tratta sempre di salvaguardare l’immagine dell’uomo fatta proprio nel nostro testo costituzionale, tenendo ferma sì l’anteriorità assiologica della persona, ma senza che ciò avvenga in opposizione alle legature che avvincono la persona nelle dinamiche sociali e ne fanno la componente di una comunità politica votata al mutuo riconoscimento di valore.