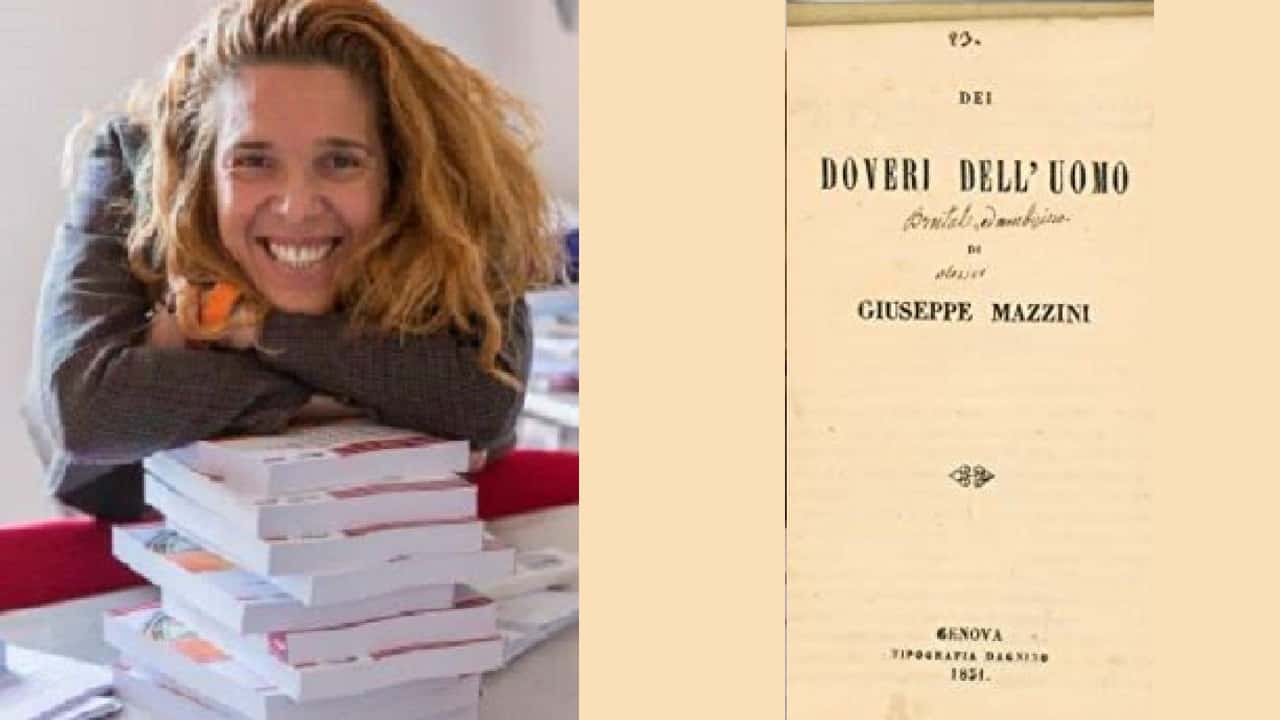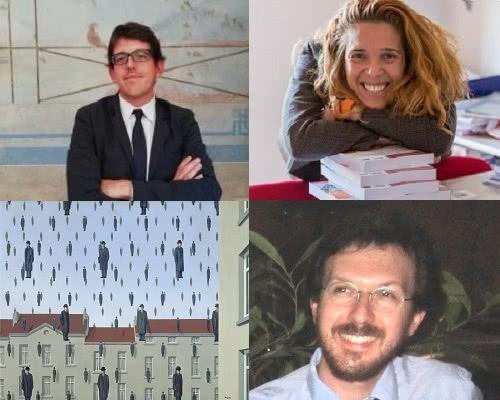
La Carta UE in condominio fra Corte costituzionale e giudici comuni. Conflitto armato, coabitazione forzosa o armonico menage?
a cura di Roberto Giovanni Conti
Interviste a:
Lara Trucco, ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università di Genova,
Giuseppe Martinico, associato di diritto pubblico comparato presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa
Vincenzo Sciarabba, associato di diritto costituzionale
3) La Corte costituzionale, alla luce delle ultime pronunzie resa in tema di rapporti fra la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Corte cost.n.269/2017, n.20/2019 e 63/2019), si identifica con la magistratura alla quale è dedicato il Titolo IV della Costituzione e se sì in che misura quando procede all’interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea? Può l’anima politica dell’organo di giustizia costituzionale rappresentare un elemento decisivo per determinare un approccio diverso alla Carta UE rispetto a quello del giudice comune soggetto soltanto alla legge secondo l’art.101 Cost.?
Lara Trucco
3. Venendo all’ultimo quesito, va preliminarmente osservato che le tre pronunce ivi menzionate (Corte cost. sent. n. 269 del 2017, sent. n. 20 del 2019 e sent. n. 63/2019) sono state rese dalla Corte nell’ambito di giudizi instaurati in via indiretta, per cui è tenendo a riferimento la “via incidentale” che ci si propone di abbozzare la risposta.
Specie in questa prospettiva, in disparte la diversa collocazione sistematica delle disposizioni costituzionali che le riguardano (Titolo VI e Titolo IV della Costituzione), non pare possibile addivenire ad un appiattimento della Corte sul giudice comune nell’attività di interpretazione della Carta UE.
Peraltro, parte della risposta la si è già data, sottolineandosi il ruolo decisivo di “regista” riservato a se medesima dalla Corte, all’atto di far valere in sede interpretativa ed applicativa il parametro costituzionale nei rapporti interordinamentali, guardando sia, come si è detto, al sistema delle fonti interno, sia, secondo quanto si dirà ora, al versante esterno al nostro ordinamento. Rilevandovi, anche qui, il ruolo diverso e nel contempo complementare di giudici comuni e giudice delle leggi: gangli del sistema giudiziario europeo, i primi, e (anche) anticorpo dell’ordinamento costituzionale interno, la seconda.
Del resto, è nota la giurisprudenza attraverso cui il nostro giudice costituzionale ha sbarrato l’ingresso ad una norma (nella fattispecie di matrice consuetudinaria) escludendo che potesse dispiegare effetti in ambito interno, ravvisandone il contrasto con “principi fondamentali e diritti inviolabili” della Costituzione (sent. n. 238 del 2014). Così come sono conosciute le pronunce relative ai rapporti con la Convenzione EDU, ora da estendersi anche alla Carta sociale europea (sent. n. 120 del 2018), con l’affermazione della necessità “assoluta e inderogabile” di procedere alla “verifica della conformità” a Costituzione delle norme convenzionali (sentt. n. 348 del 2007, n. 311 del 2009, n. 93 del 2010, n. 196 del 2010, n. 80 del 2011, n. 113 del 2011, n. 236 del 2011, n. 135 del 2014, n. 49 del 2015); e della possibilità di svolgere, altresì, una “verifica di omogeneità”, al fine di appurare “se le stesse norme CEDU, nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana (sentt. n. 349 del 2007 e n. 317 del 2009). Là dove dal canto suo il caso Taricco ha reso tangibile, da ultimo, a quali estreme conseguenze potrebbe portare la giurisprudenza inaugurata con le decisioni relative ai casi Frontini e Granital.
Il dato che emerge da un tale quadro è, con riguardo ai giudici comuni, la progressiva dilatazione “della legge” a cui solo, i medesimi, “sono soggetti” (art. 101, 2° c. Cost.), a fronte invece della “soggezione” del giudice costituzionale alla “sola” Costituzione (se del caso, variamente interpretata alla luce del diritto sovranazionale), nell’assolvimento del ruolo, costituzionalmente affidatogli, di custode della Carta costituzionale stessa.
In questo senso, al quesito è possibile dare una risposta positiva nella misura in cui nell’“anima politica” a cui ci si riferisce, si scorgano gli esiti del cd. “costituzionalismo”, secondo una declinazione (qui) sul piano giudiziale del senso più profondo del tema del “potere” e dei suoi “limiti”.
Il fatto, poi, che, nella più recente giurisprudenza costituzionale si sia voluto addirittura scorgere una sorta di “sovranismo di ritorno” ci induce a rilevare come (al di là dei riferimenti costituzionali che si sono in precedenza richiamati) sul versante eurounitario siano le stesse norme dei trattati a sancire la perdurante centralità degli Stati e dei relativi sistemi di giustizia costituzionale: l’“Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali” (art. 4, c. 2°, TUE).
Su questa base, al di là dei “moniti” della giurisprudenza eurounitaria (v., ad es., A c. B e Melki e Abdeli), si può (ed anzi si deve) continuare a ritenere che, almeno fino a quando non si deciderà di rimettere mano alle fonti originarie UE – pur nel più generale quadro dei “contrappesi” europei ed internazionali – nella dimensione nazionale sia doveroso per i giudici – anche costituzionali – tutelare il nucleo identitario fondamentale ordinamentale contenuto nelle “proprie” Costituzioni.
Affinché, poi, la “difesa identitaria” non trasmodi in una chiusura autoreferenziale, pare necessario che in futuro – e con questo torniamo alla nostra giurisprudenza costituzionale – la “prima” ed “ultima” parola che la Corte si è riservata sia mantenuta in un’accezione al possibile restrittiva: con una sostanziale identificazione dei richiami svolti al “rango costituzionale della questione e dei diritti in gioco” (sentt. n. 20 del 2019 e n. 63 del 2019) ed alla “vocazione costituzionale” dell’oggetto del sindacato (sent. n. 194 del 2018) con i “principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale” ed “i diritti inalienabili della persona umana” già enucleati nella propria più antica giurisprudenza (v., supra, nonché già la sent. n. 1146 del 1988).
Si osserva, peraltro, come una tale prospettiva sia quella che meglio consente di apprezzare l’apertura – mai così ampia come oggi – del nostro “ordinamento costituzionale” agli influssi normativi sovranazionali ed internazionali; mentre analogamente non potrebbe dirsi laddove, invece, si optasse per un’interpretazione estensiva degli incisi testé richiamati, ampliando i “controlimiti” attivabili dalla Corte a, tendenzialmente, l’intero contenuto della Carta costituzionale. Un tale approccio, infatti, non solo si scontrerebbe frontalmente con i principi “cardine” (degli effetti diretti e della primazia delle norme eurounitarie) sanciti dalla Corte di giustizia (sin già nelle storiche pronunce Van Gend & Loos e Costa c. ENEL), ma finirebbe verosimilmente per compromettere la stessa natura sovranazionale dell’Unione, riducendo oltremodo il potere di disapplicazione diretta da parte dei giudici del diritto UE.
Vincenzo Sciarabba
In linea di principio e da un punto di vista dogmatico, si potrebbe rispondere che il dubbio sulla possibilità di identificare la Corte costituzionale con la magistratura alla quale è dedicato il Titolo IV della Costituzione potrebbe avere una sua ragion d’essere solo nell’ipotesi astratta in cui la Corte costituzionale non fosse già separatamente inquadrata e disciplinata dal Costituente all’interno di un diverso Titolo della seconda parte della Costituzione (dedicato alle “Garanzie costituzionali”), a indicazione della peculiarità, e per così dire dell’autonomia concettuale, dell’organo (del resto evidente tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto il profilo funzionale).
E nessuna incidenza, in questa prospettiva, sembrano poter avere le ricordate pronunce dello stesso giudice delle leggi, come tali non idonee a modificare l’inquadramento costituzionale e la natura istituzionale della Corte.
D’altro canto, è evidente come tali pronunce abbiano determinato un significativo cambiamento di ruolo della Consulta, che avrebbe potuto cogliersi in modo ancor più lampante in relazione ad un’altra ben nota questione classificatoria… se questa non fosse stata già risolta dalla Corte stessa pochi anni addietro, prima ed indipendentemente dalla svolta del 2017 circa il ruolo della Carta dei diritti fondamentali: si allude alla questione della riconducibilità o meno del nostro organo di giustizia costituzionale nel novero delle giurisdizioni nazionali abilitate (o tenute) a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali relative all’interpretazione (o alla validità) dei trattati e degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione ex art. 267 TFUE.
Sembra infatti piuttosto ovvio che, qualora la risposta positiva a tale quesito non fosse già stata data dalla Consulta – dapprima, nel 2008 (ord. n. 103), con riguardo ai giudizi in via principale, e poi anche, nel 2013 (ord. n. 207), con riguardo ai giudizi in via incidentale –, essa avrebbe dovuto essere data a partire dal 2017 proprio in conseguenza dell’affermata competenza ad occuparsi, nell’ambito di tutti i giudizi innanzi ad essa, dei profili di compatibilità della disciplina interna con la Carta dei diritti fondamentali, in questa sede rilevante quale parametro di legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).
Ferma restando dunque la profonda, congenita ed insuperabile differenza tra la Corte costituzionale e la magistratura comune, si può dunque riscontrare – per effetto della “svolta” effettuata con la sent. n. 269/2017 – un elemento di basilare (ma, come si dirà, non totale) coincidenza nel rispettivo (e in linea di principio analogo) ruolo di interpreti della Carta dei diritti fondamentali, connesso, se non altro, alla comune soggezione ai chiarimenti che, in caso di dubbi, potranno e dovranno richiedersi alla Corte di giustizia.
Tuttavia, anche e precipuamente in questa prospettiva, sembrano potersi scorgere – alla luce tra l’altro di una serie di affermazioni contenute nelle sentenze 269/2017, 20/2019 e 63/2019 – alcune differenze di notevole rilievo nella posizione della Corte costituzionale rispetto a quella della generalità dei giudici comuni, Corte di cassazione inclusa (pur trovandosi quest’ultima, a sua volta, in una posizione sotto certi aspetti speciale e per così dire privilegiata).
Una differenza rilevante – che si ricollega alla specifica funzione del giudizio presso la Corte costituzionale (e, più in generale, alla particolare configurazione istituzionale e al peculiare ruolo di quest’ultima) – può ad esempio essere ben colta ponendo l’attenzione sulla sentenza n. 20/2019 e, segnatamente, su alcune riferite considerazioni del giudice a quo, esplicitamente e significativamente avallate dal giudice delle leggi.
In particolare, sembrano molto indicativi i passaggi in cui si ricorda come il giudice rimettente (il TAR Lazio), pur mostrandosi pienamente consapevole del fatto che, trattando le norme censurate della pubblicazione di dati reddituali e patrimoniali relativi a dirigenti delle pubbliche amministrazioni (e ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado), veniva in rilievo un trattamento di dati personali soggetto anche alla disciplina del diritto comunitario/eurounitario, e soprattutto del fatto che la Corte di giustizia aveva ritenuto le pertinente norme europee direttamente applicabili, giungesse tuttavia a escludere che le disposizioni legislative contestate fossero suscettibili di essere disapplicate per contrasto con normative europee in quanto non sarebbe stata in realtà individuabile una «disciplina self-executing di tale matrice direttamente applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio».
A tale conclusione il rimettente arrivava sulla base di alcuni significativi rilievi, tra loro collegati: nella prospettiva del giudice a quo (e soprattutto, per così dire, del giudizio a quo: v. oltre), “i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza di fonte europea invocati dai ricorrenti nel giudizio principale non sarebbero [stati] altro che «criteri in base ai quali effettuare una ponderazione della conformità» ad essi della disciplina censurata”, operazione che però necessariamente sconterebbe “i differenti caratteri e la diversa portata dell’interesse pubblico generale che si intende tutelare attraverso il regime di trasparenza, e che può avere una configurazione diversa, a seconda del sistema nazionale considerato”.
Non a caso – e tale circostanza sembra decisiva (offrendo un più solido fondamento alle affermazioni appena richiamate, che rischierebbero altrimenti di risultare astratte, autoreferenziali e per certi versi contraddittorie rispetto al richiamato riconoscimento della potenziale diretta applicabilità delle norme europee rilevanti) – la Corte di giustizia, come ricorda il giudice a quo, ha sì ritenuto, a seguito di rinvio pregiudiziale, che le invocate norme europee fossero direttamente applicabili, ma «ha stabilito che la valutazione sul corretto bilanciamento tra il diritto alla tutela dei dati personali e quello all’accesso ai dati in possesso delle pubbliche amministrazioni doveva essere rimessa al giudice del rinvio, escludendo perciò che fosse stata definitivamente compiuta dalla normativa europea» (e si noti che, come è stato autorevolmente ricordato, quando la Corte di giustizia afferma, in via generale, che spetta al giudice nazionale applicare al caso concreto i principi da essa affermati, il riferimento è da intendersi a tutti i giudici nazionali, incluse le Corti costituzionali che si inseriscono nel dialogo in base agli schemi e alle logiche proprie delle rispettive Costituzioni).
È precisamente su questa base (e per i più precisi motivi che emergeranno un po’ alla volta nelle prossime righe) che, come si diceva, il giudice rimettente ha ritenuto che le disposizioni interne censurate non potessero essere disapplicate nel caso di specie, «posto che non sarebbe realmente individuabile una disciplina self-executing di matrice europea applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio», e ha invece affermato che i principi “presidiati dalle norme europee, primarie e derivate, indicate quali parametri interposti – si presenterebbero non già quali disposizioni idonee a regolare la fattispecie al suo esame, bensì quali «criteri» di riferimento per effettuare una «ponderazione della conformità» della disciplina censurata, mostrando di intendere che tale operazione sia di segno diverso dalla semplice applicazione o non applicazione di una norma al fatto”.
Escluso dunque che la normativa europea offrisse una immediata soluzione al caso concreto, scartata inoltre la via di un rinvio pregiudiziale, «proprio perché in occasione analoga la Corte di giustizia aveva devoluto al giudice nazionale la valutazione sul corretto bilanciamento tra i due diritti potenzialmente confliggenti – quello alla tutela dei dati personali e quello ad accedere ai dati in possesso delle pubbliche amministrazioni – [il giudice a quo decideva] di sollevare questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni al suo esame, ritenendo [ecco forse il punto nevralgico e più esplicito] che la valutazione sul bilanciamento in parola non po[tesse] che spettare a questa Corte» (cioè alla Corte costituzionale, la quale, per parte sua, riferendosi presumibilmente proprio a questa considerazione del rimettente o comunque agli elementi fattuali alla base di essa, afferma testualmente, poco più avanti, che «[n]on erra, pertanto, il giudice a quo quando segnala la peculiarità dell’esame cui deve essere soggetta la disciplina legislativa che egli si trova ad applicare, e quando sottolinea che tale esame va condotto dalla Corte costituzionale»).
Tirando le fila, e provando a esplicitare l’aspetto oggettivamente cruciale ed ai nostri fini più interessante, la vicenda ha mostrato come possano darsi situazioni in cui le speciali caratteristiche del giudice e del giudizio di costituzionalità (connesse anche, per anticipare un cenno di risposta all’ultima parte della domanda, alla sua anima “politica”) rappresentino – dallo stesso punto di vista degli altri attori giurisdizionali (per un verso la Corte di giustizia, che ha rimesso le operazioni di bilanciamento in concreto ai giudici nazionali, ritenendo di non potersi spingere a compierle essa stessa; e per l’altro il giudice a quo, che nel caso di specie ha ritenuto tali operazioni esorbitanti dal ruolo di un giudice “comune”… e il fatto poi che a dirlo non sia stato un giudice monocratico di provincia ma addirittura il TAR Lazio rende il tutto ancor più significativo!) – un motivo per affidare alla Corte costituzionale il compito di esprimersi (almeno di dire la “prima parola”, come la stessa Corte ha voluto precisare) su questioni di particolare delicatezza e, per così dire, complessità costituzionale, in sé e, a maggior ragione, nelle loro implicazioni interordinamentali.
Quanto infine all’interrogativo, poc’anzi richiamato, relativo alla possibile incidenza dell’anima “politica” della Corte costituzionale come fattore di differenziazione del suo approccio alla Carta dei diritti rispetto a quello del giudice comune, in aggiunta alle ricadute di quanto si è detto finora anche su questo profilo della tematica sembra di poter dire che, in linea di principio, tale anima politica dovrebbe essere quanto più possibile “oscurata” laddove si tratti di interpretare la Carta, dovendosi semmai, a questo riguardo, riconoscere alla sola Corte di giustizia il potere di compiere quelle delicate valutazioni in senso lato politiche che pur inevitabilmente (o comunque molto frequentemente) possono risultare necessarie/opportune laddove vi sia da desumere da più o meno scarne disposizioni normative implicazioni puntuali con riguardo a specifiche situazioni fattuali e normative potenzialmente ricadenti sotto “l’ombrello” di tali disposizioni.
Al contrario, l’anima politica della Corte costituzionale sembrerebbe poter svolgere un ruolo importante – e ciò può contribuire anzi a spiegare l’opportunità se non la necessità del coinvolgimento della Corte in casi del genere – laddove, ferma una determinata interpretazione (non “politica”, o comunque non frutto di valutazioni “politiche” della Corte costituzionale) della Carta, si pongano questioni ulteriori, vale a dire questioni di raffronto, di bilanciamento, di armonizzazione o al limite di drastica opzione tra le indicazioni normative derivate dalla Carta e le indicazioni normative provenienti dalla Costituzione e/o dalla CEDU (il tutto ovviamente alla luce della giurisprudenza delle rispettive Corti), ben potendosi e anzi talora dovendosi ai fini in discorso compiere da parte della Corte costituzionale (quantomeno in prima battuta) valutazioni e scelte che possono in effetti definirsi (sempre in senso molto lato) “politiche”: tra queste, ad esempio ed in particolare, quelle relative al maggior o minor grado di “apertura” (se si vuole di cedevolezza, ma il termine può risultare fuorviante) dell’ordinamento costituzionale interno nei confronti degli ordinamenti o sistemi europei, ovviamente nel quadro dei vincoli sovranazionali o internazionali esistenti ma anche del fisiologico, più o meno ampio a seconda dei casi, margine di influenza “nazionale” sulla definizione ultima e sulla eventuale rimodulazione nel tempo di tali vincoli da parte degli organi europei a vario titolo competenti (tra i quali, come è ben noto, vanno senz’altro annoverate le due Corti di Lussemburgo e Strasburgo, che hanno anzi conquistato sul campo, e proprio su questo terreno, un ruolo di primissimo piano).
Giuseppe Martinico
Quella che molti chiamano l’anima politica dell’organo di giustizia costituzionale e che potremmo anche definire, seconda altra terminologia, “la «politicità» del giudizio sulle leggi” (su cui, fra i più recenti, si veda il libro di Bisogni) rappresenta sicuramente un elemento di differenziazione rispetto alla posizione del giudice comune, ma non credo che la principale differenza risieda nella “posizione” del giudice comune con riferimento all’art. 101 Cost., ma nel fatto che la missione della Corte costituzionale è disciplinata nello specifico dagli articoli 134 e ss. della Costituzione. Tuttavia, non mi pare che le pronunzie ricordate nella domanda dicano questo. Nel momento in cui si fa riferimento al necessario riconoscimento dello spazio funzionale all’intervento della Corte costituzionale con tanto di pronuncia di illegittimità costituzionale dotata di effetti erga omnes mi pare che si confermi la peculiare missione della Consulta nel sistema nazionale. Tuttavia, è corretto dire che il ruolo di garanti che essi (Corte costituzionale e giudici comuni) hanno ha prodotto talvolta una somiglianza nelle funzioni svolte, si pensi agli obblighi derivanti dalle situazioni descritte dall’art. 267 TFUE. Tutto questo – differenze e somiglianze - viene richiamato molto chiaramente, a mio avviso, nella sentenza 63/2019:
Alla luce di queste parole pare di poter concludere che la posizione che la Corte costituzionale si riconosceva nella 269 sembra essere diversa da quella evincibile dalle 20 e 63/2019, in cui essa sembra “arretrare”, rinunciando (se mai l’avesse pensato davvero) al coinvolgimento previo esclusivo e accettando la simultaneità dei rinvii. Il messaggio a me pare essere il seguente: se il giudice comune vuole può coinvolgere la Corte costituzionale che, nel realizzare il suo compito, amplierà lo spettro di analisi alla Carta. In tutto questo non scorgo necessariamente un male nel trittico di pronunce ricordato. Se la Corte costituzionale è sincera (come credo sia) nell’auspicare un vero concorso di rimedi allora la disapplicazione/non applicazione non viene negata, ma diventa strumento di tutela immediata che può essere “arricchito”, nel caso, da una pronuncia di incostituzionalità erga omnes. Rimangono, tuttavia, dei dubbi con riferimento ai c.d. rapporti orizzontali, ma non sono interamente addebitabili alla nostra Corte costituzionale a mio avviso, dato che alcuni riguardano la controversa natura dell’effetto diretto c.d. orizzontale.
Un’altra conferma della differenza della posizione fra Corte costituzionale e giudice comune risiede nella necessità di evitare proprio quella “octroyée methodology of construing common constitutional traditions” ricordata nella prima risposta. In questo, ripeto, la 269/2017 va letta come parte di un trend più ampio attivato da Corti costituzionali tutt’altro che euroscettiche. Come la Consulta ha detto, il suo intervento è funzionale “anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei diritti siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea e dall’art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in tale ambito”, precisazione, come ricordato in precedenza, da molti vista come problematica. A stemperare il passaggio accorre il richiamo al rispetto del principio di leale cooperazione. Gli stessi concetti di “concorso di rimedi giurisdizionali” e di “doppia pregiudizialità” sono funzionali a ritagliare un ruolo per la Corte costituzionale che non è prospettabile per il giudice comune. Anzi, per certi versi l’accentramento della pronuncia sul caso di potenziale conflitto serve proprio a impedire (come era stato con le sentenze gemelle del 2007 con riferimento alla CEDU e su questo parallelismo insiste giustamente V. Sciarabba nel suo intervento) i rischi connessi a un controllo di costituzionalità diffuso mascherato da controllo di comunitarietà, vista l’equivalenza delle disposizioni in gioco.
Un’altra considerazione da fare, sempre relativamente al rapporto fra Corte costituzionale e giudici comuni è quella relativa alla progressiva accettazione del meccanismo del rinvio pregiudiziale, in cui il giudice costituzionale ha rinunciato a considerarsi totalmente altro dai giudici comuni. In questo l’enfasi sulla doppia pregiudizialità non deve indurre a pensare che ora la Consulta voglia tornare indietro. A conferma di questo vanno evidenziate alcune continuità esistenti fra l’adesione della Corte costituzionale italiana al meccanismo dell’art. 267 TFUE e la doppia pregiudizialità che originariamente era stata concepita (anche) come strumento di dialogo indiretto o, se vogliamo, nascosto. In entrambi i casi il giudice costituzionale non rinuncia alla sua posizione di garante del controlimite interno ma, anzi, responsabilizza l’interlocutore europeo, invitandolo a decidere se azionare o meno il “conflitto” (si pensi alla nota vicenda del favor rei nel caso Berlusconi). Se questo è vero allora la doppia pregiudizialità rimane una strategia utile anche dopo la scelta di ricorrere al rinvio pregiudiziale da parte della Consulta. Ricapitolando, vi è un elemento comune fra la doppia pregiudizialità e le conseguenze dell’adesione alla procedura del rinvio pregiudiziale da parte della Consulta: la Corte costituzionale italiana, nel sollevare la questione pregiudiziale alla CGUE, non rinuncia all’arma del controlimite o, meglio, al diritto all’ultima parola (che, mi pare, per certi versi conti più della “prima parola” richiamata nella sentenza 20/2019). A questo proposito uno degli aspetti ambigui della sentenza 269/2017 era rappresentato dalla possibilità per il giudice comune di sollevare una questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE “ove, per altri profili, la ritengano contraria al diritto dell’Unione”. Questo passaggio, come noto, sparisce nella sentenza 20/2019 in cui, invece, si afferma che “resta fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria”. Questo cambiamento, insieme a quello relativo al passaggio dalla concezione che sembrava postulare la “necessità di un intervento erga omnes di questa Corte” all’idea secondo cui “va preservata l’opportunità di un intervento con effetti erga omnes di questa Corte”, è sicuramente quello che contribuisce di più a un “rasserenamento” generale di quella dottrina che aveva visto intendimenti sovversivi nella giurisprudenza della Consulta.
In conclusione, il trittico di pronunce ricordato a mio avviso non presenta tutti gli aspetti problematici che sono stati segnalati dalla dottrina e in questo non credo che si possa ragionare di uno stravolgimento nel rapporto fra Corte costituzionale e Corte di giustizia, anche se è chiaro il messaggio lanciato dalla prima ai giudici comuni. Con ciò non si vuole negare l’esistenza di alcune ambiguità (quella in primis relativa al destino della disapplicazione/non applicazione), ma sottolineare la necessità, anche da un punto di vista metodologico, di contestualizzare queste pronunce e di non cedere a un approccio manicheo conflitti versus dialogo. In questo la nostra Corte costituzionale ha, per esempio, nella ordinanza 24/2017 affiancato accanto ai passaggi dedicati al 4.2 TUE anche un costante riferimento al principio di legalità penale inteso come tradizione costituzionale comune, usando insieme due strategie argomentative che il vecchio art. 6 TUE (versione pre-Lisbona) codificava nella medesima disposizione e che, con il Trattato di Lisbona, sono state apparentemente scisse. In questo senso le riflessioni suscitate in dottrina dalla saga Taricco (e il “seguito” rappresentato dalla sentenza 115/2018 e, ancora prima, dall’obiter dictum nella sentenza 269/2017 della Corte Costituzionale) confermano la centralità dei conflitti costituzionali nell’attuale fase del diritto europeo. La saga Taricco è forse solo l’episodio più eclatante di lunga catena di eventi. In questo contesto, persino pronunce caratterizzate da toni forti e apparentemente ispirate da dinamiche tutt’altro che cooperative hanno dato avvio a importanti scambi di argomenti fra i giudici. Fra i commentatori della saga Taricco io mi trovo particolarmente d’accordo con quanto scritto da Sarmiento secondo cui l’uso strategico dell’argomento dell’identità avrebbe scatenato un vero e proprio dialogo, in cui gli interlocutori sono partiti da posizioni e premesse diverse, prendendo in considerazione la tesi dell’altro e giungendo poi a un compromesso. Ecco che allora dialogo e conflitto non devono essere visti come concetti antitetici, dato che anche la minaccia dei conflitti può essere funzionale allo scambio di argomenti e quindi a dinamiche cooperative. Questi disaccordi interpretativi innescano, in altre parole, fenomeni di dialogo stricto sensu inteso. Qui si potrebbe aprire un vero e proprio “vaso di Pandora”, tanto è contestata la validità scientifica di tale concetto. Per evitare di riaprire discussioni meramente teoriche, basti in questa sede ricordare che esiste dottrina che ha seriamente definito cosa intendere per dialogo. Rinviando a questa scrupolosa letteratura – e condividendo, allo stesso tempo, lo scetticismo di Maestri del diritto che hanno espresso dubbi con riferimento all’abuso di questo concetto – si definisce “dialogo” proprio il duraturo scambio di argomenti fra soggetti che si riconoscono reciprocamente come interlocutori dotati di pari dignità e legittimazione. In questo contesto i conflitti non sono elementi di disturbo nella strada verso la coerenza del sistema, ma possono anche giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’ordinamento. Allo stesso tempo, ovviamente, non è sempre possibile rinvenire il contributo dato a livello sistemico da tali disaccordi interpretativi. D’altronde, questo è coerente con la logica “non riduzionista” che caratterizza la visione del disordine causato dai conflitti come elemento non sempre riconducibile alla razionalità del sistema. Su questo sfondo l’ordine e il “disordine” (scatenato dai conflitti) interagiscono, favorendo l’emersione dei cambiamenti sociali (e giuridici) e il rinnovamento dell’organizzazione, in una dinamica per cui il disordine “diventa paradossalmente vettore d’ordine”, come il passaggio da una visione “assoluta” (quella della sentenza Internationale Handelsgesellschaft) a una “relativa” del primato (il primato rispettoso dell’identità nazionale di cui all’art. 4.2 TUE) dimostra.
Clicca qui per leggere la prima domanda
Clicca qui per leggere la seconda domanda
Clicca qui per leggere la repliche e le conclusioni