
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Le nuove norme processuali in materia di persone, minorenni e famiglia (d.lgs. n. 149/2022): prime letture sintetiche
di Giuseppe Buffone
Giustizia Insieme propone ai suoi lettori una serie di contributi relativi alla riforma della procedura civile, per conoscere, approfondire e discutere. L’articolo presentato riguarda la riforma dei procedimenti in materia di persone, minori e famiglia.
I precedenti articoli:
1. La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.)
2. La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura
3. La riforma del processo civile in appello. Le disposizioni innovate dal D. Lgs n. 149/2022
4. La riforma dell’esecuzione forzata: le novità del D. Lgs n. 149/2022
5. Le nuove disposizioni in materia di processo del lavoro
Sommario: 1. Regime transitorio – 2. Criterio generale di interpretazione – 3. Ambito di applicazione – 3.1. Regime della connessione - 4. Le disposizioni generali - 4.1. Poteri del giudice – 4.2. Ascolto del minore – 4.3. Curatela speciale – 5. Procedimento di separazione e divorzio – 5.1. Competenza territoriale - 5.2. Il processo - 5.3. Contemporanea proposizione delle domande di separazione e divorzio – 5.4. Provvedimenti provvisori – 5.5. Procedimento su domanda congiunta - 6. Il processo minorile a gestione condivisa.
1. Regime transitorio
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n 149 (cd. Riforma Cartabia)[1] ha introdotto nuove norme di procedura dedicate ai procedimenti che riguardano la persona e la famiglia: le nuove disposizioni sono contenute nel libro II, (nuovo) titolo VI-bis del codice di procedura civile («Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», cd. procedimento PMF), in particolare negli articoli 473-bis e ss c.p.c.
Queste disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dall’art. 1, comma 380, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, ossia legge di Bilancio 2023[2]). Il regime transitorio è stato modificato anche dal cd. decreto milleproroghe (decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198[3]) che, per quanto qui interessa, ha effetto soprattutto per il regime dell’udienza di giuramento del consulente tecnico d’ufficio. La legge di Bilancio 2023, modificando l’art. 35 del dlgs 149/2022, ha incluso anche la modifica dell’art. 193 c.p.c. tra le norme di applicazione anticipata alla data del 1° gennaio 2023. Il decreto milleproroghe, tuttavia, all’art. 8 (proroghe di giustizia) ha previsto che l’art. 221, comma 8, decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 continua ad applicarsi alle udienze da svolgere fino al 30 giugno 2023, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. Ebbene, il nuovo art. 193 c.p.c. – come riscritto dalla Riforma Cartabia - prevede, al comma secondo, che “in luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma”. La disposizione richiamata dal decreto milleproroghe statuisce, invece, che “in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”. Entrambi i regimi giuridici regolano l’udienza di giuramento del CTU dematerializzata: alla luce del coordinamento delle disposizioni di diritto transitorio, la regola prevista dalla decretazione d’urgenza (ed estesa nel tempo dal d.l. 198/2022) continua ad applicarsi fino alle udienze da svolgere fino al 30 giugno 2023; successivamente a quella data, sarà applicabile il nuovo art. 193 c.p.c. come riscritto dal dlgs 149/2022[4].
2. Criterio generale di interpretazione
Il decreto legislativo n. 149 del 2022 racchiude un corpus iuris di estrema complessità e, soprattutto, capillare quanto ai settori di intervento. Si porranno certamente diversi quesiti ermeneutici e, conseguentemente, elevato sarà il tasso di intervento degli interpreti. Ciò nondimeno, in questo caso, può essere utile segnalare che tutte le relazioni illustrative sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale[5] a dar conto delle ragioni di ogni scelta normativa adottata. E ciò è importante anche per ricordare un criterio generale di interpretazione che certamente può essere utilizzato in questa occasione: il principio del cd. “Legislatore consapevole”. “Il canone interpretativo del «Legislatore consapevole» presuppone un Parlamento attento al diritto giurisprudenziale e composto, almeno in parte, da tecnici; si tratta di un criterio che deve orientare l’interprete verso la scelta ermeneutica più vicina alla volontà espressa nella legge”[6]. Ebbene, tenuto conto di come sono stati organizzati i lavori dei tecnici in questo caso e della composizione delle Commissioni preposte alla stesura delle norme, dovrà prestarsi particolare attenzione alle modalità di interpretazione, presupponendo che ciò che è stato scritto (o non scritto) sia “consapevole”. Altrimenti detto: le nuove norme devono leggersi come frutto della consapevole conoscenza dello “stato dell’arte” del processo al momento dell’intervento legislativo e come risultato voluto[7].
3. Ambito di applicazione
Il nuovo procedimento PMF ha vocazione generale: le nuove disposizioni si applicano a tutti i procedimenti (contenziosi) relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni (art. 473-bis c.p.c.). Sussistono solo tre eccezioni: 1) non si applica il procedimento PMF se “la legge dispone diversamente”; 2) non si applica il procedimento PMF nei casi di esclusione previsti dall’art. 473-bis, primo comma, c.p.c. (procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, procedimenti di adozione di minori di età, procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea); 3) restano fuori dall’ambito applicativo del nuovo rito unificato a cognizione piena tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerali (art. 473-ter c.p.c.). In questa ipotesi, il tribunale giudica in composizione collegiale, salvo che sia altrimenti disposto (art. 50-bis c.p.c.) e i decreti sono immediatamente esecutivi (art. 473-ter c.p.c.)[8].
L’adozione del termine “famiglie” mira a includere tutti modelli familiari, vuoi che si tratta di coppie unite in matrimonio, vuoi che si tratti di convivenze di fatto. Le nuove norme si applicano anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso: in tal caso, l’applicabilità è stata espressamente prevista nell’art. 1, comma 25[9] della legge 20 maggio 2016 n. 76 (“si applicano, in quanto compatibili (…) le disposizioni di cui al Titolo IV-bis del libro secondo del codice di procedura civile (…)”. Il nuovo procedimento assorbe anche le controversie tra genitori non legati da vincolo matrimoniale. Al riguardo, una precisazione è opportuna. Nel vigore del vecchio assetto ordinamentale, le liti tra genitori non uniti da matrimonio erano collocate nel procedimento camerale e fondate sulla base giuridica formata dal combinato disposto degli artt. 316, quarto comma, 337-bis c.c.[10] Nell’attuate procedimento PMF, l’art. 473-ter c.p.c. prevede che i provvedimenti di cui all’articolo 316 del codice civile “sono pronunciati in camera di consiglio”. Ma, adesso, il rinvio è al “nuovo articolo 316 c.c.”, come modificato dal dlgs n. 149/2022[11], che riconduce questo istituto esclusivamente alle liti “endofamiliari” ossia ai diverbi tra genitori uniti e, quindi, non in una fase di separazione (in linea con istituti simili, come quello di cui all’art. 145 c.c.[12]). Quanto a dire: nel caso in cui una coppia unita sia in disaccordo su questioni che riguardano i figli, opera il rito camerale e l’art. 316 c.c., ma se si tratta di disgregazione della famiglia (ossia: una separazione), allora si applica il procedimento PMF (perché si tratta di vero e proprio procedimento contenzioso). Nell’ambito del procedimento PMF vanno anche collocate le controversie in materie di alimenti, in quando non è espressamente prevista una esclusione (e, quindi, ricade in questa tipologia di procedimento anche la controversia alimentare tra conviventi, ai sensi dell’art. 1, comma 65, legge n. 76/2016).
Le nuove disposizioni di applicano, come detto, anche ai procedimenti relativi allo stato delle persone (“azioni di stato”), incluso il procedimento previsto dall’art. 250 c.c. che, a tal fine, è stato espressamente modificato per confluire nel nuovo rito unitario[13]. Queste azioni sono di competenza del tribunale ordinario (artt. 38 disp. att. c.c., 9 c.p.c.) anche quando la parte attrice sia un minore. Per effetto della inclusione dei procedimenti relativi allo stato delle persone in seno al rito unitario, per determinare la competenza territoriale si applica l’art. 473-bis.11 c.p.c.: “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale” (secondo la logica del forum conveniens). Questa nuova regola modifica, di fatto, il pregresso “status quo” della giurisprudenza in virtù del quale nelle azioni di stato (anche ove coinvolti minori), la competenza è del luogo di residenza del convenuto[14]. Il nuovo grimaldello in seno al rito unitario apre, invece, la porta della competenza del foro di residenza del bambino anche ove questi sia coinvolto in una azione di stato (alla luce della formulazione generale: “tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore”).
Così delineato l’ambito di applicazione, è importante, in punto di qualificazione giuridica, affermare che non si tratta di un rito speciale (non più). Il procedimento PMF è stato inserito, sistematicamente (e consapevolmente), all’interno del Libro II del c.p.c. (processo ordinario di cognizione). Questa scelta sottolinea anche dal punto di vista sistematico che si tratta a tutti gli effetti non già di un rito settoriale, quanto di un modello processuale generale[15]. Volendo essere più chiari: non si tratta più di un “procedimento speciale” di cui al Libro IV del c.p.c. (“Dei procedimenti speciali”) ma di un processo ordinario di cognizione, di cui al Libro II del c.p.c. (“Del processo di cognizione”); il termine “speciale”, anche quando usato anche dalla Dottrina[16], non va, dunque, frainteso perché significa rito ordinario con alcune caratteristiche di “specialità” nel regime giuridico che lo tratteggia.
Si tratta, dunque, del processo ordinario di cognizione con rimedi e tutele particolareggiate. Queste ultime sono contenute nel Capo III (Disposizioni speciali), costituito da sette sezioni. Si è andato incontro, quindi, a esigenze di tutela particolareggiata, caso per caso.
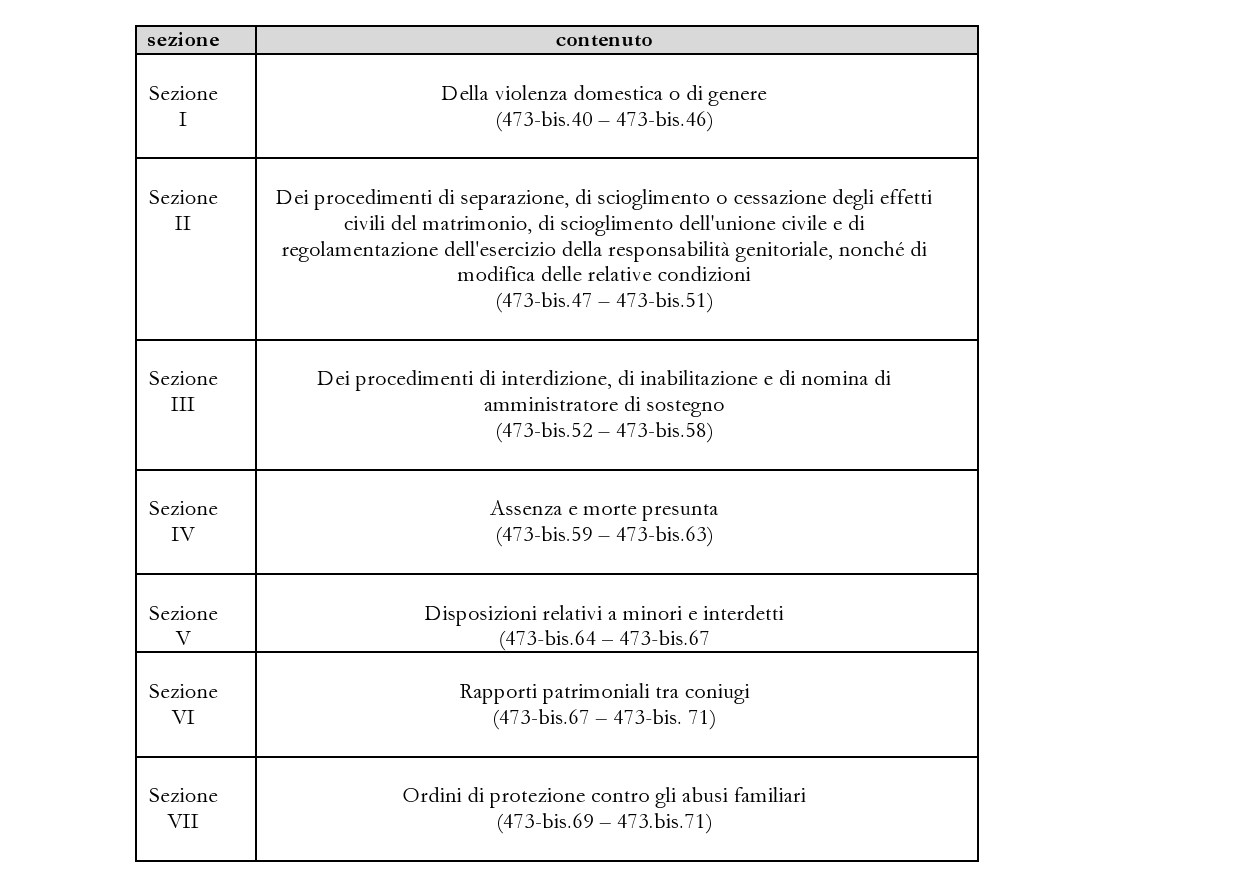
3.1. Regime della connessione
Fatta questa premessa, può rilevarsi, forse, una omissione in seno al nuovo articolo 40 c.p.c. (in materia di connessione). La riforma, infatti, si è preoccupata di introdurre al terzo comma dell’articolo 40 c.p.c. la disciplina che dispone la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi in cui si determina connessione (ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) tra una causa sottoposta a tale rito e una causa invece da trattarsi con rito speciale diverso da quelli di cui agli articoli 409 e 422 c.p.c. Non ha, invece, nulla previsto per il caso del procedimento PMF. In presenza di questa possibile lacuna non dovrebbe propendersi, come soluzione, per la prevalenza del procedimento di cognizione ordinario generale ma, adottando una interpretazione funzionale, dovrebbe applicarsi quello “particolareggiato” degli artt. 473-bis e ss c.p.c. Altre conseguenze si registrano in tema di cumulo processuale. Ebbene, fermo restando che tra le domande deve sussistere un vincolo di connessione (che, ad esempio, è in genere escluso con la domanda di divisione del patrimonio: v. Cass. civ. n. 6424/2017), dovrebbe propendersi, a questo punto, per la possibilità della trattazione congiunta delle azioni tipiche del procedimento PMF e le azioni di risarcimento del danno endofamiliare. Rispetto a tale aspetto, un approfondimento può essere utile. L’art. 1, comma 24, lett. c) della legge n. 209 del 2021, ha richiesto al Legislatore di istituire il futuro Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, attribuendogli anche la competenza sui “procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare” (che sarà assegnato alle sezioni circondariali). Questa materia non è oggetto della delega attuata nel dlgs n. 149/2022. Ciò nondimeno, alla luce del nuovo procedimento PMF può legittimamente predicarsi la possibilità del cumulo tra le azioni di separazione e divorzio e la domanda di risarcimento del danno endofamiliare (che, peraltro, è in genere “accessoria”). Valga, comunque, considerare che già nel vigore del “rito speciale” di separazione/divorzio la Corte di Cassazione ha dimostrato favore per il regime del cumulo in caso di domande risarcitorie fondate su cd. illeciti endo-familiari[17]: ad esempio, là dove ha affermato, di recente, che “è consentita, nel procedimento camerale finalizzato all'adozione delle misure di cui all'art. 709-ter c.p.c., la proposizione della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare per gli atti pregiudizievoli commessi dall'altro genitore ai danni del minore, non essendovi motivo per imporre al genitore, che intenda svolgere siffatta domanda nell'interesse del figlio minore, la necessità di proporre un'autonoma azione da illecito aquiliano; l'art. 709-ter c.p.c. è, infatti, norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice di trattare una domanda ordinaria con rito speciale, per preminenti ragioni di celerità del mezzo di tutela, ed il provvedimento terminativo del giudizio riveste il carattere della decisorietà, con conseguente idoneità al giudicato” (Cass. Civ. n. 27147 del 2021). Depone a favore della inclusione delle azioni di risarcimento del danno endofamiliare nell’ambito del procedimento PMF, in caso di cumulo processuale, il nuovo art. 473-bis.39 c.p.c. che, al secondo comma, conferma la previgente previsione dell’art. 709-ter (“Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore”) ma stavolta nell’ambito delle disposizioni comuni di tutto il procedimento e non, quindi, nel contesto di una intercapedine di rito speciale.
In presenza di “connessione” il rito è ormai la sede in cui proporre tutte le domande. Ad esempio, nel rito del divorzio, possono essere anche decise, in regime di cumulo processuale, la domanda di mantenimento del cognome del maritoo di liquidazione della quota di trattamento di fine rapporto, etc.[18]
A scanso di equivoci è bene evidenziare che, nonostante l’introduzione del rito unitario in materia di famiglia, resta – sino a quando non entrerà in vigore la riforma del tribunale delle persone, dei minori e delle famiglie - la ripartizione delle competenze tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni, seppur ai sensi del novellato art. 38 disp. att. c.c.[19]
4. Le disposizioni generali
Il dlgs 149/2022 introduce delle norme “generali” per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie: si tratta degli articoli 473-bis – 473-bis.10, racchiusi nel Capo I. Queste disposizioni regolano, con carattere generale, tutti i procedimenti che ricadono nell’ambito di applicazione del procedimento PMF. L’art. 473-bis.1 individua la composizione dell’organo giudicante con una scelta che punta ad accelerare la governance dei procedimenti a decisione collegiale ammettendo che la trattazione e l'istruzione possano essere delegate a uno dei componenti del collegio (si passa, dunque, a un modello a istruzione monocratica e decisione collegiale). In virtù della disposizione in esame, il giudice relatore potrà, ad esempio: nominare il curatore speciale del minore (oppure il tutore provvisorio nei casi previsti); esercitare i poteri d’ufficio riconosciuti nel caso in cui debbano essere adottati provvedimenti in materia di minori; condurre l’ascolto del bambino; adottare i provvedimenti indifferibili; tenere l’udienza di comparizione personale delle parti, all’esito della quale adottare i provvedimenti provvisori; ammettere istanze istruttorie, CTU, delegare indagini ai Servizi socio assistenziali; tenere le ulteriori udienze istruttorie necessarie per giungere alla decisione; modificare i provvedimenti provvisori ricorrendone i presupposti[20]. Resta, invece, confermata – in mancanza di disposizione di deroga in tal senso – la riserva di collegialità per l’eventuale incidente di costituzionalità: infatti, nei giudizi in cui il tribunale decide in composizione collegiale, il giudice relatore/istruttore difetta di legittimazione (ex multis, Corte cost., n. 266 del 2014) che sussiste solo con riferimento a questioni concernenti disposizioni di legge che il giudice istruttore deve applicare per provvedimenti rientranti nella sua competenza, mentre non sussiste quando la norma impugnata assuma rilevanza per la risoluzione della causa (Corte cost. n. 552 del 2000).
Nell’ipotesi in cui il procedimento sia di competenza del tribunale per i minorenni, il regime presenta, invece, delle differenze poiché “nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale possono essere delegati ai giudici onorari specifici adempimenti ad eccezione dell'ascolto del minore, dell'assunzione delle testimonianze e degli altri atti riservati al giudice. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore” (art. 471-bis.1). Si istituisce, dunque, una sorta di “riserva” di giudice togato per gli snodi e gli atti di maggiore importanza per lo svolgimento del procedimento.
4.1. Poteri del giudice
Una novità importante è iscritta nell’art. 473-bis.2 dove si tipizza – e consolida con base giuridica ad hoc – un principio invalso nei procedimenti che coinvolgano minori: il potere officioso del giudice. La nuova disposizione si distingue per il dettaglio con cui identifica i casi in cui il giudice può adottare provvedimenti in assenza di domanda di parte oppure attivare iniziative per la raccolta della prova. Il dettaglio si traduce in “regole d’azione” che identificano l’esercizio “legale” di questi poteri. Innanzitutto, sono poteri esercitabili esclusivamente in favore del minore (che è parte sostanziale del processo: v. Cass. civ. n. 16410/2020[21]): la disposizione, infatti, premette che l’iniziativa del giudice deve essere adottata «a tutela dei minori». Sussistendo questo presupposto, il giudice può muoversi nel processo “in deroga all’art. 112 c.p.c.” e, pertanto, adottare iniziative ex officio. La nuova norma, dunque, legittima una deroga sia al principio della domanda che al principio dispositivo.
L’articolo include misure tipiche e misure atipiche (ossia a contenuto non predeterminato). Il giudice può: 1) nominare il curatore speciale (nei casi di cui all’art. 473-bis.7 c.p.c.); 2) disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile (con riferimento pertanto, in primis, alle limitazioni di cui agli articoli 2721 e ss c.c.).; 3) con riferimento alle domande di contributo economico, ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria; 4) «adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 c.p.c.». Si è detto che deve trattarsi di un esercizio “legale” e, dunque, rispettoso delle condizioni che l’art. 473-bis.2 prevede: queste sono, essenzialmente, il rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Al cospetto di una iniziativa officiosa, il giudice dovrà, dunque, necessariamente garantire la partecipazione delle parti, nella misura ritenuta adeguata e applicando, in primo luogo, l’art. 101 c.p.c. Tenuto conto della natura della misura, il contraddittorio potrà essere garantito ex ante oppure ex post.
L’art. 473-bis.3 c.p.c. regola, invece, i poteri del pubblico ministero che, nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.
4.2. Ascolto del minore
Gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. disciplinano l’istituto dell’ascolto del minore ereditando il portato della giurisprudenza di legittimità che ha, di fatto, compilato un codice dell’audizione dei bambini a uso forense. Va premesso che il “Diritto del minore di esprimere la propria opinione” è ormai oggetto di armonizzazione europea (art. 21, Reg. UE n. 1111 del 2019[22]) e rappresenta l’istituto “cardine” dei procedimenti minorili. Le regole giuridiche consolidatesi nell’ordinamento italiano si snodano affermando che: 1) l’audizione del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento obbligatorio (Cass. civ. n. 16410/2020); 2) l’adempimento è svolto a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione (Cass. civ. n. 1474/2021); 3) in caso di omessa audizione del minore, il procedimento è viziato da nullità (Cass. civ. n. 23804/2021). L’ascolto deve essere disposto rebus sic stantibus ossia “per ogni procedimento” che coinvolga il bambino (essendo pertanto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti: v. Cass. civ. n. 9691/2022). Ebbene, questa architettura di regole e principi trova, oggi, specifica collocazione negli articoli citati che, in particolare, determinano i casi dell’ascolto (473-bis.4) e le sue modalità (473-bis.5). La disciplina presenta, invero, differenze sostanziali rispetto alla precedente, in senso migliorativo. In primo luogo, i casi di esclusione motivata dell’audizione sono, ora, ben tipizzati nel secondo comma dell’art. 473-bis c.p.c.: 1) l’ascolto è contrasto con l'interesse del minore; 2) l’ascolto è manifestamente superfluo; 3) sussiste una ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore; 4) il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato. L’esclusione dell’ascolto in caso di “rifiuto” del bambino costituisce l’adesione all’orientamento che era stato espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito. Si era affermato, infatti, che “l’audizione del minore deve essere esclusa dove il fanciullo, prossimo a divenire maggiorenne (cd. grand enfants) comunichi, anche tramite i suoi rappresentanti (i genitori) il proprio rifiuto all’ascolto. Accertato che il rifiuto è pacifico (dovendosi altrimenti accertarne la veridicità), è contrario all’interesse del fanciullo ricercare ostinatamente di assumere la sua opinione: come tutti i diritti, ferma la titolarità, il concreto esercizio passa anche per un atto di volontà del fanciullo. Peraltro, non rispettare il rifiuto del minore rappresenterebbe un’aporia logica prima che giuridica: si dispone l’audizione per ascoltare il minore, ma non lo si ascolta nella dichiarazione più importante (cioè che non vuole essere ascoltato)” (Trib. Milano, sez. IX civ., 21 febbraio 2014)[23].
L’art. 473-bis.4, terzo comma, introduce, poi, una disposizione ad hoc per le ipotesi di accordo dei genitori: in questi casi, “il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario”. Questa norma mira a tutelare l’interesse del minore a non essere ulteriormente esposto a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familiare, qualora il giudice prenda atto dell’accordo tra i genitori e ritenga non indispensabile procedere all’ascolto. Tale disposizione abroga quanto previsto dall’articolo 337-octies del codice civile, secondo cui nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo all’affidamento dei figli, il giudice deve sempre procedere all’ascolto, salvo che ciò appaio in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo” (Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5).
La disposizione che completa il regime è quella di cui all’art. 475-bis.5 c.p.c. che si occupa delle modalità dell’ascolto. La funzione di questa norma riposa nella “doppia” anima dell’ascolto del bambino: è istituto a protezione del minore in quanto parte del procedimento ma è anche un incombente del processo che deve collocarsi “all’interno della procedura” nel senso di garantire il contraddittorio delle parti. La partecipazione dei genitori (e dei difensori) all’ascolto in quanto “incombente processuale” è realizzata in diversi modi: 1) le parti possono proporre argomenti e temi di approfondimento per l’audizione; 2) le parti, su autorizzazione del giudice, possono partecipare all'ascolto; 3) dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore. A corredo della disciplina, sempre in tema di modalità dell’ascolto, la Riforma conferma la precedente disciplina prevedendo che “quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 473-bis.5, terzo comma, del codice” (art. 152-quater disp. att. c.p.c.). Aggiunge, però, una nuova disposizioni di particolare importanza, nell’art. 152-quinquies disp. att. c.p.c. (Registrazione audiovisiva dell’ascolto): “con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico”. Questa norma di collega all’ultimo comma dell’art. 473-bis.5 c.p.c. («Dell'ascolto del minore è effettuata registrazione audiovisiva. Se per motivi tecnici non è possibile procedere alla registrazione, il processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore»). Ciò vuol dire che l’obbligo della videoregistrazione entrerà in vigore una volta che il Ministero della Giustizia abbia adottato un decreto ministeriale che doti gli uffici degli strumenti tecnologici necessari alla videoregistrazione, da redigere a cura dello stesso organo ministeriale. In assenza, tuttavia, il giudice può comunque, sulla base anche delle prassi sino ad ora seguite, valutare la videoregistrazione a tutela del minore e a beneficio del contraddittorio.
Le nuove norme predicano l’ascolto diretto del minore che, dunque, deve essere condotto dal giudice.[24] La relazione illustrativa precisa che «il legislatore ha qui escluso espressamente la delega, da parte del giudice, dell’ascolto del minore, stante la delicatezza dei temi sui quali il minore è chiamato ad esprimersi»[25]. Questa esclusione, tuttavia, non può interpretarsi in senso assoluto, ossia insuperabile, proprio alla luce della cornice internazionale ed europea entro cui si colloca il diritto del minore a esprimere la propria opinione. Occorre sempre tener presente che nelle cause in cui coinvolto un bambino è il processo che deve “adattarsi” al minore e non il contrario: si parla, infatti, di «accomodamenti procedurali». Tant’è che, come visto, l’interesse superiore del minore infrange anche il dogma del principio della domanda. Ciò vuol dire che, eccezionalmente, il giudice, nell’interesse superiore e preminente del minore, potrebbe valutare assolutamente necessaria una audizione “delegata” e indiretta, ad esempio a mezzo di esperto in sede di consulenza tecnica d’ufficio. Che le eccezioni siano possibili lo conferma, ad esempio, il fatto che la normativa prevede espressamente anche l’ipotesi dell’audizione condotta dal curatore speciale. Valga considerare che, per le Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore dovrebbe essere finanche data al minore la possibilità di scelta circa le modalità di audizione perché «è possibile che alcuni minori preferiscano essere ascoltati da uno “specialista” che poi trasmette il loro punto di vista al giudice»[26]. Ipotesi concrete possono essere quelle di rischio per il benessere psico-fisico del bambino: in questi casi, è stata la stessa Corte EDU ad imporre di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i bambini[27].
Pertanto: la regola generale è che l’audizione debba essere diretta (quindi, condotta dal giudice); eccezionalmente, tuttavia, per ragioni primarie di tutela del bambino, l’ascolto può essere realizzato con modalità diverse.
Nei procedimenti transfrontalieri, invece, il modello di audizione “privilegiato” è quello tramite modalità videoconferenza (e, quindi, tramite collegamenti audiovisivi). È una scelta di buon senso: evita che il bambino debba essere trasportato da uno Stato all’altro e garantisce che il giudice possa procedere all’ascolto rapidamente. In questa direzione si pone il Considerando n. 53 del Regolamento Bruxelles 2-ter[28] (“l’autorità giurisdizionale può valutare la possibilità di tenere un’audizione in videoconferenza o con altre tecnologie di comunicazione”), da leggere in combinato disposto con il Considerando n. 21 del Regolamento UE 2020/1783 (sull’assunzione delle prove nei procedimenti transfrontalieri[29]). A completamento della disciplina, de jure condendo, si deve poi tener conto della proposta di “Regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria” (del 1° dicembre 2021) che, nel testo oggetto di orientamento generale approvato dal Consiglio UE[30], prevede una integrazione del regime giuridico UE mettendo a disposizione dei giudici due strumenti complementari: questa proposta, per l’ascolto del bambino nei procedimenti di famiglia; il Reg. 2020/1783, per l’ascolto del minore se escusso come testimone[31].
4.3. Curatela speciale
Il procedimento PMF si arricchisce di altre interessanti disposizioni di carattere generale: A) art. 473-bis.6 che regola la reazione del processo al caso in cui emerga il rifiuto del minore a incontrare il genitore o siano allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (il giudice procede all'ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l'abbreviazione dei termini processuali); B) articoli 473-bis.7 – 473-bis. 8 che racchiudono le norme in tema di curatore del minore (a cui possono essere attribuiti anche specifici poteri di rappresentanza sostanziale, quali ad esempio la decisione sulla iscrizione scolastica, sulle cure mediche, su trattamenti sanitari etc.); C) art. 473-bis.9 che riproduce la disciplina previgente in tema di disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave; D) l’art. 473-bis.10 in materia di mediazione familiare (per cui la Riforma introduce una autonoma disciplina organica inserita nel capo II-bis, titolo II delle disp. att. c.p.c.).
La nuova normativa sulla curatela speciale fa tesoro del diritto vivente e dell’elaborazione dogmatica della dottrina[32] pure introducendo una norma inedita (art. 473-bis.8 ultimo comma c.p.c.) che colma lacuna della disciplina in punto di revoca del curatore introducendo un procedimento di competenza del presidente del tribunale o del giudice che procede e l’attribuzione della legittimazione attiva per la proposizione dell’istanza ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, al tutore, al pubblico ministero o al minore medesimo[33].
Alla luce della nuova disposizione inserita, il Legislatore modula due diverse ipotesi di curatela speciale: processuale (art. 473-bis.8 primo e secondo comma) e sostanziale (art. 473-bis.8 terzo comma). Il curatore speciale del minore, nei primi due commi dell’articolo 473-bis.8 c.p.c. è figura processuale ossia soggetto (nella maggior parte dei casi individuato tra avvocati altamente specializzati) chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori (specificamente indicati nella norma, per esempio nei casi di procedimenti di decadenza, di procedimenti ex articolo 403 c.c., di affidamento etero familiare del minore etc.) oppure nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Al contrario, il curatore speciale del minore nel terzo comma dell’art. 473-bis.8 ha natura sostanziale: agisce “fuori” dal processo e per situazioni specifiche su mandato del giudice. In tutti i casi, il curatore speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.
Importante – e già presente nella disciplina previgente – è il potere in capo al giudice (anche relatore nel corso dell’istruzione e della trattazione) di attribuire al curatore specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Al riguardo, è bene precisare che la disposizione non delinea una fisiologia tipica nell’esito della curatela in questo caso: quanto a dire che è, poi, il giudice a definire le modalità di adozione del provvedimento finale. Alla luce delle prassi giurisprudenziali, infatti, sono diffuse almeno due metodologie (entrambe da ritener compatibili con il nuovo art. 473-bis.8). In un primo caso, il giudice non attribuisce al curatore un effettivo potere di rappresentanza sostanziale, bensì il compito di da far confluire una posizione scritta nell’interesse del minore (relazione): a seguito della posizione rappresentata nell’interesse del minore, è il giudice ad adottare l’atto necessario (ad esempio, attribuendo a uno dei due genitori – quello che era favorevole a tale atto – il potere di procedere da solo; oppure emettendo misura ad hoc rivolta ai terzi interessati, come ente locale, sanitario o scuola). In questo caso, quindi, l’atto conclusivo resta giudiziale. Valga un esempio. Un padre vuole iscrivere il figlio in una scuola pubblica la ma madre non è d’accordo. All’esito dello svolgimento dei compiti, il curatore conclude nel senso che, nel migliore interesse del bambino, va preferita l’iscrizione nella scuola [34]pubblica. A questo punto, il giudice autorizza il padre a iscrivere il figlio alla scuola pubblica (superando, così, la necessità del consenso del genitore dissenziente). Altra ipotesi è, invece, quella della rappresentanza strettamente sostanziale, perché di natura sostitutiva: è il curatore che, direttamente, pone in essere l’atto necessario nell’interesse del bambino (ad es., sottoscrivendo il modulo di iscrizione a scuola). La nuova norma non esplicita in che misura venga liquidato il compenso del curatore e ciò perché questa figura può essere ricondotta all’alveo degli ausiliari del giudice nominati ai sensi dell’articolo 68 c.p.c. Ne consegue che la liquidazione è fatta con decreto dal giudice che lo ha designato (art. 52 disp. att. c.p.c.) e posta a carico di chi è tenuta a sostenerla (art. 53 disp. att. c.p.c.). In linea di principio, è spesa che il giudice può liquidare e porre a carico di entrambi genitori o di quello che, all’esito dell’incombente, sia risultato “soccombente”. Ove il curatore speciale assuma le vesti del difensore del minore, potrà depositare in nome e per conto del medesimo, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (il curatore speciale del minore che rivesta anche la qualifica di avvocato può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., potendo cumulare le due qualifiche - che restano, comunque, distinte - e non avendo necessità del formale conferimento a sé stesso della procura alle liti).
Il curatore speciale del minore è soggetto su cui grava l’obbligo di ascolto del minore, nei limiti di cui all’art. 473-bis. c.p.c. Orbene, come noto, nella maggior parte dei casi il curatore speciale è un avvocato specializzato che, peraltro, concentra in sé la qualifica di curatore e di avvocato del minore. Il codice deontologico forense vieta agli avvocati di procedere all’ascolto di una persona di minore età senza il consenso dei genitori (art. 56) ma questa norma non opera in presenza di una designazione giudiziale che assegna la qualifica di curatore speciale. La disciplina applicabile non richiama, in questo caso, l’art. 473-bis.5 (modalità dell’ascolto): ciò non esclude che il giudice possa dare indicazioni e precisare la metodologia dell’ascolto ove lo ritenga opportuno o necessario.
Altra distinzione che risulta dal dato normativo è quello tra apertura della curatela facoltativa e vincolata. In alcuni casi, infatti, è il Legislatore che configura, ex ante, la necessità del curatore (art. 473-bis.8, primo comma); in altri casi, la scelta è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (art. 473-bis.8, secondo comma[35]; art. 473-bi.7, secondo comma). In linea di principio, il Legislatore si muove nei binari che aveva già delineato la giurisprudenza di legittimità e costituzionale[36].
L’acquisita centralità del curatore non deve, però, sfociare nell’«abuso» di utilizzo di questa figura tenuto conto del fatto che esso rappresenta una significativa deroga alla regola generale della rappresentanza del figlio da parte dei genitori, diretta espressione della responsabilità genitoriale di cui sono titolari[37].
5. Procedimento di separazione e divorzio
In seno al nuovo titolo IV-bis (Libro II c.p.c.), la sezione VII disegna le disposizioni particolareggiate per i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni (artt. 473-bis.47 – 473-bis.51 c.p.c.). La cornice regolatoria è costituita da queste disposizioni, in combinato disposto con quelle dei Capi precedenti (norme generali, del giudizio di primo grado, del grado di appello). Orbitano nello spettro del nuovo rito unitario, ovviamente, anche le controversie che hanno ad oggetto la nullità del matrimonio.
5.1. Competenza territoriale
Le regole di competenza territoriale prevedono un criterio prioritario se “devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore” (art. 473-bis.11[38]): in questa ipotesi è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale[39], a salvaguardia della sua continuità affettivo relazionale[40]. Il criterio generale della residenza del convenuto (art. 18 c.p.c.) è, dunque, secondario (si applica in mancanza di minori coinvolti nel processo[41]). La residenza abituale del bambino deve essere decisa di comune accordo dei genitori, rientrando tra le questioni di particolare importanza[42]. Per non frustrare lo spirito della norma e per disincentivare trasferimenti attuativi di forme di “forum shopping”, è previsto che, in caso di trasferimento non autorizzato della residenza del minore, permanga la competenza del tribunale del precedente luogo di residenza, qualora il ricorso sia depositato entro l’anno[43].
Ci si è chiesti se in caso di declaratoria di incompetenza territoriale il giudice possa pronunciare provvedimenti provvisori[44]. Nel riparto di competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, il Legislatore è espressamente intervenuto nell’art. 38 disp. att. c.c.: 1) i provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario; 2) i provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. In questa ipotesi, però, la disciplina relativa alle misure interlocutorie si lega a doppio filo con il fatto che è in corso una translatio iudicii (il procedimento viene trasferito da un ufficio all’altro); ciò non accade per la competenza territoriale e, da qui, la mancanza di un regime analogo. Applicando in questa sede il principio del Legislatore consapevole dovrebbe propendersi per la esclusione dell’applicazione analogica del regime previsto dall’art. 38 disp. att. c.c. che, invero, regola una fattispecie processuale ben diversa (per quanto si è detto).
5.2. Il processo
Il procedimento regolato dal rito unitario si introduce con ricorso (secondo le regole generali: art. 473-bis.12 se promosso dalle parti; art. 473-bis.13 se promosso dal pubblico ministero) che deve essere redatto in modo chiaro e sintetico[45]; quale corollario, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda deve rispondere ai criteri di chiarezza e sinteticità[46] (art. 473-bis.12, primo comma, lett. e).
Il ricorso deve contenere: 1) l’indicazione del giudice (“l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta”), i riferimenti soggettivi della lite, le indicazioni relative ai minori o ai figli maggiorenni ma bisognosi di protezione (“il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono”; “il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura”), gli ulteriori elementi identificativi dell’azione (“la determinazione dell’oggetto della domanda” e “la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni”); 2) “l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione”.
Quali caratteri [47]di specialità, in questo caso:
1) Il ricorso deve indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse (e deve essere allegata la copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti).
2) In ogni caso, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
3) Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale[48] che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute)
Rispetto ai requisiti del ricorso, si segnala un refuso.
L’articolo 473-bis-51 c.p.c. prescrive che Il ricorso sia sottoscritto anche dalle parti e contenga “le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, c.p.c. (…)”. Il richiamo ai numeri 1), 2) 3) e 5) è un refuso legislativo perché l’art. 473-bis.12 presenta un elenco per lettere e non per numeri. Quindi i numeri 1), 2), 3) e 5) – citati nell’art. 473-bis.51 c.p.c. - devono essere letti come richiamo alle lettere a), b), c), e).
In linea con le scelte adottate anche per il rito ordinario generale, le preclusioni processuali e i termini per le difese si consumano in un momento anteriore all’udienza di prima comparizione, al fine di consentire una accelerazione del procedimento. La scelta adottata è, quindi, quella di far retroagire al momento della proposizione degli atti introduttivi, le preclusioni allegative e quelle probatorie, quando la controversia abbia ad oggetto diritti disponibili[49].
Parte attrice e parte convenuta si scambiano gli atti introduttivi (ricorso e comparsa di risposta) e, poi, hanno termini per le “ulteriori difese” (art. 473-bis.17 c.p.c.).
Il regime delle preclusioni processuali sortisce delle eccezioni (v. art. 473-bis.19):
1) le decadenze processuali previste (artt. 473-bis.14 e 473-bis.17) «operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili» (art. 473-bis.19, primo comma);
2) le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori;
3) le parti possono proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
Il procedimento, nella sua struttura, ricalca il modello tipo del procedimento in materia di famiglia. Il presidente con decreto nomina il giudice relatore e fissa l’udienza, avvisa e rende edotto il convenuto dei termini decadenziali che sono fissati alle sue difese, della necessità di munirsi di un difensore tecnico, potendo godere del patrocinio a spese dello Stato, della necessità di costituirsi entro trenta giorni anteriori l’udienza[50]. Su iniziativa dell’attore, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, copia del ricorso e decreto vengono notificati al convenuto, in modo di garantire dalla notifica all’udienza un termine a difesa non inferiore a sessanta giorni, con dilazione ulteriore per i casi in cui la notifica debba essere effettuata all’estero e salvo sanatoria, mediante rinvio della prima udienza, in caso di termine inferiore. Se l’orologio biologico del procedimento non è compatibile con esigenze indifferibili, il ricorrente può richiedere provvedimenti provvisori (cautelari): in questo caso, si attiva la fase interlocutoria d’urgenza prevista dall’art. 473-bis. 15 che confluisce in misure adottate inaudita altera parte.
A scanso di equivoci, va evidenziato che non è più prevista “l’udienza presidenziale”[51]: il Presidente attiva il procedimento ma, poi, consegna la “gestione” della procedura al giudice relatore (designato ai sensi dell’art. 473.bis.14, secondo comma). Ben inteso, non è escluso che la trattazione sia collegiale (v. artt. 473.bis.14, 473.bis.21) ma, evidentemente, la consuetudine già consolidata è nel senso di delegarla al giudice relatore.
Ogni procedimento – anche quello di separazione – si conclude, ora, con un modulo decisorio uniforme: la sentenza. Scompare, dunque, il “decreto” di omologa della separazione consensuale che viene sostituito da una decisione tipica decisoria.
Il modello procedimentale “comune” è quello di cui all’art. 473-bis.28 c.p.c.
Una volta esaurita l’istruzione, il giudice relatore fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini comuni per le attività difensive finali e precisamente:
1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
All’udienza la causa viene quindi rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è infine depositata nei successivi sessanta giorni.
Va da sé che, nel linguaggio processuale, l’udienza conclusiva del giudizio non sarà più “udienza di precisazione delle conclusioni” (che sono già state precisate nelle note), bensì udienza di rimessione della causa in decisione (secondo la precisa dizione dell’art. 473-bis.28, primo comma, c.p.c.).
5.3. Contemporanea proposizione delle domande di separazione e divorzio
Una straordinaria innovazione introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 riguarda la possibilità di contemporanea proposizione della domanda di separazione giudiziale e di quella divorzile.
Una premessa di teoria generale è opportuna. Come noto, si distingue tra presupposti processuali e condizioni dell’azione. I primi attengono all'esistenza stessa del processo, nonché alla sua validità e procedibilità, e devono sussistere prima della proposizione della domanda a pena di improponibilità. Al contrario, le condizioni dell’azione sono i requisiti di fondatezza della domanda, necessari affinché l'azione possa raggiungere la finalità concreta cui essa è diretta: è sufficiente che tali condizioni esistano al momento della pronuncia, e non necessariamente a quello della domanda[52]. La giurisprudenza, su alcune questioni, ha talvolta offerto letture diverse qualificando un fatto vuoi come condizione dell’azione, vuoi come presupposto processuale. La differenza non è solo dogmatica: se una condizione dell’azione non sussiste al momento della domanda ma si verifica prima della rimessione della causa in decisione, la domanda è comunque procedibile. Al contrario, se un presupposto processuale manca ab origine, la domanda è in ogni caso improponibile[53].
Ebbene, sulla scorta dell’orientamento costante della giurisprudenza[54], il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (anche vuoi solo a mezzo di decisione parziale sul solo status[55]) costituisce un presupposto della domanda di divorzio che, in suo difetto, è improponibile. Da qui, quale conseguenza logico-giuridica, l’improponibilità della domanda di divorzio unitamente alla richiesta di separazione, a prescindere dal suo passaggio in giudicato in itinere, durante il processo in regime di cumulo.
È qui che la Riforma Cartabia cambia pagina. L’art. 473-bis.49, infatti, introduce la possibilità del cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel dettaglio, il primo comma della norma in esame prevede la possibilità di proporre contemporanea domanda di separazione e di divorzio, precisando che il divorzio potrà essere pronunciato solo previa verifica dei presupposti richiesti dalla normativa vigente: la disposizione, in particolare, afferma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Ciò sta a significare che la domanda divorzile può essere presentata anche dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.
In virtù di questa disposizione, il divorzio potrà essere pronunciato solo dopo che già sia stata pronunciata, nel medesimo giudizio, la sentenza parziale di separazione, previo accertamento che tale decisione sia passata in giudicato e che sia trascorso il tempo richiesto (sulla base delle modifiche introdotte dalla l. 6 maggio 2015, n. 55, un anno) dalla comparizione delle parti dinanzi al giudice nel procedimento in esame (nel quale sono state proposte contemporaneamente le domande di separazione e divorzio). Qualora tali presupposti non dovessero essere sussistenti, la domanda di divorzio dovrà essere dichiarata improcedibile.
La norma, così delineata, potrebbe imporre un ripensamento della qualificazione giuridica del “giudicato sulla separazione”: la contemporanea proponibilità di entrambe le domande sembra voler dire che il passaggio in giudicato della separazione è, ora, non più presupposto processuale bensì condizione dell’azione; in questo modo, si eviterebbero aporie nella teoria generale del diritto processuale civile.
In concreto, l’attore, con il ricorso, presenta distinte conclusioni: con la prima, chiede dichiararsi la separazione dei coniugi, con pronuncia parziale sullo status; con la seconda, sul presupposto del passaggio in giudicato della decisione di separazione, chiede pronunciarsi il divorzio. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato (art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.).
La sentenza, per l’effetto, contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti (art. 473-bis. 49, ultimo comma). Viene quindi specificamente indicata la necessità di puntualizzare la diversa decorrenza dell’assegno di mantenimento o di divorzio in favore del coniuge o dell’ex coniuge debole, stante la rilevanza statistica di tali domande, e al fine di evitare possibili sovrapposizioni di pronunce, con potenziali problemi di contraddittorietà di giudicati e di controversie nella fase esecutiva[56].
L’art. 473-bis.49 recepisce, anche, talune prassi sviluppatesi negli uffici giudiziari all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 55 del 2015: se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40 c.p.c. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Inoltre, se questi procedimenti davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274 c.p.c.
5.4. Provvedimenti provvisori
Il nuovo rito della famiglia, anche se non prevede più i provvedimenti presidenziali, contempla l’espressa possibilità di provvedimenti temporanei (diretti a regolare le situazioni giuridiche soggettive nelle more del processo) o urgenti (per far fronte a situazioni improcrastinabili). Queste misure in itinere sono assunte con ordinanza dal giudice delegato nel contesto della più ampia trattazione del processo; infatti, alla prima udienza, il tribunale (giusta l’art. 473-bis.22 c.p.c.): 1) pronuncia le misure provvisorie e urgenti (“quando occorra”); 2) provvede sulle richieste istruttorie; 3) predispone il calendario del processo (per cui v. art. 81-bis disp. att. c.p.c.)[57]; 4) fissa la successiva udienza determinandone il contenuto (es. assunzione dei mezzi di prova ammessi)[58]. Nei procedimenti di separazione e divorzio, questa trama di regole si integra di alcune disposizioni particolareggiate, previste dall’art. 473-bis.50 c.p.c. In questi casi, infatti, il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473-bis.22, primo comma, «indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39».
I provvedimenti “urgenti” che il tribunale può adottare mantengono il loro carattere di atipicità, proprio per adattarsi alla situazione concreta che necessita di intervento; sono, inoltre, discrezionali essendo giustificati dal criterio di “opportunità” (“dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni”), con l’unico limite che devono mantenersi nella cornice formata dai “limiti delle domande da proposte dalle parti e dei figli” (art. 473-bis.22, primo comma).
In quest’ambito può essere interessante richiamare una recentissima novità legislativa che potrebbe arricchire l’arsenale di misure protettive del bambino in dotazione alla giurisdizione del giudice della famiglia. Il 30 gennaio 2023, la Commissione europea ha pubblicato la decisione (UE) di esecuzione 2023/201 che fissa l’entrata in funzione (tra l’altro) del Regolamento UE 2018/1862 dalla data del 7 marzo 2023[59]. Questo Regolamento[60] introduce il nuovo sistema di informazione Schengen (SIS)[61] che presenta una novità: nel sistema di allerta è possibile inserire una segnalazione («alert») anche riguardo a “minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, un familiare o un tutore a cui deve essere impedito di viaggiare” (nuovo articolo 32)[62]. Prima di questo nuovo strumento, la segnalazione era possibile se il minore era stato già sottratto: con il nuovo strumento sono ampliate le ipotesi che consentono l’inserimento dell’alert (ammessa in via precauzionale rispetto alla possibile sottrazione).
Si reputa che questa misura appartenga anche al giudice del procedimento ex artt. 473-bis e ss c.p.c. perché l’art. 32, par. 3, Reg. 2018/1862 espressamente precisa che “la segnalazione di un minore [a rischio di sottrazione] è inserita in seguito a una decisione delle autorità competenti, incluse le autorità giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di responsabilità genitoriale, in caso di rischio concreto ed evidente che il minore possa essere fatto uscire in modo illecito e imminente dallo Stato membro in cui hanno sede le autorità competenti”[63]. Il sistema di “allerta” può condurre a misure immediate atte ad impedire al minore di proseguire il viaggio (v. art. 33 Reg. 2018/1862): l’immediatezza è normativamente prevista perché, in questo caso, “gli uffici SIRENE[64] intervengono immediatamente” (art. 8, par. 3, Reg. 2018/1862). La segnalazione ha durata annuale, salvo possibilità di ulteriore durata a mezzo di proroga (v. art. 53, par. 4, Reg. 2018/1862) e può essere cancellata se “le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione prendono una decisione sull'affidamento del minore” (art. 55, par. 2, lett. a), Reg. 2018/1862)[65].
5.5. Procedimento su domanda congiunta
Nell’articolo 473-bis.51 c.p.c. la nuova disciplina uniforma il regime giuridico sotteso ai procedimenti che nascono da una domanda congiunta, vuoi che si tratti di coppia matrimoniale, vuoi che si tratti di convivenza di fatto e sia per accordi di separazione o divorzio, sia per modifiche dei patti raggiunti in precedenza.
In questi casi, la competenza può essere radicata presso il luogo di residenza dell’una o dell’altra parte. Anche se la norma sul punto tace, resta comunque competente anche il foro di residenza abituale del bambino, per il caso in cui questa non coincida con la residenza dei due genitori, dovendosi ritenere che l’art. 473-bis.51 introduca ulteriori criteri rispetto a quello generale (art. 473-bis.11). Al riguardo, la Relazione illustrativa[66] riporta che “in presenza di minori collocati fuori dalla famiglia di origine il procedimento congiunto non potrà riguardare i provvedimenti a tutela dei figli, che dovranno essere richiesti al tribunale ordinario o al tribunale per i minorenni con altro e diverso procedimento”. Ciò vale, per l’appunto, solo in presenza di limitazioni della responsabilità genitoriale non nel caso, invece, di mere circostanze o situazioni di vita familiare[67].
Nell’ambito di questi procedimenti, l’audizione del bambino è disposta dal giudice solo se necessario (art. 473-bis.4, ultimo comma[68]).
La domanda si introduce con ricorso sottoscritto anche dalle parti “e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”. L’articolo 473-bis-51, secondo comma, c.p.c. prescrive, come detto, che il ricorso contenga “le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5) (…)” ma come si è già fatto presente, il richiamo ai numeri 1), 2) 3) e 5) è un refuso legislativo perché l’art. 473-bis.12 presenta un elenco per lettere e non per numeri. Quindi i numeri 1), 2), 3) e 5) – citati nell’art. 473-bis.51 c.p.c. - devono essere letti come richiamo alle lettere a), b), c), e).
Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali[69]. Questa espressa previsione a favore anche dei trasferimenti immobiliari inclusi in schede negoziali di separazione o divorzio testimonia ancora una volta l’evoluzione ordinamentale nel senso di riconoscere sempre maggiore autonomia ai coniugi; come bene ha evidenziato la Dottrina, “il principio di libertà e di autoresponsabilità che ne risulta consacrato tratteggia come diritto potestativo, in senso sostanziale, il potere in capo ai coniugi di separarsi e di divorziare, di disciplinare i risvolti anche economici di dette scelte, nonché di modificare il regime ab initio concordato[70]”.
I procedimenti su domanda congiunta consentono alle parti di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte: in questo caso, però, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis.13, terzo comma (ossia, la documentazione economica richiesta nel caso di procedimento contenzioso).
A seguito del deposito, il presidente fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale esprime il proprio parere entro tre giorni prima della data dell'udienza. All'udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione. Il procedimento si conclude con sentenza “con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti”. Come già osservato, il modello decisorio viene uniformato nella forma della sentenza (non è, dunque, più previsto il decreto di omologa).
In caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio. Il giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.
6. Il processo minorile a gestione condivisa
Un principio che non è espressamente indicato dalle norme del nuovo rito è, in realtà, una delle anime che emerge in modo chiaro dal tessuto delle nuove disposizioni: il processo che riguarda i bambini deve intendersi a “gestione condivisa”. Si tratta, infatti, di un rito che, come detto, si muove a “tutele particolareggiate” in cui il campo d’azione ospita diversi protagonisti, ciascuno dei quali chiamato a profondere uno sforzo convergente verso il prevalente interesse del minore: il curatore speciale (ora con poteri anche sostanziali), il consulente (ora specializzato), il mediatore familiare (ore regolato con albo), il coordinatore genitoriale (ora previsto ex lege); soprattutto: l’avvocato, il giudice. Il fatto che il procedimento chiami tutti gli interlocutori a tener presente l’interesse dei bambini coinvolti muta in parte il rapporto tra il tribunale e l’avvocatura perché deve presumersi che entrambi i due interlocutori di giustizia tengano in considerazione gli interessi del bambino e, quindi, in quest’ottica, si ispirino al principio di leale collaborazione. In ciò, la gestione del procedimento – affidata al tribunale – diventa «condivisa» nel senso che il giudice, man mano, conduce il procedimento e coltiva le sue scelte coinvolgendo attivamente gli avvocati.
E ciò presuppone un rapporto di lealtà per cui molto utili paiono le recenti osservazioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione[71]: l’avvocato (…) è investito di una funzione di grande rilievo sociale, che esige da lui la massima professionalità. L’esercizio della giurisdizione non può avere luogo senza la reciproca e continua collaborazione tra avvocati e magistrati, che si deve fondare sul principio di lealtà; per cui, ove il professionista tradisca questa fiducia, potrà certamente essere chiamato a rispondere, in altra sede, del suo operato infedele; ma non si deve trarre dall’esistenza di possibili abusi, che pure talvolta si verificano, una regola di giudizio che abbia come presupposto una generale e immotivata sfiducia nell’operato della classe forense”.
Sono anche queste i principi essenziali del processo minorile: lealtà, collaborazione.
Le nuove norme sono uno “spartito” che il giudice – direttore d’orchestra – è tenuto ad eseguire nel modo migliore soprattutto pensando ai suoi ascoltatori principali: i bambini. E come in tutte le esecuzioni meglio realizzate, l’orchestra presuppone un lavoro di squadra, ciascuno nel suo ruolo. Anche perché, dopo tutto, da soli si può andare anche più veloci, ma insieme si va più lontano.
[1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2022, n. 243, S.O.
[2] Legge 29 dicembre 2022, n. 197: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” in Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303
[3] Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303.
[4] V. Milleproroghe 2023, prorogati i termini in materia di giustizia civile in Ilprocessocivile.it
[5] Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5).
[6] Cass. civ., sez. III, 24 agosto 2007, n. 17958
[7] Valga un esempio. Il Decreto modifica l’art. 37 (in tema di difetto di giurisdizione) prevedendo che “Nei giudizi di impugnazione [il difetto di giurisdizione] può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito”. Si tratta del recepimento della regola già invalsa nella giurisprudenza (v. ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n. 22349 del 2018).
[8] L’art. 473-ter c.p.c. introduce la regola generale della “immediata esecutività” dei decreti del giudice tutelare pronunciati in camera di consiglio. Tuttavia, resta immutato l’art. 741 c.p.c. in virtù del quale “i decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo”. Deve, dunque, ritenersi che per i decreti pronunciati in camera di consiglio: se del giudice tutelare, sono immediatamente esecutivi; altrimenti, sono efficaci decorsi i termini di cui all’art. 741 c.p.c. Forse, questa non era l’intenzione del Legislatore delegato perché, a dire il vero, è una differenza di regime un po' distonica.
[9] Comma così sostituito dall'art. 29, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
[10] V. ad es., Trib. Milano, sez. IX civ., 14 gennaio 2015)
[11] In particolare, il nuovo quarto comma recita: “Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figli!”
[12] Istituto noto come cd. mediazione giudiziale. Nella casistica giudiziaria, le ipotesi di procedimenti non contenziosi di queto tipo sono rarissime.
[13] Questo particolare aspetto è chiarito dalla Relazione illustrativa: “Il terzo comma, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 1 comma 22, lett. a) modifica il quarto comma dell’articolo 250 c.c., armonizzandolo con i principi che reggono il nuovo rito unitario in materia di procedimenti per le persone, i minorenni e le famiglie. A fronte del rifiuto del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio al riconoscimento da parte dell’altro, quest’ultimo può rivolgersi al tribunale del luogo di residenza abituale del minore. Il procedimento segue le norme delineate dal nuovo rito unitario; il giudice, in linea con quanto previsto dall’articolo 250 del codice civile nella sua attuale formulazione, può adottare, in ogni momento e dunque anche prima della decisione sullo status i provvedimenti ritenuti opportuni per instaurare la relazione tra il figlio colui che ha richiesto il riconoscimento” (Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5)
[14] V. Trin. Milano, 26 giugno 2013 in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9318 - pubb. 22/07/2013: “In materia di azione ex art. 269 c.c., la competenza si radica nel luogo di residenza del convenuto (Cass. Civ. 1373/1992, Sez. Un.; Cass. Civ., 11021/1997: precedenti che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non rintracciandosi, peraltro, nel codice di rito, un foro del “concepimento” e nemmeno potendosi ritenere prevalente la tutela del minore, in quanto la causa ha ad oggetto la paternità biologica che, se accertata, legittima le domande nell’interesse della prole, per le quali, sì, opera il foro di residenza del minore (es. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.p.c.)”
[15] Danovi F., Le ragioni per una riforma della giustizia familiare e minorile in Famiglia e Diritto, 2022, 4, 327
[16] V. ad es., Carratta A., Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Famiglia e Diritto, 2022, 4, 350
[17] Una delle ipotesi di illecito endofamiliare ormai ben tipizzata dalla giurisprudenza è quella della violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c.: essa, secondo il diritto pretorile vigente, costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare. Interessante anche evidenziare come, sempre secondo la linea di pensiero dei giudici, questa tipologia di danno è risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (Cass. civ., 28 novembre 2022 n. 34986)
[18] Se ne dà atto anche nella relazione illustrativa a proposito dell’art. 473-bis.49 c.p.c.: v. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5
[19] Cecchella C., Il nuovo processo familiare e minorile nella legge delega sulla riforma del processo civile in Questione Giustizia
[20] V. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario: Relazioni sulle novità normative della riforma “Cartabia” (diritto e procedura civile), 2023, 236
[21] Ex multis, in tema di minore come “parte” del processo (in senso formale o sostanziale), v. Cass. civ. 6 dicembre 2021 n. 38719
[22] “Le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato”. Questa norma costituisce, ormai, l’acquis del diritto europeo. Ad esempio, è anche ripresa nella recente proposta della Commissione europea, del 7 dicembre 2022, di Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (art. 15 della proposta).
In Dottrina, v. in particolare: Musseva Boriana, The recast of the Brussels IIa Regulation: the sweet and sour fruits of unanimity in ERA Forum Volume 21 (2020), 1. La Prof.ssa Musseva ha presieduto proprio il negoziato sul recast di Bruxelles II-bis, durante la Presidenza del Consiglio dell’UE nel semestre della Bulgaria.
[23] Questa norma recepisce anche le indicazioni del Consiglio d’Europa: “L’essere ascoltato è un diritto del minore, non un dovere da imporgli” (Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, punto n. 46).
[24] Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia raccomanda che i minori siano ascoltati direttamente. Commento generale n. 12 sul diritto del minore di essere ascoltato (CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009), par.35 35.
[25] V. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5
[26] V. Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, punto n. 115
[27] V. ad es., Corte EDU, 8 luglio 2003, Sahin v. Germania (n. 30943/96)
[28] Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)
[29] “La videoconferenza potrebbe inoltre essere usata per ascoltare un minore come previsto dal regolamento (UE) 2019/1111”: così Cons. 21, Regolamento (UE) 2020/1783 del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione)
[30] In data 9 dicembre 2022: v. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/12/09/digital-justice-council-adopts-negotiating-mandates-on-two-proposals-to-digitalise-judicial-cooperation-and-access-to-justice/
[31] V. il Considerando n. 21-a: “Qualora un minore partecipi a procedimenti in materia civile o commerciale, in particolare in qualità di parte, a norma del diritto nazionale, il minore potrebbe partecipare all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma del presente regolamento, tenendo conto dei suoi diritti procedurali. Tuttavia, se il minore partecipa al procedimento ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, ad esempio se deve essere ascoltato in qualità di testimone, il minore potrebbe essere ascoltato anche mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma del Regolamento (UE) 2020/1783”.
[32] G. Ruffini, Il processo civile di famiglia e le parti: la posizione del minore, in Dir. fam. pers. 2006, 1258-1259
[33] D’Amato D., Il curatore speciale del minore alla luce della riforma del processo civile in Rivista di diritto processuale, 2022, 4, 1317
[34] Cass. civ., sez. 2, 3 gennaio 2019 n. 9
[35] Il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Per Cass. civ, 11 maggio 2018, n. 11554 «la sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ai fini della nomina del curatore speciale, in un procedimento nel quale si discuta del suo affidamento, deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all’incapacità , anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio, non potendosi desumere la sussistenza del conflitto di interessi dalla mera conflittualità interna tra i genitori ove risulti la loro piena capacità ed una buona relazione con il minore».
[36] Spicca, per importanza: Corte cost. 11 marzo 2011, n. 83, in Fam. e dir. 2011, 545 ss., con nota di F. Tommaseo, La Corte costituzionale sul minore come parte nei processi della giustizia minorile
[37] D’Amato, opera cit.
[38] “La norma costituisce espressione dei principi sovranazionali in materia (Reg. UE 1111/19; Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori conclusa all’Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101) e di quelli espressi dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass., ord. 7 giugno 2021, n. 15835)”. Così: Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5
[39] Il concetto di residenza abituale fa capo a una situazione di “fatto” che prescinde dalle risultanze anagrafiche e si determina in base al luogo in cui il bambino ha la sede prevalente dei suoi interessi ed affetti. Essendo una situazione “di fatti”, l’accertamento della residenza abituale si risolve in una “quaestio facti” (Cass. civ., Sez. Un., 13 dicembre 2018 n. 3239). Si tratta di una nozione ormai adottata (e simile) sia in ambito europeo (habitual residence, résidence habituelle) che nazionale e fa leva sul dato esperienziale per cui i giudici del luogo di residenza abituale si trovano di norma nella migliore posizione per valutare le misure da adottare nell’interesse del minore (Corte Giust. UE, 14 luglio 2022, C-572/21). La residenza abituale è, dunque, criterio per determinare sia la competenza territoriale (a livello nazionale) che la competenza giurisdizionale (a livello UE e internazionale).
[40] Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 5 giugno 2017, n. 13912; Cass., 22 luglio 2014, n. 16648 del 2014).
[41] In tal senso va letto il secondo comma dell’art. 473-bis.11 c.p.c. che prevede in sostanza, che in assenza di figli minori, il tribunale territorialmente competente sia individuato in base ai criteri generali degli articoli 18 e seguenti.
[42] Come ora risulta espressamente dal testo dell’art. 316 c.c., come novellato dal dlgs 149/22
[43] Questa è la chiara spiegazione della norma offerta dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5. Si precisa anche che “la fissazione di un termine, decorso il quale la competenza spetta al giudice del nuovo luogo di residenza del minore pure in presenza di trasferimenti non autorizzati, risponde alla necessità di superare alcune incertezze interpretative (Cass., ord. 20 ottobre 2015 n. 21285) ed è espressione dei principi generali della normativa sovranazionale (art. 9 Reg. UE 1111/19 e art. 7 conclusa all’Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101)”.
[44] V. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario: Relazioni sulle novità normative della riforma “Cartabia” (diritto e procedura civile), 2023, 237
[45] Nuovo art. 121 c.p.c. come modificato dal dlgs n. 149 del 2022
[46] Il mancato rispetto di questi criteri può essere valutato ai fini della decisione sulle spese del processo (v. nuovo art. 46 disp. att. c.p.c.: “Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari”)
[47] La regola generale (art. 473-bis. 12, terzo comma) prevede che questi document debbano essere presentati solo in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori. L’art. 473-bis.58, tuttavia, prescrive che “Nei procedimenti di cui alla presente sezione, al ricorso e alla comparsa di costituzione e risposta è sempre allegata la documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma”
[48] “Il piano genitoriale consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, degli elementi principali, che la norma espressamente individua, del progetto educativo e di accudimento del minore. Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice, investito del procedimento, di individuare e dettagliare all’interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più opportune nell’interesse del minore, costruite “su misura” rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate” (Rel. Ill.)
[49] Carratta A., Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile, in Famiglia e Diritto, 2022, 4, 352
[50] Si tratta degli avvisi sui termini decadenziali che l’attore, per i processi che si introducono con citazione, deve precisare nell’atto ai sensi dell’articolo 163, 3° comma, n. 7, c.p.c.
[51] In alcuni commenti alla delega legislativa, si ipotizzava che, invece, l’udienza presidenziale sarebbe rimasta nel regime giuridico: v. Vullo E., Nuove norme per i giudizi di separazione e divorzio, in Famiglia e Diritto, 2022, 4, 358
[52] per tutte, Cass. n. 21100 del 2004
[53] Un caso, ad esempio, riguarda la domanda di scioglimento della comunione legale proposta in pendenza del giudizio di separazione. Sulla questione, la Corte di Cassazione si è, in genere, pronunciata affermando che l'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione, prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o dell'omologa di quella consensuale), comporta l'improponibilità della domanda (tra le altre, Cass. n. 4351 del 2003; n. 9325 del 1998; n. 8707 e 11931 del 1997). Al contrario, altro indirizzo (Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 26 febbraio 2010 n. 4757), qualificando il fatto della separazione come mera “condizione”, ha affermato che “la domanda di scioglimento della comunione legale può essere proposta anche in pendenza della causa di separazione tra i coniugi. La pronuncia di merito acquisterà però efficacia solo se interviene dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione”.
[54] V. ad es., Cass. civ. n. 36176 del 2021
[55] Da ormai molto tempo, la Suprema Corte ha chiarito che la domanda parziale sulla separazione è ammissibile (Cass. civ., Sez. Un. n. 15279 del 2011).
[56] Così Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5)
[57] La Riforma, modificando l’art. 81-bis disp. att. c.p.c. ha previsto che “Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità”
[58] Come si è osservato, “la prima udienza nel nuovo rito per le persone, per i minorenni e per le famiglie diventa lo snodo centrale del giudizio” (Costabile, Procedimento: la prima udienza in IlFamiliarista.it)
[59] Decisione di esecuzione (UE) 2023/201 della Commissione del 30 gennaio 2023 che fissa la data di entrata in funzione del sistema d'informazione Schengen ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio
[60] Regolamento (UE) 2018/1862 del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione
[61] Per l’Italia, l’ufficio competente: Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione Centrale della Polizia Criminale — Servizio per il Sistema Informativo Interforze — Divisione N.SIS
[62] Art. 32. Obiettivi e condizioni per l'inserimento delle segnalazioni. 1. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro segnalante, sono inserite nel SIS segnalazioni sulle seguenti categorie di persone: (…) c) minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, un familiare o un tutore a cui deve essere impedito di viaggiare;
[63] V., anche, il Considerando n. 32: “Le segnalazioni di minori a rischio di sottrazione da parte di uno dei genitori dovrebbero essere inserite nel SIS su richiesta delle autorità competenti, incluse le autorità giudiziarie competenti in materia di responsabilità genitoriale conformemente al diritto nazionale. Le segnalazioni di minori a rischio di sottrazione da parte di uno dei genitori dovrebbero essere inserite nel SIS laddove tale rischio sia concreto ed evidente, e in limitate circostanze. É, pertanto, necessario prevedere garanzie rigorose e adeguate. Nel verificare se sussista un rischio concreto ed evidente che un minore possa essere fatto uscire in modo illecito e imminente da uno Stato membro, l'autorità competente dovrebbe tenere conto della situazione personale del minore e dell'ambiente a cui è esposto”.
[64] In virtù del SIS (v. art. 7, Reg. 2018/1862), ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale, operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che garantisca lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari («ufficio SIRENE»)
[65] Più nel dettaglio, si ha cancellazione: “alla risoluzione del caso, ad esempio se il minore è stato reperito o rimpatriato o le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione prendono una decisione sull'affidamento del minore”
[66] Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in Gazz. Uff. 19.10.2022, serie gen. n. 245, suppl. ord. n. 5)
[67] Si pensi al caso di un bambino, che per le più svariate ragioni, abbia provvisoriamente dimora presso i nonni
[68] Art. 473-bis. 4, terzo comma, c.p.c.: “Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario”
[69] È la ripresa di quanto ha affermato la giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., SS.UU. 29 luglio 2021, n. 21761
[70] Spadafora A., Autonomia privata nei rapporti familiari in Enciclopedia del Diritto, I tematici, IV-2022, 76
[71] Cass. civ., Sez. Un., 9 dicembre 2022 n. 36057
Le Sezioni Unite e i figli nati da maternità surrogata: una decisione di sistema. Ancora qualche riflessione sul principio di effettività nel diritto di famiglia[1]
di Mirzia Bianca
Sommario: 1. Riflessioni preliminari. - 2. Perchè si tratta di una decisione di sistema? L’ultima tappa di un lungo percorso - 3. Le ragioni della decisione e i diversi piani di lettura - 4. Il piano di lettura del principio di effettività.
1. Riflessioni preliminari
Il problema dei figli nati da maternità surrogata praticata all'estero da qualche anno affatica i giudici delle Corti nazionali ed europee alla ricerca della individuazione di un difficile equilibrio tra esigenze prima facie assolutamente inconciliabili: la conservazione del divieto della maternità surrogata e la realizzazione del miglior interesse del minore a vedersi riconosciuta la genitorialità di intenzione, ovvero la genitorialità del partner del genitore biologico che ha con questi condiviso il progetto genitoriale, pur non essendo genitore di sangue. Come è evidente, rispetto al passato la corte degli attori coinvolti è cambiata. Negli anni ‘70 e ‘80 il dibattito intorno alla maternità surrogata vedeva protagoniste in conflitto di interessi la madre committente e la madre uterina. Oggi, invece, i protagonisti del dibattito sono esclusivamente i genitori committenti e in particolare il problema attiene al riconoscimento del solo genitore di intenzione, sia esso il componente di una coppia omoaffettiva o di una coppia eteroaffettiva. La frizione tra le due rilevate opposte esigenze, che è emersa con chiarezza dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale[2] e della Cassazione a Sezioni Unite nella decisione n. 38162 del 30 dicembre 2022 che qui si commenta[3], si è tradotta plasticamente nella contrapposizione tra due opposte soluzioni: la trascrizione automatica del provvedimento straniero o l'adozione. Deve dirsi che questo dibattito, che affatica l'interprete da circa un decennio, è solo un segmento di quello di più ampia portata relativo ai diversi modelli di instaurazione della filiazione ed esso appare peculiare. In primo luogo perchè lo spostamento della pratica procreativa all'estero ha portato necessariamente ad una delocalizzazione[4] del dibattito che ha assunto profili del tutto diversi rispetto a quello ordinario sul divieto della maternità surrogata, implicando riflessioni di diritto internazionale privato e di rapporto tra gli ordinamenti. In secondo luogo perchè il problema attiene esclusivamente al riconoscimento del genitore di intenzione, dato che non si pongono problemi rispetto al genitore biologico, ovvero il genitore che utilizzando questa pratica ha dato il proprio materiale genetico. In terzo luogo perchè il dibattito è stato spesso inquinato dalla sovrapposizione dei diritti dei bambini con problemi degli adulti, come per esempio l'accesso alle pratiche procreative da parte delle coppie omoaffettive e la violazione del principio di non discriminazione[5]. In quarto luogo perchè almeno in Italia l'assenza di un intervento del legislatore, insieme alla mancanza di una moderna legge sull'adozione, a differenza di altri Paesi dell'Europa che hanno di recente legiferato[6], ha portato inevitabilmente a caricare tutto il peso del dibattito sulla giurisprudenza, che ha condotto un percorso talvolta accidentato e disseminato da vari ostacoli, che non ho avuto remore a chiamare “travagliato”[7]. La decisione che qui si annota rappresenta l'ultimo tassello di questo tortuoso percorso. Ho voluto fare queste precisazioni quale premessa fondamentale per capire l'importanza di questa decisione e il contesto ordinamentale in cui essa è inserita. Avendo già partecipato a questo dibattito con note a qualche significativa decisione[8], sarebbe stato preferibile da parte mia non intervenire anche adesso. La ragione per cui, leggendo questa decisione a Sezioni Unite, ho sentito la voglia di dedicare alcune riflessioni, cercherò di spiegarla nelle pagine che seguono. Posso solo anticipare che, a mio parere, con questa decisione la Corte di Cassazione ha tolto all'interprete la sensazione di incertezza che da tempo caratterizza l'attuale stagione del diritto di famiglia, contribuendo a definire una nuova stagione caratterizzata dalla speranza nella individuazione di un sistema di principi che, rappresentando le assi portanti del moderno diritto di famiglia[9], facilitano un dialogo tra le Corti, dialogo che in questa decisione appare a chi scrive connotato da ragionevolezza e da equilibrio.
2. Perchè si tratta di una decisione di sistema? L’ultima tappa di un lungo percorso
Come emerge dal titolo che ho voluto dare a questa mia nota, il dato caratterizzante di questa decisione a Sezioni Unite è che si tratta di una decisione di sistema. Prima di spiegare perchè, può essere utile per il lettore indicare, sia pure sinteticamente, le tappe di questo suggestivo ma, come detto, travagliato percorso giurisprudenziale, di cui questa decisione rappresenta l'ultima tappa. Nel silenzio del legislatore, una prima tappa di questo percorso è stata la decisione a Sezioni Unite del 2019 n. 12193 con la quale la Corte di cassazione, pur rifiutando la soluzione della trascrizione automatica per violazione del principio di ordine pubblico, si preoccupa della sorte dei figli nati da maternità surrogata, ritenendo adeguata la soluzione dell'adozione in casi particolari, meglio conosciuta come Stepchild Adoption. Nell'affermare la contrarietà all'ordine pubblico, la Corte ribadisce la riprovazione nei confronti della maternità surrogata, considerata in questa decisione, come in altre, pratica lesiva della dignità della donna e dell'istituto dell'adozione, oltre che strumento di sfruttamento della vulnerabilità femminile. A livello di giurisprudenza europea, la Corte europea dei diritti dell'uomo conferma la non obbligatorietà della scelta della soluzione della trascrizione automatica e la discrezionalità degli Stati nella scelta di una soluzione alternativa, ponendo il solo limite della individuazione di uno strumento celere ed efficiente. Una seconda tappa è stata la decisione della Corte costituzionale n. 33 del 2021[10]. In questa decisione la Corte ritiene non fondata la questione di legittimità dell'art. 12, comma 6 della legge 40, ribadendo l'importanza del mantenimento del divieto della maternità surrogata. La Corte ritiene tuttavia che la soluzione dell'adozione in casi particolari non sia da ritenersi del tutto adeguata a realizzare il migliore interesse del minore. Ciò in particolare in quanto questo istituto, a differenza dell'adozione piena e legittimante, richiede il consenso del genitore biologico e non determina l'instaurazione di rapporti di parentela. In questa decisione la Corte sollecita l'intervento del legislatore. La terza tappa è l'ordinanza della prima sezione civile della Corte di Cassazione n. 1842 del 2022, che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Qui la Corte, preso atto del silenzio del legislatore e della riconosciuta inadeguatezza dello strumento dell'adozione in casi particolari rilevata dalla Corte costituzionale, sollecita una decisione a Sezioni Unite per rispondere ad una serie di quesiti. Tra questi quello relativo al superamento del diritto vivente (espresso dalla Sezioni Unite nel 2019) con la conseguente affermazione di un vuoto normativo. Sul fronte del divieto della maternità surrogata, la Corte entra nel merito delle ragioni del divieto e cerca di scomporre la monoliticità del divieto e della conseguente violazione dell'ordine pubblico, proponendo una selezione di modelli di maternità surrogata non contrari all'ordine pubblico e quindi legittimanti la soluzione della trascrizione automatica. La quarta e ultima tappa è quella della decisione a Sezioni Unite oggetto di attenzione in queste pagine. La decisione che qui si commenta si è trovata in questo guado ordinamentale e, utilizzando tutti i dati del diritto effettivo che aveva a disposizione, ha dato una risposta sistematica e coerente che, nel ripercorrere tutti i passaggi della giurisprudenza, non ha mai smentito il passato, ma ha confermato i passi precedenti, integrandoli via via che il sistema ha mostrato segni di evoluzione. Inoltre questa decisione ha mostrato che in questa materia la giurisprudenza interna non si pone in conflitto ma dialoga con la giurisprudenza europea. Per queste ragioni a mio parere è una decisione di sistema, perché le ragioni poste a fondamento della soluzione prescelta non hanno nulla di ideologico, ma riconducono tutto a sistema, con un'operazione culturale di ricucimento delle varie tappe, che appaiono quindi portate tutte ad unità e coerenza. Questa decisione, al di là delle poche critiche che possono ad essa muoversi, assume così un importante valore simbolico perché si pone quale modello di giurisprudenza virtuosa che ingenera nell'interprete un sentimento di fiducia nel principio di effettività, talvolta messo a dura prova da orientamenti ondivaghi e troppo spesso contraddittori.
3. Le ragioni della decisione e i diversi piani di lettura
L'attributo di decisione di sistema non attiene esclusivamente al tema della filiazione derivante da maternità surrogata, ma si estende a tutti i temi satellitari che questa delicata problematica evoca e che sono sintetizzabili nei diversi piani di lettura di questa decisione. I diversi piani di lettura sono: a) il contenuto e la portata del divieto della maternità surrogata; b) il contenuto del principio di dignità; c) la nozione e il contenuto dell'ordine pubblico; d) il contenuto del principio del migliore interesse del minore; e) l'evoluzione in materia di adozione in casi particolari; f) la definizione dei limiti della genitorialità di intenzione; g) il principio di effettività e il ruolo della giurisprudenza. Ciascuno di questi piani di lettura si presterebbe a note di commento autonome. In questa sede non è chiaramente possibile. Ciò che invece mi preme qui evidenziare è che in questa decisione tutti i piani di lettura sono stati composti in un piano armonico ed unitario, dal quale non risulta alcuna distonia del sistema ma, anche con riferimento a tematiche distinte, l'interprete ha finalmente la sensazione di una visione coerente e unitaria, come quella che si ha quando si ammira un paesaggio dall'alto di una veduta aerea. Procederò così ad analizzare ciascuno dei piani di lettura evidenziati sinteticamente e solo al fine di far emergere la sistematicità di questa decisione. Dedicherò un paragrafo a parte all'ultimo piano di lettura, quello attinente al principio di effettività e al ruolo della giurisprudenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che con fermezza la Corte risponde negativamente ai primi quesiti sollevati in ordine al superamento del diritto vivente e all'esistenza di un vuoto normativo. Entrando nel merito delle questioni a) con riferimento alla maternità surrogata le Sezioni Unite respingono la suggestione contenuta nell'ordinanza della prima sezione in ordine alla scomposizione di diversi statuti della maternità surrogata e riaffermano il carattere monolitico del divieto, che vale anche nel caso in cui la maternità surrogata sia frutto di una libera scelta della donna e sia revocabile. L'affermato carattere monolitico del divieto non è tuttavia frutto di una presa di posizione precostituita ma raccoglie i dati del diritto effettivo. Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale si riscontra un orientamento compatto che ha sempre riprovato questa pratica procreativa, in quanto ritenuta lesiva della dignità della donna e dell'istituto dell'adozione. La riprovazione di questa pratica appare compatta anche a livello di Paesi dell'Unione europea, fatta eccezione per quei pochi che ne ammettono la liceità. Inoltre deve rilevarsi che l'Unione europea, che già nel 2015 aveva condannato tale pratica inserendola nel dibattito dei diritti umani, ha di recente confermato e rafforzato tale giudizio anche in occasione della guerra in Ucraina, che ha enfatizzato il profilo dello sfruttamento delle donne, focalizzando l'attenzione su quella che a ragione è stata definita come una “un'industria” che lede la dignità della donna e del soggetto nato[11]. Nella motivazione della sentenza la condanna della maternità surrogata è ferma e riferita ad ogni modello di maternità surrogata: liberale[12], consapevole e libera, commerciale, in quanto il dato della illiceità è fondato condivisibilmente sulla rinuncia della donna alla maternità[13]. Tale affermazione consente alla Corte a Sezioni Unite di prendere posizione anche rispetto b) al principio di dignità, principio di cui si afferma qui la valenza oggettiva[14]. La nota vicenda del lancio dei nani della giurisprudenza amministrativa francese ha schiuso un dibattito tra due opposte nozioni della dignità: una meramente soggettiva, mutabile e derogabile in ragione del diverso soggetto coinvolto e una oggettiva, che valga per tutti e che non è derogabile neanche nel caso di una libera scelta del soggetto leso nella propria dignità[15]. La riaffermata riprovevolezza nei confronti della maternità surrogata, in quanto pratica lesiva del principio di dignità, dà ragione del mantenimento del divieto. Il mantenimento del divieto trova ragione in una scelta precisa dell'ordinamento italiano e non è il frutto di una arretratezza o di una dimenticanza del legislatore. L'interprete coglie un principio di continuità con scelte condotte dal giudice delle leggi, che non solo ha sempre mostrato di riprovare questa pratica, ma anche quando ha rimosso il divieto della fecondazione eterologa, ha mantenuto quello della maternità surrogata[16]. L'interprete coglie inoltre una continuità con la disciplina di Paesi contigui. Anche il legislatore francese, che di recente è intervenuto con la legge sulla bioetica[17], ha scelto comunque di mantenere il divieto. L'interprete coglie poi la conformità con il costante giudizio di riprovazione di questa pratica a livello di legislazione europea.
c) Quanto al principio di ordine pubblico[18], la Corte, ne afferma chiaramente la violazione e si esprime anche sul suo contenuto. L'ordine pubblico, sebbene si sia evoluto in una dimensione più ampia rispetto al ristretto ambito nazionale, deve “misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale”. La Corte, utilizzando tale formula, si pone in una linea di continuità con quanto le Sezioni Unite hanno già affermato, sia con riferimento alla questione dei figli nati da maternità surrogata[19], sia con riferimento alla questione del riconoscimento di una sentenza straniera in materia di danni punitivi[20]. L'interprete si sente così rassicurato, in quanto consapevole che questa decisione non è una scheggia impazzita, ma parte di un disegno unitario e coerente. d) Anche con riferimento all'incerta formula del migliore interesse del minore, le Sezioni Unite prendono una posizione equilibrata e condivisibile. In primo luogo il migliore interesse del minore viene considerato anch'esso principio di ordine pubblico internazionale. Qui viene dato ascolto alla dottrina che aveva rifiutato una impostazione conflittuale della problematica dei figli nati da maternità surrogata, volta a contrapporre l'ordine pubblico con il migliore interesse del minore[21]. Inoltre, e questo è il dato più importante, ne viene affermato il carattere necessariamente concreto. Il migliore interesse del minore non è mai una formula astratta ma deve necessariamente fare i conti con la situazione concreta di quel singolo bambino, situazione che non è mai uguale a se stessa. Per queste ragioni le Sezioni Unite respingono la soluzione della trascrizione automatica, in quanto cristallizzerebbe una presunzione di migliore interesse applicabile a priori per tutte le situazioni. Nel rifiutare la soluzione della trascrizione automatica, inoltre, le Sezioni Unite si pongono in conformità con l'orientamento della giurisprudenza europea che ha sempre lasciato ampia discrezionalità ad ogni Stato, escludendo l'obbligatorietà della soluzione della trascrizione automatica. e) Con riferimento alla soluzione dell'adozione in casi particolari, le Sezioni Unite, non si limitano a confermare il diritto vivente già espresso nel 2019, ma lo adattano all'evoluzione nel frattempo operata dal sistema. L'intervenuta decisione del giudice delle leggi che nel 2022, con la decisione n. 79, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55 l. adoz., ha consentito infatti alle Sezioni unite di considerare questa importante tappa evolutiva e di superare le critiche in ordine alla mancanza di un rapporto di parentela. Quanto alla critica in ordine al necessario consenso del padre biologico richiesto dalla disciplina dell'adozione in casi particolari, che potrebbe subordinare la richiesta di genitorialità alla situazione conflittuale tra genitore biologico e genitore di intenzione, lasciando quindi al solo padre biologico la scelta, le Sezioni Unite, sempre riferendosi al diritto effettivo, affermano che tale consenso non può essere inteso come l'esercizio di un potere arbitrario, “potestativo”, in quanto il giudice deve controllare che il rifiuto dello stesso sia conforme al migliore interesse del minore. f) Infine mi sembra che le Sezioni Unite in questa decisione abbiano portato a sistema i requisiti per il riconoscimento della genitorialità di intenzione. Per genitorialità di intenzione, non si intende infatti la traduzione letterale di genitorialità di volontà, ma una genitorialità non di sangue che tuttavia si caratterizza per due requisiti importanti che sono l'esistenza di un progetto genitoriale e la presenza di un concreto legame affettivo. La decisione a Sezioni Unite ci ricorda che tutti questi elementi devono essere presenti affinché possa essere riconosciuta una genitorialità non di sangue[22]. L'interprete si accorge chiaramente che questa soluzione compone con coerenza ed equilibrio altre ipotesi di genitorialità di intenzione, come quella adottiva. Anche qui, al fine di realizzare il migliore interesse del minore, il sistema rifiuta ogni automatismo e instaura una procedura che, oltre a prevedere un tempo dell'affidamento preadottivo, demanda al giudice il controllo in ordine alla capacità affettiva degli adottanti e quindi alla realizzazione del migliore interesse del minore.
4. Il piano di lettura del principio di effettività
L'analisi dei diversi piani di lettura mostra all'interprete uno scenario in cui questa decisione è parte di un sistema di diritto effettivo coerente. Per queste ragioni si tratta di una decisione che è il frutto dell'applicazione del principio di effettività, che rappresenta l'ultimo importante piano di lettura di questa ricca e complessa decisione. Potremmo dire che la metodologia sostanzialistica del principio di effettività, espresso nella formula “Ex facto oritur ius”[23] emerge dalla metodica che è stata seguita nella stesura di questa decisione che, in relazione ai vari piani di lettura evocati da questa complessa problematica, applica con coerenza e continuità quello che è l'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza, non solo interna ma anche europea. La formula del diritto che emerge dal fatto e dalla realtà delle cose trova qui piena ed espressa applicazione, in quanto il diritto che si applica non è semplicemente la norma giuridica, ma la norma giuridica così come essa è interpretata dalla giurisprudenza. Ma il rinvio al principio di effettività entra anche nella motivazione di questa decisione che coglie l'occasione per rimeditare sul contenuto di questo principio e sul ruolo assegnato alla giurisprudenza. Si legge infatti in motivazione che “la giurisprudenza non è fonte del diritto”. Questa affermazione evoca le elaborazioni più raffinate del principio di effettività che, pur riconoscendo nella giurisprudenza il canale per veicolare le rinnovate istanze della realtà sociale, hanno ribadito che la giurisprudenza non è fonte formale del diritto e in questo senso essa non si sostituisce al legislatore[24]. Significativo al riguardo un passaggio della motivazione: “Si tratta di temi, infatti, in rapporto ai quali lo stesso diritto di famiglia, nel mentre riflette, come uno specchio, lo stato dell’evoluzione delle relazioni familiari nel contesto sociale, tuttavia non può prescindere dal sistema, affidato anche alle cure del legislatore”. Queste importanti riflessioni sul principio di effettività nel diritto di famiglia offrono all'interprete gli strumenti per affinare il contenuto dello stesso, proprio in materie come questa in cui la forza del fatto si manifesta con maggiore incidenza rispetto ad altri settori del diritto, assumendo talvolta il vigore e l'ineluttabilità del fatto compiuto. Sono infatti proprio problematiche delicate e a così alto contenuto etico che consentono di riflettere ancora sul principio di effettività e di integrarne i contenuti, anche alla luce della avvertita complessità del sistema. Tale principio, che rappresenta l'ossatura portante di una metodologia sostanzialistica del diritto, e che trova proprio nel diritto di famiglia una costante applicazione, non può tuttavia prescindere da due caratteri, che sono a mio parere la coerenza e la gradualità. Quanto alla coerenza[25], deve dirsi che la forza del principio di effettività intanto può spiegarsi in quanto il diritto che emerge dal fatto esprima un sistema coerente di principi. Il pericolo della sua scomparsa o della sua dissoluzione si annida in un sistema in cui si azzera il dialogo tra le Corti e in cui ognuna di esse crea diverse monadi giuridiche, tra loro incomunicabili, deriva che ingenera nell'interprete un sentimento di perenne smarrimento. L'incoerenza si traduce poi in ultima istanza inevitabilmente in una negazione della verità[26] e della giustizia. Quanto all'attributo della gradualità, esso emerge da un passaggio della motivazione di questa decisione laddove si afferma che “...la ricerca dell’effettività richiede un camminare in direzione di una meta non ancora completamente a portata di mano, perché la gradualità concorre a far assorbire il cambiamento e le novità nel sistema, con la giurisprudenza che accompagna ed asseconda l’evoluzione che si realizza nel costume e nella coscienza sociale”. E' proprio la mobilità del diritto di famiglia e il suo saldo legame con le istanze della società e con il costume che chiama in causa il valore della gradualità, perchè la verità è che i cambiamenti culturali e sociali sono quelli che richiedono una più profonda elaborazione da parte della società, elaborazione che spesso è inconsapevole. Per questo si comprende perchè autorevole dottrina, pur affermando il valore del principio di effettività, ha riconosciuto nell'intervento del legislatore la forza di incentivare il processo di evoluzione della società e dei costumi[27].
Potrei continuare ancora ad enumerare altre ragioni per le quali questa è una decisione di sistema, ma credo che ormai il lettore ha capito il perchè e soprattutto ha capito perchè questa decisione mi piace.
[1]Dedico anche questo mio scritto al mio caro ed adorato padre, per continuare con lui un dialogo che non si è mai interrotto.
[2]C. Cost. 9 marzo 2021, n. 33, così testualmente in motivazione: “...Gli interessi del minore dovranno essere allora bilanciati, alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo perseguito dall'ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore”.
[3]Così testualmente in motivazione: “L’esigenza di salvaguardare i valori ispiratori dell’ordinamento ita-liano si traduce in una finalità general-preventiva: scoraggiare i cittadini dal ricorso all’estero ad un metodo di procreazione che l’Italia vieta nel suo territorio, perché ritenuto lesivo di valori primari.
Dall’altro lato, si profila, una volta che il bambino è nato, l’esigenza di proteggere il diritto fondamentale del minore alla continuità del rapporto affettivo con entrambi i soggetti che hanno condi-viso la decisione di farlo venire al mondo, senza che vi osti la modalità procreativa”.
[4] M. PARADISO, Au bon marché des droits. Tra globalizzazione dei diritti e globalizzazione della
procreazione, in Riv. dir. civ., 2018, 983 ss.
[5] In questo senso si v. C. Cost. 23 ottobre 2019, n. 221 e 15 novembre 2019, n. 237. Entrambe le decisioni hanno respinto il giudizio di illegittimità di norme per violazione del divieto di discriminazione.
[6]V. al riguardo la recente legge francese e la recente legge svizzera, che hanno riformato l'originario impianto delle adozioni.
[7]V. il mio Il travagliato percorso della tutela del bambino nato da maternità surrogata. Brevi note a margine dell'ordinanza di rinvio alle sezioni Unite n. 1842 del 2022, in Giustiziainsieme del 27 ottobre 2022.
[8]V. al riguardo la mia nota alla decisione a Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 12193 dell'8 maggio 2019, La tanto attesa decisione delle Sezioni unite. Ordine pubblico versus interesse del minore?, in Familia 2019, 369 e ss. Nel 2020 ho poi commentato la decisione della Corte costituzionale n. 230 sul riconoscimento della genitorialità di intenzione nel caso di coppia omoaffettiva femminile, La genitorialità d'intenzione e il principio di effettività. Riflessioni a margine di Corte cost. n. 230/2020, in questa rivista il 16 dicembre 2020; la mia nota a Cass. civ., sez. I, ord., 29 aprile 2020, n. 8325, in giudicedonna.it, 2/2020, Il revirement della Cassazione dopo la decisione delle Sezioni Unite. Conflitto o dialogo con la Corte di Strasburgo? Alcune notazioni sul diritto vivente delle azioni di stato. Ho poi commentato la decisione della Corte costituzionale n. 79 del 2022 in tema di adozione in casi particolari: La corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione, in Familia 2022, 364 e ss. Infine ho commentato l'ordinanza della I sezione della Corte di Cassazione di rinvio alle Sezioni Unite n. 1842 del 2022: Il travagliato percorso della tutela del bambino nato da maternità surrogata. Brevi note a margine dell'ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite n. 1842 del 2022, in questa rivista il 27 ottobre 2022.
[9]Sulla stagione dell'incertezza e dello smarrimento e sulla stagione della speranza rinvio al mio Il diritto di famiglia e il ruolo del giurista nelle diverse stagioni, in in M. CAVALLARO-F. ROMEO-E. BIVONA-M. LAZZARA, (cur.), Sui mobili confini del diritto, Torino, 2022, Vol. I, 118 ss. Considerazioni analoghe si rinvengono nella mia voce Minori (tutela sostanziale in generale), in Enc dir. Volume Famiglia, diretto da F. Macario, Milano, 2022, 886 e ss.
[10]V. al riguardo il bel commento di A. MORACE PINELLI, La Corte costituzionale interviene sui diritti del minore nato attraverso una pratica di maternità surrogata. Brevi note a Corte cost. 9 marzo 2021, n. 33.
[11]V. Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne: “....ricorda che lo sfruttamento sessuale a fini di maternità surrogata e a fini riproduttivi è inaccettabile e costituisce una violazione della dignità umana e dei diritti umani; condanna la pratica della maternità surrogata, che può esporre allo sfruttamento le donne di tutto il mondo, in particolare quelle più povere e in situazioni di vulnerabilità, come nel contesto della guerra; chiede che l'UE e i suoi Stati membri prestino particolare attenzione alla protezione delle madri surrogate durante la gravidanza, il parto e il puerperio e rispettino tutti i loro diritti nonché quelli dei neonati; sottolinea le gravi ripercussioni della maternità surrogata sulle donne, sui loro diritti e sulla loro salute, le conseguenze negative per l'uguaglianza di genere nonché le sfide derivanti dalle implicazioni transfrontaliere di tale pratica, come è avvenuto nel caso delle donne e dei bambini colpiti dalla guerra contro l'Ucraina; chiede che l'UE e i suoi Stati membri analizzino le dimensioni di tale industria (il corsivo è mio), il contesto socioeconomico e la situazione delle donne incinte, nonché le conseguenze per la loro salute fisica e mentale e per il benessere dei neonati; chiede l'introduzione di misure vincolanti volte a contrastare la maternità surrogata, tutelando i diritti delle donne e dei neonati”. Sulla maternità surrogata come “mercificazione della maternità”, v. A. MORACE PINELLI, Il problema della maternità surrogata torna all'esame delle Sezioni Unite, in Familia, 2022, 437 e ss.
[12]V. invece A. GRASSO, Maternità surrogata altruistica e tecniche di costituzione dello status, Torino, 2022, 74 e ss.
[13]V. testualmente in motivazione: “...L’ordinamento italiano non consente il ricorso ad operazioni di maternità surrogata. L’accordo con il quale una donna si impegna ad attuare e a portare a termine una gravidanza per conto di terzi, rinunciando preventivamente a “reclamare diritti” sul bambino che nascerà, non ha cittadinanza nel nostro ordinamento. Tale pratica è vie-tata in assoluto, sotto minaccia di sanzione penale, dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004. Il divieto è presidiato dalla reclusione e dalla multa per “chiunque, in qualsiasi forma”, la “realizza, organizza o pubblicizza”.
[14]Sulla valenza oggettiva della dignità nel caso della maternità surrogata, v. le belle pagine di G. LUCCIOLI, Il parere preventivo della Corte Edu e il diritto vivente italiano in materia di maternità surrogata: un conflitto inesistente o un conflitto mal risolto dalla Corte di Cassazione, saggio pubblicato il 22 maggio 2020 in questa rivista. Si rinvia anche alle recenti e belle pagine di A. MORACE PINELLI, Le persistenti ragioni del divieto della maternità surrogata e il problema della tutela di colui che nasce dalla pratica illecita. In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, in Fam e dir. 2022, 1175, il quale, oltre a confermare il carattere oggettivo della lesione della dignità, ha collocato il dibattito sul divieto della maternità surrogata nel più ampio dibattito civilistico in ordine all'esercizio dei poteri privati. Questa collocazione è particolarmente suggestiva in quanto richiama la monografia di mio padre Le autorità private, Napoli, 1977.
[15]Per questo dibattito v. in questa rivista l'intervista di R. CONTI ai costituzionalisti D’Aloia, D’ Amico e Repetto pubblicata il 22 maggio 2019.
[16]C. cost. n. 162 del 2014.
[17] Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
[18]Sul principio di ordine pubblico v. gli scritti di V. CALDERAI e da ultimo il bel saggio Ordine pubblco internazionale e Drittwirkung dei diritti dell'infanzia, in Riv dir civ 2022, 478 e ss.
[19]V. C. S.U. n. 12193 del 2019
[20]C. S.U. n. 16601 del 2017.
[21]Sia consentito un rinvio alla mia nota delle Sezioni Unite del 2019, La tanto attesa decisione delle Sezioni unite. Ordine pubblico versus interesse del minore?, cit.
[22]Per queste considerazioni rinvio alla mia nota all'ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite n. 1842: Il travagliato percorso della tutela del bambino nato da maternità surrogata. Brevi note a margine dell'ordinanza di rinvio alle sezioni Unite n. 1842 del 2022, cit.
[23]V. C.M. BIANCA, Ex facto oritur ius, in Riv. dir. civ., 1995, I, 787 ora in Realtà sociale ed effettività
della norma giuridica. Scritti giuridici, vol. I, t. 1, Milano, 2002, 189 ss. Il tema era stato da Lui trattato
già precedentemente nel saggio: Il principio di effettività come fondamento della norma di diritto
positivo: un problema di metodo della dottrina privatistica, in Estudios de derecho civil en honor del
prof. Castán Tobeñas, vol. II, Pamplona, 61 ss. e ora in Realtà sociale ed effettività della norma giuridica.
Scritti giuridici, vol. I, t. 1, cit., 35 ss. Sulla considerazione di questa formula quale filo rosso dell'impostazione metodologica del pensiero di C.M. Bianca, si rinvia a M. BIANCA, Il diritto di famiglia e la missione del giurista. L'insegnamento di mio padre Cesare Massimo Bianca, in Familia, 2021, 125 e ss e da ultimo il mio Cesare Massimo Bianca e il saggio ex facto oritur ius, in Vita not. 2022, 569 e ss.
[24]C.M. BIANCA, Ex facto oritur ius, cit.: “Prendere atto del principio di effettività non vuol dire tuttavia conferire né riconoscere un potere normativo ai giudici né dare ingresso alla 'consuetudine giurisprudenziale' come fonte del diritto”.
[25]Sulla coerenza quale valore dell'ordinamento si rinvia alla Relazione inedita di E. NAVARRETTA al Convegno che si è tenuto all'Università La Sapienza il 14 e il 15 ottobre 2022, Persone, minorenni e famiglie. Il cammino dei diritti e delle tutele. Dedicato a Cesare Massimo Bianca e a coloro che aprono nuove vie.
[26]Sul principio di verità v. R. CONTI, Relazione inedita al Convegno Persone, minorenni e famiglie. Il cammino dei diritti e delle tutele. Dedicato a Cesare Massimo Bianca e a coloro che aprono nuove vie, cit.
[27]Così C.M. BIANCA, Lo pseudoriconoscimento dei figli adulterini, in La riforma del diritto di famiglia, Atti del Convegno di Venezia svolto presso la Fondazione “Giorgio Cini” nei giorni 30 aprile-1° maggio 1967, Padova, 1967, 183 e ss. e ora in Realtà sociale ed effettività della norma giuridica. Scritti giuridici, vol. I, T. 1, Milano, 2002, 303 e ss.
Diritti fondamentali della persona di minore età e best interests of the child*
di Elisabetta Lamarque
L’autrice mette alla prova della giurisprudenza più recente le due principali conclusioni a cui era giunta in uno scritto di qualche anno fa circa la portata del principio dei best interests of the child come principio di rango costituzionale: a) il principio non impone che l’interesse della persona di minore età debba sempre automaticamente prevalere su tutto e su tutti; b) il principio diffida delle previsioni legislative rigide.
The author tests the most recent case law on the two main conclusions she reached in a booklet written a few years ago regarding the scope of the best interests of the child principle as a constitutional principle: a) the principle does not impose that the interest of the child must always automatically prevail over everything and everyone; b) the principle does not tolerate rigid legislative provisions.
Sommario: 1. Premessa. 2. Nessuna superiorità gerarchica, nessuna automatica prevalenza, nessuna tirannia del principio. 3. Le origini. 4. La giurisprudenza di Strasburgo. 5. Chiarezza concettuale e precisione lessicale nella più recente giurisprudenza costituzionale. 6. Flessibilità delle regole legislative. 7. Cosa ci attende nel prossimo futuro.
1. Premessa
Qualche anno fa avevo scritto un libretto sui best interests of the child nella prospettiva del diritto costituzionale[1]. In quel libretto avevo provato ad andare oltre alle conclusioni nichilistiche allora dominanti, che vedevano l’interesse del minore come una “scatola vuota” che poteva essere riempita di qualunque contenuto a seconda dei parametri culturali, o comunque extragiuridici, di riferimento dell’interprete, ma soprattutto avevo tentato di combattere l’uso retorico che gli operatori del diritto – giudici, avvocati ma anche la dottrina – spesso facevano del principio del preminente, o superiore, interesse del minore, locuzione che allora – ma per fortuna forse non più oggi, come argomenterò più avanti – con poca consapevolezza invariabilmente si preferiva per rendere in italiano il principio appunto dei best interests of the child.
Quel principio, invece, avrebbe richiesto di essere maneggiato dagli giuristi italiani con maggiore attenzione, addirittura con prudenza, essendo nato ed essendosi sviluppato in un ambiente culturale profondamente diverso dal nostro, quello angloamericano, ed essendosi proprio da lì diffuso sulla scena internazionale grazie soprattutto alla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, che lo enuncia in via generale all’art. 3[2], per poi consolidarsi in ambito europeo prima tramite la giurisprudenza di Strasburgo e poi attraverso la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Avevo scelto di occuparmi del principio dei best interests, dunque, proprio perché mi ero accorta che il principio era invocato in tutte le occasioni nelle quali veniva in rilievo la posizione di una persona di minore età quasi come formula di stile, in modo indiscriminato e a volte anche a sproposito, e avevo constatato con preoccupazione che troppo spesso gli interpreti ne facevano un uso poco avvertito, superficiale, generico e dunque appunto retorico, se non addirittura strumentale, servendosene da pretesto per ‘coprire’ scelte volte a favorire – nel singolo caso concreto – gli interessi degli adulti.
In effetti, il “superiore” interesse del minore è un’espressione efficace, perché mette tutti a tacere. Chi oserebbe sostenere oggi l’idea opposta, che il bene degli adulti viene prima di quello dei bambini?
Ed è anche un abito buono per tutte le stagioni e per tutte le occasioni. Quanto volte abbiamo visto, soprattutto in passato, nei discorsi politici e giornalistici, ma spesso purtroppo anche in quelli dei giuristi[3], che nel suo nome si vuole giustificare una soluzione a un problema sociale, etico e giuridico, ma anche la soluzione esattamente contraria?
Quanto ai contenuti di quello studio, che risale al 2016, ormai sette anni fa, avevo innanzitutto approfondito un aspetto che già a quei tempi era data per scontata, e cioè la circostanza che nel nostro ordinamento il principio dei best interests si collochi a livello costituzionale, si imponga quindi alla legislazione primaria. Che il principio abbia rango costituzionale si ricava infatti sia da una lettura sistematica ed evolutiva della Costituzione italiana – una lettura che peraltro allora non tutti ricordavano che la Corte costituzionale avesse già offerto nel lontano 1981[4] –, sia da una ricognizione degli effetti sull’ordinamento costituzionale dei bill of rights internazionali e sovranazionali. Su questo punto non serve ora ritornare.
Per il resto, avevo raggiunto alcune conclusioni – due le principali – riguardo alla portata del principio che allora mi parvero non banali, e che qui è utile richiamare per metterle a confronto con i più recenti sviluppi giurisprudenziali.
Erano tuttavia due punti fermi – se di punti fermi è mai possibile parlare, nel campo del diritto – entrambi di segno negativo, relativi a ciò che il principio dei best interests certamente non vuole, non impone, non richiede. Un po’ come nella poesia di Montale: Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo[5].
In primo luogo, avevo concluso che il principio dei best interests non impone affatto all’interprete di far prevalere sempre e comunque i diritti del bambino o dell’adolescente sui diritti degli adulti che si trovano in relazione con lui o su altri beni della collettività del medesimo rango costituzionale, al contrario di ciò che sembrerebbe suggerire l’espressione italiana che lo traduce nei termini di “preminente” o “superiore” interesse del minore.
In secondo luogo, avevo constatato che principio dei best interests non sopporta – o, meglio, male sopporta – gli automatismi, o comunque più in generale diffida delle previsioni legislative rigide, prive di flessibilità, che impediscono all’organo pubblico incaricato di decidere nel caso concreto (un giudice, di solito, ma anche un altro operatore) di compiere una scelta ritagliata, modellata, sulle peculiarità, sulle sfumature, che quel caso presenta.
2. Nessuna superiorità gerarchica, nessuna automatica prevalenza, nessuna tirannia del principio
Prendiamo dunque le mosse dal primo punto: il principio dei best interests of the child non impone che l’interesse della persona di minore età debba sempre automaticamente prevalere su tutto e su tutti.
Ce lo insegnano la nascita e gli sviluppi storici del principio; ce lo fa chiaramente capire la Corte di Strasburgo; ma soprattutto ce lo dice esplicitamente da qualche anno – almeno dal 2017 – la nostra Corte costituzionale.
Motiverò ora brevemente, nell’ordine, tutte e tre queste affermazioni, partendo dalle origini storiche del principio.
3. Le origini
Nella preistoria del principio, nell’Ottocento, la best interests of the child doctrine nasce, nei paesi di common law, per consentire, nel caso di separazione o divorzio, singole eccezioni alla rigida regola, tipica di una società patriarcale, che imponeva di affidare i figli al padre.
L’affidamento alla madre all’inizio era disposto dalle corti in casi rarissimi, se i figli erano molti piccoli e quando il padre legale era all’evidenza del tutto inadatto, ad esempio perché vagabondo, alcolizzato o violento.
A un certo punto, però, e siamo già nella seconda metà del secolo scorso, il principio dei best interests esce dal ristretto ambito del diritto di famiglia – affidamento e adozione – e diventa uno dei cardini del vastissimo dibattito sui children’s rights in ambito nord americano.
Si tratta di un dibattito per noi europei continentali molto difficile da comprendere perché controverte su ciò che da noi è invece dato sempre per scontato, e cioè sulla circostanza che i bambini, in quanto persone umane, siano titolari di diritti fondamentali.
Nel dibattito nord americano sui children’s rights, infatti, si contrappongono – semplificando molto – due orientamenti.
Da una parte stanno coloro che ritengono che anche i bambini e gli adolescenti siano titolari di rights, intesi naturalmente come in generale sono intesi i rights in quell’area culturale, e cioè come diritti di autodeterminazione in tutte le sfere della propria vita.
Si tratta dell’orientamento dell’autonomy o della self-determination, che denuncia l’ingerenza del potere pubblico nelle decisioni che riguardano la vita di una persona di minore età e che per questo motivo ritiene che i bambini e gli adolescenti siano soggetti oppressi, the last minority, “l’ultima minoranza” da liberare, dopo le donne, i neri e gli omosessuali.
Dalla parte opposta si situano invece coloro che tremano al pensiero di abbandonare i bambini e gli adolescenti ai loro diritti, e cioè alle loro scelte, le quali possono sempre ritorcersi a loro danno, e sostengono che sia piuttosto necessario intervenire per compensare la loro debolezza e vulnerabilità.
È questo l’orientamento della protection o della salvation, a volte denominato anche nurturance orientation.
È esattamente al cuore di questo secondo orientamento che nasce e si sviluppa il nostro principio. Secondo questa linea di pensiero, infatti, ai children non devono essere garantiti rights, intesi nel senso di poteri di autodeterminazione, ma al contrario protection, e a tale scopo altri soggetti (pubblici o privati, ma su questo punto le varie concezioni divergono) devono essere incaricati di decidere per loro e al posto loro in che cosa consistano i loro best interests, e cioè in quale modo si realizzi meglio il loro welfare o il loro well-being (termini che non a caso nella tradizione anglo-americana dei children’s rights sono spesso utilizzati come sinonimi dei best interests).
Per spiegare il significato che ha il principio dei best interests nell’area culturale dove è storicamente nato – un significato che certamente il principio porta con sé quando irrompe sulla scena internazionale e sovranazionale – si potrebbe allora dire così.
In base a questo principio, chi si trova a dover prendere una decisione che riguarda la vita di una persona di minore età – che di solito da noi è un’autorità pubblica come un giudice o un assistente sociale – deve abbandonare ogni preconcetto e ogni idea personale per mettersi nei panni del bambino (in the child’s skin), e da questa prospettiva deve individuare ciò che conta di più per la vita del bambino e che gli garantisce il massimo benessere possibile (well-being o welfare, appunto).
Ne consegue che la decisione finale dovrà tendere a realizzare la soluzione migliore per il bambino che si trova in quella determinata situazione concreta, senza tuttavia trascurare o pretermettere i diritti degli adulti che sono in relazione con lui e le altre eventuali esigenze proprie della società. Diritti ed esigenze, dunque, che continuano a mantenere un peso e che richiedono di essere considerati ai fini della decisione stessa.
Del resto, se ci si pensa bene, il tenore testuale dell’espressione inglese va inequivocabilmente in questa direzione. Interests è al plurale e dunque la parola indica i vari possibili interessi/esigenze/bisogni che ogni bambino nutre; best è il superlativo relativo di good, buono. Essa richiede quindi semplicemente che ‘i migliori’ – e cioè i più significativi, i più importanti – tra i numerosi interessi/esigenze/bisogni del bambino siano tenuti in conto e garantiti da chi deve decidere al posto suo. E il ‘pacchetto’ dei più significativi tra questi interessi/esigenze/bisogni primari della persona di minore età è proprio ciò che le assicurerà il benessere, e cioè il welfare e il well-being.
Già allora, di conseguenza, proponevo che l’espressione inglese best interests of the child fosse resa in italiano con locuzioni più vicine al suo reale significato, e meno ingannevoli, quali ad esempio ‘il migliore interesse’ o ‘il massimo benessere possibile’ della persona di minore età, oppure ancora ‘la soluzione migliore’ (tra tutte quelle possibili) per il bambino o l’adolescente.
Queste traduzioni, alternative a quella corrente, assicurano che il superlativo relativo resti tutto interno al novero degli interessi della stessa persona di minore età, interessi dei quali i più importanti devono essere considerati e protetti.
Al contrario, con queste traduzioni rimane correttamente assente l’elemento della comparazione con altre esigenze e diritti tutelati dall’ordinamento, sui quali il ‘pacchetto’ di interessi/esigenze/bisogni, e anche diritti, del bambino e dell’adolescente non è detto che debba sempre prevalere, al contrario di ciò che suggerisce la più tradizionale traduzione italiana nei termini di “superiore” o “preminente” interesse del minore’.
4. La giurisprudenza di Strasburgo
I segnali che provengono dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo vanno inequivocabilmente in quest’ultimo senso.
Lasciamo perdere il fatto che ci sarebbe molto da dire sulla alluvionale giurisprudenza di Strasburgo sui best interests, e molto anche da criticare: quanto all’incertezza del fondamento del principio nella Cedu (art. 8 primo o secondo paragrafo?), quanto all’incoerenza di molte sue applicazioni, ma anche quanto alla contraddittorietà stessa di alcune sue affermazioni di principio contenute in quella parte sempre uguale delle sentenze di Strasburgo che precede l’applicazione della Convenzione al caso di specie in cui a volte si legge, a distanza di poche righe e magari all’interno della stessa pagina, un’affermazione e anche il suo contrario.
Il punto che qui interessa è invece chiaramente enucleabile da tutta la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e può essere riassunto nel modo che segue.
È vero che l’interesse del bambino e dell’adolescente ha sempre “particolare importanza”, ma quando l’interesse del minore e quello ad esempio dei suoi genitori biologici sono in conflitto, l’art. 8 Cedu “esige che le autorità nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessi – da noi si dice un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali – nel quale l’interesse del minore, “a seconda della sua natura e complessità”, può – attenzione: può, non deve! – avere la precedenza su quello dei genitori.
Esemplare, in questo senso, tra le moltissime, la nota sentenza Strand Lobben del 2019, seguita anche da altre molto recenti, tra cui anche sentenze di condanna dell’Italia, come A.I. del 2021[6].
Nella giurisprudenza di Strasburgo l’idea che l’interesse e i diritti del minore debbano essere sottoposti a bilanciamento, e non debbano al contrario automaticamente prevalere su ogni altro interesse o diritto altrui, è sempre presente e soprattutto sempre praticata.
È interessante notare che ciò accade anche quando sull’altro piatto della bilancia, rispetto ai diritti e agli interessi del minore, non ci sono i diritti degli adulti ricorrenti davanti alla Corte di Strasburgo (tipicamente, per fare un esempio, il diritto dei genitori biologici a non vedersi spezzato il legame con il figlio), bensì ci sono interessi generali della società come quelli che vengono in rilievo quando si tratta di riconoscere una surrogazione di maternità avvenuta all’estero. In questo è chiarissima, ad esempio, la recente sentenza K.K. contro Danimarca del 2022[7].
5. Chiarezza concettuale e precisione lessicale nella più recente giurisprudenza costituzionale
Ancora più significativa, oltre che molto più coerente al proprio interno, è la giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, che almeno a partire dal 2017 presenta un crescendo davvero notevole di chiarezza concettuale.
Prendiamo, tra le molte, la nota sentenza n. 33 del 2021, che dichiara inammissibile per discrezionalità del legislatore la questione relativa alla possibilità di iscrivere all’anagrafe come figlio della coppia committente il bambino nato all’estero a seguito di una pratica di gestazione per altri[8].
C’è, nella sentenza n. 33, la massima attenzione a sottolineare che “l’interesse del bambino non può essere considerato automaticamente prevalente rispetto a ogni altro controinteresse in gioco”.
E ciò perché «se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»“.
Ne consegue che gli interessi del bambino possono e devono essere sottoposti a un equo bilanciamento con diritti fondamentali altrui ed esigenze e interessi di pari rango costituzionale.
Non è un caso che i termini “bilanciamento” e “bilanciati” ricorrano ben cinque volte nel Considerato in diritto della sentenza n. 33 la quale, come noto, conclude: “Gli interessi del minore dovranno essere bilanciati, alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo perseguito dall’ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore”.
A una simile ritrovata chiarezza concettuale corrisponde, nella motivazione delle sentenze costituzionali più recenti, la ricerca di nuove espressioni linguistiche per indicare il nostro principio, differenti da quella tradizionale e capaci di sgombrare il campo da ogni residua possibilità di fraintendimento.
In alcune importanti sentenze del 2020 (la 102, sulla sospensione della responsabilità genitoriale per il reato di sottrazione di minore)[9], e del 2021 (la sentenza n. 32, ad esempio, e ancora una volta la n. 33)[10] la Corte costituzionale è esplicita nel proporre un nome più adeguato per il nostro principio, suggerendo di chiamarlo principio della “soluzione ottimale per il minore”, o della “soluzione ottimale in concreto per l’interesse del minore”, o ancora “principio del miglior interesse del minore”.
Tuttavia, nella motivazione di quelle stesse sentenze del 2020 e del 2021 gli aggettivi “superiore” e “preminente”, o “superiori” e “preminenti”, accompagnati a “interesse” o “interessi” del minore o del bambino, riaffiorano a tratti, quasi per abitudine o inerzia.
La svolta si ha invece nella più recente sentenza sull’adozione in casi particolari, la n. 79 del 2022, con la quale la Corte costituzionale estende all’adottato la parentela con i parenti dell’adottante[11].
Nella motivazione di questa pronuncia la Corte costituzionale si riferisce sempre al principio “del miglior interesse del minore”, oppure qualifica tale interesse come “primario” – e dunque, attenzione, un interesse molto importante, ma non già per forza prevalente qualsiasi altro[12]. – mentre gli aggettivi “preminente” e “superiore” compaiono solo come relitti del passato, nelle citazioni testuali di atti meno recenti.
La stessa accuratezza nella scelta delle parole, invece, non si ritrova ancora nella giurisprudenza della Cassazione dove – si pensi ad esempio alla sentenza delle Sezioni Unite dello scorso dicembre sullo status del nato all’estero da surrogazione di maternità[13] – convivono pacificamente la versione ‘ripulita’ e aggiornata del nome italiano del principio dei best interests e la formulazione tradizionale, con tutta la sua pericolosa carica di ambiguità.
Non bisognerebbe mai dimenticare, invece, che la formulazione tradizionale consente di utilizzare il principio nelle nostre aule giudiziarie in modo vuoto, retorico o addirittura fraudolento, dato che consente al giudice di non motivare in modo approfondito sulle circostanze di fatto del singolo caso concreto a cui invece la sua decisione dovrebbe sempre correlarsi.
6. Flessibilità delle regole legislative
Passo ora, molto molto più brevemente, al secondo punto, che dopo quello che ho detto finora risulterà chiarissimo.
Il principio dei best interests non ama gli automatismi legislativi, e anzi è ontologicamente incompatibile con le soluzioni legislative rigide che non consentono all’organo pubblico che deve in un determinato momento assumere una decisione che riguarda la vita di un bambino o di un adolescente di modularla su tutte le circostanze di fatto a sua conoscenza – che siano circostanze positive o negative, risorse o difficoltà –, comprese quelle relative al passare del tempo e all’avvenuto consolidamento di alcune situazioni di fatto[14]. E ciò allo scopo di assicurare a quel bambino o a quell’adolescente di godere, nei limiti del possibile, date appunto le circostanze in cui si trova, degli interessi/delle esigenze/dei bisogni più importanti, fondamentali per il suo pieno sviluppo.
Ma come si fa se la legge è rigida, se prevede un automatismo? La risposta è ovvia: se il testo della legge, o l’intero sistema legislativo, impone al giudice un’unica soluzione, la quale appare al giudice stesso dissintona rispetto alle esigenze del minore in carne e ossa che ha di fronte, il giudice non ha altra strada, per recuperare il potere di decidere diversamente, che adire la Corte costituzionale, chiedendole di cambiare, di manipolare, la legge per introdurvi la flessibilità richiesta dal principio dei best interests.
Le manipolative di accoglimento della Corte costituzionale che rispondono positivamente a simili accorati appelli dei giudici comuni sono molto numerose. Tra le più antiche, esemplare è la sentenza dell’inizio degli anni Novanta che introduce la possibilità per il giudice di derogare al limite dei quaranta anni massimi di differenza di età tra adottante e adottato nell’adozione internazionale, qualora lo richieda l’interesse del figlio[15], che è poi stata seguita da molte altre successive, in tutti i settori del diritto, dal diritto civile, a quello penale, processuale penale e dell’esecuzione penale.
Negli anni più vicini a noi, ad esempio, sono molto note e commentate le sentenze che eliminano l’automatica applicazione della pena accessoria della decadenza dalla responsabilità genitoriale per i delitti di soppressione e di alterazione di stato[16], o più di recente la sentenza che fa fuori l’automatismo nella sospensione della responsabilità genitoriale per il ben più grave delitto di sottrazione e mantenimento del minore all’estero[17].
7. Cosa ci attende nel prossimo futuro
In conclusione di queste riflessioni si possono richiamare due casi recenti per i quali auspico che possano presto intervenire analoghe pronunce costituzionali manipolative.
In primo luogo segnalo un’ordinanza di rimessione della Cassazione, prima sezione civile, depositata pochi giorni fa, che chiede alla Corte costituzionale di rendere flessibile la rigidissima regola della legge sull’adozione del 1983 secondo cui con l’adozione piena, legittimante, cessano irreversibilmente i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine, intesa come comprensiva dei parenti fino al quarto grado[18].
Viene quindi sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale una regola legislativa che nei suoi primi quarant’anni di vita non era mai stata messa in discussione proprio perché era universalmente ritenuta indispensabile per mettere al sicuro, in una botte di ferro, tutti gli adottati, sancendone l’esclusiva appartenenza alla nuova famiglia adottiva.
Oggi invece, la Cassazione ritiene che, se riferita a un caso difficile come quello sottoposto al suo giudizio, di due fratelli rimasti orfani di madre a seguito di un femminicidio, tale regola contrasta con il principio dei best interests proprio perché eccessivamente rigida. Essa infatti vieta, una volta dichiarata l’adozione piena dei due bambini – o, meglio, una volta dichiarato lo stato di abbandono che prelude all’adozione – di mantenere vivi i loro rapporti con tutti i parenti di sangue anche se la relazione con alcuni di loro, se coltivata “secondo le modalità stabilite in via giudiziale”, potrebbe contribuire al benessere dei bambini.
Un secondo caso di notevole attualità è quello che riguarda l’adozione in casi particolari del nato all’estero da surrogazione di maternità da parte del partner del genitore biologico che aveva condiviso il progetto procreativo.
Qui mi spiace un po’ intervenire in senso leggermente critico, o perlomeno dubbioso, sulla sentenza delle Sezioni Unite dello scorso dicembre, già richiamata[19], che – tengo a precisare – condivido invece pienamente nel suo esito.
Al par. 11 le Sezioni Unite ricordano che secondo la stessa Corte costituzionale uno degli aspetti di inadeguatezza della soluzione di compromesso – di negare la trascrizione della doppia genitorialità e di consentire invece l’adozione in casi particolari da parte del genitore non biologico – risiede nel fatto che, seguendo il dettato della legge del 1983, sarebbe impossibile pronunciare l’adozione quando manca l’assenso del genitore biologico.
Ebbene, le Sezioni Unite affermano che i giudici, in casi come questi, sono chiamati a considerare “le potenzialità dell’interpretazione costituzionalmente conforme” per superare, se l’interesse del figlio lo richiede, il dissenso del genitore biologico all’adozione da parte del genitore non biologico, “senza che occorra sollevare, persistendo l’omissione da parte del legislatore, una questione di legittimità costituzionale”.
Non condivido questo suggerimento.
È vero che le Sezioni Unite non avrebbero potuto sollevare loro stesse il dubbio di costituzionalità per carenza assoluta di rilevanza.
Tuttavia, in un diverso futuro giudizio, instaurato proprio da un genitore non biologico che volesse superare il rifiuto da parte del genitore biologico, a mio parere la lettera della legge sull’adozione, che testualmente richiede sempre il suo consenso, non potrebbe essere aggirata in via interpretativa.
Pronunciare lo stesso l’adozione in casi particolari nonostante il dissenso del genitore biologico sarebbe come disapplicare la legge nel caso concreto: operazione che, in un sistema accentrato di controllo di costituzionalità, al giudice non è mai consentita.
Al contrario, il giudice potrebbe, e dovrebbe, attivare un nuovo incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte costituzionale – con il consueto meccanismo – una manipolazione del rigido testo di legge che dia ingresso alla valutazione caso per caso, da parte del giudice stesso, della rispondenza della richiesta adozione ai bisogni fondamentali del nato dalla pratica di surrogazione di maternità.
Senza contare che l’intervento solitario di un giudice che opera un’interpretazione conforme della legge vale solo provvisoriamente, salvo impugnazione della sua sentenza, e comunque vale soltanto per le parti del suo giudizio.
Al contrario, se quello stesso giudice si rivolge alla Corte costituzionale, la Corte può rimuovere il problema una volta per tutte, non solo per tutti i casi futuri ma anche per quelli in itinere, con benèfici e stabili effetti erga omnes.
Alla continua correzione dei testi di legge da parte del virtuoso raccordo Corte costituzionale-giudici comuni, del resto, siamo da tempo tutti abituati, nel campo del diritto di famiglia come in molti altri settori dell’ordinamento, dato l’endemico ritardo, la colpevole inerzia, dei nostri legislatori di ogni colore, incapaci di adeguare tempestivamente il tessuto normativo ai mutamenti già avvenuti nelle relazioni umane in seno alla società.
* Il testo è una versione rivista e corredata di note della relazione presentata al convegno sul tema Le relazioni giuridiche familiari tra natura e storia. Prospettive culturali e questioni aperte che si è tenuto presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca nei giorni 26, 27 e 28 gennaio 2023.
[1] E. Lamarque, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2016.
In proposito avverto che molte delle osservazioni svolte nel presente contributo sono tratte, anche testualmente, da quel volume e da altri miei scritti successivi sul tema, tra cui segnalo soltanto E. Lamarque, I best interests of the child, in La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Conquiste e prospettive a 30 anni dall’adozione, a cura dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Roma, 2019, 140 ss., in open access all’indirizzo www.garanteinfanzia.org, e, da ultimo, G. Mingardo ed E. Lamarque, Gestazione per altri e best interests of the child. La prospettiva della Corte costituzionale italiana, in La surrogazione di maternità nel prisma del diritto. Problemi aperti e sfide future, a cura di F. Pesce, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, 123 ss.
[2] Art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Convention on the Rights of the Child (CRC), adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 1991: “In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration”.
[3] Lo nota, con particolare riferimento ai temi legati alla PMA, M. Acierno, Il mantra del preminente interesse del minore, in Questione Giustizia, 2019.
[4] Corte cost., sent. n. 11 del 1981, redattore Leopoldo Elia. Ora invece questa sentenza capostipite è ricordata come tale dalla Corte costituzionale (si veda ad esempio il punto 4.1. del Considerato in diritto di Corte cost., sent. n. 102 del 2020, il punto 5.3. del Considerato in diritto di Corte cost., sent. n. 33 del 2021 e il punto 5.2.3. del Considerato in diritto di Corte cost., sent. n. 79 del 2022).
[5] E. Montale, Non chiederci la parola, in Ossi di seppia, Piero Gobetti Editore, Torino, 1925.
[6] Strand Lobben e altri contro Norvegia, Grande Camera, 1 settembre 2019, n. 37283/13, parr. 204 e 220 e A.I. contro Italia, prima sezione 1 aprile 2021, n. 70896/17, parr. 87 e 94.
[7] Corte eur. dir. Uomo, seconda sezione, sentenza 6 dicembre 2022, no. 25212/21, par. 57.
[8] Si occupano di questa sentenza e di quella che immediatamente la precede (Corte cost., sentt. nn. 32 e 33 del 2021), tra i molti, M. Sesta, La prospettiva paidocentrica quale ‘fil rouge’ dell’attuale disciplina giuridica della famiglia, in Famiglia e diritto, n. 7/2021; M. Dogliotti, Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via di inammissibilità è l’unica percorribile?, in Famiglia e diritto, n. 7/2021; G. Ferrando, La Corte costituzionale riconosce il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori?, in Famiglia e diritto, n. 7/2021; G. Recinto, Le “pericolose oscillazioni” della Suprema Corte e della Consulta rispetto alla maternità surrogata, in Famiglia e diritto, n. 11/2021; R. Bin, L’interpretazione della Costituzione in conformità delle leggi. Il caso della famiglia, in Famiglia e diritto, n. 2/2022; M.N. Bugetti, Lo status di figlio di coppia omosessuale a dieci anni dall’introduzione dello stato unico di filiazione. Un ‘excursus’ giurisprudenziale (e qualche riflessione), in Famiglia e diritto, n. 8-9/2022; R. Bin, Tecniche procreative, ordine pubblico, interesse del minore. Conclusioni, in Rivista di Biodiritto, n. 3/2021; M. Acierno, La Corte costituzionale “minaccia” un cambio di passo sull’omogenitorialità?, in Questione Giustizia, 2021; E. Frontoni, L’adozione in “casi particolari” non è più sufficiente per tutelare l’interesse dei minori nati attraverso maternità surrogata, in Nomos, n. 2/2021; F. Astone, Procreazione di coppie ‘same sex’ e ‘status’ dei figli: un problema di discrezionalità legislativa?, in Giur. cost., n. 2/2021; V. Calderai, Il dito e la luna. I diritti fondamentali dell’infanzia dopo Corte cost. n. 33/2021, in Giur. it., n. 2/2022; M. Caldiroli, Surrogazione di maternità e ordine pubblico: verso un cambio di rotta, in Rivista di Biodiritto, n.2/2022; M. Caldiroli, La genitorialità intenzionale e l’interesse del minore: un vuoto di tutele intollerabile, in Osservatorio costituzionale, n. 3/2021; B. Carminati, Corte costituzionale, sent. 33/2021: tutela dei figli nati all’estero tramite maternità surrogata, in Rivista di Biodiritto, n. 2021; G. D’Amico, La Corte e il “non detto”. Riflessioni a partire dalle sentt. n. 32 e n. 33 del 2021, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 4/2021; G. D’Amico, La preminente ... discrezionalità del legislatore e il “giuoco delle parti”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2021; G. Mingardo, Approdi e partenze: lo stato della gestazione per altri e la prospettiva futura, in Rivista Aic, n. 3/2021; F. Paterniti, Status di figlio e limiti alle possibilità genitoriali delle coppie omoaffettive: lacune dell’ordinamento, attese legislative e (problematici) arresti giurisprudenziali, in Rivista Aic, n. 3/2021; F. Rimoli, Diritto all’omogenitorialità, ‘best interest of the child’ e ‘famiglia naturale’: un problema ancora irrisolto, in Giur. cost., n. 2/2021; A. Ruggeri, La PMA alla Consulta e l’uso discrezionale della discrezionalità del legislatore, in Consulta Online, n. 1/2021; U. Salanitro, L’adozione e i suoi confini. Per una disciplina della filiazione da procreazione assistita illecita, in La nuova giurisprudenza civile commentata, n. 4/2021; S. Tonolo, La Corte costituzionale e la genitorialità delle coppie dello stesso sesso tra trascrizione degli atti di nascita esteri e soluzioni alternative, in Corr. giur., n. 8-9/2021; P. Veronesi, Ancora sull’incerto mestiere del nascere e del diventare genitori: i casi di cui alle sentenze nn. 32 e 33 della Corte costituzionale, in Rivista di Biodiritto, n. 3/2021.
[9] Su cui, tra gli altri, P. Pittaro, La sospensione della responsabilità genitoriale come pena accessoria. incostituzionale se automatica, in Famiglia e diritto, n. 10/2020; G. Matucci, “Cecità” della legge e interesse concreto del minore. Sull’incostituzionalità dell’automatica sospensione della responsabilità genitoriale, in Giur. cost., n. 3/2020; G. Laneve, Pene accessorie che incidono sulla responsabilità genitoriale: dalla “cecità” dell’automatismo legislativo allo sguardo sulla relazione genitore-figlio, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 4/2020; L. Delli Priscoli, Sottrazione internazionale dei minori e “the best interest of the child” quale interesse alla bigenitorialità, in La giustizia penale, n. 8-9/2020.
[10] Si veda supra la nota 6.
[11] Su questa sentenza M.C. Carbone, Famiglia e nuovi rapporti di parentela: la Corte costituzionale traccia il sentiero per il riconoscimento giudico della “familiarità sociale”, in Consulta Online, n. 3/2022 e M.C. Errigo, Garantire le relazioni familiari. La decisione della Corte costituzionale n. 79/2022, in Osservatorio costituzionale, n. 3/2022.
[12] Analogamente Corte cost., sent. 33 del 2021 aveva ritenuto che agli interessi del minore dovesse essere assegnato uno speciale peso in ogni bilanciamento, ma aveva subito chiarito che ciò non significa assegnare all’interesse del minore una assoluta prevalenza sugli altri diritti individuali e interessi della collettività: “la frequente sottolineatura della ‘preminenza’ di tale interesse ne segnala bensì l’importanza, e lo speciale ‘peso’ in qualsiasi bilanciamento; ma anche rispetto all’interesse del minore non può non rammentarsi che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe ‘tiranno’ nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona”.
È davvero curioso notare che, tutto all’opposto, nella giurisprudenza costituzionale più antica, precedente Corte cost., sent. n. 11 del 1981, cit., lo speciale peso nel bilanciamento con gli interessi della persona minore di età sembrava doversi assegnare “al superiore interesse della società” (così Corte cost., sent. n. 156 del 1967, tra l’altro relativa al delicatissimo tema dell’ispezione corporale del imputato minorenne).
[13] Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162.
[14] Corte eur. dir. Uomo, prima sezione, sent. T.C. contro Italia, 19 maggio 2022, n. 54032, parr. 57-58, oltre a quelle richiamate al par. 349 della guida all’art. 8 Cedu, predisposta dalla cancelleria della stessa Corte di Strasburgo (Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights. Right to respect for private and family life, home and correspondence, Updated on 31 August 2022, all’indirizzo https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_8_eng.pdf).
[15] Corte cost., sent. n. 148 del 1992.
[16] Corte cost., sentt. n. 31 del 2012 e n. 7 del 2013.
[17] Corte cost., sent. n. 102 del 2020, cit.
[18] Cass. sez. I civ., ord. 5 gennaio 2023, n. 230.
[19] Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162, cit.
Audizione al Senato del Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo sul tema delle intercettazioni del 31 gennaio 2023
I fattori di criticità della materia delle intercettazioni appaiono, ad un’osservazione obiettiva, tali e tanti da mettere in crisi ogni ambizione di poter realizzare altro che progressive tappe di una faticosa ricerca di equilibri resi continuamente precari dalle evoluzioni tecnologiche e degli stessi fenomeni criminali.
Siamo di fronte a tensioni che attraversano i sistemi giuridici di tutte le società democratiche e che continuamente si trasformano e impongono nuove sfide.
Naturalmente, molto può farsi. A condizione di sottrarsi alla tentazione di rendere una materia così delicata oggetto di continue contrapposizioni polemiche e grossolane o strumentali semplificazioni, anziché di uno sforzo condiviso e responsabile di avvicinamento ad una dimensione problematica di straordinaria complessità, che, per di più, nello scenario italiano soffre l’effetto della perdurante azione di ulteriori fattori di criticità.
Proverò ad indicare alcuni di tali fattori, nei quali, a mio avviso, possono scorgersi i tratti di evidenti ritardi istituzionali, legislativi e degli assetti organizzativi del sistema giudiziario, che definiscono altrettanti profili di responsabilità.
Ma, confidando nell’interesse di codesta Commissione a conoscere le valutazioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, proverò anche ad indicare anche alcune possibilità, da tempo mature, per realizzare una manovra di deciso rafforzamento del quadro delle garanzie difensive, senza detrimento delle istanze di efficace contrasto di gravi fenomeni criminali.
Una manovra possibile soltanto avendo avuto cura di sgombrare il capo da grottesche e miopi visioni di una realtà oltremodo complessa, che esige analisi realistiche e rigorose, anche se non sempre confortanti, derivandone da esse, infatti, non già le illusorie ricette che ordinariamente discendono dall’insofferenza per la complessità dei problemi da considerare, ma la responsabilità di un impegno gravosissimo per le istituzioni politiche, amministrative e giudiziarie.
Procederò ad una rassegna tanto dei fattori di criticità quanto di alcune possibili vie d’uscita con criteri descrittivi ai limiti della brutalità delle necessarie sintesi.
- La trasformazione del rapporto fra giurisdizione e tecnologie conseguente al passaggio nell’era digitale: da tempo fanno ingresso nel processo penale gigantesche masse informative ed enormi flussi di dati personali, ciò che acuisce e finanche drammatizza, da un lato, il tema della tutela dei diritti individuali trascinati nelle indagini e nel processo e, dall’altro, il ritardo del sistema giudiziario a dotarsi di tecnologie e saperi, ma vorrei dire anche di una cultura delle nuove tecnologie, di cui vi è necessità impellente per governare i rischi di collisione fra le ragioni di giustizia e i beni e gli interessi, privati e istituzionali, complessivamente coinvolti;
- L’ingresso del digitale nella vita di organizzazioni e reti criminali: quando si valuta l’aggressività delle tecniche investigative, occorre tener conto anche della straordinaria vitalità delle tecniche di elusione di ogni controllo collegata alla capacità, non solo del crimine organizzato mafioso, di dotarsi di tecnologie in grado di preservarne l’impenetrabilità: piattaforme criptate e ricorso al dark web per le ordinarie comunicazioni telematiche, sofisticati sistemi di sorveglianza elettronica delle aree di interesse, ossessiva cura della segretezza di movimenti e comunicazioni dei vertici dei gruppi criminali. Giovanni Falcone, ricorderete, diceva “i mafiosi saranno avranno sempre una lunghezza di vantaggio su di noi”. Un modo semplice, ma acuto, per indicare una caratteristica costante della criminalità mafiosa: la sua capacità di agire avvalendosi di straordinarie capacità di adattamento, ma anche di conoscenza della modernità e delle sue tecnologie. La lungimiranza di quel giudizio è visibile nei dati dell’ordinaria esperienza investigativa, attraverso la visione di vere e proprie nuove componenti dei gruppi criminali, costituite da complesse funzioni di security, ossessivamente protese a prevenire ogni controllo, a controllare ogni potenziale rischio d’indagine, a proteggere e bonificare ogni luogo e dispositivo utilizzato a fini criminosi, a dotarsi di dispositivi di storage dei dati di gestione degli affari criminali e delle collegate attività di reinvestimento speculativo e riciclaggio assolutamente impenetrabili. Questa dimensione funzionale del crimine organizzato è in parte tutta interna alle organizzazioni criminali, generando nuove figure direttive e nuove leadership, e in parte si intreccia invece con l’ordinario sistema d’impresa del mondo cyber e con le stesse funzioni investigative, l’uno e le altre essendo continuamente esposte a pesante pressione corruttiva e collusiva: non vi è indagine di mafia nella quale non si registrino tracce di evidenti di ciò, ciò che in controluce rivela che la diretta penetrazione di presenze e interessi mafiosi nel concreto agire di cyber security è un rischio sempre più concreto e reale.
- La continua modificazione del panorama investigativo che si realizza quando entrano in gioco, ed è ormai regola nelle indagini appena rilevanti, le tecniche investigative impiegate in altre giurisdizioni: le piattaforme telematiche criptate: non è possibile entrare nei dettagli di questa ormai nota frontiera investigativa, ma certo i confini dei relativi campi problematici non possono essere tracciati prescindendo da ciò che avviene nei sistemi ancorati rigidamente al rule of law, a meno di optare per un impossibile isolamento internazionale e di pagare il prezzo di un arretramento della nostra capacità di contrasto dei più gravi fenomeni criminali: un tema assai delicato, dove è in gioco persino il tradizionale primato di professionalità ed efficacia dei nostri apparati di polizia, di fatto pressoché esclusi da ambiti di cooperazione che esigono la condivisione di eccezionali risorse tecnologiche e di nuovi strumenti operativi, come l’impiego a fini investigativi, pur rigidamente controllato attraverso la fissazione di rigorosi presupposti e limiti, di nuove tecniche intrusive e di quei medesimi hackers etici che anche lo Stato ha per fortuna, sia pure solo in tempi recentissimi, imparato ad utilizzare per sottoporre i propri sistemi informati a stress test necessari per saggiarne la resistenza ad attacchi interni ed esterni; oggi le indagini più importanti in materia di narcotraffico e di riciclaggio si nutrono di acquisizioni probatorie rese possibili da quadri normativi e strumenti investigativi più avanzati di quelli disponibili per la magistratura e le forze di polizia italiane. Basterebbe pensare, per apprezzare i divari normativi delle condizioni del lavoro investigativo, alle previsioni del codice di rito francese che consentono l’istallazione di un dispositivo tecnico per accedere, archiviare e trasmettere dati informatici memorizzati in un dispositivo anche attraverso il ricorso a risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale ai sensi dell’art. 706-102-1[1] e ss. del codice di procedura penale. Ma analoghe possibilità si rinvengono nelle legislazioni tedesche, olandesi e belghe, consentendo attività, ormai giunte alla violazione live di quelle piattaforme criptate, impossibili nello scenario italiano, ma essenziali per l’efficacia delle indagini in materia di criminalità organizzata e terrorismo. La necessità di avanzamento delle frontiere normative e delle capacità investigative è ancor più visibile considerando gli effetti e l’impatto complessivo di uno scenario globale segnato da conflitti armati ed ibridi, nei quali è diffuso l’impiego anche sperimentale di tecnologie aggressive dei sistemi informativi, che inevitabilmente si trasferiranno nel mercato dell’impresa, a disposizione anche delle reti criminali mafiose e terroristiche. Può sembrare una prospettiva di rischio lontana, ma così non è, se soltanto si guarda al ruolo che tipicamente quelle reti criminali da sempre giocano nelle aree segnate da profondi processi di destabilizzazione.
- Una lunga stagione di pratica subalternità cognitiva della macchina giudiziaria, ma anche degli apparati di polizia nell’impiego a fini di giustizia delle tecnologie digitali: a quelli appena accennati è collegato intimamente un ulteriore fattore di criticità, che da tempo io individuo nel determinarsi - a valle di una prolungata stagione di tacita rinuncia dello Stato ad esercitare la responsabilità di investire in tecnologie digitali e, quel che più conta, di impegnarsi nell’organizzazione e nel controllo gestionale dell’impiego a fini di giustizia di quelle sempre più raffinate tecnologie - nel determinarsi e nel persistere di una condizione, culturale prima ancora che pratico-operativa, di grave subalternità, innanzitutto cognitiva, dell’amministrazione della giustizia e, dunque, della giurisdizione e delle nostre pur straordinarie forze di polizia, rispetto alle tecnologie impiegate nelle indagini, totalmente in mani private e di regola impiegabili soltanto attraverso la mediazione tecnica di soggetti privati. Altro che le “risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale” previste dalle leggi francesi: in Italia, l’uso investigativo delle tecnologie, soprattutto di quelle più sofisticate e invasive, richiederebbe più incisive e mature policies di sicurezza effettivamente riconducibili alla responsabilità dello Stato (uso da anni, per indicare una via d’uscita, una metafora ferroviaria: i vagoni possono essere privati, ma i binari devono essere tracciati e presidiati da agenti pubblici). Il tema riguarda, volendo, anche le funzioni di intelligence e, dunque, di preservazione della sicurezza della Repubblica, dal momento che le garanzie funzionali in questo ambito delle agenzie si realizzano con le stesse tecnologie e mediante l’impiego dei medesimi fornitori utilizzati dalla giustizia penale, ai quali ultimo è dovuto affidamento, che non può essere tuttavia assoluto, come dimostrano casi emblematici, quale quello rivelato dalle indagini della Procura di Napoli sul programma Exodus, che forse già dal nome avrebbe dovuto suscitare apprensione in chi scelse di dotarsi di un software per intercettazioni telematiche con captatore informatico che operava trasferendo in chiaro su un server in Colorado del sistema di cloud di Amazon i dati captati, come tali visibili da chiunque sul web.
Dunque, il sistema esige una profonda e complessiva opera di razionalizzazione e securizzazione, che modifichi sensibilmente prassi, abitudini e comportamenti, ingenerati da una lunga stagione di pauperismo e subalternità tecnologica dell’amministrazione della giustizia e degli apparati di polizia, in grado di incidere negativamente, oltre che sull’efficacia delle indagini, anche sulla correttezza del trattamento dei dati personali e, dunque, sulla tutela della riservatezza delle persone coinvolte a vario titolo nelle indagini e nei processi.
Il Garante della protezione dei dati personali, del resto, di ciò ebbe modo di accorgersi, allorquando, nell’estate del 2013, adottò una delibera che improvvisamente aprì uno squarcio nell’allora debolissimo tessuto protettivo dei dati personali delle intercettazioni.
I Procuratori della Repubblica furono per la prima volta indicati come responsabili del trattamento dei dati personali e chiamati ad assumere iniziative rigorosamente ispirate dalla necessità di alzare, praticamente da terra, gli standard di sicurezza delle sale e delle procedure organizzative funzionali alle intercettazioni.
Fortunatamente, molto tempo è passato. Molte cose sono cambiate.
Poco dopo quella delibera, infatti, fu avviata una significativa azione di potenziamento delle misure di sicurezza dei sistemi di gestione delle intercettazioni.
Anche su tale scia, molti uffici requirenti hanno sviluppato una più avanzata cultura della sicurezza dei dati delle intercettazioni, ricercando e applicando soluzioni persino più avanzate di quelle richieste dalla legge per la corretta e sicura gestione dei dati delle intercettazioni, nella consapevolezza del ruolo di garanzia della legalità processuale nella fase delle indagini preliminari che il p.m. deve conservare e che appare francamente preoccupante che sia considerato con sufficienza e approssimazione concettuale.
Oggi questi temi sono al centro del confronto permanente che la DNA ha avviato con tutti i Procuratori distrettuali: un confronto necessario per ancorare il coordinamento investigativo a modelli organizzativi e metodologie di lavoro razionali e uniformi.
Ma molte cose devono essere ancora fatte, soprattutto per estendere le prassi virtuose a tutti gli uffici e, in particolare, anche alle Procure ordinarie dalle più piccole dimensioni, ove si concentrano maggiormente le debolezze infrastrutturali e il correlato rischio di introduzione di prassi improprie e inadeguate.
È una strada lunga quella che occorre percorrere, senza interrompere il cammino sia pure faticosamente fatto sin qui, del quale sono parte essenziale:
a) il principio posto alla base della riforma del 2017, secondo il quale, quali che siano presupposti e limiti di utilizzabilità delle intercettazioni, occorre preservare dalla conoscenza di persone diverse dai soggetti processuali la conoscenza delle intercettazioni irrilevanti a fini di giustizia e, a maggior ragione, di quelle inutilizzabili; le une e le altre devono essere definitivamente segregate e protette da ogni pubblicità;
b) per questa ragione viene introdotto uno strumento nuovo: l’Archivio riservato delle intercettazioni: come preciserò, tale strumento è, per scelta normativa, soltanto parzialmente utilizzato, ma ha grandi potenzialità, poiché consente ulteriori, grandi implementazioni delle funzioni di segregazione e controllo della corretta gestione dei dati, attraverso l’auspicabile estensione dell’obbligo del suo impiego per la gestione di attività d’indagine, che non sono stricto iure captazioni, ma che determinano l’acquisizione di masse di dati personali persino più grandi e delicate (dalle funzioni di on line search dei captatori telematici, vale a dire di ricerca file nella memoria dei dispositivi e di keylogger sino alle copie forensi dei dispositivi di comunicazione oggetto di ispezione e sequestro); ciò comporterebbe la conseguenza di estendere anche a queste attività le regole del codice che impongono una rigorosa e controllata dal giudice selezione dei dati rilevanti e utilizzabili e la definitiva segregazione di quanto il giudice ritenga irrilevante ed inutilizzabile);
c) il decreto ministeriale 20 aprile 2018, che ha introdotto disposizioni per definire i requisiti tecnici dei programmi informatici funzionali all’esecuzione delle intercettazioni mediante captatore, a partire dalla regola fondamentale che tali programmi siano elaborati ed utilizzati assicurando l’integrità, la sicurezza e l’autenticità dei dati captati su tutti i canali di trasmissione riferibili al captatore; un ambito problematico delicatissimo, ma che esige chiarezza e la preservazione del dibattito dal rischio di enfatizzazione di allarmi infondati e suscettivi di uso strumentale: è ben vero che tecnicamente è possibile elaborare e impiegare malware in grado di manipolare i dati, distruggendoli o creandoli, ma si tratterebbe (oggi come ieri, per le analoghe attività abusive astrattamente possibili nell’epoca dell’analogico e dei verbali cartacei) di attività illegali, sanzionate penalmente in modo severo, potendo di volta in volta integrare, a seconda dei casi, i delitti di depistaggio, di intercettazione illegale, di accesso abusivo a sistemi informatici e telematici, di frode in pubbliche forniture, di calunnia, di falso materiale o ideologico in atti pubblici, di favoreggiamento. Il richiamo a queste gravi ipotesi delittuose vale a rendere chiaro che gli abusi in questo campo non sono senza prezzo: la vicenda Exodus, già richiamata nelle audizioni che hanno preceduto la mia, sta lì a dimostrarlo, se, dopo aver segnalato le relative pratiche abusive, si tiene a mente che si tratta di abusi individuati dalla magistratura, che ha proceduto immediatamente nei confronti dei responsabili della società che gestiva quel software illegale per le intercettazioni mediante captatore informatico, che peraltro è risultato nella disponibilità anche delle agenzie di intelligence. Un dato che segnalo soltanto per indicare che i rischi collegati alla dipendenza cognitiva dello Stato dalle tecnologie private hanno dimensione più ampia di quella data dalla visione delle intercettazioni giudiziarie, ma anche per sottolineare che lo Stato e la magistratura non assistono inermi alla consumazione di abusi e delitti in danno dell’amministrazione della giustizia e delle libertà dei cittadini. Come è avvenuto anche quando è stata denunciata, a margine di una famosa vicenda processuale, tutt’ora in corso, la possibilità che ci fosse stato un illecito uso dei dispositivi di memorizzazione dei dati trasmessi da un captatore informatico: in questo caso, escludendosi, allo stato delle mie conoscenze, la fondatezza di quelle allarmanti ipotesi, sulla base di immediati e approfonditi accertamenti, svolti in contraddittorio con le parti private, affidati congiuntamente da tre procure della Repubblica agli specialisti del C.N.A.I.P.I.C. della Polizia postale e delle comunicazioni.
d) Al decreto del 2018 avrebbe dovuto accompagnarsi un altro, volto all’istituzione di un Tavolo tecnico presso il Ministero della giustizia per il monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie, intervenuto soltanto pochi giorni fa; il Tavolo tecnico è uno strumento essenziale per presidiare le funzioni di controllo pubblico sui rischi correlati all’impiego di tecnologie sempre più invasive; per di più uno strumento flessibile, che consente anche la partecipazione di rappresentanti di culture e interessi diversi, dall’accademia al mondo dell’impresa; un altro passo importante che potrà dare frutti importanti, attraverso un lavoro collegiale al quale sono chiamati a partecipare anche il Procuratore generale della Cassazione e il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ma al quale è prevista e auspicabile la partecipazione anche di altri Uffici giudiziari.
e) Come si accennava, il nuovo decreto sulle tariffe delle prestazioni funzionali all’esecuzione delle intercettazioni, per quanto adottato faticosamente e con non poche traversie del suo cammino, è infine giunto al traguardo, ponendosi come importante strumento di garanzia: non solo dell’uniformità e dell’economicità delle relative spese, ma dell’interesse generale a definire e a rendere uniforme un profilo identitario dei fornitori e delle tecnologie impiegate, secondo principi di trasparenza, affidabilità tecnologica e organizzativa, correttezza del trattamento dei dati personali, integrità e sicurezza dei dati e tracciabilità di ogni attività che li riguardi; anche in questo caso, l’esperienza delle Procure che si erano già dotate di standard di sicurezza assai elevati ha molto contribuito a definire i contenuti del decreto, come può agevolmente rilevarsi, confrontando le misure organizzative che il decreto oggi rende obbligatorie per tutti ai provvedimenti organizzativi già adottati, fra le altre, dalle Procure di Napoli, Torino e Milano.
f) Nella sua premessa, il decreto 18.10.2022 reca finalmente la prima, pur debolissima, traccia normativa di un altro, essenziale passaggio evolutivo dei sistemi di intercettazione: “occorre proseguire nella razionalizzazione tecnica ed organizzativa dei sistemi di intercettazione, avente quale obiettivo finale la realizzazione di cinque data center nazionali, e che tale processo deve essere accompagnato da una revisione sistematica dei metodi di programmazione delle spesa relativa”: a questo obiettivo si lega la responsabilità, anche politica, di realizzare urgentemente il consolidamento delle attuali 140 sale server (attraverso la creazione di poche sale interdistrettuali, governate da architetture digitali e logiche di gestione direttamente definite e controllate dal Ministero, ovviamente nella cornice data dal perimetro nazionale della cybersicurezza): si tratta di un progetto a lungo rimandato, benché ricompreso sin dal 4 aprile 2017, dal Piano decennale di finanziamenti per gli investimenti nel settore delle infrastrutture digitali dell’amministrazione giudiziaria che nasceva dallo sforzo di ripensare l’intera architettura dei sistemi di intercettazione alla luce delle indicazioni date dal Garante nazionale della privacy nel 2013; è del tutto evidente, infatti, che 140 sale server, per di più gestite secondo modelli differenziati, offrivano e tuttora offrono garanzie solo apparenti ai temi della sicurezza, essendo costituite da macchine e algoritmi gestiti da privati, la conoscenza e l’uso dei quali avviene soltanto attraverso la mediazione dell’impresa privata. Il consolidamento delle infrastrutture è un passaggio essenziale e una scelta non più eludibile o rinviabile, sulla quale da tempo convergono le sensibilità maturate fra le procure distrettuali. Da questo passaggio, apparentemente pratico, dipende invece l’equilibrio complessivo del sistema e nessuna scelta normativa, anche oggi, potrebbe vantare credibilità prescindendo dalla sua realizzazione. Non solo: la mancata realizzazione di quel progetto consentirebbe di chiudere agevolmente la procedura di infrazione, per violazione delle regole sull’evidenza pubblica europea nelle procedure di affidamento dei servizi funzionali alle intercettazioni, da tempo pendente nei confronti dell’Italia. Io credo che il Parlamento possa far molto anche vigilando sulla tempestività dei processi organizzativi necessari alla coerente attuazione delle leggi adottate e dettando per essi direttive e cadenze rigorose.
g) Lo stato dei processi di digitalizzazione e la gestione dell’Archivio delle Intercettazioni: questo fondamentale strumento di segregazione delle intercettazioni inutilizzabili o non rilevanti a fini di giustizia ha dimostrato di funzionare: anzi, come già detto, deve estendersene l’impiego al complesso dei dati personali afferenti alle comunicazioni che cadono nell’orbita delle investigazioni (da quelli acquisiti con il captatore con funzioni on line search alle copie forensi di dispositivi oggetto di ispezione, perquisizione e sequestro, sino ai servizi di videosorveglianza o di localizzazione con GPS, talvolta non meno invasivi delle intercettazioni), che invece oggi, di regola, con l’esercizio dell’azione penale sono assoggettati al regime di pubblicità proprio della fase del giudizio. Ma già attualmente il sistema, da tutti apprezzato, rivela criticità: di capienza, per insufficienza delle architetture di storage, di sicurezza, per la perdurante assenza di sistemi di monitoraggio degli accessi, delle operazioni e degli interventi sui server delle imprese fornitrici dei servizi (il software sperimentato a Milano e Napoli dal Ministero, il cd. Bomgar, sembra essere stato accantonato, per ragioni non chiare: forse, perché lento e inadeguato, ma, forse, anche per la resistenza opposta dalle società del settore all’introduzione di controlli sulle fonti e le tecniche di inserimento dei dati), ma soprattutto pensato solo per la gestione del procedimento in corso, mancando ancora una regola temporale per la conservazione dei dati, di fatto imponendosi quella del sine die. Sono criticità che dovrebbero costituire oggetto di prioritaria considerazione politica e gestionale, salvo a voler rendere ancora una volta omaggio alla tradizionale indifferenza delle politiche della giustizia ai temi posti dalle tecnologie e dalla loro gestione, che hanno invece grande e silenzioso impatto sulla sorte dei diritti delle persone.
Soprattutto, molto può il Parlamento fare per l’avanzamento degli equilibri del rapporto fra esigenze delle indagini e diritti della persona: perché vi è bisogno di un deciso avanzamento di quegli equilibri, attraverso la previsione di nuove e più elevate garanzie individuali e della funzione difensiva.
Ma non vi è bisogno alcuno di indebolire senza ragione la capacità di risposta repressiva di gravi fenomeni criminali, perché ciò determinerebbe prezzi elevati da pagare e inevitabili, nuove e inconcludenti oscillazioni del pendolo legislativo.
Vi sono, dunque rilevanti e anche gravi deficit normativi che aggravano le tensioni sul complesso rapporto fra segretezza delle indagini (e dei contenuti e della stessa esistenza delle intercettazioni, in particolare) ed effettività del diritto di difesa e della libertà di informazione: sono profili bisognevoli di urgente intervento, possibile senza indebolire l’efficacia delle indagini.
Alcuni di tali profili sono da sempre sulla sfondo, ma vanno comunque indicati, per non sottacere i pericoli che si profilano quando se ne oscura il rilievo:
a) l’ipocrita distinzione fra atto segreto e atto non più segreto, ma non pubblicabile: un tema che la dottrina liberale più autorevole addita da sempre come primo fattore di credibilità del sistema (basta rimandare agli scritti di Glauco Giostra e Francesco Palazzo e di tanti altri eminenti studiosi): un sistema razionale esigerebbe che ciò che sia segreto sia effettivamente tutelato e preservato come tale e ciò che segreto più non è possa essere pubblicato; la riforma del 2017 va in questa direzione, prevedendo, da un lato, la definitiva segregazione di ciò che non è utilizzabile e rilevanti a fini di giustizia e, dall’altro, la pubblicabilità delle ordinanze cautelari, salvo che nella parte riferita ai contenuti delle intercettazioni: una strada giusta, ma non interamente percorsa; peraltro, la disciplina transitoria, pur ragionevole, di fatto ha rallentato e persino ostacolato la stessa visione dell’importanza degli effetti pratici conseguenti alla riforma;
b) la mancanza di una formale ed espressa previsione normativa sull’accesso degli organi di informazione agli atti non segreti esclusivamente mediante la procedura formale dell’art. 116 c.p.p.: non è la panacea di ogni male, ma l’esperienza dimostra che, dove si applica quella procedura, si sopiscono le tensioni e si annullano quasi i rischi propri del sistema di scambi immorali denunciato da anni dal giornalismo più attento e colto; sancire espressamente la legittimità di quell’interpretazione, che fortunatamente va estendendosi, varrebbe a consolidare e diffondere modelli più avanzati, in linea con l’idea fondamentale che vuole le democrazie fondate sui principi di indipendenza della funzione giudiziaria e di libertà di informazione.
Ma altre questioni sembrano estranee al dibattito pubblico e sono a mio avviso, invece, straordinariamente rilevanti nella prospettiva del potenziamento delle garanzie difensive e del contenimento del rischio di abusi.
Ed è di questi ultimi profili che, a mio sommesso avviso, occorre la più urgente valutazione del legislatore.
Li indico assai sommariamente, ma spero con sufficiente chiarezza, atteso il rilievo cruciale dei relativi passaggi normativi.
1) Vi è un evidente ritardo normativo nel prendere atto della profonda necessità di innalzamento delle garanzie legali collegate alla tutela dei dati personali che confluiscono nei sistemi digitali: un ritardo evidente, direttamente collegato al da tempo sopravvenuto rilievo eccezionale dei dati personali diversi da quelli oggetto della tradizionale captazione delle comunicazioni: ma tale da imporre, come è stato detto, “la formulazione di un nuovo apparato normativo dagli orizzonti più vasti” (Marafioti, 2023). La stessa nozione codicistica di “intercettazione”, intesa quale captazione clandestina dei flussi di comunicazione in atto fra due soggetti, entra in crisi nell’era digitale, non valendo ad abbracciare e disciplinare unitariamente fenomeni diversi, ma caratterizzati comunemente dalla sottrazione alla sfera di privatezza delle persone di dati di straordinario rilievo giuridico e sociale. È questo un punto cruciale per cogliere la radice di tensioni che la giurisprudenza mostra di non saper risolvere e che probabilmente non può risolvere, come dimostra la sofferenza visibile nell’impiego delle tradizionali categorie del documento e della corrispondenza per individuare la cornice normativa di attività invasive per le quali si rivela la necessità di rafforzamento delle garanzie individuali. Una sofferenza ancor più grande, perché palesemente sostenuta dalla consapevolezza che soltanto il legislatore può definire il punto di equilibrio fra efficienza delle indagini e tutela della riservatezza e delle altre libertà fondamentali; è forse giunto il momento di riconoscere che vi è un deficit di effettività del principio di legalità processuale e delle correlate garanzie difensive che può essere colmato senza pregiudizio per le esigenze di accertamento dei reati più gravi e in coerenza con l’intervento legislativo del 2017; mi riferisco alle possibilità di acquisizione occulta di chat pregresse e comunque di contenuti dei dispositivi di comunicazione telematica mediante captatore in funzione on line search o alle possibilità di ispezione, perquisizione e sequestro di archivi informatici, quali quelli contenuti anche in un semplice smartphone, derivanti dall’inquadramento giurisprudenziale di queste attività come attività “atipiche” di ricerca della prova: è giunto il momento, di “valorizzare, nel settore delle indagini digitali, il principio di proporzionalità quale parametro di legittimità per le attività investigative” (Marafioti, 2023), ciò che oggi non è, se, come sovente accade, è dato sequestrare uno smartphone o altro dispositivo analogo con provvedimento adottabile procedendo per qualsivoglia reato: in ipotesi, anche per semplici contravvenzioni ovvero comunque per delitti di scarsa gravità. In pratica, si tratta di innalzare il valore del principio di libertà di comunicazione prevedendo l’intervento del Giudice e l’introduzione di rigorose condizioni di proporzionalità ed adeguatezza dell’agire investigativo, così legando l’esercizio del potere di acquisizione dei dati personali a rigidi presupposti, definiti da adeguati limiti edittali e da altre tassative specificazioni e, non ultimo, a più rigorosi e perciò controllabili oneri motivazionali; soprattutto, è necessario prevedere che i dati siano trattati come quelli delle intercettazioni, confluendo nell’Archivio delle Intercettazioni: soltanto così i dati irrilevanti a fini di giustizia potranno restare segregati e sfuggire ad ogni diffusione sterminatrice della reputazione, dell’onore e della vita delle persone.
2) Vi sono altri temi di complessità e delicatezza tali da imporre la necessità d un intervento immediato del legislatore e per tale via limitare la discrezionalità giudiziaria correlata a clausole generali che abbisognano di essere sostituite da rigorose e tassative prescrizioni legali: in generale, è istituzionalmente pericoloso che tali temi siano affidati al giudice al di fuori di una rigorosamente delimitata griglia normativa: non solo per la precarietà e la possibile difformità delle pronunce, ma perché, valendo ogni revirement o comunque nuovo indirizzo interpretativo a creare instabilità e pratica crisi della prevedibilità e della stessa comprensibilità della giurisdizione, si introduce ogni volta il rischio di travolgimento di esiti processuali non definitivi, ma legittimamente formati su indirizzi della giurisprudenza di legittimità tanto consolidati da costituire diritto vivente: i rischi più alti li vedo per le stesse indagini di mafia e di terrorismo in relazione alle oscillazioni giurisprudenziali che ormai segnano, nonostante plurimi interventi delle Sezioni Unite della Cassazione, l’interpretazione del concetto di “criminalità organizzata” di cui all’art. 13 del d.l. 152/1991, sul quale posano i pilastri di un regime differenziato delle intercettazioni per i delitti di mafia e terrorismo che mi pare che nessuno possa contestare nella sua perdurante necessità e nella sua stessa giustificazione razionale; bene, dinanzi a pronunce, per quanto isolate, che, stravolgendo gli indirizzi dati dalle Sezioni Unite, affermano che sarebbero delitti di criminalità organizzata soltanto quelli associativi, così giungendo alla conclusione, contraria persino al senso comune, che un omicidio di mafia non sarebbe un delitto di criminalità organizzata; si staglia così tutta la responsabilità politica del legislatore di definire esattamente i contorni e i limiti di tale nozione: al vantaggio della chiarezza delle scelte politiche si assocerà quello della salvaguardia delle vicende processuali in corso; è questo un tema che attualmente agisce come fattore di destabilizzazione di tutte le indagini e di tutti i processi di mafia non ancora giunti alla definitiva conclusione, anche con riferimento all’analoga clausola legale che definisce l’ambito di applicazione della disciplina della sospensione feriale dei termini processuali: al momento, tale tema ha formato oggetto di una mia preoccupata missiva diretta al Procuratore generale della Corte di Cassazione, nella quale ho potuto esprimere soltanto, in uno all’allarme condiviso dai Procuratori distrettuali, l’auspicio di un urgente, nuovo intervento delle Sezioni Unite. Ma, intanto, ancora nei giorni scorsi, cadono nel nulla processi costruiti pazientemente sulla base di orientamenti dalla giurisprudenza di legittimità della stabilità dei quali sembrava potersi confidare.
3) Naturalmente, al piano dell’innalzamento delle garanzie attiene anche la questione della ulteriore delimitazione dell’impiego di alcune delle tecniche di indagine più invasive, come quelle legate all’impiego a fini di captazione del cd. trojan, vale a dire le intercettazioni telematiche mediante captatore informatico; si tratta di un tema sul quale il mio Ufficio è pronto ad offrire ogni doveroso e opportuno contributo informativo, ma che di per sé è oggetto di una responsabilità tipicamente politica, come tale esclusiva del legislatore e delle forze politiche che concorrono a determinarne l’esercizio. Quale Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, tuttavia, avverto la responsabilità di porre a disposizione delle valutazioni del Parlamento i dati di una ormai vasta e consolidata esperienza, i quali dimostrano, senza tema di smentita, che l’efficacia reale dell’azione di contrasto della criminalità mafiosa dipende largamente dalla capacità di proiettare le indagini sui versanti nei quali operano le sue componenti più sofisticate e pericolose, perché deputate ai processi di reinvestimento speculativo, di condizionamento delle pubbliche amministrazioni (basta al riguardo riferirsi alle valutazioni governative che sono state alla base dello scioglimento degli organi elettivi di amministrazioni anche di grande importanza sociale) e di penetrazione profonda dei mercati d’impresa, a partire da quelli sui quali si riversano i maggiori flussi della spesa pubblica. Tali processi sono affidati non a uomini con la coppola sul capo e la lupara in spalla, ma al linguaggio, largamente praticato dal mercato e nel mercato, della frode fiscale e, soprattutto, della corruzione. Molte ed anche importanti indagini di mafia, soprattutto, ma non solo, nelle regioni centro-settentrionali, sono originate da indagini avviate sul fronte del contrasto della corruzione e delle frodi fiscali; escluderle dal novero di quelle per le quali quelle tecniche investigative sono consentite sarebbe dunque scelta legittima, ma destinata ad avere conseguenze pesantissime, non solo sul versante del contrasto della corruzione, ma anche sul terreno delle indagini di mafia. Come pure appartiene alla responsabilità esclusiva del legislatore la scelta del tempo di tale eventuale scelta, coincidente con l’attuazione di processi di spesa pubblica finanziati con risorse euro-unitarie, generate, almeno in parte, dalla tassazione di cittadini ed imprese di altri Paesi dell’Unione Europa, per presidiare l’uso delle quali l’Unione agisce anche in ambito investigativo e giudiziario attraverso l’Ufficio del Procuratore Europeo. Non spetta ad un magistrato pronunciarsi al riguardo, ma vorrei, anche in questa autorevolissima sede, ricordare le parole pronunciate dal Presidente Draghi nella sala dedicata a Giovanni Falcone della DNA nel settembre scorso, invitandoci a considerare quale disastroso effetto avrebbe sulla credibilità dell’Italia la mera diffusione della percezione che una significativa parte di quelle risorse possano finire nelle mani delle mafie e nei mille rivoli di fenomeni corruttivi che certo non sono estranei alla spiegazione del dato statistico che rivela che il 70 per cento delle opere pubbliche incompiute si trovano nelle regioni meridionali. In ogni caso, vale forse la pena di sottolineare che nel 2019 non si realizzò l’introduzione dell’uso del trojan per i delitti contro la p.a., già consentito dalla riforma del 2017 per tutti i delitti che consentono il ricorso alle intercettazioni, ma soltanto l’equiparazione dei delitti di corruzione et similia ai delitti di criminalità organizzata e terrorismo ai limitati fini, oltre che dell’estensione degli ambiti di privata dimora considerati prescindendo dal loro utilizzo a fini criminosi, dell’esclusione dell’obbligo del Giudice di indicare, all’atto dell’autorizzazione, non soltanto le ragioni che rendono necessaria quella invasiva modalità di captazione, ma anche “i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l’attivazione del microfono” (art. 267, comma 1, c.p.p.): una clausola che nell’esperienza pratica si risolve nella pretesa di esercizi di chiromanzia che contrastano con la realtà delle investigazioni e la stessa possibilità di predisporre dettagliati piani previsionali e nella conseguente generazione di controversie e polemiche intorno ai limiti di quelle predizioni, tanto più considerando che, dopo tutto, quando si ricorre al captatore, lo si fa partendo dal dimostrato presupposto che non sia dato individuare preventivamente i luoghi e i tempi di una determinata condotta. Ma conviene ricordare, poiché nel dibattito pubblico sembra affacciarsi l’idea che le intercettazioni siano disposte ad ogni passo di un qualsiasi pubblico ufficiale, che per i delitti di criminalità organizzata soltanto la soglia di accesso a queste tecniche di intercettazione è data dalla sussistenza di sufficienti indizi, per tutti gli altri casi, compresi quelli in tema di corruzione, essendo invece necessaria la dimostrazione dell’esistenza di gravi indizi di reità.
4) Le ragioni di rivisitazione normativa non si esauriscono lungo quei pur fondamentali tracciati argomentativi: vi è una grave ed evidente carenza di garanzia legale di fondamentali istanze di rafforzata tutela della segretezza dei contenuti delle intercettazioni nelle prassi operative: in alcuni uffici esistono già disposizioni organizzative e direttive alla polizia giudiziaria che impongono, ad esempio, di attestare la distruzione di ogni copia di lavoro di file audio e trascrizioni una volta scaduto il termine dato dalla legge per procedere all’elaborazione investigativa del materiale raccolto ovvero anche il divieto di inserire nei data base delle forze di polizia i contenuti delle intercettazioni prima e indipendentemente dalla cristallizzazione del materiale utilizzabile e rilevante da quello che tale non è che si realizza al momento dell’esercizio dell’azione cautelare o della richiesta di giudizio, ovvero ancora il dovere di traduttori, interpreti e consulenti trascrittori di attestare di non conservare alcuna copia dei dati cui hanno avuto accesso per ragioni del loro ufficio di ausiliari; sono scelte rivelatesi importanti nella prevenzione degli abusi del passato, ma che sarebbe necessario elevare di rango precettivo, assicurandone l’uniforme applicazione. Va, in altri termini, sancita la necessità di ancoraggio a precisi canoni normativi del trattamento di informazioni e dati così delicati: ad esempio, prevedendo un divieto generale di conservazione da parte di chiunque vi abbia avuto accesso di dati diversi da quelli che possono legittimamente ritenersi rilevanti e utilizzabili; una materia delicata, che non consente però il trascinamento di prassi insensibili alle istanze di tracciabilità e controllo delle attività investigative che hanno a che fare con dati segreti, a cominciare dall’impiego di tecniche codificate di raccolta e conservazione di atti e documenti informatici; i dati segreti vanno trattati come tali, soprattutto se si prevede che quelli non rilevanti a fini di giustizia, ma intanto acquisiti agli atti, sia destinati restare tali: il loro trattamento esige dunque precise garanzie di trattamento, conservazione e tracciabilità; si tratta di un aspetto importante, che vale a rimarcare con nettezza la distinzione fra la libertà di informazione, che può giungere persino oltre il confine del segreto, e il dovere dei pubblici ufficiali di preservare il segreto, osservando regole e protocolli assai più rigidi di quelli oggi praticati.
5) È parimenti necessario, al medesimo fine, che una norma legale imponga all’amministrazione della giustizia di assicurare la tracciabilità di tutti gli interventi, anche di mero accesso, ai dati delle intercettazioni conservati nell’Archivio delle intercettazioni: scelta tanto più necessaria fino a quando le infrastrutture fondamentali - le sale server - non saranno consolidate e trasferite nella sfera di controllo dello Stato: le tecnologie consentono già ora di farlo, con riferimento ai server privati dei fornitori collegati all’A.D.I., ma, in mancanza di una prescrizione legislativa che ne faccia una priorità, il dispiegamento dei software a ciò necessari finisce inevitabilmente in coda alla lista delle cose da fare delle strutture ministeriali; ma è cosa che non tollera approssimazioni e ritardi, come quelli già sopra indicati; tocca al Ministero colmare al più presto il vuoto di iniziative su questo decisivo terreno, ma il Parlamento può aiutare il Ministro e il Ministero a realizzare questo passaggio, prescrivendone la doverosità e dettandone i tempi.
6) La tensione sui profili di sicurezza collettiva e della stessa funzione di sicurezza della Repubblica, che pure si avvale dei medesimi servizi, conseguente alla continua tensione dei nuovi prodotti e delle nuove strategie commerciali con i principi alla base della definizione normativa di prestazioni obbligatorie da assicurare a fini di giustizia e di sicurezza: materia delicatissima, come ovvio. Ma segnata da due distinte e fra loro concorrenti urgenze di regolazione legislativa:
a) la prima è generata dalla decisione della Grande Sezione della Corte UE del 20 settembre 2022, in materia di presupposti e condizioni di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico. L’interpretazione della Corte integra la disciplina data dalla Direttiva 58/2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, distinguendo le possibilità di conservazione dei dati che nei sistemi nazionali possono essere introdotte con provvedimenti normativi, a seconda della natura e del diverso valore degli obiettivi delle misure legislative. La Corte costruisce quindi una gerarchia delle esigenze che possono giustificare una conservazione ampia dei metadati delle comunicazioni (quelli cioè destinati a confluire nei cd. tabulati, che altra decisione della Corte UE ha imposto di riservare al Giudice), a seconda che si tratti di “salvaguardia della sicurezza nazionale” ovvero di esigenze di “prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e… della sicurezza pubblica”: nel primo caso soltanto, in forza di un necessario principio di proporzionalità, sarebbe possibile introdurre o conservare un obbligo di conservazione generalizzato e indiscriminato di quei metadati. Questa la decisione, ma l’adattamento normativo nel sistema italiano non può non tener conto del fatto che criminalità mafiosa e terroristica partecipano a pieno titolo alla definizione di minacce alla sicurezza nazionale; lo comprova, oltre alla constatazione della realtà derivante dalla storia recente del nostro Paese, la circostanza che criminalità organizzata e terrorismo sono anche, secondo la legge italiana (e sin dal d.l. 345/1991), minacce alla sicurezza della Repubblica, come tali corrispondenti a specifiche finalità preventiva delle agenzie di intelligence; appare cruciale, dunque, nel valutare l’impatto della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, tenere al riparo il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo, da una ridefinizione degli obblighi di conservazione che varrebbe a minare la sicurezza nazionale, tanto più nel momento nel quale la pericolosità del crimine organizzato mafioso e del terrorismo si salda alle spinte minacciose che su questi versanti muovono dai teatri di guerra e di destabilizzazione;
b) secondo punto: ogni giorno entrano in gioco software e tecniche commerciali che rischiano di vanificare o ostacolare seriamente quella finalità di prevenzione, tanto della sicurezza nazionale che della sicurezza pubblica e della correlata esigenza di prevenzione e perseguimento dei reati: la riservatezza è giustamente un atout commerciale ed anche dunque un fattore di concorrenza, ma gli obblighi in tema di prestazioni obbligatorie valgono a costruire una cornice di compatibilità con i valori della sicurezza: ogni volta si produce la necessità di una verifica tecnica attenta: un settore questo nel quale la DNA, con l’essenziale partecipazione dei servizi centrali di polizia, agisce come interlocutore naturale tanto delle imprese quanto dei ministeri interessati, ma del quale sarebbe necessario un coordinamento costante e unitario, che non può che essere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le attribuzioni della quale sono peraltro direttamente coinvolte, sia dal punto di vista del ruolo della nuova Agenzia per la cybersicurezza sia da quello delle prerogative del sistema di intelligence che per le sue attività ricorre alle medesime tecnologie: un tema urgente anche questo, non solo nella prospettiva della riscrittura già in corso di molte delle norme del codice delle telecomunicazioni, ma anche e soprattutto in quella del raccordo operativo di funzioni statuali di amministrazione attiva che ancora sfuggono alla logica propria soltanto di una visione unitaria ed organica di una così delicata materia.
[1] L’articolo 706-102-1 del codice di proc.pen., nella sua formulazione risultante dalla legge 23 marzo 2019, dispone: "Si può ricorrere all'attuazione di un dispositivo tecnico il cui scopo, senza il consenso degli interessati, è quello di accedere, ovunque, a dati informatici, di registrarli, archiviarli e trasmetterli, in quanto conservati in un sistema informatico, come vengono visualizzati su uno schermo dall'utente di un sistema automatizzato di elaborazione dati, poiché li introduce inserendo dei caratteri o mentre vengono ricevuti e inviati dalle periferiche.
“Il pubblico ministero o il giudice istruttore può designare qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata ed iscritta in uno degli elenchi previsti dall'articolo 157, al fine di compiere le operazioni tecniche che consentano la realizzazione del dispositivo tecnico di cui al primo comma di questo articolo. Il Pubblico Ministero o il Giudice Istruttore possono altresì prescrivere l'utilizzo di risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale nelle forme previste dal Capo I del Titolo IV del Libro I”.
Regionalismo differenziato e divari di cittadinanza nelle più recenti proposte di riforma*
di Francesco Manganaro
Sommario: 1. La crisi del regionalismo italiano - 2. Le incertezze interpretative sull’autonomia differenziata - 3. I disegni di legge Calderoli e le connesse disposizioni della legge di bilancio - 4. Le materie oggetto dell’autonomia differenziata.
1. La crisi del regionalismo italiano
Il disegno di legge proposto dal Ministro Calderoli a dicembre e quello appena emanato hanno riaperto il tema del regionalismo differenziato, rimasto silente durante il periodo pandemico
Mi sembra necessario, per affrontare una questione così delicata, almeno accennare al contesto in cui si pone tale vicenda, soprattutto richiamando, seppure assai brevemente, quale sia l’attuale ruolo delle Regioni nel complessivo contesto istituzionale.
Non vi è dubbio che la scelta del Costituente di creare le Regioni avesse come scopo di individuare un livello legislativo sui territori, che consentisse di differenziare le scelte normative generali del Parlamento nazionale. E’ altrettanto scontato che il Costituente volesse attribuire alle Regioni una funzione legislativa, che avrebbe dovuto essere attuata attraverso le attività amministrative degli enti locali (art. 118 Cost. vecchio testo).
Questa originaria idea ha subito una profonda metamorfosi, innanzitutto per la tardiva costituzione delle Regioni e l’ancora più tardiva attribuzione delle funzioni, ma anche perché le Regioni, con la creazione di enti di amministrazione sub-regionali, hanno accorpato alla funzione legislativa quella amministrativa, così sottraendola agli enti territoriali. Tanto è vero che la dottrina più recente in materia di regionalismo non esita a produrre un ampio manuale di diritto regionale che conferma fin dal suo titolo il mutamento genetico delle Regioni[1], nonché la totale distonia di un sistema autonomistico che avrebbe dovuto svilupparsi attraverso un coordinamento tra Regioni ed enti locali.
La distorsione del regionalismo italiano è confermata dalla dottrina che più ampiamente si è occupata del tema. Si è parlato di Regioni senza regionalismo[2], di un regionalismo senza modello[3] e si è criticamente osservato che l’autonomia regionale sia stata utilizzata in maniera congiunturale[4] secondo gli interessi del sistema politico[5].
È in questo quadro che il costituente del 2001, nell’ambito di un processo autonomistico di de-statalizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 5 Cost., introduce una specifica disposizione sul regionalismo differenziato (art. 116, c. 3 Cost.) il cui contenuto comporta non solo problemi interpretativi, ma anche l’esplicita previsione che si debba tener conto degli equilibri finanziari previsti dall’art. 119 Cost., poiché quanto più aumenta l’asimmetria tanto più deve crescere la solidarietà.
Bisogna, perciò, valutare il regionalismo differenziato in un’ottica che riduca e non aumenti i divari di cittadinanza[6], come ci ricorda ampiamente il PNRR, che pone questo obiettivo come una delle tre priorità trasversali alle sei Missioni, secondo un principio di coesione sociale, economica e territoriale[7], previsto dal Next Generation EU, ai sensi degli artt. 174 e 175 del TFUE. Un principio ribadito di recente nell’autorevole intervento del Presidente della Repubblica che, nel discorso di fine anno, ha ricordato con significative espressioni che le differenze legate a fattori sociali, economici, organizzativi, sanitari tra i diversi territori del nostro Paese <<feriscono il diritto all’eguaglianza>>.
2. Le incertezze interpretative sull’autonomia differenziata
Quanto al contenuto normativo dell’art. 116, c. 3 si è sviluppato un ampio dibattito, già dal momento dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale introdotto dalla legge 42/2009, ma soprattutto negli anni 2017-2020 quando alcune Regioni (Emilia – Romagna, Lombardia e Veneto) hanno chiesto l’attuazione del regionalismo differenziato,
Innanzitutto, la norma costituzionale prevede che alle Regioni a Statuto ordinario possano essere attribuite <<ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia>> nelle materie ivi indicate. Ora, tale formula non significa necessariamente che debbano essere assegnate maggiori potestà legislative, ma potrebbe ben significare un ampliamento delle funzioni amministrative delle Regioni nelle materie oggetto di legislazione concorrente, un’iniziativa che ben potrebbe essere attuata utilizzando l’art. 118 Cost.[8].
Rimasta minoritaria tale ipotesi, la questione si è spostata su un altro versante, quello relativo agli atti necessari per trasferire le funzioni legislative. Innanzitutto, la previsione di stipulare singole intese con ogni Regione crea non solo un’asimmetria nell’asimmetria, ma configura un’autonomia regionale fuori da ogni contesto istituzionale complessivo, quasi che l’autonomia differenziata sia un fatto che attenga al rapporto di una Regione con lo Stato, senza alcun quadro generale di riferimento, valido per tutte le Regioni[9]. Le iniziative già assunte dalle Regioni dal 2017 in poi dimostrano palesemente quanto sia errato un rapporto face to face tra Stato e singole Regioni, per la totale difformità delle richieste. Come è noto, infatti, alcune Regioni hanno chiesto, in un primo momento, l’attribuzione di tutte le ventitre materie comprese nel comma 3 dell’art. 116 Cost., mentre altre hanno fatto scelte diverse.
Si è osservato, a questo proposito, che ove tutte le Regioni chiedessero, come sarebbe in teoria possibile, tutte le materie si incorrerebbe in una grave violazione della Costituzione, in quanto verrebbe svuotato l’ambito della legislazione concorrente previsto dall’art. 117 Cost. Per prevenire tale evento, parte della dottrina ha proposto di introdurre una legge – quadro nazionale che regolamenti in modo unitario i principi dell’autonomia differenziata[10].
L’altra grande questione è proprio il ruolo del Parlamento nel procedimento autonomistico, visto che non è chiaro se esso possa o meno modificare l’intesa concordata tra Governo e Regione.
Si noti, a margine dell’ampia discussione avvenuta in dottrina, che la norma costituzionale è stata implicitamente superata per le modifiche istituzionali sopravvenute, poiché quando il Costituente aveva previsto l’approvazione dell’intesa con la maggioranza assoluta dei parlamentari intendeva coinvolgere anche la minoranza parlamentare, ma non poteva prevedere l’avvenuta riduzione del numero dei parlamentari e la possibilità di una maggioranza assoluta in capo ad un solo partito o ad una sola coalizione.
Ma, a parte questo profilo, il punto più controverso attiene alla possibilità che il Parlamento possa emendare l’intesa e sulle eventuali conseguenze successive. La dottrina del tutto maggioritaria considera necessario un passaggio parlamentare senza alcun vincolo circa l’emendabilità, mentre sul punto la prima bozza Calderoli prevedeva, prima della sottoscrizione dell’intesa, un parere della Commissione per le questioni regionali, anche acquisibile tacitamente (art. 2, commi 4-5). Il nuovo testo introduce alcune modifiche che non cambiano il senso complessivo dell’iter previsto: si prevede che il parere venga dato dai <<competenti organi parlamentari>> nel termine di sessanta giorni, mentre rimane la possibilità che il procedimento prosegua, trascorso il termine indicato.
L’intesa definitiva già sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale, va inviata alle Camere come allegato di un disegno di legge per <<l’approvazione>> (prima bozza), oggi per la <<deliberazione>> (art. 2, c. 8). Anche così scritta la novella non chiarisce se il Parlamento possa emendare la bozza di intesa già sottoscritta e quali siano le conseguenze di queste eventuali modificazioni.
3. I disegni di legge Calderoli e le connesse disposizioni della legge di bilancio
Ma veniamo al tema più specificamente assegnatomi, cioè gli ultimi interventi normativi concretizzatosi nei disegni di legge Calderoli e nelle connesse disposizioni contenute nella legge di bilancio 2023[11].
Il disegno di legge si concentra sulla necessità di stabilire i livelli essenziali delle prestazioni[12] prima di poter procedere all’attuazione delle intese con la Regione, attuative del regionalismo differenziato (art. 1).
Innanzitutto, è stato acutamente osservato che su questo punto il disegno di legge è quasi uno specchietto per le allodole, in quanto l’intera disciplina per la determinazione dei LEP è contenuta nella legge finanziaria, già approvata dal Parlamento[13]. E’ questa la vera novità rispetto al passato[14], poiché i precedenti governi avevano previsto le modalità di realizzazione dei LEP in disegni di legge mai approvati definitivamente, mentre, in questa occasione, al disegno di legge Calderoli si aggiungono norme già vigenti nella legge di bilancio, che rendono del tutto superfluo il disegno di legge, quanto meno sulle modalità di definizione dei LEP.
La disciplina dei LEP è, infatti, integralmente contenuta nella legge di bilancio ai commi da 791 a 801, a cui peraltro la bozza Calderoli rinvia. Invero, in tale legge è già del tutto definito il percorso per la determinazione dei LEP, <<quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale>> e garantire <<il pieno superamento dei divari territoriali>> (c. 791). Nella legge di bilancio, la determinazione dei LEP è conseguente alla previa ricognizione dei costi standard, tanto è vero che il comma 792 prevede la procedura per la loro individuazione a partire da una <<ricognizione della spesa storica a carattere permanente nell’ultimo triennio>>[15].
È qui uno dei punti nodali su cui valutare i reali effetti del regionalismo differenziato.
Come è noto, la determinazione dei fabbisogni standard era già prevista, ma mai realizzata (tranne che per in materia sanitaria), già dalla legge sul federalismo fiscale n. 42/2009, secondo cui i decreti attuativi avrebbero dovuto effettuare la «determinazione del costo e del fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che, valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica».
Dal punto di vista del procedimento previsto, mi limito a rilevare come sia paradossale costituire una Cabina di regia ed una Commissione tecnica per la determinazione dei fabbisogni standard per poi stabilire che, nel caso in cui le attività dei predetti organi non si concludessero entro sei mesi, il Presidente del Consiglio, d’intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina un commissario che <<entro trenta giorni>> (c. 797) procede al completamento della attività non perfezionate.
In secondo luogo, sempre dal punto di vista procedimentale, appare ancora più grave che tutto il procedimento previsto nella legge finanziaria per la determinazione dei LEP avvenga attraverso atti governativi, eludendo gravemente il dettato costituzionale, secondo cui la determinazione dei LEP non può che avvenire con legge statale, come previsto dall’art. 117, lett. m) Cost. Insomma, la definizione dei LEP è una questione di ordine generale, che ha un suo percorso normativo specifico ed è un errore confonderlo con l’attuazione dell’autonomia differenziata, che ha percorsi normativi diversi[16].
Quanto al merito, il dibattito attuale è tutto incentrato sulla determinazione dei LEP, ma si trascura un presupposto essenziale, cioè l’esigenza di misure perequative territoriali, necessariamente antecedenti a qualsiasi innovazione istituzionale per evitare la crescita dei divari di cittadinanza[17]. Come è noto, l’art. 116 Cost. consente ulteriori forme di autonomia regionale «nel rispetto dei principi dei cui all’articolo 119», disposizione pedissequamente riportata nella legge delega 42/2009, che introduceva il federalismo fiscale. E’ impossibile perciò pensare di attuare il regionalismo differenziato senza rispettare il contenuto dell’art. 119 Cost., che prevede uno specifico fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante[18].
Invero, il sistema pensato dal Costituente del 2001 è ben più complesso ed articolato, con obiettivi più ampi del solo regionalismo differenziato. La legge delega prevedeva, infatti, come primo presupposto, l’autonomia finanziaria delle Regioni, in grado di avere tributi propri, con conseguente maggiore responsabilizzazione della spesa. Opportunamente, il percorso di un regionalismo maturo veniva definito attraverso vari passaggi, prevedendo il «superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 2) della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni (art. 2, l. m)». Da allora tutto è rimasto come prima, per la mancata definizione dei costi standard e per l’inesistenza di misure perequative.
Anche chi non è pregiudizialmente contrario al regionalismo differenziato non può non rilevare che il percorso costituzionalmente corretto, previsto già dal 2009, è del tutto mancato, cosicché la “fuga in avanti” di un regionalismo differenziato senza perequazione è un grave pericolo, che accentua i divari di cittadinanza e giustifica le preoccupazioni di gran parte della dottrina[19].
L’enunciazione delle misure perequative contenuta nei disegni di legge Calderoli si limita alla citazione di quanto già previsto nell’art. 119 Cost., ma senza definire mezzi e strumenti per realizzarle; non viene istituito alcun fondo perequativo né indicato il modo in cui le Regioni dovrebbero contribuirvi[20].
La perequazione, secondo la norma costituzionale, va calcolata secondo la capacità fiscale per abitante, mentre attualmente, ad esempio per la distribuzione del maggior fondo destinato alle Regioni in materia sanitaria, è lo Stato a determinare quanto attribuire alle Regioni, che dividono tra loro tale fondo in modo da garantire un finanziamento pro capite simile. Cosicché <<la perequazione è dunque realizzata, in quel contesto, non tanto sulla base della diversità della “capacità fiscale per abitante” ma sulla base del riconoscimento di fabbisogni simili fra le Regioni, calcolati sulla base della ripartizione delle risorse messe a disposizione dello Stato>>[21]. Non avendo tributi propri, la pseudo perequazione non è altro che la compartecipazione delle Regioni ad un fondo statale trasferito ad esse. Da ciò si deduce che la mancata previa determinazione delle forme e delle modalità di perequazione rischia di trasformare queste risorse <<da prestazioni sostanziali da garantire a mere quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali maturato nel territorio regionale (come già ricordato manca un riferimento a possibili tributi propri delle regioni differenziate), sul modello già impiegato in materia di riparto del fondo sanitario nazionale>> [22].
In conclusione, la determinazione dei LEP attraverso i costi standard, accertati sulla spesa storica, come previsto nella legge di bilancio, non consente di realizzare la perequazione prevista dall’art. 119 Cost. e comporta ulteriori divari di cittadinanza. Non vi è traccia, inoltre, di un fondo perequativo, anzi sia nella prima che nella seconda bozza del disegno di legge la modalità di finanziamento rimane la compartecipazione al gettito di tributi erariali maturati nel territorio regionale[23], così confermando la differenza tra territori, dovuta alla diversa capacità fiscale (art. 5 nuova bozza).
Peraltro, entrambe le bozze presentano, su questo profilo, un’altra contraddizione. Da una parte, nella legge di bilancio si configura un procedimento complesso per la determinazione dei LEP e dei costi standard, dall’altra la prima bozza del disegno di legge prevedeva che, fino alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, si sarebbe fatto ricorso «al criterio della spesa destinata a carattere permanente, fissa e ricorrente, a legislazione vigente», sia per le materie soggette ai LEP sia per quelle che non li prevedano. Né è migliore la modifica introdotta con la nuova bozza che attribuisce alle singole intese - come meglio si vedrà di seguito - il potere di prevedere modalità e procedure per il trasferimento delle funzioni (art. 4).
4. Le materie oggetto dell’autonomia differenziata
Il dibattito sull’autonomia differenziata si è soffermato molto sulle procedure necessarie nonché sulla determinazione dei livelli essenziali di prestazione dei diritti civili e politici, molto meno sulle materie oggetto di trasferimento, la cui eterogeneità pone alcune rilevanti questioni.
Il primo disegno di legge Calderoli distingueva esplicitamente tra materie sottoposte ai LEP e materie o ambiti di materie non riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni (art. 3, c. 3), individuando una diversa disciplina ai fini del trasferimento alle Regioni. La modifica ora introdotta nella nuova bozza mantiene tale dicotomia, confermando che le materie sottoposte ai LEP possono essere trasferite solo dopo la determinazione degli stessi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard (art. 4, c. 1), mentre invece le materie diverse da quelle del comma 1 (id est: non sottoposte ai LEP), possono essere trasferite subito dopo l’approvazione del disegno di legge, secondo modalità, procedure e tempi definiti dalle intese (art. 4, c. 2).
Tuttavia resta indefinito come si individuano le materie o gli ambiti di materie esclusi dall’applicazione dei LEP[24]. Il primo disegno di legge attribuiva alla totale discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione di tali materie (art. 3, c. 3). La seconda bozza elimina questa disposizione, ma – come già rilevato - lascia alle trattative tra Stato ed ogni singola Regione il potere discrezionale di stabilire quali siano le materie non soggette ai LEP. Il rimedio è peggiore del male, perché la nuova disposizione, lasciando alla contrattazione delle singole Regioni con lo Stato l’individuazione delle materie sottratte ai LEP, potrebbe finanche produrre l’effetto paradossale che una stessa materia possa essere sottoposta al regime dei LEP in una Regione e non in un’altra.
Sotto altro profilo, tali disposizioni confermano che, non essendo tutte le materie previste dall’art. 116 c. 3 Cost. valutabili alla luce dei LEP, la determinazione di essi è operazione connessa ma autonoma rispetto alla partita del regionalismo differenziato[25].
Il mancato assoggettamento ai LEP di alcune materie induce addirittura a domandarsi se esse siano oggetto di possibile trasferimento e con quali modalità, a maggior ragione perché alcune di esse attengono ad un contesto sovra-regionale, tale da renderne difficile un trasferimento tout court.
La dottrina si è infatti chiesta, ad esempio, se sia logico, soprattutto dopo gli eventi pandemici e bellici, che una materia come i rapporti internazionali possa essere oggetto di potestà legislativa regionale, così come la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia o anche la disciplina di porti ed aeroporti civili o delle grandi reti di trasporto e di navigazione. Il rischio concreto, insito nel processo di trasferimento della legislazione alle Regioni in queste materie, è uno spezzettamento della disciplina normativa, che impedisca le necessarie politiche nazionali, anche perché alcune di tali materie sono oggetto di politiche che coinvolgono non solo lo Stato nazionale, ma addirittura organismi sovranazionali[26].
Una diversa, ma ancora più complessa questione si pone, invece, per le materie oggetto dei LEP, prima di tutto istruzione e sanità.
Per valutare in concreto quali possano essere gli scenari possibili, è utile tenere conto delle concrete fattispecie previste nelle bozze delle intese già predisposte con le tre Regioni che avevano da tempo avviato il processo autonomistico.
Se consideriamo, ad esempio, il settore nevralgico dell’istruzione, tutte le tre Regioni potranno determinare la programmazione dell’offerta formativa, con la possibilità di definire anche la dotazione organica e l’assegnazione alle singole scuole dei docenti; potranno costituire un fondo regionale per contratti a tempo determinato in caso di necessità dell’organico delle scuole, anche istituendo posti in deroga; potranno finanziare nuovi corsi universitari, con ulteriori risorse rispetto al fondo di finanziamento ordinario statale.
In materia di salute, le intese prevedono, tra l’altro, l’autonomia regionale nell’organizzazione della governance delle aziende sanitarie ed una maggiore autonomia legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi. Quanto al personale, si introduce una maggiore autonomia finalizzata a rimuovere specifici vincoli di spesa stabiliti dalla normativa statale, inclusa la regolamentazione dell’attività libero professionale e la facoltà, in sede di contrattazione integrativa collettiva, di prevedere, per i dipendenti del SSN, incentivi e misure di sostegno.
Siffatte previsioni normative potrebbero comportare un miglioramento dei servizi nelle Regioni con maggiore produzione di reddito, ma non sono consone al principio di perequazione, in quanto non corrispondono al principio di cui all’art. 119 Cost.
Invero non si vuole qui fare riferimento solo alle risorse economiche pur importanti, ma al rischio di una più profonda frammentazione delle materie. Ad esempio, nel caso dell’istruzione, i ragazzi della scuola dell’obbligo che si trasferiscono da una Regione all’altra saranno costretti a cambiare radicalmente i programmi di studio? E cosa avverrà del lavoro nelle amministrazioni pubbliche sia per quanto attiene all’istruzione che alla sanità? Non si può escludere l’attuazione di “gabbie salariali”, con contratti dal contenuto differenziato da Regione a Regione (in tal senso la recente polemica suscitata dalle dichiarazioni, invero smentite, del Ministro dell’istruzione e del merito). Si potrebbero introdurre, come stigmatizzato a legislazione vigente dalla Corte costituzionale, misure limitative per i docenti o per i fruitori di servizi sociali che non abbiano residenza da un certo numero di anni nella Regione?[27].
Sui profili contenutistici delle intese va fatto un serio discernimento. Ecco perché la previsione di un’intesa concordata dallo Stato con ogni singola Regione, senza una previa determinazione di principi generali e di criteri perequativi costituzionalmente previsti, rappresenta un serio rischio di un’autonomia differenziata che aumenti, invece di ridurre, i divari di cittadinanza.
* Intervento, rivisto ed aggiornato, presentato al seminario dei Lunedì di Giustizia Insieme Novità e possibilità dell’autonomia differenziata nelle più recenti proposte di riforma.
[1] G. Gardini, C. Tubertini, L’amministrazione regionale, Torino, 2022.
[2] G. Pastori, Le regioni senza regionalismo, in Il Mulino, 2, 1980, 204 ss.
[3] M. Luciani, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, 1994.
[4] A. Ruggeri, Devolution, “controriforma” del titolo V e uso congiunturale della Costituzione, ovverosia quando le “ragioni” della politica offuscano la ragione costituzionale, in Dirittiregionali.it, 24 aprile 2003.
[5] R. Bifulco, Il regionalismo tra processi federali e sistema dei partiti, in Italianieuropei, 3, 2009, 172 ss.
[6] Per una recente ed approfondita analisi degli squilibri territoriali: ISTAT, I divari territoriali nel PNRR: dieci obiettivi per il Mezzogiorno, Focus, 25 gennaio 2023. Sul punto, anche: A. Barone, F. Manganaro, PNRR e Mezzogiorno, in Quad. cost., 1, 2022, 148 ss.; F. Manganaro, Regionalismo differenziato: dove eravamo rimasti?, in Astrid Rassegna, 9/2022.
[7] F. Manganaro, Politiche di coesione, in Enc. Dir. – I tematici, Milano, 2022, 839 ss.
[8] M. Cammelli, Flessibilità, autonomia, decentramento amministrativo: il regionalismo oltre l’art. 116.3 Cost., in Astrid, maggio 2019.
[9] Sulla necessità di un quadro generale di riferimento: R. Bifulco, I limiti del regionalismo differenziato, in Rivista AIC, 4, 2019, 260 ss.
[10] Di recente: G. M. Salerno, Con il procedimento di determinazione dei LEP (e relativi costi e fabbisogni standard) la legge di bilancio riapre il cantiere dell’autonomia differenziata. Editoriale, in Federalismi.it, 11 gennaio 2023, secondo cui , «La scelta a favore della legge di attuazione ovvero “legge-quadro” – soluzione che, tra l’altro, nella scorsa legislatura era stata suggerita anche dalla Commissione ministeriale di studio presieduta dal compianto Amico e Collega Beniamino Caravita - va senz’altro accolta positivamente, considerato quanto si è appena detto circa la necessità costituzionalmente rilevante, oltre che l’opportunità, di disporre di uno strumento regolatorio di ordine generale che permetta la corretta attuazione dell’art. 116, comma terzo, Cost.».
[11] Sul punto, si vedano le puntuali osservazioni di E. Zampetti, Novità e possibilità dell’autonomia differenziata nelle più recenti proposte di riforma. Introduzione a un dibattito sul tema dell’autonomia differenziata, in questa Rivista.
[12] Manifesta una fondata opinione critica A. Cioffi, Il problema dei LEP nell’autonomia differenziata. Una spiegazione della differenza, inquesta Rivista.
[13] Sulla indispensabile necessità di determinare i LEP, osserva la Corte costituzionale (sent. 220/2021) che <<La non fondatezza della questione peraltro non esime questa Corte dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché <<il nucleo invalicabile di garanzie minime>> per rendere effettivi tali diritti (ex multis, sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020)>>.
[14] Si è peraltro paventato il sospetto che l’introduzione della disciplina nella legge di bilancio sia avvenuta per evitare che possa essere sottoposta ad un referendum abrogativo nazionale, non consentito dall’art.75 Cost.: P. Maddalena, L’attuazione dell’articolo 116 della costituzione. Bozza Calderoli, in AmbienteDiritto.it, 4/2022.
[15] Peraltro la norma affida tale compito alla stessa società pubblica SOSE s.p.a. a cui era già stata inutilmente assegnata in passato ai sensi del d.lgs. 2010 del 2016, attuativo del federalismo fiscale.
[16] In tal senso: A. Cioffi, Il problema dei LEP nell’autonomia differenziata. Una spiegazione della differenza, cit.
[17] Su questo punto, di recente, G. Gardini, C. Tubertini, Le prospettive del regionalismo: idee per una rifondazione, in Astrid Rassegna, 2/2023, 47, secondo cui «una volta risolto il nodo della determinazione dei fabbisogni standard e della perequazione, si potrà forse guardare con minore preoccupazione anche all’ipotesi dell’attivazione della clausola della c.d. autonomia differenziata ex art. 116, comma 3, Cost.».
[18] Tra i tanti lavori sul punto, si veda: L. Antonini, La rivincita della responsabilità. A proposito della nuova legge sul federalismo fiscale, in Quad. suss., 2009, 1 ss.; R. Bifulco, Osservazioni sulla legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale, in www.astrid-online.it, 24 maggio 2009; G. Rivosecchi, La determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali: un elemento di incertezza nella via italiana al federalismo fiscale, in www.federalismi.it., 20 aprile 2011; F. Trimarchi Banfi, Il regionalismo differenziato: una questione preliminare, in Astrid Rassegna, 12/2019; A. Poggi, Il regionalismo italiano ancora alla ricerca del “modello plurale” delineato in Costituzione, in Federalismi.it, 8 maggio 2020; S. Pajno, Il regionalismo differenziato tra principio unitario e principio autonomista: tre problemi, in Federalismi.it, 4 marzo 2020; L. Di Majo, Il regionalismo differenziato: un questione di metodo prima ancora del merito, in Rivista AIC, 1, 2020, 255 ss.; S. Staiano, Anti-mitopoiesi. Breve guida pratica al regionalismo differenziato con alcune premesse, in Federalismi.it, 2 novembre 2022.
[19] A. D’Atena, Dove vanno le Regioni?, in Rivista AIC, n. 4/2022; C. Mirabelli, Vanno evitate forzature per non sbagliare il passo, in Il Quotidiano del Sud, 17 novembre 2022; I. Sales, Un’idea cinica del Paese, in La Repubblica, 18 novembre 2022; M. Villone, Il progetto Calderoli sull’autonomia è pericoloso, in Domani, 20 novembre 2022; S. Cassese, L’autonomia voluta dalla Lega ferisce l’unità del Paese, in La Stampa, 21 novembre 2022; G. De Minico, Perché il ddl Calderoli supera il confine della legittimità costituzionale, in Il Sole 24 ore, 6 gennaio 2023; I. Cipolletta, L’imbroglio dell’autonomia. Troppi poteri a regioni già inutili, in Domani, 9 gennaio 2023.
[20] Lo dimostrano con un’accurata analisi economica, in relazione alla disciplina del federalismo fiscale, A. Filippetti, F. Tuzi, Autonomia finanziaria regionale e regionalismo asimmetrico: verso un finanziamento dell’asimmetria ben temperato, in Argomenti, 17, 2021, 70 ss.
[21] L. Spadacini, M. Podetta, L'autonomia differenziata: spunti a partire dalla ed. Bozza Calderoli e dall'ultima legge di bilancio, in Astrid Rassegna, 2/2023.
[22] L. Spadacini, M. Podetta, L'autonomia differenziata: spunti a partire dalla ed. Bozza Calderoli e dall'ultima Legge di bilancio, cit.
[23] Nella prima bozza di disegno di legge le funzioni trasferite venivano finanziate anche con riserva di aliquota.
[24] In questo senso ora anche: G. Gardini, C. Tubertini, Le prospettive del regionalismo: idee per una rifondazione, 47- 48.
[25] A. Cioffi, Il problema dei LEP nell’autonomia differenziata. Una spiegazione della differenza, cit.
[26] A. Ruggeri, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, in Consulta Online, 31 ottobre 2019, 600 ss.
[27] Ad esempio, la Corte, nella sentenza n. 107/2018, ha ritenuto costituzionalmente illegittima una legge regionale, che prevedeva come fattore preferenziale per l’iscrizione agli asili nido la residenza o lo svolgimento di attività lavorativa per almeno quindici anni in Veneto, sul presupposto che i diritti fondamentali della persona vanno tutelati indipendentemente dal tempo di residenza in una Regione.

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
