
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.)
di Riccardo Ionta e Franco Caroleo
La pareidolia è quel processo psichico che porta a ricondurre ad immagini conosciute quel che si mostra amorfo. È l’illusione che porta a vedere un volto in una nuvola, il denominatore comune di note opere d’arte, da Mantegna a Dalì. È la manifestazione della tendenza ad affrontare il disordine per mezzo di strutture ordinate e forme familiari. Ed è quel che accade leggendo il nuovo art. 127-ter c.p.c. che introduce, in parte complicandola, la trattazione scritta nella sistematica della procedura civile. Da un lato nella norma si scorge qualcosa che non c’è, l’udienza, ma di cui vi sono tutti gli accadimenti ed effetti. Dall’altro la norma prevede uno strumento processuale dalla struttura indecisa. Nel presente scritto si propone una sistematizzazione della trattazione scritta nelle coordinate codicistiche - nella consapevolezza di come questa si sia ormai imposta nella prassi e nella certezza che essa verrà utilizzata in modo esteso - al fine di offrire all’operatore del diritto uno strumento giuridico effettivamente dotato di senso. Lo scritto presenta, alla fine, uno schema riepilogativo delle principali questioni affrontate.
Sommario: 1. Dall’emergenza alla codificazione. - 1.1. Prassi, emergenza, codificazione. - 1.2. Complicazioni e semplificazione. - 2. I principi. - 2.1. Strumentalità e flessibilità delle forme di trattazione. - 2.2. Direzione del procedimento e ragionevole durata. - 2.3. La scrittura e il principio di pubblicità dei dibattimenti giudiziari. - 3.4. Oralità, immediatezza e concentrazione. - 3. Quel che resta dell’udienza. - 3.1 Il concetto di udienza. - 3.2 Il concetto di trattazione (orale e scritta). - 3.3. La dimensione temporale. - 3.4. La dimensione ordinamentale. - 4. Il potere di disporre la trattazione scritta. - 4.1. Discrezionale o vincolato. - 4.2. Tre regole. - 4.3. I termini per disporre la trattazione scritta. - 4.4 L’assegnazione del termine per il deposito delle note. Orario e data di udienza. - 5. Il diritto di opporsi, il diritto alla trattazione orale e la mancata opposizione. - 5.1. Il diritto di opporsi alla trattazione scritta. - 5.2. Il diritto alla trattazione orale. - 5.3 La mancata opposizione e l’acquiescenza. - 5.4 Il provvedimento e il silenzio del giudice sull’opposizione. - 6. Le modalità della trattazione scritta. - 6.1 Il deposito delle note e il mancato deposito. - 6.2 Il dovere del giudice di provvedere entro trenta giorni. - Appendice. Schema riepilogativo.
1. Dall’emergenza alla codificazione
1.1. Prassi, emergenza, codificazione
La trattazione scritta è nella terza fase della sua esistenza.
Prassi
La prima fase della trattazione scritta è stata quella della prassi. La trattazione scritta già esisteva, e da tempo, nella concreta realtà degli uffici giudiziari. In taluni di questi non era insolito vedere i difensori scrivere, nel verbale di udienza, le proprie richieste e conclusioni e sottoporre il testo al giudice il quale, sempre per iscritto, assumeva il suo provvedimento. Ancor più frequente era ed è l’effettiva irrilevanza della trattazione orale del procedimento in udienza che, spesso, troppo spesso, è ridotta alla ripetizione di stanche espressioni (“ci si riporta”, “conclude come in atti”, “impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito” e così via) volte solo a riempire di contenuto la comparizione in presenza.
Emergenza
La seconda fase della trattazione scritta è stata quella dell’emergenza pandemica[1], con tre diversi passaggi.
La trattazione scritta introdotta nella prima e più dura fase della pandemia - prima ex art. 2, comma 2, lett. h, decreto-legge 8 marzo 20202, n. 11 e poi ex art. 83, comma 7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - aveva una natura strettamente emergenziale. La finalità della norma, dal carattere eccezionale, era quella di consentire l’ordinaria trattazione orale della causa, e quindi la presenza negli uffici, solo quando indispensabile. Lo scopo finale è stato quello di escludere la presenza negli uffici di giustizia salvo i casi eccezionali idonei a giustificare una deroga alle limitazioni, di movimento e ingresso nei luoghi, dettate dalla legislazione pandemica[2].
La trattazione scritta ex art. 221, comma 4, legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione del c.d. decreto-legge “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) - ha avuto invece la finalità di consentire la trattazione scritta quando l’ordinaria trattazione orale del procedimento non appariva strettamente necessaria. Scopo finale della norma è stato infatti quello non di escludere ma di moderare e ponderare la presenza negli uffici di giustizia - inadeguati al rispetto delle regole di contingentamento delle presenze - permettendo al giudice, nei limiti prescritti, di disporre la trattazione scritta del procedimento civile[3].
Il terzo passaggio della trattazione scritta emergenziale è stato quello della “normalizzazione”. Il superamento delle fasi più dure della pandemia e l’allentamento, sino all’abrogazione, delle regole di contingentamento delle presenze, hanno consolidato nelle prassi degli uffici giudiziari la trattazione scritta ex art. 221, co. 4. La trattazione scritta è divenuta così, in disparte gli abusi pur verificatesi, uno strumento di ordinaria flessibilità, normativamente eccezionale, largamente apprezzato e utilizzato nei tribunali.
Codificazione
La terza fase della trattazione scritta coincide con la sua codificazione per mezzo dell’art. 127-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023.
Le disposizioni sulla trattazione scritta sono collocate nella Sezione II “Delle udienze”, Capo I (“Delle forme degli atti e dei provvedimenti”), Titolo VI (“Degli atti processuali”) del Libro I (“Disposizioni generali”).
Il potere di disporre la trattazione scritta è generalmente previsto nel nuovo terzo comma dell’art. 127 c.p.c. rubricato “Direzione dell’udienza”: “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte” L’art. 127-ter c.p.c. “Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza” è dedicato alla disciplina specifica della trattazione scritta.
La codificazione non è un atto neutro. La norma perde, anche giuridicamente, la sua essenza emergenziale ed eccezionale ed entra a far parte del complesso sistema della procedura civile[4].
1.2. Complicazioni e semplificazione
Complicazioni
Il legislatore con l’art. 127-ter c.p.c. ha in parte cambiato la trattazione scritta sino ad ora conosciuta e praticata incidendo così su esperienze e prassi consolidatesi negli ultimi tre anni[5]. Le complicazioni – che si evidenzieranno nel corso dello scritto - derivano da una sottovalutazione, da una intenzione e da una previsione.
La sottovalutazione è quella degli effetti della codificazione. La comparsa della trattazione scritta nel codice, strutturato sull’oralità, come si vedrà nel prosieguo, appare il frutto di un mero innesto normativo più che di una vera e propria codificazione.
L’intenzione, almeno letterale, è quella di scindere la trattazione scritta dall’udienza. Intenzione espressa nell’affermazione per cui l’udienza è sostituita dal deposito delle note. Inciso, si vedrà, impreciso in quanto è la trattazione orale del procedimento, prevista per l’udienza, ad essere sostituita e non l’udienza. Intenzione, tuttavia, non compiutamente realizzata in quanto il termine per la scadenza del deposito è da considerarsi data di udienza “a tutti gli effetti”; in quanto l’onere di “comparizione” resta - onere principale riferibile all’udienza e presupposto degli altri oneri e facoltà processuali - poiché il mancato deposito delle note determina i medesimi effetti previsti dagli artt. 181-309 c.p.c. (espressamente richiamati per la trattazione scritta emergenziale); in quanto l’art. 127-ter c.p.c. è inserito nelle norme codicistiche relative alle udienze e alla direzione dell’udienza.
La previsione - espressione della sottovalutazione e dell’intenzione sopra evidenziate - è quella di un termine unico e perentorio per il deposito delle note di trattazione scritta. Un termine non più ancorato alla data di udienza (e calcolato a ritroso da essa) ma decorrente dalla data di emissione del provvedimento con cui il giudice dispone la trattazione scritta[6].
Le complicazioni portano ad una secca alternativa: o la trattazione scritta è possibile per tutte o quasi tutte le fasi di trattazione (“udienze”) oppure per nessuna o quasi nessuna (salvo per le “udienze” che per il codice non esistono - udienza di precisazione delle conclusioni, udienza “interlocutoria”, udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori - e per la nuova udienza di rimessione della causa in decisione). L’art. 127-ter c.p.c., norma generale, è impostata in favore della prima alternativa - come si evince già dall’ampia formulazione che ad oggi consente, a differenza di prima, la trattazione scritta anche per le fasi in cui è prevista la comparizione personale delle parti - senza tuttavia essere strutturata in detto senso.
Semplificazione
A fronte delle complicazioni l’interprete è chiamato ad una approfondita opera di razionalizzazione per sistematizzare la trattazione scritta nelle coordinate codicistiche – nella consapevolezza di come questa si sia ormai imposta nella prassi e nella certezza che essa verrà utilizzata in modo esteso - al fine di offrire all’operatore del diritto uno strumento giuridico effettivamente dotato di senso.
A tal fine, sono due gli strumenti utilizzati, nel presente scritto, per semplificare la complessità.
Il primo è il concetto di udienza quale categoria utile ad ordinare la realtà. Nel presente studio - come già espresso nei precedenti scritti[7] - si proporrà di ricorrere all’udienza quale schema logico-giuridico perché questa, seppur “non c’è”, “è come se ci fosse”. In termini più precisi si sostiene che è alla trattazione del procedimento che bisogna guardare e non all’udienza, ossia che è necessario guardare al contenuto (l’attività) e non al contenitore. E se la trattazione orale del procedimento avviene (ad oggi) nello spazio-tempo chiamato udienza, la trattazione scritta del procedimento è come se avvenisse in udienza, nel tempo d’udienza, recandone tutti gli effetti.
Il secondo è la valorizzazione del ruolo attribuito al consenso delle parti - espresso o tacito - utile altresì a realizzare un esercizio della giurisdizione condiviso (e non autoritativo).
2. I principi
2.1. Strumentalità e flessibilità delle forme di trattazione
L’art. 127-ter c.p.c. è una norma sulla forma della trattazione.
Attribuisce al giudice il potere, discrezionale o vincolato, di disporre che lo svolgimento della singola fase e attività processuale avvenga in forma scritta per mezzo del deposito di note - cui segue necessariamente un provvedimento scritto del giudice - invece che nella forma orale, documentata con il processo verbale. Al potere del giudice di disporre la trattazione scritta segue, per le parti, un onere di deposito - e non una semplice facoltà – e, ove soddisfatto, sorge il dovere del giudice di provvedere nel termine di trenta giorni.
È la relazione tra l’onere per le parti e il conseguente dovere del giudice che rende la sequenza una delle modalità con cui i soggetti processuali si relazione e comunicano tra loro, ovvero, una trattazione. L’art. 127-ter c.p.c., in altri termini, non prevede un mero “onere di deposito”, sia perché il giudice deve provvedere sul contenuto delle note, sia perché il mancato deposito determina le medesime conseguenze della mancata comparizione in udienza.
La norma, in tal senso, è riconducibile al principio di strumentalità delle forme (o della congruità delle forme allo scopo). Principio che – volto ad evitare il formalismo ovvero la tendenza a considerare le forme un “rituale complicato da considerarsi quasi fine a sé stesso” - consente alle parti e al giudice di rispettare le forme “solo in quanto e nei limiti in cui sono necessarie per conseguire lo scopo obbiettivo, ossia per assolvere alla loro funzione di garanzia o di obbiettività: ove non rispondono a questa funzione, possono essere trasgredite”[8].
L’art. 127-ter c.p.c., codificando la trattazione scritta, e aprendo al suo generale utilizzo, allarga lo spettro del principio di strumentalità delle forme includendo - nel rispetto del principio costituzionale del contraddittorio in condizioni di parità - l’alternativa tra trattazione orale e trattazione scritta della fase e attività processuale. La norma, così, introduce un innovativo principio di flessibilità delle forme di trattazione e “persegue un ragionevole fine di elasticità in forza del quale le risorse offerte dall'ordinamento devono essere calibrate in base alle effettive esigenze di tutela”[9].
2.2. Direzione del procedimento e ragionevole durata
L’art. 127-ter c.p.c. è una norma sulla direzione del procedimento.
Il legislatore ha ricondotto il potere di disporre la trattazione scritta al potere del giudice di direzione delle udienze, come si desume dalla collocazione codicistica dell’art. 127, comma terzo, c.p.c. e dell’art. 127-ter c.p.c. La riconduzione normativa è tanto precisa da essere o imprecisa o indicativa.
Il potere di disporre la trattazione scritta della singola fase del singolo processo ha certamente una influenza sulla programmazione e sulla organizzazione della specifica udienza - che dal magistrato potrà essere programmata e organizzata prevedendo la trattazione scritta o orale, in presenza o da remoto, delle singole fasi dei processi chiamati per quel giorno - ma sembra rientrare solo latamente nello specifico potere ex art. 127, primo comma, c.p.c. di disporre che “la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo”. Quest’ultima norma è difatti finalizzata a disciplinare l’ordine dell’udienza in cui sono chiamate più cause - udienza che in teoria “manca” per la causa per cui è stata disposta la trattazione scritta -, l’ordine di chiamata delle cause previste per lo specifico giorno[10] e a disciplinare la trattazione orale che avviene davanti al giudice (“regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente”). Quindi delle due l’una: o il legislatore è stato impreciso oppure la trattazione scritta del procedimento nel tempo di udienza è equiparata alla trattazione orale del procedimento nel tempo-spazio di udienza.
Il potere di direzione dell’udienza attribuito al giudice è, del resto, solo una parte del più ampio potere di direzione del processo (art. 175 c.p.c.)[11].
Il potere ex art. 127-ter c.p.c., per come configurato, pare più correttamente riconducibile al potere di direzione del procedimento che, ex art. 175 c.p.c., è finalizzato al suo sollecito e leale svolgimento. Il procedimento è difatti strutturato in un progressivo svolgimento di fasi (introduttiva-istruttoria-decisoria) temporalmente organizzate dai termini processuali (tra cui il termine ex art. 127-ter c.p.c. o il termine-luogo chiamato udienza). In tal senso, la locuzione secondo cui il giudice “fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali” (art. 175 c.p.c.) può ad oggi intendersi come inclusiva di quel “termine”, che è data di udienza, disposto dal giudice per il deposito ex art. 127-ter c.p.c. L’aggancio al potere di direzione del procedimento disvela la connessione tra il principio di flessibilità delle forme di trattazione e il principio costituzionale della ragionevole durata del procedimento[12] e consente al giudice di poter imporre la forma di trattazione, orale o scritta, ritenuta necessaria a garantire la ragionevole durata del procedimento.
2.3. La scrittura e il principio di pubblicità dei dibattimenti giudiziari
L’art. 127-ter c.p.c. è una norma che esclude la pubblicità delle udienze.
L’art. 128 c.p.c. prescrive, a pena di nullità, la pubblicità dell’udienza “in cui si discute la causa”. L’art. 84 disp. att. c.p.c. prevede invece che “le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche”. In termini più precisi, quindi, la pubblicità è prescritta dal codice a pena di nullità per le fasi di discussione orale del processo.
L’art. 128 c.p.c., norma sulla pubblicità, è prima di tutto una norma sulla forma orale della discussione. La forma orale è, difatti, la prima componente della pubblicità della discussione poiché nel codice vigente questa è pubblica solo se orale e solo se detta oralità si sviluppa in un momento-luogo pubblico come l’udienza a porte aperte. Pubblicità-oralità della fase di discussione sono un’endiadi pur se, astrattamente, la prima può essere garantita, in modo estensivo, anche da altre forme. La scrittura, almeno nella sistematica del codice, esclude quindi la pubblicità.
Il principio di pubblicità del dibattimento giudiziario[13] si afferma in via generale alla fine del XVIII secolo[14] e si consolida via via come “regola generale” come “espressione di civiltà giuridica”[15]. Regola espressa in vari atti internazionali - “componente naturale e coessenziale del processo ‘equo’ garantito dall'art. 6 della C.E.D.U”[16] - e implicitamente prevista dal sistema costituzionale prima “quale conseguenza necessaria del fondamento democratico del potere giurisdizionale, esercitato appunto, come recita l'art. 101, in nome del popolo”[17] e poi anche quale componente naturale e coessenziale del giusto processo del novellato primo comma dell'art. 111 Costituzione letto alla luce dell'art. 6 C.E.D.U.[18].
Il principio non ha valenza assoluta né per la Corte Costituzionale né per la Corte EDU[19] e può cedere in relazione a determinati procedimenti e fasi procedimentali e in presenza di giustificazioni obiettive e razionali[20]. Non è quindi consentito escludere a priori la pubblicità dell’udienza dibattimentale ma è possibile escluderla in concreto e per la tutela di altri interessi meritevoli di tutela - nelle giustizie diverse da quella penale anche non di caratura costituzionale[21] - ovvero condizionare la pubblicità alla presentazione, da almeno una delle parti, di un’apposita istanza di discussione[22].
La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente orientato la struttura del principio di pubblicità dell’udienza dall’art. 101, comma 1, Cost. all’art. 6 CEDU. La lettura del principio ha così marginalizzato l’interesse pubblico che ne costituisce la radice - la partecipazione del popolo all’amministrazione della giustizia - in favore del diritto di parte alla pubblicità della discussione giudiziaria. La conseguenza è che la pubblicità dei dibattimenti civili, salvo che per l’udienza pubblica in Cassazione, non è la proiezione dell’interesse pubblico, ma una proiezione dell’interesse della parte processuale. Il legislatore, allora, può garantire la pubblicità della discussione anche con la sola previsione della possibilità, per l’interessato, di richiedere che la stessa avvenga in pubblica udienza. La parte può di conseguenza rinunciare alla pubblicità.
La Corte Costituzionale ha, in tal senso, ritenuto non irragionevole la previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di parte dell'udienza pubblica, posto che, in assenza di una effettiva discussione, “la trattazione in pubblica udienza finirebbe per ridursi alla sola relazione della causa e cioè ad un atto che, in quanto espositivo dei fatti e delle questioni oggetto del giudizio, è comunque riprodotto nella decisione e reso conoscibile alla generalità con il deposito della stessa”[23].
La trattazione scritta emergenziale ha beneficiato dell’art. 23, comma 3, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, norma speciale sulla possibilità di disporre la celebrazione “a porte chiuse” delle udienze pubbliche.
L’art. 127-ter c.p.c., interpretato alla luce degli approdi della Corte costituzionale, può essere applicato alla discussione prevista in pubblica udienza - e così escludere la pubblicità della discussione - a tre condizioni:
1) la prima è quella di garantire il contraddittorio in condizioni di parità; e tanto è possibile solo garantendo alle parti il deposito di memorie di discussione, o meglio, la possibilità del deposito;
2) la seconda è quella di rinvenire delle ragioni obiettive e razionali per la possibilità esclusione; se la Corte costituzionale n. 73/2022 ha ritenuto valida, per il processo tributario, la ragione di garantire le “esigenze di celerità e di economia processuale” tanto può valere anche per l’art. 127-ter c.p.c. interpretato, come visto prima, quale norma sulla direzione del procedimento (e di garanzia della sua ragionevole durata);
3) la terza condizione è quella di garantire, in ogni caso, il diritto di ciascuna delle parti alla discussione orale in pubblica udienza; e tanto significa che l’art. 127-ter c.p.c. richiede una interpretazione costituzionalmente orientata del suo secondo comma: l’opposizione di una sola delle parti al provvedimento che dispone la trattazione scritta per l’udienza di discussione orale - e non solo l’opposizione di entrambe - vincola il giudice a disporre la trattazione orale a porte aperte.
L’esigenza del legislatore di formulare la nuova disposizione dell’art. 379, comma 1, c.p.c. sulla pubblica udienza in Cassazione[24] - “L’udienza si svolge sempre in presenza” - e la rinnovata connessione tra l’interesse pubblico ex art. 101 Cost. e la pubblicità dell’udienza suggeriscono che la pubblicità delle altre udienze di discussione civili sia solo la proiezione dell’interesse della parte. Trova conforto allora l’interpretazione per cui l’art. 127-ter c.p.c. può essere applicato, nel rispetto delle tre condizioni esplicate, alla discussione orale prevista in pubblica udienza derogando, quindi, alla pubblicità.
2.4. Oralità, immediatezza e concentrazione
La trattazione scritta della causa, escludendo l’oralità, sembra sacrificare l’immediatezza e la concentrazione. L’oralità, difatti, è il mezzo attraverso cui il codice garantisce queste e il contraddittorio in condizioni di parità[25].
La trattazione orale non è però l’unico modo per assicurare il contraddittorio in condizioni di parità. Questo è garantito (come suggerisce la fase introduttiva del giudizio civile, la discussione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c.) o può essere garantito - ad esempio con la facoltà delle parti, per la discussione, di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni non solo in funzione delle difese svolte dalla controparte[26] - anche dalla trattazione scritta. “Porre un'alternativa tra difesa scritta e discussione orale nel processo civile non può determinare alcuna lesione di un adeguato contraddittorio, anche perché le parti permangono su di un piano di parità”[27] e deve “escludersi che sussista un'unica forma in cui il confronto dialettico possa estrinsecarsi e che questa vada necessariamente identificata nella difesa orale”. “Non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità”[28].
L’immediatezza e la concentrazione non sono condizione indefettibili per l’attuazione del contraddittorio e per la formazione del convincimento del giudice[29]. L’attuazione del contraddittorio, infatti, non implica necessariamente che il confronto dialettico tra i litiganti si svolga in modo esplicito e contestuale, potendo dispiegarsi anche in tempi successivi, purché anteriori all’assunzione del carattere della definitività della decisione, e come momento soltanto eventuale del processo[30]. E tanto perché la garanzia del contraddittorio sta nella “necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento”[31], ossia, in altri termini, nell’assicurare alle parti la possibilità di incidere, con mezzi paritetici, sul convincimento del giudice.
La trattazione scritta se esclude l’immediatezza - salvo aprire a nuove forme come la trattazione via chat – non esclude comunque la concentrazione. Essa può essere preservata dalla trattazione scritta, ad esempio ove il codice prevede la contestualità tra discussione e decisione, solo a patto di vincolare il giudice, alla scadenza del termine per il deposito delle note, all’immediato deposito del dispositivo ovvero della sentenza nello stesso giorno[32].
La trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sembra essere stata strutturata dal legislatore in modo contrastante con le esigenze della concentrazione e della celerità: consentire alle parti, salvo possibili diverse interpretazioni, di depositare le note sino alle fine del giorno fissato come termine (e non fino all’orario previsto come orario di udienza) e consentire al giudice di provvedere entro trenta giorni, salvo il diverso e più lungo termine disciplinare (e non immediatamente “come” nell’udienza), apre ad inevitabili sfasamenti temporali e a ritardi.
3. Quel che resta dell’udienza
“L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte” recita il periodo iniziale del comma 1 dell’art. 127-ter c.p.c.
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo” dispone il penultimo comma dell’articolo che, pur non menzionando gli artt. 181-309 c.p.c., ricollega al mancato deposito delle note entro il termine-data di udienza, gli stessi effetti della mancata comparizione delle parti per l’udienza.
“Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti” afferma l’ultimo comma dell’articolo.
Le norme confermano, al di là dell’apparente dato testuale, quanto già sostenuto in precedenza, ossia che l’udienza non scompare, o meglio, non scompare del tutto. L’udienza perde la sua dimensione spaziale. Quel che resta è la sua dimensione logico-giuridica, temporale e, quindi, anche ordinamentale.
Il legislatore ha voluto scindere la trattazione scritta dall’udienza concependo questa nel suo senso statico di contenitore temporale e spaziale: se c’è trattazione scritta allora non c’è luogo e quindi non c’è udienza. È altrettanto evidente che, per lo stesso art. 127-ter c.p.c., l’attività svolta con la trattazione scritta è come se si svolgesse in udienza posto che se ne conservano tutti gli effetti.
Il processo è una progressione di atti posti in essere dai soggetti, nel contradditorio, in un dato tempo e, a volte, in un dato luogo. Il processo di cognizione è scandito in diverse fasi - introduzione, l’istruzione, la decisione - che contengono a loro volta specifiche attività processuali (o sub-fasi). La cadenza, normativa nel rito ordinario, corrisponde ad una logica modulazione del giusto processo.
Il concetto di processo (e per esso quello di fase processuale) non coincide con il concetto di udienza - elemento e contenitore spazio-temporale di alcune delle sue fasi - né con quello di trattazione (intesa in senso generale), forma che assumono tutte le fasi e sub-fasi processuali. Il concetto di udienza, a sua volta, non coincide con quello di trattazione.
Se si vuol comprendere l’effettività dell’art. 127 ter c.p.c. è quindi alla trattazione del procedimento che bisogna guardare e non all’udienza, perché è necessario guardare al contenuto e non al contenitore. E se la trattazione orale del procedimento avviene nello spazio-tempo chiamato udienza, la trattazione scritta del procedimento è come se avvenisse in udienza, o meglio nel tempo d’udienza o in un tempo ad esso pienamente equiparato, recandone tutti gli effetti.
3.1. Il concetto di udienza
L’udienza è il luogo e il tempo in cui i soggetti del processo si relazionano, tra loro, per il compimento degli atti processuali[33]. Il giudice ha il dovere - processuale e ordinamentale - di “tenere” udienza e dirigerla ed è l’unico soggetto necessario di essa[34]. Le parti hanno l’onere di comparire in udienza (artt. 181, 309 c.p.c.), dinanzi al giudice, al fine di compiere determinati atti del processo[35].
“Udienza” – indica la giurisprudenza formatasi sull’art. 343 c.p.c. - è un concetto dal duplice significato. In senso statico, è il contenitore spazio-temporale di specifiche attività processuali[36]. In senso dinamico, è l’attività giurisdizionale resa dal giudice nelle fasi processuali [37].
Tempo
I “giorni della settimana” e le “ore” - ovvero l’arco temporale - in cui i magistrati devono tenere udienza sono programmati (per mezzo delle tabelle di organizzazione) dal presidente del tribunale il quale, secondo le disposizioni di attuazione del c.p.c., è chiamato in teoria a determinare in modo separato le udienze “destinate esclusivamente” alla prima comparizione delle parti, all’istruttoria e quelle destinate alla discussione[38]. Per la singola causa il giorno - e non l’orario - è indicato dalla parte (art. 163 c.p.c.) o dal magistrato[39].
L’udienza ha quindi una duplice dimensione temporale: è il termine di riferimento entro cui compiere determinate attività processuale (soddisfare l’onere di comparizione, costituirsi, depositare gli atti il cui termine di deposito è fissato a ritroso); è la porzione di tempo in cui compiere le attività processuali orali (ad esempio, la discussione).
La dimensione temporale costituisce il nucleo fondamentale dell’udienza perché - e la trattazione scritta ormai lo ha dimostrato con chiarezza, grazie al processo civile telematico, così come lo comprova la fase iniziale del nuovo rito civile di primo grado - il luogo di udienza non è indispensabile per garantire il contraddittorio in condizioni di parità (poiché, a non essere indispensabile, è la contestuale presenza dei soggetti del processo).
Luogo
Il luogo dell’udienza è il tribunale adito e l’aula, o per questa altra sala, dove deve essere presente il giudice designato il giorno previsto per le udienze[40]. Le ipotesi in cui l’attività processuale può svolgersi al di fuori del tribunale sono tassativamente stabilite (ad esempio: artt. 203, 255, 259, 262 e 421 c.p.c.) e l’art. 67 disp. att. c.p.c. - che consentiva al giudice conciliatore di tenere le udienze, in caso di urgenza, nella propria abitazione - è stato abrogato.
Il nuovo art. 196-duodecies c.p.c., destinato alla trattazione orale da remoto, afferma poi che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d’udienza a tutti gli effetti e l’udienza si considera tenuta nell’ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento.
3.2. Il concetto di trattazione (orale e scritta)
La trattazione della causa, intesa in senso generale, è la modalità attraverso cui i soggetti del processo si relazionano e comunicano tra di loro nel processo e per il processo[41] attuando il contraddittorio. Il concetto generale si distingue da quello della trattazione “in senso stretto”, specifica fase processuale (art. 180 c.p.c.) che segue quella introduttiva[42].
L’oralità e la scrittura sono le due forme di trattazione delle fasi e attività del processo civile. Le forme, suggeriva Chiovenda, non si escludono a vicenda manifestando per lo più la tendenza a prevalere l’una sull’altra. La forma della scrittura è propria della fase introduttiva del giudizio, quella orale è la forma della attività di trattazione-istruttoria. La fase decisoria è sia scritta, tendenzialmente mista, e orale. La trattazione, quindi, può avvenire o non avvenire in udienza.
L’oralità non conosce una norma generale di disciplina – ma solo una norma di apertura per la singola fase (art. 180 c.p.c.) e norme specifiche sulla discussione - essendo la forma ordinaria della trattazione e quella materialmente necessaria per talune attività. Se le parti e il giudice si relazionano e comunicano in forma orale, quindi intervenendo contestualmente[43], vi è la necessità di un tempo-luogo per detta contestualità e del processo verbale delle attività compiute.
La trattazione (integralmente) scritta della fase e attività processuale è disciplinata ora dall’art. 127-ter c.p.c.[44]. Le parti e il giudice si relazionano, e comunicano tra loro, mediante la redazione e il deposito telematico di note scritte cui segue necessariamente un provvedimento scritto. La trattazione scritta si distingue così dal mero deposito di note proprio per il fatto che, il deposito, determina il dovere del giudice di rispondere entro un termine dato e il mancato deposito i medesimi effetti ex artt. 181-39 c.p.c. Se le parti e il giudice si relazionano e comunicano in forma scritta, non essendoci un intervento contestuale, vi è solo bisogno di un tempo entro cui compiere le attività (per le parti e il giudice) e non di un luogo.
3.3. La dimensione temporale
Il periodo iniziale del comma 1 dell’art. 127-ter c.p.c. è impreciso nella formulazione perché l’udienza - sia se fissata e soprattutto se non ancora fissata - non può mai essere sostituita dal deposito delle note scritte.
E tanto perché l’udienza coincide con il luogo e il tempo - o meglio le ore del giorno della settimana - in cui il giudice deve trattare i procedimenti e le relative fasi di essi. L’udienza è sempre programmata e fissata dal calendario previsto in tabella. Il giudice, o la parte, a ben vedere, individuano (fissano) solo lo specifico giorno di trattazione del singolo procedimento e tanto nei limiti di un calendario di udienze già stabilito dalle tabelle di organizzazione. L’udienza quindi o si svolge - e il giudice deve (nel suo arco temporale) trattare i procedimenti e le parti compiere le attività - oppure non si svolge.
La disposizione, in sintesi, confonde l’udienza con la trattazione.
È l’attività processuale orale, prevista per la data di udienza, che può essere sostituita dall’attività scritta - ovvero dal deposito delle note - e non l’udienza (che il giudice deve sempre tenere nei giorni previsti dalla tabella). In altri termini, la norma afferma che la trattazione orale prevista per l’udienza può essere sostituita dalla trattazione scritta (con onere di deposito delle note su cui il giudice deve provvedere).
L’ultimo comma dell’art. 127-ter c.p.c. invece evidenzia che, con la trattazione scritta, non c’è il luogo di udienza. E questo perché, semplicemente, non ce ne è bisogno.
Il penultimo comma conferma la parificazione piena tra le forme di trattazione, scritta e orale, in rapporto all’onere di comparizione: il mancato deposito delle note ha, difatti, i medesimi effetti processuali della mancata comparizione in presenza. Comparizione in presenza che, appare utile ricordarlo, le parti soddisfano con la mera presentazione fisica in aula entro l’orario di udienza fissato, senza che sia necessario svolgere alcuna ulteriore ed effettiva attività.
Quel che resta dell’udienza è quindi una delle due dimensioni temporali. Resta la data di udienza ovverosia il termine di riferimento entro cui compiere determinate attività processuali: in primis, soddisfare l’onere di comparizione (o comunque un onere “senza nome” parificato a questo) depositando le note contenenti quelle istanze e conclusioni che la parte avrebbe presentato, oralmente, all’udienza quale porzione di tempo.
3.4. La dimensione ordinamentale
La disposizione secondo cui “Il giorno di scadenza del termine …è considerato data di udienza a tutti gli effetti” implica che, se l’udienza non c’è, è tuttavia come se ci fosse. E ciò anche a livello ordinamentale. In altri termini il giorno di scadenza del termine appare comunque parificato al giorno di udienza anche ai fini degli effetti processual-ordinamentali.
L’udienza quale contenitore spazio-temporale, come già detto, è solo individuata dal giudice (o dalla parte ex art. 163 c.p.c.) in quanto le udienze sono programmate e fissate dal presidente mediante le tabelle di organizzazione. Quando il giudice indica l’orario per la trattazione del singolo procedimento esercita “solo” quel potere di ordine ex art. 127-175 c.p.c.
Il giudice allora sarà tenuto a far coincidere “il giorno di scadenza del termine” con una delle date di udienza previste dalle tabelle per l’udienza. In tal senso, potrebbe anche ipotizzarsi la possibilità per il giudice, in forza dell’art. 175 c.p.c., di stabilire uno specifico orario entro cui depositare le note di trattazione scritta o che queste, comunque, debbano essere depositate entro l’arco temporale delle udienze (“giorni e ore”) stabilite dalle tabelle di organizzazione.
L’udienza, come visto, ha un preciso significato ordinamentale in quanto costituisce il modo e il tempo attraverso cui il giudice adempie al suo dovere di “tenere” udienza. In connessione con quanto appena detto, se il giudice deve far coincidere “il giorno di scadenza del termine” con una delle date di udienza previste dalle tabelle per l’udienza allora adempie al suo dovere (altrimenti, no).
4. Il potere di disporre la trattazione scritta.
4.1. Discrezionale o vincolato
L’art. 127-ter, comma 1, c.p.c. dispone che “L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
La prima parte del comma appare superflua nella sua formulazione.
È infatti chiaro che la trattazione scritta non possa essere disposta per quelle attività processuali - come l’assunzione delle prove orali - che richiedono la presenza di soggetti, come i testimoni, diversi dalle parti, la cui attività non è sostituibile dal deposito telematico di uno scritto (salvo il caso in cui sia stata disposta la testimonianza scritta). Soggetti, appare utile precisare, ulteriori (più che diversi) rispetto a quelli indicati, dato che la trattazione delle fasi processuali richiede sempre la presenza almeno dei difensori (su cui grava, perciò, un onere di comparizione che, talvolta, è rivolto anche alle parti personalmente).
La disposizione sembra non porre limite alcuno alla trattazione scritta e tuttavia, per avere un’effettiva funzione, deve essere interpretata nella sua portata sistematica e indicare il criterio cui conformarsi per affermare quando il giudice può o deve disporre la trattazione scritta della causa – se richiesta da entrambe le parti - in sostituzione della trattazione orale.
4.2. Tre regole
La norma, in tal senso e in termini più precisi, dispone che nel rispetto del contraddittorio in condizioni di parità, la trattazione orale della causa può essere sempre sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. ove questa sia idonea allo scopo. La stessa non può essere disposta nel caso in cui la legge prescrive la forma orale come obbligatoria per la tutela del diritto specifico della parte alla trattazione orale o per la tutela di un interesse diverso da quello delle parti (pubblico) [45].
La norma è così costituita da tre regole concentriche. E a tali regole risponde sia la possibilità per il giudice di disporre la trattazione scritta, sia la possibilità per le parti di vincolare il giudice nel disporla.
Prima regola
La prima regola è di apertura. La trattazione scritta può essere disposta, in astratto, anche quando il codice prevede, in modo generale (art. 180 c.p.c.) o puntuale, la forma orale della trattazione e, pertanto, un’attività da compiersi in udienza. Non ha valore generale, invece, la regola inversa. La trattazione scritta non è pertanto automaticamente esclusa da tutte quelle disposizioni che prevedono o presuppongono l’oralità della fase o dell’attività. Il codice presuppone o richiede l’oralità, o frangenti di oralità, per tutto l’arco del processo, in forma esplicita o implicita, e ritenere che la trattazione scritta non possa essere disposta in tali casi è insensato perché l’art. 127-ter c.p.c. non avrebbe ragione di esistere.
Seconda regola
La seconda regola è di chiusura. La trattazione scritta può sostituire la trattazione orale quando, mutata la forma, risultano soddisfatte le medesime esigenze e i medesimi diritti. In altri termini, quando è idonea al raggiungimento dello scopo e alla soddisfazione del contraddittorio in condizione di parità. E posto che la legge presuppone o determina la forma orale della trattazione poiché la valuta, in astratto, congrua allo scopo, è possibile trasgredirla - in applicazione del principio di strumentalità delle forme - ove l’alternativa scritta sia valutata, in concreto, idonea allo scopo.
Il primo corollario della regola è che il giudice può disporre, e imporre, la trattazione scritta solo ove non frustri lo scopo e ove non privi, in alcun modo, le parti dell’effettività del contraddittorio in condizioni di parità.
Il secondo corollario di questa regola è enunciato dall’art. 127-ter c.p.c., per cui la trattazione scritta è disposta “se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”: le parti, ove concordi, hanno diritto alla trattazione scritta poiché valutata, in concreto, come congrua al raggiungimento dello scopo e il giudice ha il dovere di disporla. In sintesi, la trattazione scritta è quindi sempre possibile ove tutte le parti manifestino, in modo espresso o tacito (per mancata opposizione al provvedimento che la dispone), una volontà in tal senso.
Terza regola
La terza regola è quella per cui la trattazione scritta non può essere disposta dal giudice se la legge prevede l’obbligatorietà della trattazione orale a tutela del diritto specifico della parte proprio alla trattazione orale (un diritto disponibile) o a tutela di un interesse pubblico.
La legge prescrive come obbligatoria la trattazione orale, a tutela di un interesse della parte in tal senso, in due occasioni.
(a) La prima è quando la legge prevede l’oralità come l’unica forma per l’attività da compiersi.
L’oralità è l’unica forma normativa prevista, ad esempio, nel caso dell’interrogatorio libero, del tentativo di conciliazione. È il caso altresì della discussione orale nel rito lavoro (non invece del rito ordinario la cui fase di discussione prevede diverse alternative). In tali ipotesi, a ben vedere, la legge mira a preservare non l’oralità di per sé ma l’immediatezza e la concentrazione dell’attività per mezzo dell’oralità.
Una considerazione apre alla possibilità di disporre la trattazione scritta. Appare necessario distinguere tra la “obbligatorietà” della fase, l’obbligatorietà della attività e l’obbligatorietà della forma. Lo svolgimento delle tre fasi processuali è sempre necessario per gravare il giudice della decisione ma, al loro interno, non tutte le attività sono obbligatorie[46]. La fase di prima comparizione è necessaria ma il tentativo di conciliazione e l’interrogatorio libero non sono obbligatori, la partecipazione agli stessi è un onere per la parti, e tuttavia, se esperiti, devono essere svolti in forma orale. La fase di discussione è necessaria ma la parte è solo onerata di comparire il giorno della discussione, non ha l’obbligo di discutere effettivamente. La trattazione scritta, nelle ipotesi indicate, è allora possibile - fermo restando lo svolgimento giuridico della fase, proprio a trattazione scritta - a condizione che non si effettui materialmente la relativa attività perché tutte le parti manifestano, in modo espresso o tacito, una volontà in tal senso. L’opposizione di anche di una sola di esse, per converso, impedirà la possibilità di disporre la trattazione scritta.
(b) La seconda occasione è quando la legge ha come specifico fine quello di escludere la trattazione integralmente scritta.
E ciò accade in due ipotesi.
(b1) La prima ipotesi è quando la legge attribuisce espressamente alla parte il diritto ad ottenere l’oralità della trattazione della fase - come avviene nella disciplina degli art. 275 c.p.c., art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., dell’art 352 c.p.c. -– allo specifico scopo di escludere la trattazione (solo) scritta della causa[47]. La trattazione scritta, in queste ipotesi, non ha spazio perché la forma è prevista espressamente come diritto della singola parte che manifesta, in modo espresso, una volontà in senso contrario alla trattazione ex art. 127-ter c.p.c.
(b2) La seconda ipotesi è quando la legge prevede la forma orale come obbligatoria perché servente alla pubblicità della fase. L’art. 128 c.p.c., norma sulla pubblicità, è prima di tutto una norma sulla forma orale della discussione[48]. La forma orale è, difatti, la prima componente della pubblicità della discussione poiché questa, nel codice vigente, è pubblica a due condizioni: se orale e se detta oralità si sviluppa in un momento-luogo pubblico come l’udienza a porte aperte. Pubblicità-oralità sono un’endiadi pur se, astrattamente, la prima può essere garantita, in modo estensivo, anche da altre forme.
Se la pubblicità della discussione è considerata – come visto al paragrafo 2.3 - la proiezione del diritto della parte alla discussione pubblica allora è possibile la trattazione scritta solo ove vi sia il consenso espresso o tacito delle parti. Il dissenso di anche di una sola di esse, per converso, impedirà la possibilità di disporre la trattazione scritta.
Se la pubblicità invece risponde ad un interesse pubblico - come avviene per l’udienza pubblica di discussione in Cassazione, per cui il nuovo comma 1 dell’art. 379 c.p.c. stabilisce che “L’udienza si svolge sempre in presenza” - allora non vi è spazio per la trattazione scritta, anche se richiesta da tutte le parti.
4.3. I termini per disporre la trattazione scritta
Il giudice, secondo la lettera dell’art. 127-ter c.p.c., sembra poter disporre la trattazione scritta senza limiti di tempo e anche il giorno prima dell’udienza prevista. È utile precisare che, sebbene la disposizione presupponga che il provvedimento sia emanato fuori udienza, lo stesso può essere emanato anche in udienza.
Un’interpretazione della norma conforme ai principi evidenziati nel paragrafo 2 - e all’insopprimibilità del termine di opposizione che verrà evidenziata successivamente - impone tuttavia di configurare due limiti.
Il primo limite
Il primo limite si ricava dalla considerazione per cui la trattazione scritta è uno strumento di flessibilità utile a garantire la ragionevole durata del procedimento.
Per tale ragione non sembra ammissibile un provvedimento con cui il giudice, nel disporre la trattazione scritta, fissi il termine per il deposito delle note in corrispondenza di un giorno di udienza successivo a quello originariamente stabilito per la data di udienza. Il provvedimento sarebbe, prima di tutto, un mero differimento della data di udienza.
Un esempio aiuta a chiarire. Se l’udienza (o meglio, la trattazione della causa in udienza) è già fissata per il giorno 12 dicembre, la lettera della norma sembra consentire al giudice di disporre la trattazione scritta anche con provvedimento dell’11 dicembre, con conseguente assegnazione alle parti del termine “minimo” di 15 giorni per il deposito delle note (quindi a partire almeno dal 27 dicembre).
Il provvedimento sarebbe da considerare, tuttavia, dapprima un differimento di udienza e solo dopo un provvedimento che dispone la trattazione scritta. E tanto perché - considerando che secondo l’ultimo comma il termine di scadenza per il deposito delle note è da considerarsi data di udienza - il provvedimento dovrebbe comunque indicare un termine per il deposito delle note (almeno 27 dicembre) diverso e successivo rispetto all’originario (12 dicembre).
Se l’istituto della trattazione risponde ad esigenze di economia processuale, nel solco di una proficua direzione del procedimento ex art. 175 c.p.c., non appare giustificato un differimento della data di udienza utile alla sola operatività della trattazione scritta (che, al contrario, serve garantire una maggiore celerità procedimentale).
Il secondo limite
Il giudice deve disporre la trattazione scritta in un tempo congruo e tale da garantire, alle parti, un termine per proporre opposizione (5 giorni, riducibili in caso di particolari ragioni di urgenza) e la possibilità di conoscere tempestivamente la decisione in merito all’opposizione stessa o il silenzio-diniego del giudice (5 giorni dalla presentazione dell’opposizione). Tale, infatti, appare lo scopo del secondo comma dell’art. 127-ter c.p.c.
Il tempo congruo è individuato dal legislatore, nel primo periodo del comma citato, quando dispone che “Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note”. Termine che può essere ridotto in caso di particolari ragioni di urgenza e, può aggiungersi, con il consenso (espresso o tacito) di entrambe le parti.
Il provvedimento del giudice deve quindi intervenire in un tempo tale da consentire il rispetto del termine di 15 giorni - presunto come congruo dalla legge - intercorrente tra la comunicazione del provvedimento del giudice e il giorno di scadenza per il deposito delle note. E tanto sia nel caso in cui la trattazione in udienza del procedimento non sia stata ancora disposta (udienza non ancora fissata), sia nel caso in cui la trattazione in udienza sia stata già disposta (udienza già fissata, unica ipotesi presupposta dalla disposizione).
La violazione da parte del giudice del limite indicato dalla norma non è prevista espressamente a pena di nullità. Se il termine di 15 giorni, tuttavia, è stato indicato dal legislatore proprio al fine di garantire il raggiungimento dello scopo - la possibilità per le parti di opporsi e di conoscere in tempo utile il provvedimento giudiziale di risposta alla loro opposizione (anche se il tempo di questa conoscenza non è disciplinato, e rischia di lasciare le parti in un limbo) - sarà ravvisabile un vizio tutte le volte in cui le parti non abbiano avuto un termine utile per opporsi.
Al fine di evitare ipotesi di vizio, se il provvedimento del giudice interviene in un tempo tale da violare il termine di 15 giorni tra la comunicazione del provvedimento e il termine di scadenza per il deposito allora: deve essere garantito comunque un termine minimo per l’opposizione e il giudice deve aver cura di rispondere immediatamente se vi è stata opposizione tempestiva. In ogni caso, la mancata opposizione delle parti nel termine (consenso tacito) ovvero il deposito delle note da parte di tutte le parti consente di ritenere raggiungo lo scopo[49].
4.4. L’assegnazione del termine per il deposito delle note. Orario e data di udienza
Il termine assegnato per il deposito delle note non deve essere inferiore a 15 giorni e può essere abbreviato al ricorrere di particolari ragioni di urgenza di cui il giudice dovrà dare atto nel provvedimento (ad esempio, la ragionevole durata del procedimento se la trattazione ex art. 127-ter c.p.c. consente al giudice di disporre un rinvio breve rispetto ad una eventuale trattazione orale).
Il vero cambio di passo della nuova disposizione rispetto alla disciplina emergenziale è segnato dalla previsione, per il deposito delle note, di un termine unico. Un termine non ancorato alla data di udienza (e non più calcolato a ritroso da essa, gli ormai abituali “cinque giorni prima dell’udienza”) ma decorrente dalla data di emissione del provvedimento con cui il giudice dispone la trattazione scritta.
Cambio di passo che, allontanando la trattazione scritta dallo schema logico dell’udienza, reca alcune problematiche sulle tempistiche del deposito delle note.
Orario
Sino ad ora, difatti, il termine di 5 giorni (antecedenti alla data di udienza) per il deposito delle note era temperato dal limite dell’orario di udienza: le parti potevano non rispettare il termine di cinque giorni previsto per il deposito e tuttavia, al fine di soddisfare l’onere di comparizione, erano tenute al deposito delle note entro l’orario di udienza fissato.
Le soluzioni per l’interprete, dinanzi al termine unico fissato dal nuovo art. 127-ter c.p.c., sono tre.
1. La prima è quella di allontanarsi dallo schema logico dell’udienza.
In tal senso, il termine per il deposito delle note, come i tradizionali termini codicistici, consiste non già nella indicazione di un punto del tempo, ma nella indicazione di un periodo: ha due capi, che sono il giorno di inizio (dies a quo) e il giorno di scadenza (dies ad quem). È un termine (a giorni, non a ore) ed è quindi da escludere che il giudice possa indicare anche un orario; sicché, il deposito telematico delle note dovrà essere ritenuto tempestivo laddove effettuato entro la fine del giorno di scadenza (ovvero le 23:59 ex art. 16 bis, co. 7, d.l. n. 179/2012 ed ex nuovo art. 196-sexies c.p.c.).
Gli inconvenienti sono evidenti. Il giudice difficilmente potrà provvedere, su quanto dedotto nelle note, il medesimo giorno di scadenza del termine, frustrando così quella celerità del processo che, almeno nelle intenzioni, sembra aver ispirato il riformatore.
Le difficoltà indicate possono essere superate allora solo con la leale collaborazione delle parti. Il giudice potrà invitare le stesse a depositare le note, comunque, prima della scadenza del termine. Il Tribunale potrà concordare con il foro un (ennesimo) protocollo.
2. La seconda alternativa è quella di utilizzare lo schema logico dell’udienza dato che l’ultimo comma chiede di considerare il termine di scadenza per il deposito “data di udienza” a tutti gli effetti (si richiama a riguardo quanto detto in tema di conservazione della dimensione temporale dell’udienza).
In tal senso, il termine per il deposito delle note è da considerarsi come se fosse un termine di udienza e quindi anche l’indicazione di un punto del tempo. Il giudice, quindi, anche ricollegandosi all’art. 127 c.p.c. e 175 c.p.c., potrebbe indicare un orario e il deposito telematico delle note dovrà essere ritenuto tempestivo laddove effettuato entro tale termine orario del giorno.
I vantaggi sono evidenti. Continuare come si è fatto sino ad oggi, in modo efficace, e consentire al giudice di poter provvedere il medesimo giorno di scadenza del termine, aiutando la celerità del processo.
3. La terza soluzione è quella, sempre utilizzando lo schema logico dell’udienza, di implementare le tabelle secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice di procedure civile per cui il presidente deve indicare “i giorni e le ore” (ovvero l’arco temporale) in cui il giudice svolge l’udienza (prevedendo così un orario “limite” entro cui depositare le note).
Data di udienza
Le soluzioni per l’interprete sono due.
1. La prima è, di nuovo, quella di allontanarsi dallo schema logico dell’udienza.
In tali ipotesi il giudice potrà assegnare un termine con scadenza in un giorno anche diverso dai giorni di udienza fissati nelle tabelle di organizzazione. L’opzione sembra tuttavia non collimare con la disposizione per cui il giorno di scadenza del termine è “data di udienza a tutti gli effetti” né essere congrua con la collocazione codicistica della norma. L’ulteriore conseguenza, già evidenziata, è che non vi sarà neppure la dimensione ordinamentale dell’udienza.
2. La seconda soluzione nasce dall’idea di utilizzare lo schema logico dell’udienza.
È da escludere, per le ragioni già esposte al paragrafo 3, che il termine di scadenza per il deposito possa essere fissato in un giorno in cui il giudice non tiene udienza.
Si è detto, infatti, che se il giorno di scadenza del termine è “data di udienza a tutti gli effetti”, il giudice non è libero di determinare le date di udienza posto che, queste, secondo le disposizioni di attuazione del c.p.c. sono programmate e fissate dal presidente del Tribunale per mezzo delle tabelle di organizzazione. Al giudice, infatti, compete solo individuare la singola data di trattazione del singolo procedimento nel solco del calendario delle udienze già fissato.
5. Il diritto di opporsi, il diritto alla trattazione orale e la mancata opposizione
L’art. 127-ter, comma secondo, c.p.c. disciplina il diritto della parte costituita di opporsi al provvedimento del giudice che dispone la trattazione scritta. È necessario precisare, anche alla luce di quanto in merito all’interpretazione del comma 1, che occorre distinguere tra diritto di opporsi al provvedimento che dispone la trattazione scritta e diritto alla trattazione orale della fase procedimentale. Il primo, difatti, non implica necessariamente il secondo.
5.1. Il diritto di opporsi alla trattazione scritta
Legittimazione
Il diritto è esercitabile solo dalla parte costituita e tanto esclude che l’opposizione possa provenire da chi non è parte del giudizio e da chi non è, o non è ancora, costituito (e pur se notiziato del provvedimento perché contenuto in un atto del giudice).
Termine
Il diritto è esercitabile, dalle parti costituite, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento che la dispone.
La decorrenza è dettata a partire dalla “comunicazione” del provvedimento poiché la norma presuppone che il termine sia assegnato fuori udienza e solo alle parti costituite. Nel momento in cui, tuttavia, il provvedimento è emanato in udienza, alla presenza delle parti, appare ragionevole affermare che l’opposizione possa essere immediata.
Il termine sembra decorrere, per la parte non ancora costituita per la prima udienza, dal momento della costituzione, poiché solo con la costituzione essa diviene parte. Può ritenersi tuttavia, interpretando la norma coerentemente con il sistema codicistico e con i suoi principi, che il termine per l’opposizione decorra invece dal termine previsto per la costituzione tempestiva (nel presupposto che la parte conosca o possa conoscere il provvedimento).
Il contumace, invece, costituendosi, accetta il processo nello stato in cui si trova e con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi. Pertanto, per questa parte, il termine decorrerà dalla data di deposito del provvedimento che dispone la trattazione scritta (quando emesso dopo la dichiarazione di contumacia) e l’opposizione sarà preclusa in caso di costituzione successiva al decorrere dei cinque giorni.
La previsione di un termine per opporsi, invece, non ha senso nel caso in cui la trattazione scritta sia disposta su richiesta concorde delle parti.
Il termine non è previsto espressamente a pena di decadenza. Il decorso dello stesso, tuttavia, determina l’accettazione del provvedimento e dunque la rinuncia ad avvalersi della trattazione orale. In tale prospettiva, e orientando il discorso al principio di leale collaborazione, la parte potrà proporre opposizione, dopo il termine di 5 giorni, solo nel caso in cui sopravvengano nuovi elementi.
L’insopprimibilità del termine
Il diritto può essere compresso in quanto è possibile abbreviare il termine per il suo esercizio.
La compressione è possibile nel caso indicato dalla norma, ovvero quando vi sono particolari ragioni di urgenza. Dette ragioni non sembrano facilmente categorizzabili non essendo agevole riscontrare un immediato nesso tra urgenza e una forma specifica di trattazione, in particolare quella ex art. 127-ter c.p.c. La norma, per avere uno scopo compiuto, deve interpretarsi nel senso che è possibile l’abbreviazione del termine ove vi siano ragioni obiettive e razionali (ad esempio la ragionevole durata del procedimento poiché la trattazione ex art. 127-ter c.p.c. consente al giudice di fare un rinvio breve rispetto alla trattazione orale).
Il diritto di opporsi alla trattazione scritta, si è visto, appare comprimibile solo nel tempo di esercizio e tanto significa che qualsiasi provvedimento che dispone la trattazione scritta deve preservare la possibilità per ciascuna delle parti di opporvisi in un tempo congruo. Il provvedimento che non garantisce detta possibilità è viziato. Vizio sanato nel caso in cui la parte depositi la nota di trattazione scritta senza nuovamente opporsi al provvedimento che l’ha disposta.
5.2. Il diritto alla trattazione orale
Il diritto di opporsi alla trattazione scritta non implica il diritto della parte alla trattazione orale. Il primo implica il secondo - e vincola il giudice - solo se esercitato da entrambe le parti. Il diritto alla trattazione orale vincola sempre il giudice a revocare il provvedimento che dispone la trattazione scritta se vi è opposizione anche di una sola delle parti.
La lettura della disposizione sembra suggerire che il giudice è vincolato alla revoca del provvedimento che dispone la trattazione scritta solo se l’opposizione è manifestata congiuntamente dalle parti.
L’interpretazione proposta del primo comma dell’art. 127-ter c.p.c., anche costituzionalmente orientata, induce tuttavia a ritenere che, oltre il dettato della norma, ciascuna delle parti può vincolare il giudice alla revoca del provvedimento che dispone la trattazione orale in almeno due ipotesi.
(1) La prima, di ordine generale, è quando il giudice ha disposto la trattazione scritta frustrando lo scopo previsto ovvero privando le parti dell’effettività del contraddittorio in condizioni di parità. È il caso in cui, ad esempio, fissi l’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta senza autorizzare il deposito di memorie di discussione[50].
(2) La seconda è quando la trattazione scritta è stata disposta per una ipotesi in cui la legge prescrive una specifica forma di trattazione orale a tutela di un diritto espresso della parte ovvero a tutela di un interesse pubblico (come l’udienza pubblica in Cassazione). La legge, si è detto, prescrive come obbligatoria la trattazione orale quando prevede questa come l’unica forma per l’attività ovvero quando ha come specifico fine quello di escludere la trattazione integralmente scritta della causa. Nei casi indicati rientrano, quindi, la prima comparizione - in special modo nel rito lavoristico e nella nuova fase ex art. 183 c.p.c. in cui è previsto il tentativo di conciliazione e l’interrogatorio libero - e la discussione orale (ad esempio nel rito lavoro o ex art. 281 sexies c.p.c.) ovvero le ipotesi ex art. 275 c.p.c., art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c. o ex art 352 c.p.c.
In dette ipotesi, nel caso in cui il giudice non accolga l’opposizione revocando la trattazione scritta, l’atto successivo è destinato ad essere viziato. Vizio, si è detto, sanato nel caso in cui la parte depositi la nota di trattazione scritta senza nuovamente opporsi al provvedimento che l’ha disposta.
5.3. La mancata opposizione e l’acquiescenza
La mancata opposizione della parte, entro il termine di legge di cinque giorni, è qualificabile come consenso tacito (acquiescenza) al provvedimento del giudice, con conseguente rinuncia all’eccezione relativa all’eventuale vizio scaturente dal provvedimento del giudice che ha disposto la trattazione scritta.
Il medesimo effetto si ottiene nel caso in cui le parti - anche a fronte di un provvedimento che dispone la trattazione scritta in modo difforme da quanto stabilito dall’art. 127-ter c.p.c. - depositino le note di trattazione senza manifestare espressamente l’opposizione.
Così, ad esempio, qualora il giudice abbia assegnato un termine inferiore ai quindici giorni per il deposito delle note, la mancata opposizione della parte nei cinque giorni le impedirà di eccepire il vizio successivamente. Allo stesso modo, nel caso in cui depositi, comunque, le note senza eccepire nuovamente il vizio.
5.4. Il provvedimento e il silenzio del giudice sull’opposizione
Ai sensi del comma 2 dell’art. 127-ter, il giudice provvede sull’opposizione nei cinque giorni successivi con “decreto non impugnabile”.
La forma del decreto pare giustificata dal fatto che si tratta di una delibazione da assumere in tempi rapidi, senza la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti.
Alla medesima finalità di celerità procedimentale sembra orientata la previsione di inoppugnabilità del decreto.
Qualora il giudice ometta di pronunciarsi sull’opposizione, in assenza di un provvedimento modificativo della forma di celebrazione dell’udienza, dovrà intendersi confermata la modalità a trattazione scritta (per una sorta di silenzio-rigetto).
6. Le modalità della trattazione scritta.
6.1. Il deposito delle note e il mancato deposito
La trattazione scritta si sostanzia nel “deposito di note scritte” (non più anche lo “scambio” come avevano previsto le normative emergenziali).
Il deposito deve avvenire entro il termine fissato dal giudice.
Le note (l’aggettivo “scritte” è una ridondanza, essendo difficile immaginare delle note che non siano scritte) sono atti processuali che si distinguono dalle memorie per il loro contenuto più sintetico.
Ed infatti, le note menzionate nell’art. 127-ter c.p.c. possono contenere solo “istanze e conclusioni”.
Nel concetto di istanze possono intendersi incluse domande ed eccezioni. Così circoscritto il loro contenuto, dovranno ritenersi inammissibili quelle note che dovessero surrettiziamente integrare nuovi atti processuali esorbitanti le istanze e le conclusioni che possono prospettarsi in un’udienza di rito.
Il termine unico fissato al comma 2 è anche il termine ultimo per il deposito delle note.
Nel caso in cui nessuna delle parti depositi le note entro il termine, si producono i medesimi effetti processuali della mancata comparizione. In tal senso, il comma 4 (pur senza richiamarlo espressamente) ricalca il meccanismo degli artt. 309 e 181 c.p.c.: viene fissato un nuovo termine (o una nuova udienza) e, se neppure entro questo nuovo termine vengono depositate le note (o nessuno compare alla nuova udienza), la causa viene cancellata dal ruolo e il processo si estingue.
6.2. Il dovere del giudice di provvedere
Se nell’ultima legislazione emergenziale (art. 221, co. 4, d.l. n. 77/2020) era stato omesso qualsiasi riferimento al provvedimento finale del giudice all’esito della trattazione scritta, l’art. 127-ter gli dedica il terzo comma prevedendo anche un termine (di trenta giorni) decorrente dal giorno di scadenza del termine per il deposito delle note.
Il legislatore volutamente parla di “provvedimento”, lasciando così intendere che la trattazione scritta potrà dar luogo a provvedimenti di qualsiasi forma (ordinanza, decreto, sentenza) e natura (decisoria, istruttoria, etc.).
In assenza di una “udienza”, il provvedimento di cui al comma 3 non è altro che un provvedimento adottato dal giudice a fronte di una nota di parte (o di più parti) depositata fuori udienza e precedentemente autorizzata dal giudice (la norma sembra ricalcare lo schema dei commi 6 e 7 dell’art. 183 c.p.c., in vigore fino al giugno 2023, laddove si prevede che il giudice assegni i termini per le memorie e poi “Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni”).
Aderendo al concetto di udienza quale schema logico-giuridico, può ritenersi invece che l’emissione del provvedimento sia lo scioglimento di una riserva (assunta automaticamente alla scadenza del termine) possibile in trenta giorni (non diversa quindi da quella ex art. 186 c.p.c. che presuppone un’udienza, se non nei termini).
Il termine per l’emanazione del provvedimento decorre dal giorno di scadenza del termine per il deposito delle note, a prescindere dunque dall’eventualità che tutte le parti abbiano depositato le proprie note prima del termine.
Appendice. Schema riepilogativo
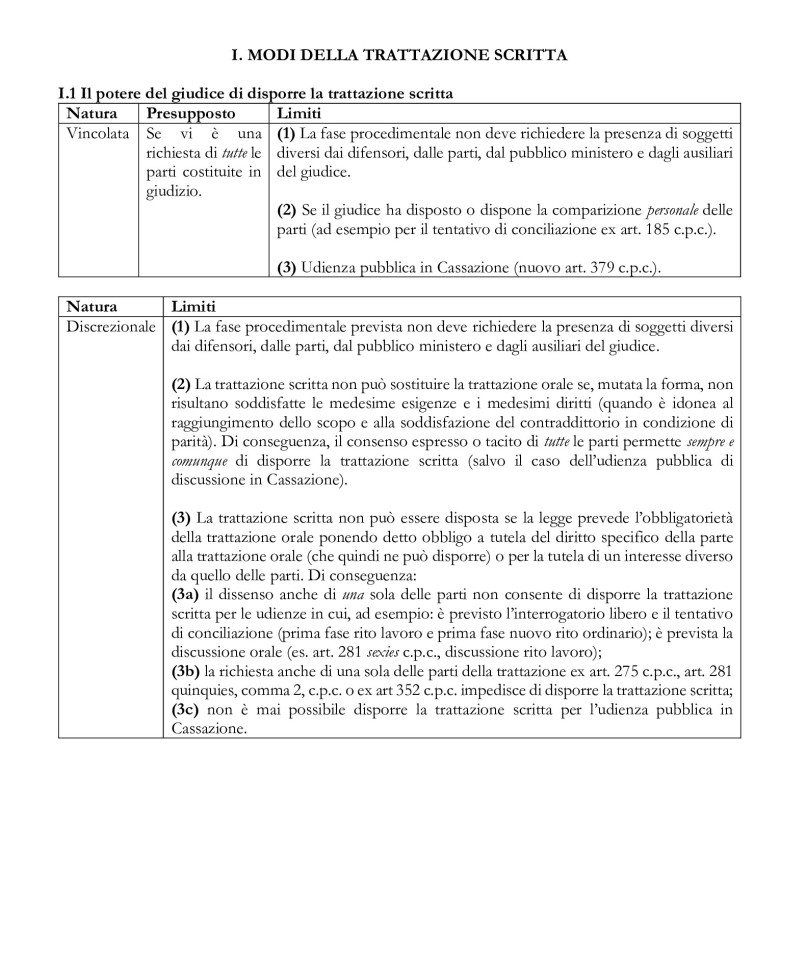
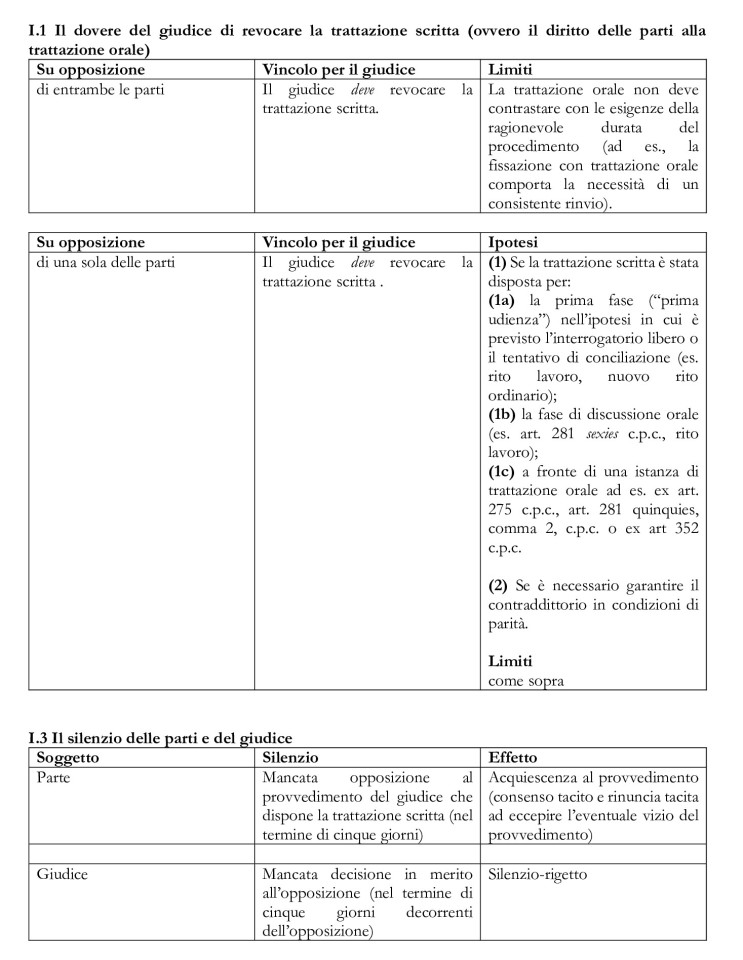
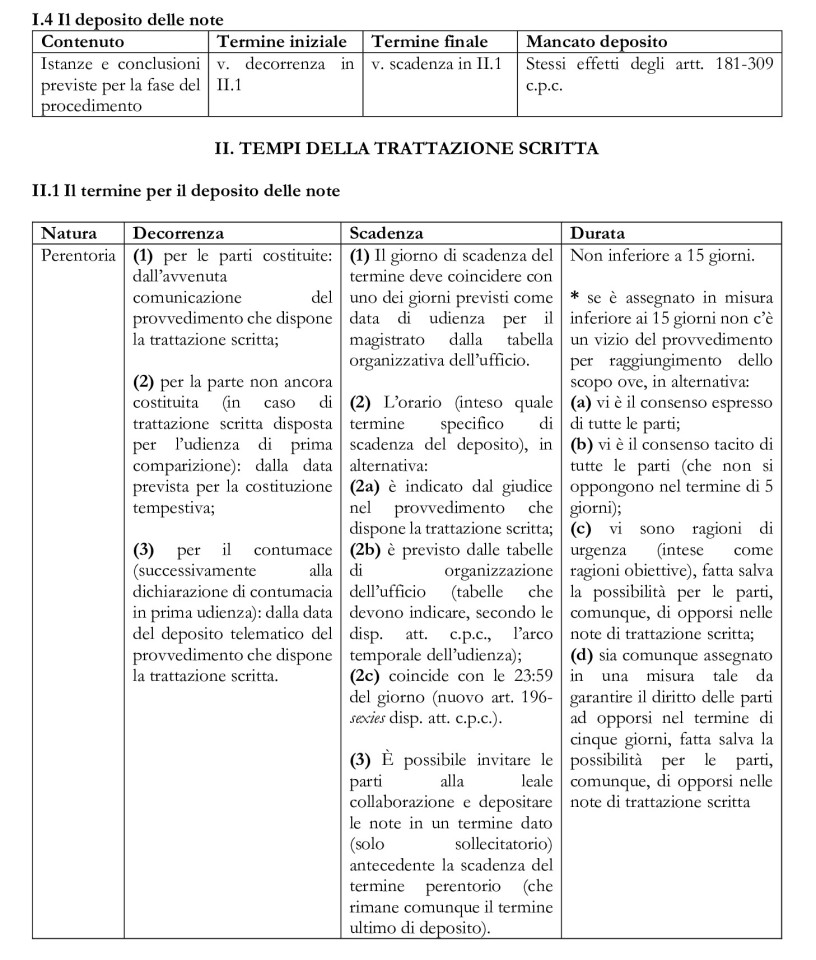
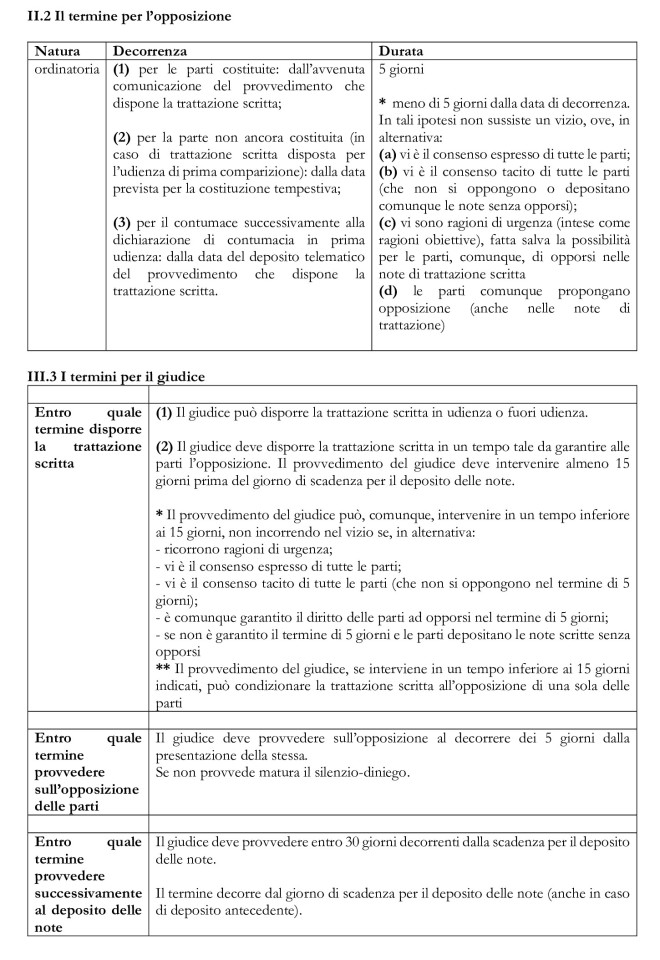
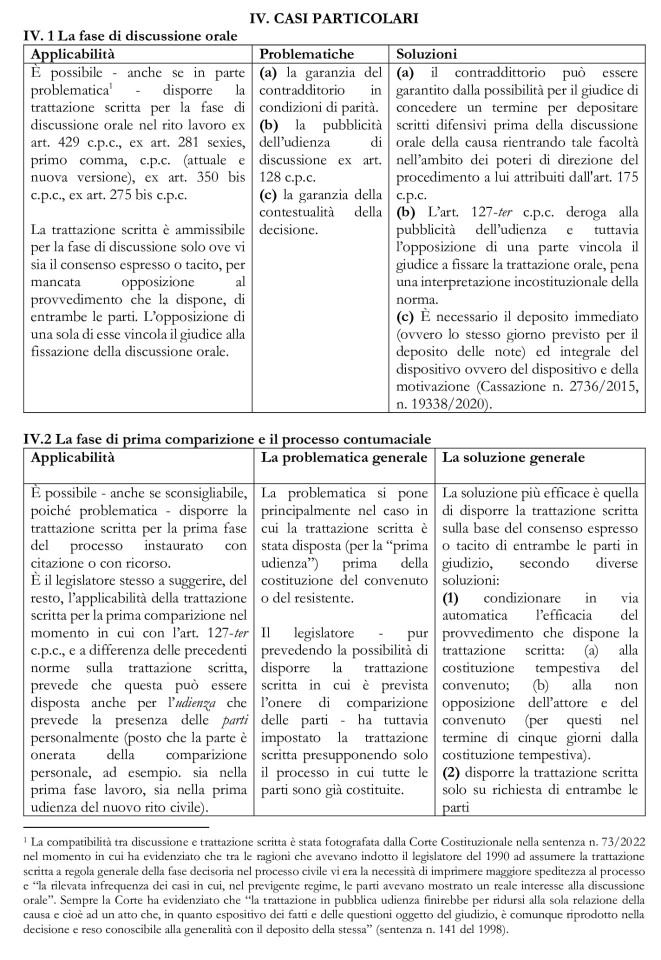
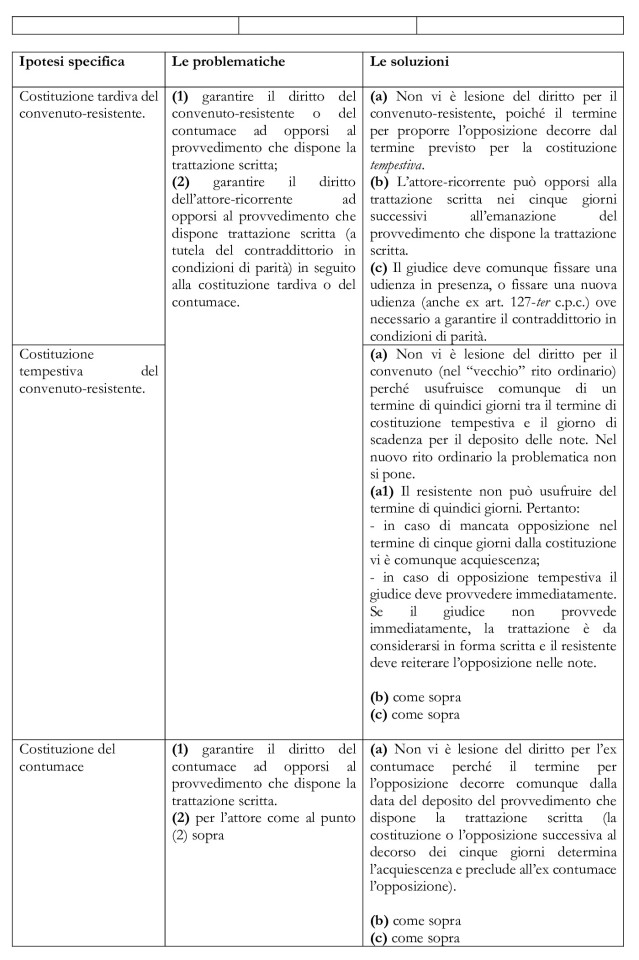
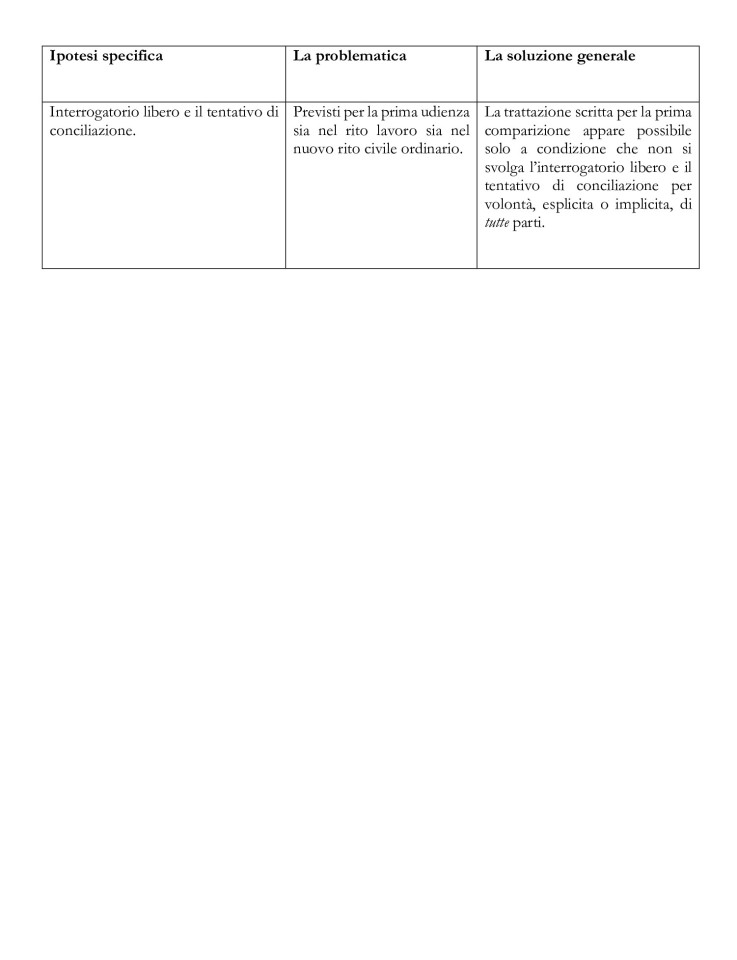
[1] BIAVATI, “Processo civile e pandemia: che cosa passa, che cosa rimane”, in Riv. trim. dir. proc. civ., I/2021, 133 ss.; BIAVATI, “Note sul processo civile dopo l’emergenza sanitaria”, in Giustizia Insieme, 15 luglio 2020; BIAVATI, “Note sul processo civile dopo l’emergenza sanitaria”, in Nuova Giurisprudenza ligure, 2020, n. 2, pp. 29 e ss.; ROSSI, “Questioni di diritto civile all’epoca del coronavirus - la legislazione emergenziale sui procedimenti esecutivi”, in Giur. It., 10, 2020; COSSIGNANI, “Giustizia civile ed emergenza coronavirus - le controversie sottratte alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze”, in Giur. It., 8-9, 2020; VILLA-IMBROSCIANO, “Udienze online e processo civile telematico: lo stato dell’arte e alcune proposte de iure condendo”, in Il diritto degli affari, 3, 2020; BROGI, “Diritto emergenziale della crisi d’impresa all’epoca del Covid-19”, in giurcost.org, 13 aprile 2020; ANGIOI, “Le forme alternative all'udienza civile nella normativa d'emergenza”, in giustiziacivile.com, 3 settembre 2020; MASONI, “Diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica (a seguito della conversione in legge del decreto ristori)”, in giustiziacivile.com, 11 gennaio 2021; CECCHELLA, “Trattazione scritta, a distanza, digitalizzazione degli atti: cosa resterà nel processo civile dell’emergenza epidemiologica”, in Questione Giustizia, 2021; DE STEFANO, “La giustizia in animazione sospesa: la legislazione di emergenza nel processo civile - note a lettura immediata all’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020)”, in Giustizia Insieme, 18 marzo 2020; DE STEFANO, “La giustizia dall’animazione sospesa passa in terapia intensiva: gli sviluppi della legislazione d’emergenza nel processo civile”, in Giustizia Insieme, 10 aprile 2020; DI FLORIO-LEONE, “Il processo di carta: dal “telematico” all’udienza da remoto”, in Questione giustizia, 24 aprile 2020; PANZAROLA, “Aspetti della normativa emergenziale anti-Covid per il processo di cognizione”, in Riv. dir. proc., IV/2021, 1361 ss.; SCARSELLI, “Contro le udienze da remoto e la smaterializzazione della giustizia”, in www.judicium.it, 13 maggio 2020; RUFFINI, “Emergenza epidemiologica e processo civile”, in Questione Giustizia, 2021.
[2] Si vedano al riguardo i precedenti scritti: CAROLEO-IONTA, “L’udienza civile ai tempi del corona virus. Comparizione figurata e trattazione scritta”, in Giustizia Insieme, 12 marzo 2020; CAROLEO-IONTA, “Trattazione scritta. Un’impalcatura”, in Giustizia Insieme, 1 aprile 2020.
[3] CAROLEO-IONTA, “La trattazione scritta. Un arabesco”, in Giustizia Insieme, 29 luglio 2020.
[4] BIAVATI, L’architettura della riforma del processo civile, Bonomia University Press, Bologna, 2021.
[5] Su questa rivista si è evidenziata la generale tendenza del legislatore a ricercare soluzioni volte a perseguire modelli astratti, senza prestare la dovuta attenzione alle criticità che emergono nel concreto esercizio della giurisdizione civile (OTTONI, Giustizia civile e ingiustizie. La Giornata Europea in Giustizia Insieme, 25 ottobre 2022).
[6] Se l’art. 221, comma 4, disponeva che “Il giudice…assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data [fissata per l’udienza] per il deposito delle note scritte”, l’art. 127-ter c.p.c. dispone che il giudice “assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note”. Previsione, quest’ultima, non accompagnata da alcuna limitazione temporale per il giudice prevista, invece, dall’art. 221 comma 4 (“Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza”). Previsione che rende macchinosa l’applicazione della trattazione scritta poiché, salvo accedere alla interpretazione proposta nello scritto, le parti possono depositare le note sino alle 23:59 del giorno previsto come data di scadenza del termine.
[7] CAROLEO-IONTA, “L’udienza civile ai tempi del corona virus. Comparizione figurata e trattazione scritta”, in Giustizia Insieme, 12 marzo 2020; CAROLEO-IONTA, “La trattazione scritta. Un arabesco”, in Giustizia Insieme, 29 luglio 2020.
[8] MANDRIOLI, Manuale, Vol. I pag. 475
[9] Così Corte Costituzionale n. 73/2022 che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità di una serie di norme del processo tributario relative alla trattazione camerale.
[10] Corte di Cassazione n. 1492/1962
[11] FAZZALARI, “La funzione del giudice nella direzione del processo civile”, in Riv. dir. proc., 1963, pp. 64-72; COMOGLIO, “Direzione del processo e responsabilità del giudice”, in Riv. dir. proc., 1977, pp. 14 ss.; FABBRINI, voce “Potere del giudice (dir. proc. civ.)”, in Enciclopedia del diritto, 1985, pp. 721 ss.; GUGLIELMINO, “Il calendario del processo”, in BESSO – FRUS – RAMPAZZI – RONCO (a cura di), Trasformazioni e riforme del processo civile. Dalla l. 69/2009 al d.d.l. delega 10 febbraio 2015, Zanichelli, Bologna, 2015, pp. 195 ss.
[12] Per Corte di Cassazione n. 3189/2012 il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti.
[13] PERA, “«Quod non est in actis, non est in hoc mundo» (a proposito della pubblicità dell’udienza nelle cause di lavoro)”, in Riv. dir. proc., 1977, 684 ss.; FABBRINI, “Regime della sentenza emessa a seguito di udienza svoltasi in forma non pubblica”, in RDL, II, 1978; BORRÈ, “La pubblicità del processo del lavoro”, in Questione e giustizia, 1982; TERESI -TROJANO, “La pubblicità degli atti giudiziali e dei registri di cancelleria”, in Giur. it., 1984, 343 ss.; ORIANI, “Atti processuali”, in EG, III, Roma, 1988; CONSOLO, “La pubblicità nel contenzioso tributario (fra la sent. 16 febbraio 1989, n. 50 della Corte costituzionale e la L. 22 maggio 1989, n. 198)”, in Rass. trib., 1989, II, 1137 e in Dal contenzioso al processo tributario. Studi e casi, Milano, 1992, 125 ss.; CRESPI, “Pubblicità delle udienze e rispetto della persona”, in Riv. dir. proc., 1994, 559 ss.; CIPRIANI, “Pubblicità dei giudizi, diritto di spedizione e udienza collegiale di spedizione”, in Riv. dir. proc., 1995, 371 ss.; CHIARLONI, “Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il processo civile”, in CIVININI – VERARDI, Il nuovo articolo 111 della Costituzione e il giusto processo civile, Atti del Convegno dell’Elba (9-10 giugno 2000), Quaderni di «Questioni Giustizia», Franco Angeli, Milano, 2001, pp. 13 ss.; FRASSINETTI, “Pubblicità dei giudizi e tutela della riservatezza”, in Riv. dir. proc., 2002; MINAFRA, “La pubblicità dei giudizi (I-II)”, in Giusto proc. civ., 2018, 875 ss. e 1151 ss.
[14] Per una efficace sintesi della storia del principio si veda Corte Costituzionale n. 212/1986.
[15] Corte Costituzionale n. 50/1989.
[16] Corte Costituzionale n. 263/2017.
[17] Corte Costituzionale n. 212/1986.
[18] Corte Costituzionale n. 263/2017.
[19] Corte EDU, 6 novembre 2018, sentenza Ramos Nunes de Carvalho e Sà contro Portogallo.
[20] Corte Costituzionale n. 141/1998.
[21] Le sentenze n. 12/1971 e n. 69/1991 Corte Costituzionale hanno evidenziato la particolare rilevanza assunta dal principio in esame nel processo penale, nel quale, in considerazione degli interessi protetti e dei riflessi sociali della violazione delle norme incriminatrici, sono ammesse deroghe solo per garantire beni a rilevanza costituzionale, laddove negli altri casi il legislatore gode di un più ampio margine di discrezionalità nell'individuazione degli interessi in grado di giustificare la celebrazione del dibattimento a porte chiuse (sentenze n. 69 del 1991 e n. 12 del 1971).
[22] Corte Costituzionale n. 141/1998 e, recentemente, n. 73/2022.
[23] Vedi nota sopra.
[24] Art. 375 comma 1 c.p.c. (nuova versione): “La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’art. 391-quater”.
[25] COSTA, Oralità e scrittura nel processo civile, Imola, 1917; PICARDI, “Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1973, 1 ss.; VOCINO, voce “Oralità nel processo (dir. proc. civ.)”, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980; DENTI, voce “Oralità. I) Principio dell’oralità”, in Enc. giur., Roma, 1990; ONG W.J., Oralità e scrittura. La tecnologia della parola, Bologna 2014.
[26] Corte di Cassazione n. 395/2017.
[27] Corte Costituzionale n. 275/1998.
[28] Corte Costituzionale n, 73/2022.
[29] Corte Costituzionale n, 73/2022.
[30] Corte Costituzionale n. 89/1972, n. 80/1992.
[31] Corte Costituzionale n. 181/2008.
[32] Secondo Corte di Cassazione n. 2736/2015 la sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione. Secondo Cassazione n. 19338/2020 la sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge.
[33] MARENGO, voce “Udienza civile”, in Enc. dir., XLV, pp. 483-494.
[34] Artt. 127, 168 bis c.p.c., 80 disp. att. c.p.c. e ss.; art. 202 circolare sulla formazione delle tabelle. L'assenza dei soggetti che hanno l'onere o il dovere di presenziare ha diversificate conseguenze sul singolo processo - il rinvio, ad esempio (artt. 164, 181 c.p.c.) - ma non sull'udienza che deve essere comunque tenuta dal giudice.
[35] La comparizione è la partecipazione effettiva - all’udienza e a mezzo del difensore - della parte costituita. Tramite la comparizione la parte soddisfa un onere (art. 181 e 82 c.p.c.) ed esercita i poteri processuali attribuiti. La comparizione delle parti in udienza si manifesta, tradizionalmente, attraverso la sola presenza all’udienza stabilita (art. 309 c.p.).
[36] Per Corte Cassazione penale n. 17314/2003 il magistrato deve ritenersi "in udienza" tutte le volte che si trovi ad amministrare giustizia con l'intervento delle parti, intendendosi per "udienza" qualsiasi seduta nella quale si svolge l'attività giudiziaria del magistrato, talché è del tutto irrilevante che l'oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l'inizio di un altro.
[37] Corte di Cassazione penale n. 18486/2022 afferma che l’art. 343 c.p. ricollega la specifica offensività della condotta di oltraggio non tanto al fatto che la stessa sia direttamente collegata allo svolgimento dell'attività processuale intesa in senso proprio, piuttosto alla circostanza che l'offesa venga rivolta al magistrato nel contesto spazio-temporale in cui questi è chiamato ad esercitare la propria funzione. Ciò comporta che il riferimento al termine "udienza" va correttamente inteso ricomprendendovi tutte quelle fasi - anche preliminari ed immediatamente successive alla celebrazione del processo - che si pongano in rapporto di diretta ed inscindibile continuità funzionale con l'attività processuale propriamente intesa. In buona sostanza, il magistrato è in udienza allorché è presente nel luogo deputato alla celebrazione della stessa e compie anche atti che possono essere meramente preparatori alla celebrazione del giudizio, nonché nelle fasi immediatamente conseguenti ad esso. La pronuncia richiama anche Cassazione penale n, 7730/1982 secondo cui l'espressione "udienza" di cui all'art. 343 c.p.c. va intesa nel senso di qualsiasi seduta, nella normale aula di udienza o altrove, ed in qualunque fase processuale essa si svolga destinata allo svolgimento dell'attività giudiziaria del magistrato.
[38] Artt. 163 c.p.c., 69 bis, 80, 113 disp. att. c.p.c. e ss.; 114 artt. 201 e 202 della circolare sulla formazione delle tabelle.
[39] Artt. 163, 168 bis, 175, 415 c.p.c., 81 e ss. disp. att. c.p.c.
[40] Artt. 163, n. 1, 414 c.p.c.
[41] MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Tomo II, Giappichelli, Torino, 2011, p. 72.
[42] TARUFFO, “La trattazione della causa”, in TARUFFO (a cura di), Le Riforme della Giustizia Civile. Commento alla L. 353 del 1990 e alla L. 374 del 1991, UTET, Torino, 1993; BALENA, “La trattazione della causa”, in BALENA – BOVE (a cura di), Le riforme più recenti del processo civile. Commento sistematico delle disposizioni processuali di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, Cacucci Editore, Bari, 2006.
[43] “Volendo significare che la causa si svolge davanti al giudice senza solennità di forma, esponendo le parti le loro questioni e le loro domande, rispondendo il giudice con l'immediatezza che è consentita dalla preventiva conoscenza della causa, e dalla possibilità di venir a contatto con la materia stessa della contesa”. SATTA S., Diritto processuale civile, Cedam, 2000, p. 300.
[44] La trattazione scritta, consentita per il periodo emergenziale, è diversa sia da quella prevista dalla vecchia formulazione dell'art. 180 post-riforma del 1950 e dall' art. 83 bis disp. att. c.p.c. sia da quella di cui all'art. 281 quinquies c.p.c., inclusive comunque di una parte di oralità.
[45] Sul tasso di oralità che dovrebbe avere qualsiasi processo si veda PAGNI, “Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l’emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell’udienza”, in www.judicium.it, 15 dicembre 2020.
[46] È necessario precisare come la parte soddisfi l’onere di comparizione in tutte le fasi del processo - attivando così i doveri del giudice - semplicemente comparendo. La parte è solo onerata di comparire il giorno della prima comparizione. La parte è onerata di comparire il giorno della discussione, non di discutere effettivamente. La parte è onerata di comparire il giorno di acquisizione della prova, non di parteciparvi attivamente. In altri termini il codice onera la parte di comparire, non obbliga la stessa al compimento delle attività.
[47] Secondo Cassazione n. 28229/2017 l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell'udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo"; sicché, avendo la discussione della causa nel giudizio d'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi.
[48] L’art 128 c.p.c. sembra fornire una prima indicazione che collide strutturalmente con l’art. 127-ter c.p.c. nel momento in cui afferma, prima di tutto, che la discussione orale debba avvenire in una udienza (che deve essere anche pubblica e in cui la discussione, per essere effettivamente pubblica, deve essere orale). La conclusione - assecondando lo sforzo del legislatore di escludere l’esistenza di una udienza quando vi è la trattazione scritta della fase - è che la trattazione scritta non potrebbe mai essere disposta per la discussione perché se c’è la trattazione scritta non c’è una udienza, prima ancora di non esserci una udienza pubblica, in cui discutere oralmente.
[49] Una soluzione utile a semplificare e ridurre i tempi di emanazione del provvedimento - e il diritto delle parti all’opposizione - è quella per cui il giudice dispone la trattazione scritta condizionandola espressamente alla mancata opposizione di una delle parti. L’opposizione di una sola di esse determinerebbe quindi, in automatico e senza necessità del provvedimento del giudice, il venir meno trattazione scritta e quindi l’onere per le parti di comparire in presenza per l’udienza.
[50] Alle stesse conclusioni sembra giungere ZITARELLI, “Le prime questioni applicative relative alla «trattazione cartolare» delle udienze”, in Riv. dir. proc., 3, 2022.
[51] La compatibilità tra discussione e trattazione scritta è stata fotografata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 73/2022 nel momento in cui ha evidenziato che tra le ragioni che avevano indotto il legislatore del 1990 ad assumere la trattazione scritta a regola generale della fase decisoria nel processo civile vi era la necessità di imprimere maggiore speditezza al processo e “la rilevata infrequenza dei casi in cui, nel previgente regime, le parti avevano mostrato un reale interesse alla discussione orale”. Sempre la Corte ha evidenziato che “la trattazione in pubblica udienza finirebbe per ridursi alla sola relazione della causa e cioè ad un atto che, in quanto espositivo dei fatti e delle questioni oggetto del giudizio, è comunque riprodotto nella decisione e reso conoscibile alla generalità con il deposito della stessa” (sentenza n. 141 del 1998).
Scheda n. 11 - La sospensione del procedimento con messa alla prova
OBIETTIVO DELLA RIFORMA
Lo scopo della riforma è quello di estendere l'ambito di applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.
Il legislatore ha perseguito detto obiettivo, da un lato, consentendo l’accesso alla messa alla prova anche con riferimento ad ulteriori specifici reati, diversi da quelli contemplati all’art. 550, comma 2, c.p.p., puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell'autore compatibili con l'istituto, e, dall’altro, prevedendo che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.
ASPETTI SOSTANZIALI
L’aspetto di novità si collega non tanto ad un indiscriminato innalzamento del tetto massimo di pena per accedere alla MAP (fino a sei anni), ma all’individuazione di ulteriori e specifici reati, puniti con pena massima non superiore a sei anni, che si prestino particolarmente alla risocializzazione.
Ed infatti, come evidenziato dalla relazione illustrativa alla riforma (pag. 309), l’estensione viene operata in modo nominativo, e quindi selettivo, attraverso il richiamo ai reati individuati dal legislatore della riforma come passibili di citazione diretta (si veda la nuova formulazione dell’art. 550 c.p.p.). Solo per questi sarà possibile accedere alla messa alla prova.
ASPETTI PROCESSUALI
L’aspetto innovativo è collegato alla proposta di MAP formulata dal PM.
Sono previsti due casi:
A) Istanza formulata in udienza (art. 464-bis, comma 1 c.p.p.) = l’imputato può chiedere termine (non superiore a venti giorni) per presentare la richiesta di messa alla prova.
I termini di presentazione sono invariati per l’udienza preliminare, per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, nel procedimento per decreto penale di condanna.
Nella citazione diretta il termine decadenziale è fissato alla conclusione dell’udienza predibattimentale.
Sono previste specifiche modalità di formalizzare la volontà dell’imputato (con dichiarazioni ricevute dal notaio, da persona autorizzata o dal difensore).
È inoltre prevista la possibilità di disporre percorsi di giustizia riparativa.
TESTO PREVIGENTE | TESTO RIFORMATO |
Art. 464-bis c.p.p. - Sospensione del procedimento con messa alla prova. 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. *** *** *** *** *** *** 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. *** *** *** *** 3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3. *** 4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. *** (Omissis) | Art. 464-bis c.p.p. - Sospensione del procedimento con messa alla prova. 1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. 3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. 4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa. (Omissis) |
A) Istanza formulata nel corso delle indagini preliminari (art. 464-ter1 c.p.p.) = la proposta è contenuta nell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. indicando la durata ed i contenuti essenziali del programma (il Pubblico Ministero può avvalersi di UEPE per determinare la proposta).
L’indagato può aderire nel termine di 20 giorni. Se così si determina, gli atti vengono trasmessi al GIP, con la formulazione dell’imputazione, il quale provvede richiedendo l’elaborazione del progetto, sempre che la proposta sia ammissibile, conforme ai requisiti procedurali e non si debba pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p.
Viene dato avviso alla p.o. a cura del PM.
Si tratta di una procedura strutturata come cartolare (la p.o. può infatti depositare memorie una volta ricevuto l’avviso) ferma restando la possibilità per il giudice di fissare udienza camerale, se ritenuto opportuno, anche nel caso in cui sia necessario verificare la volontarietà dell’imputato.
Il giudice provvede con ordinanza, eventualmente in seguito all’udienza.
ARTICOLO DI NUOVA INTRODUZIONE |
Art. 464-ter.1. Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari. 1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna. 2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice. 4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato. 5. Nel caso previso dal comma 4, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato. 6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari può fissare udienza ai sensi dell’articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. 7. Il giudice, valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova. |
DISCIPLINA TRANSITORIA
Ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 150/2022, le disposizioni degli articoli 1 e 32 del medesimo decreto che estendono la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati si applicano anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
Se sono già decorsi i termini di cui all’articolo 464-bis, comma 2, c.p.p., l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.
Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l’articolo 75, comma 3, c.p.p.
Tuttavia, detta specifica disciplina deve essere raccordata con quanto disposto dall’art. 6 del D.L. n. 162 del 31/10/2022, norma che ha introdotto nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l’art. 99-bis, ai sensi del quale il sopraindicato decreto entrerà in vigore il 30/12/2022.
Scheda n. 12 - Il processo in assenza dell’imputato (artt. 420, 420 bis, 420 ter, 484 e 489 c.p.p.)
OBIETTIVO DELLA RIFORMA
L’obiettivo della riforma è quello di ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole.
A tal fine, la nuova formulazione della norma cardine che disciplina l’assenza (art. 420-bis c.p.p.) supera il sistema di presunzioni fino ad oggi previsto.
Resta in ogni caso fondamentale la distinzione tra il momento della regolarità della notifica e quello relativo alle valutazioni sulla procedibilità in assenza, dovendosi sottolineare come l’intervento di attuazione della delega 134/2021 si connota per il tentativo di recuperare una conoscenza reale e certa e non solo formale degli atti introduttivi del giudizio.
COSTITUZIONE DELLE PARTI (ART. 420 C.P.P.)
TESTO PREVIGENTE | TESTO RIFORMATO |
Art. 420 c.p.p. – Costituzione delle parti. 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** (Omissis) | Art. 420 c.p.p. – Costituzione delle parti. 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. 2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non è presente e non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell’articolo 420-bis. 2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È considerato presente anche l’imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale. (Omissis) |
Con il nuovo comma 2-ter dell’art. 420 c.p.p. vengono ridefiniti i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente, aggiungendo alle ipotesi tradizionali, i casi dell’imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso a un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.
In tali situazioni, infatti, non solo è certo che l’imputato ha avuto conoscenza del processo e della sua imputazione, ma risulta che ha addirittura deciso di avvalersi del diritto di partecipare con una istanza scritta o con un procuratore speciale.
ASSENZA DELL’IMPUTATO (ART. 420-BIS C.P.P.)
TESTO PREVIGENTE | TESTO RIFORMATO |
Art. 420-bis c.p.p. – Assenza dell’imputato. 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. *** *** *** *** *** *** *** *** *** 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedi- mento o di atti del medesimo. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. 4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. 5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** | Art. 420-bis c.p.p. - Assenza dell’imputato. 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza: a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto; b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere. 2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. *** 3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo. *** 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 6. L'ordinanza che dichiara l’assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto; c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte. 7. Salvo quanto previsto dal comma 5, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e procede ai sensi del comma 4-bis. |
Nel testo dell’art. 420-bis sono state distinte due situazioni idonee a dare certezza della conoscenza: quella in cui l’imputato è stato citato a comparire a mani proprie o con notifica avvenuta a mani di una persona espressamente delegata dall’imputato al ritiro dell’atto e quella in cui l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.
Accanto a queste situazioni, la nuova disciplina aggiunge quelle ipotesi nelle quali, all’infuori dai casi appena menzionati, la conoscenza della pendenza del processo può comunque ritenersi effettivamente sussistente perché accertata in base a un complesso di elementi rimessi alla valutazione del giudice.
In questo caso, per offrire al giudice un criterio di valutazione sono stati indicati alcuni elementi sintomatici, idonei a far desumere l’effettiva conoscenza della pendenza del processo: il giudice dovrà dare rilevo, oltre che alle modalità di notifica, a ogni altra circostanza del caso concreto, avvalorando la valutazione giudiziale caso per caso, in contrapposizione con il sistema di indici presuntivi finora previsti.
Sono, poi, menzionati i casi di volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza processo. Tale situazione include certamente la latitanza, per la quale si prevede espressamente che si proceda sempre in assenza, trattandosi del caso tipico di sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento.
Laddove i predetti presupposti per procedere in assenza risultino non sussistere, prima di avviare la procedura prevista dell’art. 420-quater, il giudice dell’udienza preliminare dovrà disporre ulteriori ricerche finalizzate alla notificazione a mezzo della polizia giudiziaria dell’avviso di fissazione della medesima e del verbale d’udienza, dal quale risulta la data del rinvio. Nello stesso modo il giudice dovrà sempre provvedere laddove dovesse avvedersi, anche successivamente, di aver proceduto in assenza pur in difetto dei necessari presupposti indicati.
Inoltre, secondo un modulo che si ripeterà in tutto il corso del processo, se, prima della decisione, l’imputato compare, il giudice revoca sempre, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza e, solo nel caso di erronea dichiarazione di assenza oppure in presenza di precisi presupposti che è onere dell’imputato dimostrare, restituisce l’imputato nei termini per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.
IMPEDIMENTO A COMPARIRE DELL'IMPUTATO O DEL DIFENSORE (ART. 420-TER C.P.P.)
TESTO PREVIGENTE | TESTO RIFORMATO |
Art. 420-ter c.p.p. - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore. 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1. (Omissis) *** 3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. (Omissis) | Art. 420-ter c.p.p. - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore. 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell’ordinanza all’imputato che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1. (Omissis) 3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. (Omissis) |
Gli interventi sull’art. 420-ter sono diretti a uniformare la disciplina per il caso di assenza alla prima udienza o alle successive, sull’assunto che l’impedimento viene in considerazione solo dopo che si è verificata la regolarità della notifica. In conseguenza di ciò, si è escluso che ove l’impedimento sussista in sede di prima udienza debba essere sempre disposta una nuova notificazione dell'avviso di cui all'articolo 419, comma 1, c.p.p. (già utilmente e correttamente notificato), mentre quel che deve essere certamente effettuato è dare un formale avviso all’imputato della nuova udienza, attesa la sua legittima assenza.
COSTITUZIONE DELLE PARTI (ART. 484 C.P.P.)
TESTO PREVIGENTE | TESTO RIFORMATO |
Art. 484 c.p.p. – Costituzione delle parti. 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. (Omissis) 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies. | Art. 484 c.p.p. - Costituzione delle parti. 1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti. (Omissis) 2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies dell’articolo 420-ter e, nei casi in cui manca l’udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies. |
Con la modifica normativa in questione, viene meno la disciplina finora in vigore che prevedeva la verifica dell’assenza sia in udienza preliminare che alla successiva prima udienza fissata per il giudizio.
Questa scelta muove dall’assunto che il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l’imputato e si valuta, quindi, la sua piena consapevolezza di essere sottoposto a un processo è, nei riti con udienza preliminare, proprio l’udienza preliminare. E’ rispetto a quel momento, infatti, che, in modo connesso, si pretende un livello qualitativo più elevato della notifica dell’atto introduttivo ed è in quella sede che si debbono compiere le accurate verifiche di cui si è detto circa l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato, per cui è del tutto logico che a quel momento si colleghi la posizione processuale dell’imputato, senza alcuna necessità di rinnovarne la verifica in una fase successiva che ne è la mera prosecuzione, già fisiologicamente prevista come tale dal processo e, quindi, già conosciuta anche dall’imputato.
In ragione di ciò, la verifica dell’assenza in sede di dibattimento (salva sempre la verifica dell’esistenza di impedimenti) è compiuta solo nei casi in cui manca l’udienza preliminare. Qualora, invece, l’udienza preliminare si sia svolta in sede dibattimentale troveranno applicazione solo le norme che riguardano il legittimo impedimento o l’allontanamento dell’imputato dall’udienza.
RIMEDI PER L’IMPUTATO CONTRO IL QUALE SI È PROCEDUTO IN ASSENZA NELL'UDIENZA PRELIMINARE (ART. 489 C.P.P.)
TESTO PREVIGENTE | TESTO RIFORMATO |
Art. 489 c.p.p. – Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza dell’udienza preliminare. 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. *** *** *** *** *** *** *** 2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** | Art. 489 c.p.p. - Rimedi per l’imputato contro il quale si è proceduto in assenza dell'udienza preliminare. 1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Se vi è la prova che nel corso dell’udienza preliminare l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare. 2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall’imputato presente, ferma la facoltà dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era nelle condizioni di comparire all’udienza preliminare. 2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto. |
In relazione alla fase dibattimentale, applicando il predetto sistema dei rimedi, si è previsto, per prima cosa, che se l’imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis c.p.p., il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell’udienza preliminare. Soluzione derogata nel caso in cui la nullità non sia eccepita dall’imputato presente (nel qual caso, però, al medesimo è data sempre la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto) e nel caso in cui l’imputato fosse nelle condizioni di comparire in udienza preliminare.
Accanto al rimedio per l’ipotesi in cui l’assenza fosse stata mal dichiarata, si aggiunge sempre il rimedio ulteriore per i casi in cui invece risulta che, malgrado la valutazione del giudice fosse in quel momento corretta, in realtà mancava una effettiva conoscenza della pendenza del processo oppure l’imputato non ha potuto addurre in tempo un impedimento. In questi casi, però, resta ferma la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, proprio in ragione del fatto che si è correttamente proceduto in assenza.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Quanto al momento di effettiva entrata in vigore e applicazione di questa parte della riforma, trova applicazione il generale principio del tempus regit actum, dovendosi ritenere che le norme in questione entrino in vigore dalla data del 30 dicembre 2022 (in forza dell’art. 99-bis del D.L.vo n. 150/2022, come introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 162/2022).
È stato, comunque, previsto che quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti.
Promozione dell’energia rinnovabile e tutela del patrimonio culturale: verso l’integrazione delle tutele (nota a Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167)
di Antonio Persico
Sommario: 1. Introduzione. – 2. La vicenda contenziosa. – 3. Sul bilanciamento degli interessi primari. 4. – La violazione del principio di proporzionalità. 5. Lo sviluppo sostenibile attraverso l’ integrazione delle tutele. – 6. Conclusioni.
1. Introduzione.
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8167 del 23 settembre 2022, ha sindacato gli atti con cui il Ministero della Cultura ha imposto prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del Codice dei beni culturali e del paesaggio su aree nelle quali era già stata autorizzata la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte eolica. Interessante osservare come la scelta discrezionale dell’amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale sia stata censurata, da un lato, per il mancato superamento dell’ultimo gradino del test di proporzionalità, e dall’altro, per il mancato rispetto del principio di integrazione delle tutele, funzionale al perseguimento dello sviluppo sostenibile.
2. La vicenda contenziosa.
La società ricorrente in primo grado, nonché appellante incidentale, aveva ottenuto due autorizzazioni uniche ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, per la realizzazione di pale eoliche in due distinte località. Nelle conferenze di servizi tenutesi nell’ambito dei procedimenti autorizzativi, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise aveva espresso il proprio parere negativo alla realizzazione degli impianti, adducendo la presenza di beni culturali e paesaggistici in aree limitrofe e la necessità di scongiurare interferenze visive. Una volta rilasciate le autorizzazioni, la Soprintendenza avviava due distinti procedimenti di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, i quali culminavano nella dichiarazione, da parte della Direzione ministeriale competente, dell’interesse culturale di due sistemi di croci votive e viarie, ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 3, lettera a) e 13 del d.lgs. n. 42 del 2004, con contestuale individuazione delle aree territoriali da assoggettare a tutela indiretta, ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 del medesimo decreto. Sennonché, tra le aree sottoposte a tutela indiretta ricadevano anche quelle interessate dalla realizzazione degli impianti eolici autorizzati. In particolare, i provvedimenti del Ministero, in ragione dell’ «esigenza di evitare che siano alterate le condizioni di contesto ambientale e di decoro, nonché di prospettiva e visuale, delle croci votive e viarie sottoposte a tutela, oltre che di scongiurare rischi all’integrità di ciascuno dei manufatti», imponevano prescrizioni particolarmente stringenti, che proibivano «la trasformazione, sia a carattere permanente che temporaneo, dell’aspetto esteriore dei luoghi ricompresi nell’ambito del vincolo indiretto», nello specifico vietando «l’apertura di cave, la posa in opera di condotte per impianti industriali e civili, la realizzazione di palificazioni».
In prime cure, il TAR adito annullava i provvedimenti ministeriali, ritenendoli viziati per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto fondati su una superficiale ricostruzione dell’interesse storico-culturale oggetto di tutela, in mancanza di un «preciso richiamo a contributi specialistici e studi capaci di dare obbiettiva e verificabile sostanza alle valutazioni proprie dell’Amministrazione»[1]. Di contro, in accoglimento dell’appello principale proposto dal Ministero, il Consiglio di Stato nella pronuncia in commento ritiene immuni da censure le valutazioni tecnico-discrezionali dell’amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale, la quale, in presenza di un apparato bibliografico ridotto, ha correttamente proceduto in modo diretto allo studio dei beni in questione. Sorge così l’interesse all’esame dell’appello incidentale, che si appunta, tra l’altro, sulle menzionate prescrizioni di tutela indiretta, censurandone l’abnorme sproporzione, indice di sviamento della funzione.
3. Sul bilanciamento degli interessi primari.
È innanzitutto meritevole di segnalazione la chiosa introduttiva al ragionamento condotto dalla Sesta Sezione circa l’illegittimità delle prescrizioni di tutela indiretta. Si tratta di una sorta di premessa logico-giuridica allo scrutinio di proporzionalità e all’applicazione del principio di integrazione, che chiarifica, alla luce dell’interpretazione costituzionale, tanto la valenza assiologica degli interessi in campo, quanto il rapporto tra i medesimi[2]. Orbene, il Consiglio di Stato prende atto che sia la tutela del patrimonio culturale sia quella dell’ambiente, in potenziale conflitto nelle fattispecie attenzionate, costituiscono valori primari dell’ordinamento. Tale qualificazione risulta coerente con la giurisprudenza costituzionale che da tempo ha affermato il carattere primario del valore estetico-culturale protetto dall’art. 9 Cost.[3], nonché la valenza primaria e assoluta del bene ambiente, ricavato dalla lettura sistematica degli articoli 9 e 32[4] ben prima della sua positivizzazione ad opera della riforma costituzionale del 2022[5].
Il punto cruciale, evidentemente, riguarda il confronto dei valori primari con altri diritti o interessi costituzionalmente protetti, nonché con gli altri valori primari protetti dalla Costituzione. Al riguardo, la pronuncia in commento riprende le asserzioni della nota sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013 sul caso ILVA, la quale a sua volta ha dato continuità a un orientamento giurisprudenziale risalente, quantomeno, alla sentenza n. 196/2004, in tema di condono edilizio.
Com’è noto, in una datata pronuncia, la Corte costituzionale aveva fatto discendere dal carattere di primarietà riconosciuta a determinati valori, l’insuscettibilità di subordinazione a ogni altro valore costituzionalmente tutelato[6]. Secondo una certa interpretazione di tale affermazione, la primarietà riconosciuta a un determinato valore costituzionalmente protetto implicherebbe un posizionamento gerarchico prioritario del medesimo, con necessaria e indefettibile prevalenza dello stesso su ogni altro valore sottordinato. In questo senso, l’insuscettibilità di subordinazione consisterebbe nella sottrazione ai bilanciamenti con interessi contrapposti cui è generalmente chiamato il legislatore ordinario. Un altro argomento a favore di una simile ricostruzione potrebbe peraltro provenire dall’impiego del termine “assoluto”, riferito anche di recente dalla giurisprudenza costituzionale a valori preminenti dell’ordinamento come quelli paesaggistici e ambientali[7]. L’etimologia latina dell’aggettivo (ab-solutus, sciolto da vincoli/legami) potrebbe condurre a ritenere che i valori in questione siano sottratti da ogni forma di confronto con gli altri interessi protetti dall’ordinamento, dovendo necessariamente e per l’intero prevalere su questi ultimi.
Tuttavia, la lettura gerarchica del rapporto tra valori costituzionalmente protetti è apparsa sin da subito troppo rigida, in quanto imporrebbe l’aprioristico e radicale sacrificio di altre esigenze costituzionalmente tutelate, in spregio al disegno pluralista tracciato dalla Costituzione repubblicana[8].
Inoltre, detta visione condurrebbe a una fatale impasse allorché a fronteggiarsi siano degli interessi primari, come appunto nella vicenda scrutinata dal Consiglio di Stato nella sentenza in commento, dove da un lato si stagliava l’interesse alla protezione del patrimonio culturale, dall’altro un blocco di interessi saldati tra loro e comprensivo dell’interesse alla salvaguardia dell’ambiente e alla promozione delle energie rinnovabili[9], oltre alle ragioni legate allo svolgimento di attività imprenditoriali (peraltro già autorizzate).
Invero, già nella sentenza n. 53 del 1991 la Corte ha riconosciuto piena cittadinanza a un «principio di gradualità nell'attuazione della tutela ambientale in ragione del complesso bilanciamento dei numerosi e contrastanti interessi in gioco», necessario a salvaguardare la continuità delle attività produttive dall’incremento degli oneri economici che deriverebbero dall’obbligo di utilizzare tecnologie non ancora disponibili sul mercato per minimizzare le emissioni inquinanti industriali. È tuttavia nella sentenza n. 196 del 2004 che i giudici della Consulta hanno chiarito espressamente le implicazioni dell’insuscettibilità dei valori primari di essere subordinati ad altri valori: la Corte costituzionale nel 2004 ha negato che l’affermazione della primarietà di un interesse implichi «un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali»; la conseguenza di un simile riferimento assiologico è piuttosto la necessità che gli interessi primari che assurgono a valori costituzionali siano «sempre […] presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni».
La sentenza n. 85/2013, richiamata dal Consiglio di Stato nella pronuncia in commento, ha a sua volta chiarito, in linea di continuità con la sentenza n. 196 del 2004, che la qualificazione come “primari” di taluni valori «significa che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto». Inoltre, nel 2013, i giudici costituzionali hanno avuto modo di affermare in riferimento ai bilanciamenti involgenti suddetti valori, che spetta al legislatore trovare «il punto di equilibrio […] secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale». Celebre è infine il passaggio che afferma che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, abbisognando di una tutela sistemica, pena «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette».
Ora, è da notare che diversamente dalla sentenza del 2004, la sentenza del 2013 si riferisce, nell’ultimo passaggio cennato, ai “diritti fondamentali” e dunque a posizioni giuridiche aventi carattere di diritto soggettivo, mentre per quanto concerne i valori primari, essa allude ai soli bilanciamenti cui è chiamato il legislatore ordinario, esigendo in ogni caso la salvaguardia del nucleo essenziale di ridetti valori. Quanto al primo aspetto segnalato, occorre tenere presente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 2018, ha trasposto il ragionamento condotto dalla sentenza n. 85/2013 con riguardo ai diritti fondamentali al bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, ritenendo che possa definirsi ragionevole ed equilibrato suddetto bilanciamento allorché risponda «a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati».
Tornando alla pronuncia in commento, il Consiglio di Stato fa propri gli approdi della giurisprudenza costituzionale e li applica alle valutazioni discrezionali compiute dall’amministrazione. In tal senso afferma che « Così come per i ‘diritti’ (sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013), anche per gli ‘interessi’ di rango costituzionale […] va ribadito che a nessuno di essi la Carta garantisce una prevalenza assoluta sugli altri». Data la necessaria integrazione reciproca di tutti gli interessi costituzionali, la pronuncia predica la necessità di una loro tutela sistemica, fermo restando che il carattere assiologico primario della tutela del patrimonio culturale e dell’ambiente implica che simili valori non siano interamente sacrificabili al cospetto di altri interessi e che i medesimi debbano necessariamente essere presi in considerazione nei complessi processi decisionali pubblici. Il Consiglio di Stato a sua volta aggiunge qualcosa rispetto alla sentenza n.85/2013, estendendo il ragionamento in quella sede condotto anche al bilanciamento tra interessi contrapposti cui è chiamata l’amministrazione. In tal senso si arricchisce la citazione alla sentenza n. 85/2013 con un inedito riferimento alle valutazioni che l’amministrazione deve compiere in sede procedimentale: «Il punto di equilibrio, necessariamente mobile e dinamico, deve essere ricercato – dal legislatore nella statuizione delle norme, dall’Amministrazione in sede procedimentale, e dal giudice in sede di controllo – secondo principi di proporzionalità e di ragionevolezza». L’esigenza di trovare ragionevoli e proporzionati punti di equilibrio tra interessi costituzionali confliggenti si avverte peraltro «vieppiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi».
Su una simile aggiunta, tuttavia, può risultare utile una puntualizzazione. Il Consiglio di Stato, pur senza esplicitarlo, sembra riferirsi all’esercizio della discrezionalità amministrativa, qual è quella che impiega l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali e paesaggistici nel dettare le prescrizioni di tutela indiretta[10]. Più controverso è stabilire se la logica della necessaria considerazione e della salvaguardia del nucleo essenziale dei valori non assegnati alla cura principale dell’amministrazione vada seguita anche in caso di discrezionalità tecnica. Sul punto viene in rilievo l’orientamento giurisprudenziale che, evidenziando come nelle valutazioni tecnico-discrezionali non sia richiesto all’amministrazione un bilanciamento tra interessi contrapposti, ammette in esito all’esercizio della discrezionalità tecnica il sacrificio integrale degli interessi non direttamente curati dall’amministrazione, quand’anche essi fossero di rilievo assiologico primario[11]. Tuttavia, in senso contrario, la sentenza del TAR Molise, Sez. I, 27 ottobre 2022, n. 392[12], richiamando testualmente la pronuncia del Consiglio di Stato in commento, ha predicato per la Soprintendenza, in sede di rilascio del parere ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, la necessità di effettuare, nel rispetto del principio dell’integrazione delle tutele (su cui si veda infra, par. 5), una valutazione tanto «del conflitto fra gli interessi contrapposti, di rilevanza costituzionale ed equiordinata, e da coordinare in base al metodo dell’integrazione», quanto «della possibilità di comporlo con accorgimenti idonei a realizzare il loro equo contemperamento sulla base dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza».
4. La violazione del principio di proporzionalità.
A questo punto, il Consiglio di Stato è pronto a effettuare lo scrutinio di proporzionalità sul bilanciamento di interessi condotto dall’amministrazione ministeriale. Appare netta, agli occhi della sezione, l’individuazione e differenziazione dei tre step di cui si compone il test di proporzionalità (idoneità, necessarietà, proporzionalità in senso stretto). Lo scrutinio infatti, segue il modello trifasico, proprio dell’elaborazione giurisprudenziale tedesca[13], così discostandosi la sentenza tanto dal filone di giurisprudenza amministrativa nazionale che limita lo scrutinio di proporzionalità a un sindacato di idoneità e necessarietà, quanto dal filone che tende a sovrapporre lo scrutinio di proporzionalità con quello di ragionevolezza[14].
Nel caso di specie, a risultare violato è «L’ultimo gradino del test di proporzionalità», il quale «implica che una misura adottata dai pubblici poteri non debba mai essere tale da gravare in maniera eccessiva sul titolare dell’interesse contrapposto, così da risultargli un peso intollerabile». La proporzionalità in senso stretto non risulta rispettata in quanto, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dalla Soprintendenza – la tutela culturale delle croci votive, ovvero di beni visibili soltanto a pochi metri di distanza, e rispetto alla cui visione non può in alcun modo interferire l’eventuale realizzazione di altri manufatti lontani di centinaia di metri – il mezzo utilizzato appare eccessivo, determinando «il radicale svuotamento delle possibilità d’uso alternativo del territorio».
È, quella compiuta dalla Sesta Sezione, una scelta “coraggiosa” poiché, come segnala la dottrina, il sindacato sul terzo gradino della proporzionalità avvicina il sindacato di legalità a un controllo sostanzialmente di merito sull’azione amministrativa[15]. E tuttavia, pur sempre di un controllo di diritto si tratta, visto il carattere giuridico del principio di proporzionalità. La Sezione ritiene di procedere in questa direzione probabilmente per l’avvertita indifferibilità e urgenza della transizione ecologica: essa in tal senso richiama l’indirizzo politico europeo e quello nazionale, che si connotano per il sicuro favor verso la diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Peraltro, a discapito dell’affermazione per cui il nucleo essenziale di un interesse primario debba essere sempre preservato, la sentenza in commento sembra confermare la possibilità per l’amministrazione di sacrificare del tutto un interesse anche primario sul versante assiologico. Nel ritenere la violazione del principio di proporzionalità, la Sesta Sezione precisa che «L’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha, nel caso concreto, il peso e l’urgenza per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone». Si tratta quindi, a giudizio del Consiglio di Stato, di un’evenienza del caso concreto, quella per cui non si debba avere il sacrificio integrale dell’interesse ambientale. Nulla esclude, anzi a contrario risulta confermato, che in diversa fattispecie l’interesse ambientale possa essere del tutto recessivo. Si ricorda a tal proposito che la sentenza n. 196/2004 della Corte costituzione, riferendosi (anche) alle decisioni cui sono chiamate le amministrazioni, si limitava a richiedere la necessaria considerazione degli interessi primari in sede di bilanciamento.
5. Lo sviluppo sostenibile attraverso l’integrazione delle tutele.
La pronuncia, come accennato, si segnala anche per il ricorso al principio dell’integrazione delle tutele. Si tratta di un principio recentemente invocato dalla dottrina a garanzia della migliore soddisfazione delle istanze di protezione ambientale[16], il quale però non ha sino a questo momento trovato emersione nelle decisioni del giudice amministrativo[17].
Tale principio è cristallizzato nell’art. 11 TFUE, il quale si riferisce alle politiche e azioni dell’Unione: nella definizione e attuazione di esse, è necessario integrare considerazioni connesse alle esigenze di tutela ambientale, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Mutatis, mutandis, il Consiglio di Stato ritiene che il principio vada rispettato anche dalle amministrazioni nazionali, nello specifico nell’adozione delle decisioni volte a tutelare il patrimonio culturale.
Il principio dell’integrazione delle tutele può essere visto come declinazione operativa del principio di sviluppo sostenibile, altrove invocato dalla giurisprudenza senza chiarirne il contenuto e le implicazioni giuridiche[18]. Sviluppo sostenibile del quale la dottrina ha evidenziato l’indeterminatezza o vaghezza contenutistica, la debolezza logica e assiologica[19], ovvero il carattere non radicalmente innovativo rispetto agli altri principi ordinamentali[20]: in definitiva, l’inidoneità a fungere da parametro autonomo di legittimità dell’azione amministrativa.
Peraltro, la trasposizione interna del principio di sviluppo sostenibile, a opera dell’art. 3-quater del d.lgs. n. 152 del 2006, risulta alquanto problematica: a partire dai profili stilistici (mal si addice a un enunciato normativo la formula giustificativa con cui inizia il comma 3) passando a quelli contenutistici (il medesimo comma 3 richiede di individuare un equilibrato rapporto tra risorse da risparmiare e quelle da trasmettere, sennonché, le risorse risparmiate sono le stesse che verranno trasmesse alle generazioni future). Con specifico riguardo all’esercizio della discrezionalità amministrativa, il comma 2 dell’articolo 3-quater, prescrive: «nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione»: una simile formulazione sembra riproporre il tema del bilanciamento tra interessi primari, senza tuttavia nulla aggiungere alle già ricordate implicazioni del carattere primario riconosciuto agli interessi in questione, anzi preannunciando una situazione di impasse allorché siano proprio gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale a fronteggiarsi. A sua volta il comma 1 prescrive che ogni attività umana debba conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, mentre il comma 4 precisa che la risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali debba essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane. Orbene, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, pur prendendo atto della “formulazione ellittica” dell’art. 3-quater, riconosce in detto articolo il recepimento sostanziale del principio d’integrazione delle tutele, nella specie violato dall’amministrazione preposta alla cura del patrimonio culturale.
Orbene, il principio di integrazione consente il perseguimento dello sviluppo sostenibile e ne costituisce declinazione operativa nella misura in cui fornisce una «direttiva di metodo», volta a orientare la discrezionalità della pubblica amministrazione, la quale deve abbandonare una visione totalizzante dell’interesse primario affidato alla sua cura ed evitare di assumere posizioni meramente oppositive. Ciò a maggior ragione quando altra amministrazione abbia autorizzato sulla medesima area una determinata utilizzazione del territorio, come nel caso di specie. Il tutto nella già ricordata prospettiva del bilanciamento degli interessi, alla ricerca di punti di equilibrio rispondenti a ragionevolezza e proporzionalità. Ne consegue che «La piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull’uso del territorio, richiede di abbandonare il modello delle «tutele parallele» degli interessi differenziati, che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali». Risulta quindi valorizzata la funzione del procedimento, quale sedes materiae nella quale «devono contestualmente e dialetticamente avvenire le operazioni di comparazione, bilanciamento e gestione dei diversi interessi configgenti».
6. Conclusioni.
In conclusione, la pronuncia in commento ritiene illegittime le prescrizioni di tutela indiretta, in quanto apposte dall’Amministrazione dei beni culturali secondo un metodo incongruo rispetto all’esigenza di contemperamento degli interessi in gioco e teso surrettiziamente a “disapplicare” gli esiti della conferenza di servizi cui aveva preso parte la Soprintendenza, a danno dei soggetti che avevano già conseguito le autorizzazioni uniche da parte della Regione per la realizzazione degli impianti eolici. Ne deriva per l’amministrazione, in sede di riedizione del potere, la necessità di «ricercare non già il totale sacrificio dell’uso produttivo di energia pulita […], secondo una logica meramente inibitoria, bensì una soluzione comparativa e dialettica fra le esigenze dello sviluppo sostenibile e quelle afferenti al paesaggio culturale».
Resta aperto il tema accennato in coda al par. 3, relativo alla portata del principio dell’integrazione delle tutele/sviluppo sostenibile. La giurisprudenza chiarirà se esso funga da parametro di legittimità delle sole decisioni discrezionali pure dell’amministrazione ovvero se, in maniera innovativa e dirompente, esso si applichi anche alle scelte tecnico-discrezionali (nelle quali tradizionalmente si ritiene non vi siano propriamente interessi da bilanciare in concreto), come sembra invece affermare il TAR Molise.
[1] TAR Molise, Sez. I, 10 agosto 2021, n. 300.
[2] Com’è noto, il tema del confronto dell’interesse alla promozione delle rinnovabili con altri interessi costituzionalmente protetti, tra cui quello alla tutela del patrimonio culturale, è di grande attualità. In dottrina, di recente, si veda A. DI CAGNO, La produzione di energia da fonte rinnovabile: tra interesse energetico, ambientale e paesaggistico, in Riv. Giur. Amb. Dir., n. 4/2022; G. SEVERINI, P. CARPENTIERI, Sull’inutile, anzi dannosa modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in Giustiziainsieme.it, 22 settembre 2021; G. MONTEDORO, Il ruolo di Governo e Parlamento nell’elaborazione e nell’attuazione del PNRR, in www.giustiziaamministrativa.it, 2021.
[3] Cfr., ex multis, Corte cost. sentenza n. 151/1986. Cfr. anche Corte cost. sentenza n. 269/1995, dove, in relazione all’istituto della prelazione storico-artistica si afferma che trattasi «di un regime che trova nell'art. 9 della Costituzione il suo fondamento e che si giustifica nella sua specificità in relazione al fine di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita culturale del paese. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali si veda P. CARPENTIERI, Paesaggio, ambiente e transizione ecologica, in Giustiziainsieme.it, 4 maggio 2021, in particolare nota 71.
[4] Per una ricognizione in open access della giurisprudenza che ha enucleato dal testo costituzionale il valore ambiente, si vedano S. GRASSI, Ambiente e Costituzione, in Riv. quad. dir. amb., n. 3/2017; P. CARPINETO, La Tutela dell’Ambiente nella Costituzione Italiana, in Anales de la Facultad de Derecho, vol. 33, 2016; M. CECCHETTI, La disciplina giuridica della tutela ambientale come “diritto dell’ambiente”, in Federalismi.it, n. 25/2006.
[5] Sulla quale si veda L. CASSETTI, Riformare l’art. 41 Cost.: alla ricerca di “nuovi” equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?, in Federalismi.it, n. 4/2022; F. DE LEONARDIS, La riforma “bilancio” dell’art. 9 Cost. e la riforma “programma” dell’art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura, in Aperta Contrada, 28 febbraio 2022; G. MARCATAJO, La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell’ambiente, in Riv. Giur. Amb. Dir., n. 2/2022; M. CECCHETTI, La revisione degli articoli 9 e 41 Cost. e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in Forumcostituzionale.it, n. 3/2021, G. SEVERINI, P. CARPENTIERI, Sull’inutile, anzi dannosa modifica dell’articolo 9 della Costituzione, cit.
[6] Il riferimento è ancora a Corte cost. sentenza n. 151/1986.
[7] Si veda ad esempio Corte cost., sentenza n. 246/2017.
[8] Sul necessario e continuo confronto tra i plurimi valori tutelati dalla Costituzione si veda G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992
[9] La Corte costituzionale ha infatti ricavato dal sistema l’esistenza del principio, qualificato come fondamentale, di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 46/2021, 86/2019, 177/2018, 13/2014.
[10] Al riguardo, la giurisprudenza ha di recente ribadito che l’apprezzamento relativo al grado di protezione da assicurare nelle aree di tutela indiretta in concreto è affidato al nucleo della discrezionalità amministrativa, e che, una volta accertati i fatti storici, che confermano l’esistenza di territori paesaggisticamente rilevanti per plurimi profili, la scelta delle misure idonee a prevenire alterazioni o interferenze del quadro di insieme tutelato spetta, invero, indeclinabilmente all’Autorità a ciò deputata per legge, e le relative valutazioni non sono sindacabili dal giudice se non manifestamente irragionevoli o sproporzionate rispetto alle esigenze di tutela del bene (TAR Molise, I, 20 luglio 2022, n. 264).
[11] Sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2015 n. 3652: «la discrezionalità tecnica, a differenza di quella amministrativa, si concentra su un unico interesse, nel caso quello paesaggistico, attraverso la verifica in fatto della sua configurazione e trasformazione nel caso concreto. Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non può dar luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione eterogenea. Nell’esercizio della funzione di tutela spettante al MIBAC, l’interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal MIBAC stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni».
[12] Nella pronuncia si legge che «il Collegio reputa condivisibile e pienamente applicabile alla fattispecie in esame l’orientamento del Consiglio di Stato, VI Sezione, espresso dalla sentenza n. 8167/2022».
[13] D.U. GALETTA, Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell’Unione Europea), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 6/2019; ID., Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1998.
[14] Cfr. D.U. GALETTA, I principi di proporzionalità e ragionevolezza, in M.A. SANDULLI (a cura di), Princìpi e regole dell’azione amministrativa, Giuffré Francis Lefebvre, Milano, III edizione, 2020.
[15] M. D’ALBERTI, Lezioni di diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, VI edizione, 2021.
[16] M. CECCHETTI, La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2021.
[17] Cfr. invece TAR Molise, Sez. I, 27 ottobre 2022, n. 392, che richiama la pronuncia in commento.
[18] Cfr. ad esempio TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 1 settembre 2022, n. 1376.
[19] Cfr. S. PEDRABISSI, Sviluppo sostenibile: l’evoluzione giuridica di un concetto mai definito, in Revista Ibérica do Direito, n.1/2020; E. SCOTTI, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, in Il diritto dell’economia, n. 1/2019; G. MONTEDORO, Spunti per la «decostruzione» della nozione di sviluppo sostenibile e per una critica del diritto ambientale, in Amministrazione in cammino, 30 aprile 2009.
[20] Cfr. F. FRACCHIA, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in Riv. quad. dir. amb., n. 0/2010.
Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca Ramacci*
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l’ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell’art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un’applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall’art. 45 del d.P.R. 380\01.
Sommario: 1. Premessa. - 2. Presupposti della sanatoria. - 3. La “doppia conformità” in genere. - 4. La sanatoria “condizionata”. - 5. La sanatoria “parziale”. - 6. La sanatoria “giurisprudenziale”. - 7. Sanatoria degli abusi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. - 8. Sanatoria degli interventi in zona sismica. - 9. Effetti penali della sanatoria
1. Premessa
È noto che l’atteggiamento degli enti territoriali riguardo all’abusivismo edilizio, fenomeno tipicamente italiano che non ha eguali in ambito europeo, offre un contributo determinante alla costante devastazione del territorio nazionale.
L’inerzia e, talvolta, la plateale collusione, unite a disinvolte interpretazioni di una normativa di per sé perfettibile, oltre allo sporadico uso degli strumenti che la legge mette a disposizione per contrastare gli interventi edilizi illegali, incide pesantemente sullo sviluppo urbanistico del territorio, in larga parte a rischio sismico ed idrogeologico, con conseguenze talvolta molto gravi anche per l’incolumità delle persone[1].
Non si tratta affatto di una novità, perché in termini sostanzialmente simili si esprimeva, quasi trent’anni fa, la Corte costituzionale, quando venne posta in dubbio la legittimità costituzionale della legge 724\1994 che aveva riaperto i termini del condono edilizio del 1985[2].
Affermava infatti in quella occasione il giudice delle leggi che “l'entità del fenomeno di applicazione ed utilizzazione della norma impugnata nelle varie regioni (con un introito effettivo di quasi tremila miliardi limitato alla prima fase dei pagamenti), induce a ritenere la diffusione tutt'altro che isolata del fenomeno dell'abusivismo edilizio e della persistenza delle relative costruzioni, compiute nel periodo successivo al 31 ottobre 1983 (termine di riferimento dell'art. 31, della legge n. 47 del 1985), fino alla nuova data di riferimento, 31 dicembre 1993. Ciò è avvenuto non solo per il difetto di una attività di polizia locale specializzata sul controllo del territorio, ma anche in conseguenza della scarsa (o quasi nulla in talune regioni) incisività e tempestività dell'azione di controllo e di repressione degli enti locali e delle regioni, che non è valsa ad impedire tempestivamente la suddetta attività abusiva o almeno a impedire il completamento e a rimuovere i relativi manufatti”. Va peraltro rilevato come la Corte costituzionale, evidentemente consapevole del rischio di un successivo condono, osservava che “la gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità, tanto più che l’abusivismo edilizio comporta effetti permanenti (qualora non segua la demolizione o la rimessa i pristino), di modo che il semplice pagamento di oblazione non restaura mai l’ordine giuridico violato, qualora non comporti la perdita del bene abusivo o del suo equivalente almeno approssimativo sul piano patrimoniale”.
La risposta a tale monito, come sappiamo, è stato il condono del 2003 e la situazione, immutata, è sotto gli occhi di tutti.
In questo desolante contesto, tuttavia, la disciplina di settore offre, nonostante i reiterati interventi modificativi, non soltanto alcuni strumenti di repressione, ma anche specifiche disposizioni per il recupero di alcuni abusi edilizi, sebbene i primi vengano pressoché ignorati o scarsamente utilizzati e le seconde interpretate con disinvoltura, ampliandone oltremodo l’ambito di operatività, come avviene nel caso della sanatoria per doppia conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. 380/2001[3].
È appena il caso di precisare che tale istituto è del tutto differente dal “condono edilizio” di cui si è detto, in quanto quest’ultimo ha un’efficacia limitata nel tempo, essendo finalizzato alla regolarizzazione di determinati abusi edilizi realizzati entro una certa data individuata dal legislatore ed il suo effetto estintivo - che riguarda anche interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici e produce effetti anche verso reati conseguenti alla violazione delle norme antisismiche e sulle costruzioni in cemento armato - consegue al pagamento di un'oblazione, formalizzato attraverso l'attestazione, da parte dell'autorità comunale, della sua congruità, mentre la sanatoria di cui agli articoli 36 e 45 d.P.R. n. 380/01 è destinata, in via generale, al recupero degli abusi meramente formali previo accertamento della conformità degli stessi agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, nonché alla verifica della sussistenza di altri requisiti di legge specificamente individuati[4].
Risulta dunque evidente che l’ambito di applicazione della sanatoria per doppia conformità è estremamente limitato rispetto al condono e, come si dirà in seguito, esso è stato ulteriormente ridotto dalla giurisprudenza.
Si cercherà di chiarire, nei paragrafi che seguono, come l’art. 36 del TU subisca, nella prassi, interpretazioni distorte le quali, anche attraverso la creazione di tipologie di sanatoria mai considerate dal legislatore (sanatoria condizionata, parziale, giurisprudenziale) oppure non considerando i limiti conseguenti alle caratteristiche dell’area ove insiste l’abuso (come nel caso delle aree soggette a vincolo paesaggistico o le zone sismiche) sono finalizzate a far rientrare tra gli abusi recuperabili interventi edilizi palesemente non sanabili, evitando così la inevitabile demolizione e beneficiando indebitamente degli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche che il rilascio della sanatoria produce ai sensi dell’art. 45, comma 2 del T.U.
2. Presupposti della sanatoria
Proprio nel considerare le differenze tra sanatoria “ordinaria” e condono la giurisprudenza di legittimità ha descritto la prima, poco dopo l’entrata in vigore della legge 47/1985 che l’aveva introdotta, come un istituto di carattere generale (o di regime) qualificato da una fondamentale verifica di conformità, non disciplinato da disposizioni transitorie e caratterizzato da peculiari sbarramenti amministrativi e temporali in un contesto di rigoroso controllo della sostanziale inesistenza di un danno urbanistico[5].
Come si è detto, si tratta di una sanatoria che riguarda esclusivamente gli abusi c.d. formali e, cioè, quelli relativi ad interventi edilizi che sono stati realizzati senza titolo abilitativo pur presentando tutti i requisiti per ottenerlo, segnatamente quelli eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità dal permesso medesimo ovvero quelli eseguiti in assenza di SCIA alternativa al permesso di cui all’ articolo 23, comma 1 TU Ed. o in difformità da essa[6].
È stabilito anche un limite temporale per la richiesta del titolo sanante, coincidente con la scadenza del termine di cui all’art. 31, comma 3 per la demolizione imposta con l’ingiunzione di cui al precedente comma 2; con la scadenza del termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza per la demolizione o rimozione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità (art. 33, comma 1) e, infine, con la scadenza del termine fissato con le stesse modalità per la demolizione o rimozione degli interventi e delle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire (art. 34, comma primo) e, in ogni caso, fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative la quale preclude, quindi, ogni ulteriore possibilità di richiesta indipendentemente dalla scadenza dei termini suddetti.
Legittimati a richiedere la sanatoria sono il responsabile dell’abuso, l’attuale proprietario dell’immobile, cui è richiesto il pagamento di una somma a titolo di oblazione, da calcolarsi con le modalità descritte nel comma 2 dell’art. 36 ed al quale il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato.
Limiti temporali sono imposti anche per la definizione della pratica, prevedendo l’ultimo comma dell’art. 36 che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncino, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni dalla richiesta di sanatoria, decorsi i quali la stessa si intende rifiutata[7].
Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, il decorso di detto termine non esaurisce il potere della pubblica amministrazione di rilasciare comunque la sanatoria, riconoscendo quindi la possibilità di un rilascio tardivo quale espressione di un autonomo potere di autodeterminazione, non escluso da alcuna previsione normativa, sempreché, ovviamente, sussistano tutti i presupposti di legge per il rilascio[8].
La questione si è posta in relazione alle disposizioni relative all’azione penale di cui all’art. 45 del TU (di cui si dirà in seguito), il quale stabilisce, al comma 1, che l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimanga sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria, sicché la Cassazione ha ritenuto che l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda che determina il formarsi del silenzio - rifiuto determina, quale ulteriore conseguenza, la cessazione dell'obbligo del giudice penale di disporre la sospensione del procedimento,[9] precisando, altresì, che permane anche dopo l’entrata in vigore dell'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 la quale, nei procedimenti ad istanza di parte, impone la comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, peraltro, la presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina, pertanto, alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell'ingiunzione di demolizione, comportando unicamente che l'esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente sospesa[10].
Il requisito più importante che gli interventi da sanare devono possedere è, però, quello della “doppia conformità”, essendo infatti richiesto che essi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente tanto al momento della loro realizzazione, quanto al momento della presentazione della domanda.
3. La “doppia conformità” in genere
L’ultima parte del comma 1 dell’art. 36 del TU Ed. delinea in maniera del tutto lineare le caratteristiche della doppia conformità e ciò non dovrebbe, in teoria, creare alcun problema interpretativo se la norma fosse letta tenendo conto della finalità dell’istituto della sanatoria che, come si è detto, è quella di recuperare gli interventi edilizi che ben avrebbero potuto essere realizzati previo rilascio di un titolo abilitativo mediante una valutazione postuma dell’autorità competente. È dunque evidente che ciò non può avvenire se non quando l’intervento edilizio abbia avuto al momento della sua realizzazione e conservi all’atto del rilascio del titolo sanante quelle caratteristiche di compatibilità con la disciplina di settore che ne rendono lecita la presenza sul territorio.
Ciò nonostante, la concreta applicazione della richiamata disposizione ha creato non pochi problemi.
Una prima questione si è posta nel confrontare il disposto dell’art. 36 TU Ed. con la previgente disciplina (art. 13 l. 47/1985), che faceva riferimento alla conformità “agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati” ed alla assenza di contrasto “con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda”, circostanza che avrebbe potuto indurre a ritenere non più rilevante un eventuale contrasto con uno strumento urbanistico ancora in itinere, pervenendo tuttavia alla condivisibile conclusione che l’adozione di un nuovo strumento determina comunque l’applicazione delle norme di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3 cui conseguirebbe un sostanziale contrasto con la disciplina urbanistica vigente che impedirebbe all’amministrazione competente l’accoglimento della richiesta[11]. Nella medesima occasione si è anche interpretato l’ampio e generico richiamo alla “disciplina urbanistica ed edilizia vigente” nel senso che in essa rientrano, ad esempio, i regolamenti edilizi, il programma pluriennale in corso di attuazione al momento del rilascio, le prescrizioni fissate dall’art. 9 del TU per l’attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.
Sempre con riferimento alla doppia conformità ci si è interrogati anche sull’incidenza o meno, ai fini della sussistenza del requisito, di modifiche della disciplina di settore o dello strumento urbanistico sopravvenute soltanto dopo la presentazione della domanda di sanatoria, considerando che tale evenienza non impedirebbe il rilascio del titolo abilitativo in considerazione del tenore letterale dell’art. 36, che si riferisce al momento della “presentazione della domanda”.[12]
Altro aspetto considerato è quello relativo alle caratteristiche dell’opera ed al possesso di determinati requisiti soggettivi in capo a colui che richiede la sanatoria, rilevando, sulla base di considerazioni cui si era pervenuti in altre pronunce, che per l’edificazione in zona agricola la destinazione del manufatto e la posizione soggettiva di chi lo realizza sono elementi che assumono entrambi rilievo ai fini della rispondenza dell’opera alle prescrizioni dello strumento urbanistico e, di conseguenza, anche per l’eventuale valutazione di conformità ai fini del rilascio della sanatoria[13].
Un ulteriore aspetto che è stato preso in considerazione è quello relativo alle ipotesi di lottizzazione abusiva, osservando che in una tale situazione deve escludersi la possibilità di sanatoria urbanistica delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo conseguente ad accertamento di conformità, dal momento che dette opere sono senz’altro non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, sicché le stesse non sono sanabili, così come, del resto, la stessa lottizzazione abusiva[14].
Sulla legittimità della sanatoria per i soli abusi formali si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, osservando come la sanabilità di un intervento presupponga necessariamente che non sia stata commessa alcuna violazione di tipo sostanziale, in presenza della quale, invece, non può non scattare la potestà sanzionatorio - repressiva degli abusi edilizi prevista dagli artt. 27 e ss. del TU Ed., rilevando anche che “proprio la doverosità dell'esercizio di siffatta potestà, costantemente affermata dalla giurisprudenza, rafforza quanto appena detto circa la sanabilità, attraverso gli artt. 13 e 36, delle sole violazioni formali. Non può ammettersi, infatti, a pena di introdurre una contraddizione all'interno dello stesso corpus legislativo, che il legislatore da un lato imponga all'Amministrazione di reprimere e sanzionare gli abusi edilizi, dall'altro acconsenta a violazioni sostanziali della normativa del settore, quali rimangono - sul piano urbanistico - quelle conseguenti ad opere per cui non esista la cd. doppia conformità, dovendosi aver riguardo al momento della realizzazione dell'opera per valutare la sussistenza dell'abuso”[15].
4. La sanatoria “condizionata”
Considerando la nozione di “doppia conformità” di cui si è appena detto, dovrebbe essere evidente che ciò che determina la possibilità di sanatoria dell’abuso formale è, appunto, la rispondenza dell’intervento da recuperare alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione ed in quello, successivo, della sanatoria, sicché dovrebbe essere altrettanto evidente che non è possibile subordinare gli effetti del permesso di costruire postumo all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che invece non hanno.
Molto frequentemente, tuttavia, gli uffici tecnici comunali ricorrono all’illecito sistema della c.d. sanatoria condizionata per conservare abusi edilizi altrimenti non recuperabili ed assicurare a chi li ha realizzati tutti i vantaggi, anche sotto il profilo penale, che la legge assicura in caso di legittima sanatoria.
I casi più frequenti sono quelli in cui il titolo abilitativo sanante viene rilasciato subordinandone l’efficacia ad interventi da eseguire, ad esempio, per ridurne il volume renderlo conforme a quello assentibile[16] o per attribuire all’immobile caratteristiche specifiche la cui assenza impedirebbe la sanatoria[17].
Tale discutibile pratica è stata più volte censurata dalla giurisprudenza di legittimità[18], la quale ha rilevato come l’art. 36 del d.P.R. 380\01 si riferisca esplicitamente ad interventi già ultimati e stabilisca che la doppia conformità deve sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria, osservando anche che il rilascio del provvedimento consegue ad un'attività vincolata della pubblica amministrazione, consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale.
Si è ulteriormente specificato, in maniera inequivocabile, che la subordinazione della sanatoria a condizione è ontologicamente contrastante con gli elementi essenziali dell’istituto, perché le opere eseguite non possono, all'evidenza, essere conformi allo strumento urbanistico posto che se ne impone la regolarizzazione[19].
Ciò nonostante, la casistica che si rinviene nell’esaminare, anche sommariamente, la giurisprudenza in tema è fortemente indicativa della diffusione di tale pratica sotto diverse forme, come la subordinazione della sanatoria alla modifica della destinazione d'uso previa demolizione e la riduzione del numero dei piani di un edificio[20]; il rivestimento in pietra a secco di una parte fuori terra e la piantumazione di arbusti misti a macchia mediterranea a fini di “mitigazione paesaggistica” con rilevanti interventi di adeguamento ambientale e idraulico, al fine di eliminare il rischio di cedimenti[21]; la demolizione delle scale di accesso ad un sottotetto dov'era stata realizzata una mansarda abusiva (che evidentemente non sarebbe stata eliminata)[22] e così via, fino al paradossale caso della “sanatoria temporanea” laddove, evidentemente, alla impossibilità di intervenire a posteriori sulle opere ha sopperito la creatività del firmatario dell’atto[23].
Tale stato di cose non sorprende più di tanto, perché già più di venti anni addietro, vigente la l. 47\1985, la Cassazione dava atto del fatto che “nella prassi è dato riscontrare, talvolta, provvedimenti siffatti, che subordinano la sanatoria all'esecuzione nell'immobile abusivo (non sanabile nella sua completezza) di specifici interventi finalizzati a fare acquisire allo stesso la conformità agli strumenti urbanistici”[24].
Meno netta risulta invece la giurisprudenza amministrativa, la quale in un’occasione ha ritenuto possibile che un permesso di costruire, anche in sanatoria, sia soggetto a prescrizioni intese ad imporre correttivi sull'esistente o a mitigare l'impatto paesaggistico del manufatto (sì da renderlo più coerente con il contesto ambientale), qualora si tratti di integrazioni minime o, comunque, tali da agevolare una sanatoria altrimenti non rilasciabile e ciò in quanto tale soluzione interpretativa risulta rispondente alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa[25].
Sembra tuttavia che la legittimità dell’apposizione di condizioni sia limitata, per i giudici amministrativi, a casi del tutto marginali e particolari, avendo recentemente il Consiglio di Stato, dopo avere richiamato alcuni precedenti, osservato che sulla base degli stessi possa in generale ritenersi legittima la prassi di apporre condizioni ad un titolo edilizio, ma sempre che queste siano previste dalla legge o comunque rispondano a rilevanti esigenze di interesse pubblico ed, inoltre, non siano idonee a snaturare il contenuto tipico del provvedimento stesso, essendo coerenti con il fine pubblico previsto dalla norma attributiva del potere[26].
In altra pronuncia dove il precedente veniva invocato si è precisato che “… le eventuali prescrizioni devono esser anzitutto consustanziali alla sanabilità d’un certo abuso che già possieda i presupposti a tal uopo” precisando come, in quell’occasione “la Sezione aveva chiarito, per un verso, che non fosse di per sé vietato, anzi era ammissibile inserire nella concessione edilizia, in via generale e non essendovi specifiche norme di legge contrarie, prescrizioni a tutela sia dell'ambiente, sia del tessuto e del decoro abitativo, stante la natura fortemente semplificativa di tali clausole, che, in loro mancanza sarebbe necessario respingere l'istanza del privato (spiegando i punti del progetto che da rivedere), ripresentare il progetto e, poi, approvarlo emendato. Però, se la P.A. può imporre prescrizioni, esse non devono contrastare con la natura e la tipicità del provvedimento, non devono snaturare l'atto (negandone la funzione) e non devono imporre sacrifici ingiustificabili, immotivati o sproporzionati. Pertanto, un PDC in sanatoria può legittimamente introdurre o recepire prescrizioni, intese ad imporre correttivi sull'esistente o a mitigare l'impatto paesaggistico del manufatto, ove si tratti di integrazioni minime o, comunque, tali da agevolare una sanatoria altrimenti non rilasciabile (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 19 aprile 2018 n. 2366; id., VI, 9 novembre 2018 n. 6327). Fuori da queste ipotesi, le prescrizioni non possono mai sostituire o attenuare i limiti di legge (come tali, vincolanti: p. es., nei casi di “doppia conformità” ex art. 36 del DPR 380/2001, cfr. Cons. St., VI, 13 gennaio 2021 n. 423), oltre o senza i quali il bene non è mai sanabile”[27].
5. La sanatoria “parziale”
Altro abusato sistema per aggirare le disposizioni in tema di sanatoria è quello della c.d. “sanatoria parziale”, in alcuni casi strettamente collegata alla sanatoria condizionata di cui si è appena detto e quasi sempre basata sull’altrettanto noto sistema della parcellizzazione dell’abuso edilizio.
Frequentemente, infatti, in presenza di situazioni che osterebbero alla lecita realizzazione delle opere, l’intero intervento viene suddiviso in più interventi di minore rilievo al fine di consentire il titolo abilitativo per ciascuno di essi, evitando l’esito, scontato, del complesso procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di costruire e facendo ricorso alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Si tratta di una prassi la cui illegittimità è stata più volte affermata dalla Corte di cassazione[28], chiarendo che il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull’assetto territoriale e ciò in quanto l’opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva[29]. La frammentazione dell’intervento edilizio è stata utilizzata anche per altre finalità,[30] potendosi rinvenire nella casistica anche alcuni casi riferibili alla procedura di sanatoria. Anche la possibilità della sanatoria “parziale” è stata, però, fermamente esclusa sempre sul presupposto della necessaria valutazione integrale degli interventi da sanare[31], evidenziandone l’illegittimità anche nei casi in cui la conformità dell’intervento alla disciplina di settore era stata ottenuta mediante l’eliminazione delle parti di costruzione che impedivano la sanatoria.
Il meccanismo di adeguamento dell’immobile ai requisiti di legge è il medesimo della sanatoria condizionata, con la sola differenza (talvolta difficilmente individuabile nelle singole decisioni) che in questo caso l’efficacia del titolo abilitativo non è subordinata all’effettuazione degli interventi di adeguamento, che sono invece eseguiti prima di ottenere il permesso di costruire in sanatoria.
L’obiezione che viene spesso sollevata, a fronte di casi di questo genere, è che le conseguenze del ricorso a tali anomale procedure sarebbero del tutto irrilevanti perché, in definitiva, l’intervento sanato sarebbe comunque conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente non possedendo più quelle caratteristiche che lo ponevano in contrasto con essa.
Si tratta, però, si una soluzione troppo semplicistica, perché come si è detto, la sanatoria richiede specifici ed inderogabili requisiti sostanziali (la doppia conformità) e procedimentali (che non siano ancora intervenuta l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la realizzazione dell'abuso), senza considerare gli effetti criminogeni di interpretazioni eccessivamente disinvolte da parte dei dirigenti o responsabili degli uffici tecnici comunali, soggetti ai quali, peraltro, la stessa normativa urbanistica attribuisce precisi compiti di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
Occorre inoltre ricordare che la Corte costituzionale, come recentemente ribadito[32], ha avuto modo in più occasioni di considerare la “doppia conformità” (richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità), osservando che essa costituisce “principio fondamentale nella materia governo del territorio”[33], ha lo scopo di “garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità”[34], ricordando anche come la sanatoria ai sensi dell’art. 36 TU Ed. si distingua dal condono edilizio, in quanto “fa riferimento alla possibilità di sanare opere che, sebbene sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, sono state realizzate in assenza del titolo stesso, ovvero con varianti essenziali”, mentre il condono edilizio “ha quale effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale dell’abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed edilizia”[35].
6. La sanatoria “giurisprudenziale”
Altra particolare tipologia di sanatoria è quella comunemente denominata “giurisprudenziale” o “impropria”, in base alla quale sono ritenute sanabili gli interventi che, sebbene non conformi alla disciplina urbanistica ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione, lo siano divenuti successivamente e ciò sul presupposto che sarebbe insensato demolire tali opere quando, a demolizione avvenuta, potrebbero essere legittimamente assentite.
Tale suggestiva eccezione ai limiti evidenti posti dall’art. 36 TU Ed. alle possibilità di sanatoria, come ricordato anche in giurisprudenza,[36] era originariamente considerata del tutto legittima dai giudici amministrativi[37], i quali hanno tuttavia definitivamente abbandonato tale orientamento correttamente rilevandone il contrasto con il principio di legalità e dando conto del fatto che tale singolare tipologia di recupero degli abusi edilizi non è stata considerata dall’art. 36 del TU Ed. quando ha sostituito l’omologa disciplina prevista dalla previgente l. 47\1985 e ciò nonostante il parere favorevole in tal senso formulato dalla Adunanza Generale del Consiglio di Stato (il 29 marzo 2001)[38] ed osservando che l’art. 36 non è suscettibile di interpretazione analogica o riduttiva, trattandosi di norma derogatoria al principio secondo cui i lavori realizzati in assenza di valido titolo abilitativo sono sottoposti alle prescritte misure ripristinatorie e sanzionatorie[39].
I giudici amministrativi sono successivamente ritornati sull’argomento osservando che la sanatoria giurisprudenziale non può essere ammessa “(…) in quanto introduce un atipico atto con effetti provvedimentali, al di fuori di qualsiasi previsione normativa, non può ritenersi ammesso nel nostro ordinamento, caratterizzato dal principio di legalità dell’azione amministrativa e dal carattere tipico dei poteri esercitati dall’Amministrazione, secondo il principio di nominatività, poteri che non possono essere surrogati dal giudice, pena la violazione del principio di separazione dei poteri e pena l’invasione nelle sfere di attribuzioni riservate all’Amministrazione”[40], aggiungendo successivamente che è del tutto ragionevole vietare il rilascio di un permesso in sanatoria anche quando dopo la commissione dell'abuso vi sia una modifica favorevole dello strumento urbanistico in quanto “(…) tale ragionevolezza risulta da due fondamentali esigenze, prese in considerazione dalla legge: a) evitare che il potere di pianificazione possa essere strumentalizzato al fine di rendere lecito ex post (e non punibile) ciò che risulta illecito (e punibile); b) disporre una regola senz'altro dissuasiva dell'intenzione di commettere un abuso, perché in tal modo chi costruisce sine titulo sa che deve comunque disporre la demolizione dell'abuso, pur se sopraggiunge una modifica favorevole dello strumento urbanistico”[41].
Degli argomenti sviluppati dal giudice amministrativo aveva dato conto la giurisprudenza di legittimità, affermando, in più occasioni, che la sanatoria “impropria” era da ritenersi improduttiva di effetti estintivi dei reati urbanistici[42], determinando eventualmente conseguenze sull’ordine giudiziale di demolizione, rendendolo superfluo o revocabile[43] per poi pervenire, tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, all’attuale posizione contraria alla legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica[44], posizione ormai definitivamente assunta anche dalla giurisprudenza amministrativa[45].
7. Sanatoria degli abusi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
Tralasciando di richiamare l’ampio dibattito in tema di sanatoria degli interventi eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è opportuno ricordare come l’attuale formulazione dell’art. 181 d.lgs. 42\2004 consenta esclusivamente una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi definibili come “minori”, compiuta la quale (e ferma l’applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dall’art. 167), non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal primo comma dell’art. 181.
Gli interventi recuperabili sono definiti “minori” in quanto riguardano, come specifica la norma, lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica e lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del TU Ed. Si tratta, dunque, di opere caratterizzate da un impatto estremamente modesto sull'assetto del territorio vincolato rispetto agli altri interventi considerati nella medesima disposizione di legge[46].
Tale procedura, tuttavia, riguarda esclusivamente l’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 181 d.lgs. 42\2004 ed è, come si è visto, limitata ad interventi di scarso rilievo. Essa inoltre, secondo la giurisprudenza, può avere ad oggetto le sole opere già in origine assentibili perché compatibili con il paesaggio, con la conseguenza che l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica non può dipendere dall’esecuzione di determinati interventi, escludendosi dunque, anche in tali ipotesi, la possibilità di rilasciare titoli abilitativi sottoposti a condizione.[47]
La procedura, inoltre, è del tutto autonoma rispetto a quella di cui all’art. 36 del TU Ed. riguardando esclusivamente le contravvenzioni di cui all’art. 181 d.lgs. 42\2004 entro i rigorosi limiti di cui si è detto[48].
Si è pertanto posto il problema della sanabilità degli abusi edilizi eseguiti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 36 TU Ed.
La giurisprudenza di legittimità aveva ripetutamente considerato la questione alla luce delle disposizioni di volta in volta vigenti e, più recentemente[49], l’ha nuovamente esaminata alla luce della attuale disciplina, considerando anche quanto già osservato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento agli art. art. 146, comma 4, 159, comma 5 e 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004 e rilevando come, in estrema sintesi, costituendo l'autorizzazione paesaggistica, secondo l’art. 146, comma 4 citato, atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, il permesso medesimo resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la quale, però, sempre secondo la disposizione in esame, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, tranne nei casi degli abusi “minori” di cui si è detto. Da tale stato di cose consegue il principio secondo cui, essendo la possibilità di una autorizzazione paesaggistica postuma espressamente esclusa dalla legge - ad eccezione dei casi, tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, relativi agli “abusi minori”- tale preclusione, considerato che l’autorizzazione paesaggistica è presupposto per il rilascio del permesso di costruire, impedisce anche la sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380\01 e l’eventuale emissione della predetta autorizzazione paesaggistica in spregio a tale esplicito divieto, oltre a non produrre alcun effetto estintivo dei reati, non impedisce neppure l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino.
Il principio è stato successivamente ribadito in altre pronunce[50] ed anche la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente confermato il proprio orientamento[51].
È appena il caso di aggiungere che le considerazioni svolte non riguardano le zone soggette a vincolo idrogeologico che non è contemplato dal d.lgs. 42\2004, avendo anzi la giurisprudenza ritenuto possibile, in una decisione tuttora isolata, la positiva conclusione della procedura di accertamento di conformità, sebbene subordinata, in presenza di tale vincolo, al conseguimento dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del medesimo[52].
8. Sanatoria degli interventi in zona sismica
Per quanto riguarda le zone soggette alla normativa antisismica, si pone il problema del raccordo tra le disposizioni che regolano la sanatoria ex art. 36 del TU Ed. e le specifiche disposizioni di cui agli artt. 83 e ss. del medesimo testo unico e la conseguente possibilità di sanatoria degli abusi edilizi realizzati in zona sismica.
Considerando le palesi finalità di tutela dell’incolumità pubblica che la specifica disciplina persegue e la diffusa sismicità del territorio nazionale, si tratta di questione particolarmente delicata.
Ciò nonostante, l’argomento non risulta essere stato mai compiutamente trattato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha soltanto ripetutamente confermato l’ormai consolidato principio che esclude gli effetti estintivi del reato di cui all’art. 45, comma 3 del TU per tutti i reati diversi da quelli previsti dall’art. 44,[53] mentre la giurisprudenza amministrativa ha formulato interessanti considerazioni le quali, pur non pervenendo ad univoche conclusioni, offrono diversi spunti di riflessione[54].
In sintesi, la questione che si pone è abbastanza simile a quella affrontata con riferimento alla sanatoria degli abusi in zona vincolata, dovendosi invero considerare, in primo luogo, se sia o meno possibile rilasciare un’autorizzazione postuma ai fini della disciplina antisismica; quali siano i rapporti tra i titoli conseguiti in base alla disciplina antisismica ed il permesso di costruire ed, infine, se possa rilasciarsi il permesso di costruire in sanatoria per interventi abusivi eseguiti in zona sismica.
Il controllo esercitato dall’amministrazione competente per gli interventi in zone sismiche è certamente di natura preventiva, come si ricava, ad esempio, dall’art. 93 del testo unico - il quale impone, a chiunque intenda procedere ad interventi nelle zone sismiche, di darne “preavviso” scritto allo sportello unico, che a sua volta provvederà alla trasmissione al competente ufficio tecnico regionale – nonché dal successivo art. 94, il quale si riferisce ad una “preventiva autorizzazione”, sicché la procedura deve essere inequivocabilmente completata prima dell’esecuzione dell’intervento, nel rispetto delle formalità richieste.
Dal contenuto delle particolari disposizioni ed in considerazione delle loro specifiche finalità risulta evidente, inoltre, l’autonomia del procedimento autorizzatorio in esame rispetto a quello previsto per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, l’obbligo del quale resta fermo, come espressamente indicato dal primo comma dell’art. 94, cosicché esso dovrà essere conseguito, in aggiunta all’autorizzazione di cui si tratta, qualora la tipologia dell’intervento da eseguire lo richieda.
Diversamente da quanto previsto per la costruzione di opere in assenza del permesso di costruire, la specifica disciplina antisismica non contempla alcuna forma di sanatoria o autorizzazione postuma per gli interventi eseguiti senza titolo, prevedendone invece la mera riconduzione a conformità, come si ricava da quanto dispone il terzo comma dell’art. 98, il quale stabilisce non soltanto che, con il decreto o con la sentenza di condanna, il giudice deve ordinare la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità dalla specifica disciplina, ma anche che possa impartire le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi ad essa, fissando il relativo termine[55]. Analoga situazione è prevista dall’art. 100 in caso di estinzione del reato, laddove è stabilito che la Regione, in alternativa alla demolizione, possa ordinare l’esecuzione di analoghi interventi finalizzati alla riduzione in conformità delle opere illecitamente realizzate.
Sulla base delle disposizioni appena richiamate deve rilevarsi che esse non soltanto non prevedono effetti estintivi del reato conseguenti alla regolarizzazione postuma, ma neppure effetti propriamente sananti, fermo restando che la demolizione dell’intervento abusivo può essere evitata qualora tale regolarizzazione sia possibile. Il tutto all’esito di un procedimento penale, come si evince dal riferimento specifico al decreto penale ed alla sentenza di condanna.
Manca, in definitiva, una procedura che consenta all’interessato di richiedere un’autorizzazione postuma[56] e pertanto, prescindendo per il momento dal considerare l’eventuale incidenza della specifica disciplina di cui all’art. 36, l’unica possibilità offerta dalla normativa antisismica per il mantenimento in essere dell’intervento abusivo è la decisione del giudice di impartire le prescrizioni per rendere le opere conformi in luogo di ordinarne la demolizione (o le ulteriori procedure regolate dagli artt. 99 e 100). Tale decisione, poi, oltre a prevedere la pronuncia di una sentenza o un decreto di condanna, dovrà ovviamente essere motivata[57] e presuppone, altrettanto ovviamente, specifiche verifiche di natura tecnica, poiché pare evidente che lo scopo sia quello di eliminare ciò che può costituire pericolo per la pubblica incolumità o, in alternativa, di scongiurare tale pericolo mediante particolari interventi.
La giurisprudenza risalente al periodo di vigenza della l. 64\1974 ha, peraltro, precisato che il giudice penale, nell'operare la scelta tra le due alternative, non può limitarsi ad esaminare se, attraverso l'esecuzione di determinati lavori, l'opera possa o meno essere adeguata alla normativa antisismica, ma deve invece esaminare, innanzi tutto, se l'opera abusivamente realizzata si presenti conforme agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio ed, in caso negativo, non può ordinare la esecuzione di lavori di adeguamento, ma deve, invece, ordinare la demolizione del manufatto abusivo[58].
In altra occasione, invece, si è detto che la verifica di conformità da parte del giudice avrebbe dovuto riguardare la normativa urbanistica in genere (nella specie, l’allora vigente l. 10/1977)[59].
Le particolari disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche lasciano, dunque, uno spazio estremamente esiguo al mantenimento in essere degli interventi abusivi. Il destino del manufatto illecitamente realizzato in zona sismica resta, peraltro, comunque segnato qualora debba essere demolito perché in contrasto con la disciplina urbanistica (come, ad esempio, nel caso in cui sia configurabile anche il reato di cui all’art. 44 del TU Ed.), dal momento che, come si è detto, il legislatore regola, nell’art. 94, l’autorizzazione per l’inizio dei lavori in zone sismiche “fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio…” ed, infatti, si è in più occasioni condivisibilmente specificato che l’autorizzazione costituisce presupposto tassativo ai fini del rilascio del titolo edilizio[60].
Considerando ora l’art. 36 del TU Ed., è evidente che la stretta connessione tra autorizzazione sismica e permesso di costruire, di cui si è appena detto, incide in maniera significativa anche sulla procedura di sanatoria, venendosi a porre, in primo luogo, la questione della totale assenza di norme specifiche che consentano il rilascio di un’autorizzazione sismica postuma.
Tale evenienza risulta determinante, perché è evidente che se la possibilità di ottenere una autorizzazione simica “in sanatoria” ad intervento ormai eseguito non è prevista, viene a mancare un necessario presupposto per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 36 TU Ed.
La questione non è stata esaminata finora dalla giurisprudenza di legittimità, che però ha implicitamente considerato, in alcune decisioni, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione postuma, per lo più trattando degli effetti estintivi limitati ai soli reati urbanistici della sanatoria ex art. 36 o per altre ragioni,[61] mentre i giudici amministrativi, come segnalato in dottrina,[62] hanno assunto posizioni non concordi.
Vi è da un lato, infatti, una posizione più radicale che sembra escludere in ogni caso la possibilità dell’autorizzazione postuma[63] non soltanto sul presupposto dell’assenza di una disciplina analoga a quella prevista dall’art. 36 del TU, ma anche per il fatto che gli artt. 96 e ss. “non danno in alcun modo vita a un procedimento amministrativo di autorizzazione in sanatoria su istanza del privato, limitandosi a consentire la conservazione del manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica preventiva, una volta che la vicenda penale sia stata comunque definita”[64] ed inoltre, considerando che “mancando una puntuale disciplina positiva dell’autorizzazione sismica in sanatoria, va evitato il rischio di introdurre in una materia così delicata per l’incolumità delle persone – peraltro neppure pienamente disponibile da parte del legislatore regionale – una sorta di sanatoria giurisprudenziale fondata sull’accertamento postumo della conformità dell’opera comunque edificata alle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche al momento della richiesta”[65].
Altre pronunce propendono, invece, per la possibilità, a determinate condizioni, di una autorizzazione ad intervento eseguito[66], senza tuttavia confrontarsi con l’opposto orientamento e dando, anzi, per scontata tale possibilità, sempreché sussista, anche sotto il profilo della specifica normativa sismica, la doppia conformità.
Più recentemente, ribadendo che l’autorizzazione sismica deve essere acquisita preventivamente rispetto al rilascio del titolo in sanatoria, si è osservato che l’art. 36 del TU Ed. subordina il rilascio del titolo in sanatoria alla conformità sostanziale delle opere già eseguite alla normativa edilizia ed urbanistica “occorrendo, dunque, verificare, ancora prima dell’adozione del permesso di costruire in sanatoria, se le opere possano o meno ritenersi sostanzialmente conformi alla disciplina di riferimento: a tali fini, risulta necessario accertare, tra l’altro, il previo rilascio dell’autorizzazione sismica (ove prevista), idonea ad escludere quei pericoli per la staticità delle opere abusive che, ove esistenti, impedirebbero la sanatoria, imponendo l’irrogazione della sanzione demolitoria”[67].
Si è inoltre osservato[68] che tale orientamento avrebbe trovato autorevole conferma in due pronunce della Corte costituzionale,[69] anche se il giudice delle leggi, pur affermando che la regola della doppia conformità vale anche per la normativa antisismica e che “gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche”, cosicché “non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria”, non pare offrire decisivi spunti di riflessione circa l’assenza, nella disciplina urbanistica, di norme che prevedano espressamente un’autorizzazione sismica postuma, in quanto, pur non negando esplicitamente tale possibilità, focalizza piuttosto l’attenzione sul requisito della doppia conformità e precisa che la stessa comprende la disciplina urbanistica ed edilizia nel suo complesso, con la conseguenza che il permesso di costruire in sanatoria non può riguardare opere non conformi anche alla disciplina antisismica.
Ulteriore conseguenza di tale condivisibile assunto è che trattandosi, appunto, di doppia conformità, deve comunque escludersi ogni possibilità di sanatoria “condizionata” nei termini in precedenza descritti o che comunque preveda l’esecuzione di interventi di adeguamento[70].
Secondo l’orientamento più permissivo, dunque, sarebbe possibile il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per opere realizzate in zona sismica ponendo rimedio all’originaria mancanza del nulla osta sismico attraverso una valutazione postuma della conformità dell’intervento eseguito alla specifica disciplina antisismica vigente all’epoca della sua realizzazione ed al momento in cui essa avviene.
Tale soluzione, tuttavia, presenta alcuni aspetti critici.
Quello più evidente è la già ricordata assenza di specifiche disposizioni che prevedano espressamente la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità sismica, stabilendo al contrario gli artt. 93 e ss. che tale verifica deve precedere l’esecuzione dei lavori.
Per tale ragione, inoltre, la procedura regolata dalle richiamate disposizioni risulta incompatibile con la sanatoria sismica di creazione giurisprudenziale, tanto che ci si è cercato di individuare il procedimento amministrativo necessario per il conseguimento di tale sanatoria, considerando la possibilità che lo stesso sia “modellato” su quello già previsto per il rilascio della autorizzazione sismica “ordinaria”, osservando peraltro che “non è pensabile che il conseguimento del nulla osta sismico possa soggiacere al medesimo procedimento amministrativo che si sarebbe dovuto applicare all’epoca dell’intervento ove tale procedimento non sia più vigente, poiché ciò contrasterebbe evidentemente con il principio del tempus regit actum”[71].
La mancanza di una procedura puntualmente disciplinata dalla legge, inoltre, potrebbe portare alla adozione di differenti prassi nei singoli uffici competenti, aggravando ulteriormente l’attuale situazione, già caratterizzata talvolta da disinvolte applicazioni della disciplina nazionale, come si è visto, ad esempio, con la più volte menzionata sanatoria condizionata.
Si tratterebbe, inoltre, di una procedura che ingiustamente porrebbe sullo stesso piano colui che, diligentemente, agisce osservando la legge rispetto a chi realizza un intervento senza titolo, sottraendo le opere ad ogni preventivo controllo, perché il rilascio dell’autorizzazione antisismica postuma effettuato adattando il procedimento ordinario non prevede, ovviamente, a differenza di quanto stabilito dall’art. 36, alcun pagamento di somme a titolo di oblazione, né termini specifici trascorsi i quali si perfeziona il silenzio-rifiuto. Ma ciò che sembra maggiormente preoccupante è che tutto ciò avverrebbe con riferimento ad una disciplina appositamente dettata per tutelare la pubblica incolumità, offrendo la possibilità di regolarizzare interventi edilizi eseguiti in assenza del necessario preventivo controllo attraverso procedure non disciplinate dalla legge e con tempistica non prevedibile, senza contare gli inevitabili effetti criminogeni generati dalla consapevolezza di poter realizzare un intervento edilizio senza titolo con la possibilità di sanarlo a posteriori, magari solo in caso di verifica da parte delle amministrazioni competenti, come già spesso avviene per il permesso di costruire in sanatoria.
Vero è, come osservato in dottrina[72], che la soluzione interpretativa la quale ammette la sanatoria antisismica consente di colmare la mancanza di una normativa specifica e di evitare il rigetto di qualsiasi sanatoria di immobili realizzati in zona sismica anche nel caso in cui risultino pienamente conformi alla normativa tecnica di settore e, in quanto tali, inidonei a ledere l’interesse pubblico alla sicurezza delle costruzioni, ma l’orientamento più rigoroso della giurisprudenza amministrativa sembra rispondere a criteri di maggiore prudenza, in considerazione della materia trattata e conforme al dettato normativo che non ha finora previsto, nonostante le numerose modifiche, alcuna possibilità di autorizzazione simica postuma, dovendosi pertanto dubitare che l’osservanza della legge comporti la paventata violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., nonché di economicità ed efficacia presidiati dall’art. 1 della L. 241/1990.
La questione è dunque meritevole di approfondimento anche da parte della giurisprudenza di legittimità che, come si è detto, non ha mai direttamente trattato i temi di cui si è ripetutamente occupato il giudice amministrativo, limitandosi a ribadire che il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 TU Ed. e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica.[73]
9. Effetti penali della sanatoria
Come già detto la sanatoria per doppia conformità produce effetti estintivi dei dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti come stabilito dal comma 3 dell’art. 45 del TU Ed., il cui contenuto inequivocabile esclude che il suo ambito di applicazione possa essere esteso, come in precedenza ricordato, ad altri reati che, pur concernendo l’attività edilizia, hanno una diversa oggettività giuridica. L’efficacia estintiva della sanatoria è, inoltre, prodotta dall’emissione del permesso di costruire, con la conseguenza che solo tale titolo legittima l’intervento sanato ed estingue il reato (che, fino alla sua emissione è, quindi, pienamente sussistente) e non è surrogabile in forza di comportamenti taciti della p. a. e che non può tenervi luogo la corresponsione della somma dovuta a titolo di oblazione[74].
L'estinzione del reato quale conseguenza della sanatoria opera oggettivamente a seguito dell'eliminazione dell'antigiuridicità penale del comportamento illecito e possono conseguentemente beneficiarne tutti i soggetti corresponsabili dell’esecuzione dell’opera abusiva e non il solo richiedente.
La Corte di cassazione ha sempre tenuto conto della valenza sostanziale ed oggettiva dell'accertamento di conformità[75] evidenziato, nel ribadire il concetto, l’impropria formulazione letterale dell’art. 36 TU Ed., il quale sembra ricondurre l’effetto estintivo al pagamento della somma prevista a titolo di oblazione anziché all'effettivo rilascio del permesso successivamente alla verifica della conformità delle opere[76].
Si è anche rilevato, in assenza di esplicita previsione nell’art. 45 TU Ed., che gli effetti estintivi della sanatoria non si producano per gli abusi rispetto ai quali sia già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna[77], avendo peraltro tale disposizione superato, riguardo a tale aspetto, il vaglio della Corte costituzionale, la quale l’ha ritenuta non in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza[78] e per le ragioni analoghe è stata esclusa la possibilità di revisione ex art. 629 e ss. cod. proc. pen.[79]
L’estinzione del reato a seguito di sanatoria, inoltre, prevale sull’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica[80].
La richiesta di sanatoria produce anche gli effetti processuali di cui al primo comma dell’art. 45, rispetto ai quali si è precisato che la mancata sospensione del procedimento da parte del giudice, in assenza di una espressa previsione normativa, non determina alcuna lesione al diritto di difesa, potendo l'interessato far valere l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva del reato nei successivi gradi di giudizio[81].
La sospensione del processo, peraltro, non opera in caso di proposizione di un ricorso al giudice amministrativo avverso il diniego del nulla osta in sanatoria di un abuso urbanistico, essendosi ritenuto che la risoluzione del giudizio amministrativo non esplica effetti sulla sussistenza del reato ma solo sulla sua possibile estinzione, che consegue, comunque, ad una rinnovata valutazione da parte dell'autorità competente[82].
Resta da aggiungere, trattando degli effetti penali della sanatoria, che la concreta validità ed efficacia della stessa, nel processo penale, resta comunque soggetta al potere-dovere del giudice penale di verificare in via incidentale la legittimità del permesso di costruire (anche in sanatoria) e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina legislativa in materia urbanistico-edilizia, senza che ciò comporti l'eventuale "disapplicazione" dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela, da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici[83]. Infine, occorre ricordare che in generale, in tema di rilascio di titolo abilitativo edilizio senza il rispetto del piano regolatore generale o degli altri strumenti urbanistici, la giurisprudenza di legittimità, considerando che l'art.12, comma 1, del TU Ed. prescrive espressamente che il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi agli strumenti urbanistici ed il successivo art. 13 detta la specifica disciplina urbanistica che il direttore del settore è tenuto ad osservare, ha ritenuto integrato il delitto di abuso di ufficio di cui all’art. 323 cod. pen. anche nell’attuale formulazione con considerazioni senz’altro applicabili anche al permesso di costruire in sanatoria[84].
[1] Naturalmente quanto descritto rappresenta solo una delle concause del dilagare delle edificazioni illegali, dovendosi temere presenti, ad esempio, anche gli effetti dei reiterati ricorsi al condono edilizio, le modifiche peggiorative apportate al Testo Unico, la scarsa attenzione prestata in molti uffici giudiziari ai reati urbanistici e paesaggistici ed alla esecuzione delle demolizioni ordinate dal giudice penale all’esito del processo oltre, ovviamente, alla ingerenza della criminalità organizzata anche nel c.d. ciclo illegale del cemento che comporta, come altre attività illegali, ingenti guadagni.
[2] Corte cost. n. 416 del 21/7/1995.
[3] Relativamente agli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA ed il relativo accertamento di conformità, che non sono oggetto di questo lavoro, dispone l’art. 37 del TU Ed.
[4] In questi termini Cass. Sez. U, n. 15427 del 31/3/2016, Cavallo, Rv. 267041 in penalecontemporaneo.it. 2016 con nota di COGNIZZOLI Le Sezioni Unite sul calcolo del termine di prescrizione del reato edilizio in caso di sospensione del procedimento penale; in Cass. Pen. n. 9\2016, pag. 3173 con nota di SCORDAMAGLIA In tema di rapporti tra la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione del processo avente ad oggetto l'accertamento di reati urbanistici ed in Giur. It. n. 8-9\2016, pag. 2016 con nota di MARTINI Sospensione della prescrizione in caso di accesso alla concessione edilizia ex post.
[5] Cass. Sez. 3, n. 9797 del 22/6/1987, Scarcella, Rv. 176643, richiamata in motivazione dalla successiva Sez. 3, n. 6331 del 20/12/2007 (dep. 2008 ), PM in proc. Latteri Rv. 238822
[6] Sul tema ex pl. TANDA I reati urbanistico-edilizi, Padova, 2022, pag. 719 e ss.; FIALE A., FIALE E. Diritto Urbanistico Napoli, 2019, p. 788 e ss. FORESTI, La sanatoria edilizia, Milano 2019; BRIGANTE Accertamenti di conformità: tracce di una controversa evoluzione in Riv. Giur. Ed. n. 3\2018 pag. 173; D’ANGELO, Abusi e reati edilizi, Rimini, 2014; SANDULLI M.A. Testo Unico dell’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), Milano, 2009 p. 623 e ss.; REYNAUD, La disciplina dei reati urbanistici, Torino, 2007
[7] V. Cass. Sez. III 24/6/2010, n. 24245. Il Consiglio di Stato (Sez. 4, n. 410 del 1/2/2017) ha precisato che il silenzio della p. a. sulla richiesta di concessione in sanatoria e sulla istanza di accertamento di conformità ha un valore legale tipico di rigetto, costituendo un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego (v. anche Sez. 4 n. 2691 del 6/6/2008; Sez. 5 n. 706 del 11/2/2003)
[8] Cass. Sez. 3, n. 17954 del 26/2/2008, Termini, Rv. 240233. In tema di annullamento di ufficio della sanatoria già rilasciata v. Cons. Stato Ad. Pl. n. 8 del 17/10/2017
[9] La sospensione del procedimento assume rilievo anche per quanto concerne il calcolo della prescrizione del reato ed, infatti, le SU Cavallo, citate in precedenza, hanno stabilito che il periodo di sospensione del processo, previsto dall’art.45 deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio e che in caso di sospensione del processo su richiesta dell'imputato o del suo difensore, disposta oltre il termine previsto per la formazione del silenzio-rifiuto ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, opera la sospensione del corso della prescrizione a norma dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. proc. pen.
[10] Cons. Stato Sez. 6, n. 8319 del 5/12/2019; Sez. 6, n. 6233 del 5/11/2018
[11] A. FIALE, E. FIALE, cit. pag. 793. Sostanzialmente negli stessi termini si è espressa la Cassazione in Sez. 3, n. 291 del 26/11/2003 (dep. 2004), PM in proc. Fammiano Rv. 226871 (non massimata sul punto)
[12] In A. FIALE, E. FIALE, cit. pag. 794 si richiama tale soluzione interpretativa prospettata in dottrina rinvenendo una implicita conferma nel fatto che la medesima espressione è stata utilizzata nel d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, Tabella A, Parte 4, punto 40
[13] Cass. Sez. 3, n. 7681 del 13/1/2017, Innamorati, Rv. 269159
[14] Così Cass. Sez. 3, n. 28784 del 16/5/2018, PG in proc. Amente ed altri, Rv. 273307 cui si rinvia anche per i richiami ai precedenti, tra cui Sez. 3, n. 38064 del 18/6/2004, Semeraro, Rv. 230039. In senso conforme Sez. 3, n. 44517 del 17/7/2019, D’Alba Rv. 277261 che prende in considerazione anche la sanatoria conseguente a condono edilizio in relazione alla lottizzazione. Il principio è stato recentemente ribadito in Sez. 3, n. 33258 del 14/6/2022, Porticelli, non massimata.
[15] Cons. Stato Sez. 2 n. 5288 del 28/8/2020
[16] V., ad es., Cass. Sez. 3, n. 41567 del 4/10/2007, P.M. in proc. Rubechi e altro Rv. 238020 dove la Corte, nel ritenere illegittimo il titolo in sanatoria subordinato all’eliminazione di volumi in eccedenza, evidenzia anche come, in presenza di un aumento di volumetria non è corretto considerare abusivi solo i maggiori volumi rispetto all'intero manufatto, che deve dunque ritenersi completamente abusivo, anche perché l'incidenza sull'assetto urbanistico del territorio dev'essere valutata considerando l'intervento nel suo complesso. Negli stessi termini Sez. 3, n. 23726 del 24/2/2009, Peoloso, non massimata
[17] In Sez. 3, n. 7405 del 15/1/2015, Bonarota, Rv. 262422 si legge di un’illegittima sanatoria rilasciata per un intervento edilizio eseguito su particella catastale alla quale, successivamente all'abuso, era stata asservita altra particella al fine di superare il limite di cubatura stabilito dalle previsioni urbanistiche. V. anche Sez. 3 n. 8540 del 18/10/2017 (dep. 2018), Petracca, non massimata
[18] Da ultimo in Cass. Sez. 3 n. 32020 del 20/4/2022, Casciello, non massimata
[19] Così in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 48499 del 13/11/2003, Dall’Oro, Rv. 226897
[20] Cass. Sez. 3, n. 51013 del 5/11/2015, Carratù, Rv. 266034
[21] Cass. Sez. 3, n. 28666 del 7/7/2020, Murra Rv. 280281
[22] Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41669 del 25/10/2001, Tollon, Rv. 220365
[23] V. Cass. Sez. 3, n. 19587 del 27/4/2011, Montini ed altro Rv. 250477 relativa ad un caso in cui il titolo abilitativo in sanatoria era stato conseguito ma con "validità di mesi sei dalla data del rilascio", prevedendosi, alla scadenza, la necessità di una richiesta di rinnovo.
[24] Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10601 del 30/5/2000, Marinaro Rv. 217577 in motivazione. Conf. Sez. 3, n. 40269 del 26/11/2002, PG in proc. Nucci, Rv. 222704
[25] Cons. Stato Sez. 6, n. 6327 del 9/11/2018
[26] Cons. di Stato Sez. 6, n. 3738 del 12/5/2022
[27] Cons. di Stato Sez. 6, n. 5911 del 17/8/2021. V. anche Sez. 6, n. 5693 del 28/9/2020 la quale precisa, richiamando i precedenti che “è in tale ottica che vanno inquadrate quelle limitate aperture relative non a vere proprie condizioni quanto al più limitato concetto di prescrizioni nei termini sopra dettagliati. In materia edilizia va quindi condivisa la posizione teorica, seguita dalla migliore dottrina, secondo cui, se una condizione in senso proprio non possa essere apposta, laddove non prevista dalla legge, in quanto contrasterebbe con l’essenza stessa del permesso, che è atto di accertamento a carattere non negoziale, diverso è il caso in cui l’elemento accidentale sia più correttamente identificabile in termini di prescrizione, quale modalità esecutiva; prescrizioni che, se non ottemperate, non invalidano comunque l’atto autorizzativo e non ne impediscano gli effetti, con la conseguenza che sussisterà una semplice violazione delle prescrizioni, autonomamente sanzionata”.
[28] V., ex pl., Cass. Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep.2012), Forte, Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/2010, Tulipani, non massimata
[29] In questi termini Cass. Sez. 3, n. 16622 del 8/4/2015, PM in proc. Casciato, Rv. 263473 relativa a fattispecie concernente la realizzazione di opere attraverso la frammentazione degli interventi, assentiti con d.i.a., con creazione di nuovi volumi e successiva richiesta di permesso di costruire in sanatoria, titolo abilitativo, quest'ultimo, che sarebbe stato necessario fin dall'inizio per la realizzazione dell’intervento edilizio.
[30] In Cass. Sez. 3, n. 30147 del 19/4/2017, Tomasulo, Rv. 270256 la valutazione non unitaria delle opere (tre palazzine) risulta finalizzata ad una diversa individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione con riferimento a ciascun manufatto. Stessa situazione si rinviene in Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014 (dep. 2015), Prevosto ed altri, Rv. 263339 ed in Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Tucci, Rv. 223365, mentre in Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Marrella, Rv. 247175 il sistema viene utilizzato nell’ambito di una illecita attività di lottizzazione
[31] Cass. Sez. 3, n. 22256 del 28/4/2016, Rongo, Rv. 267290. Conf. Sez. 3, n. 19587 del 27/4/2011, Montini ed altro Rv. 250477, cit. V. anche n. 45241, 5/12/2007, Alioto, non massimata che sembra però riferibile ad ipotesi di sanatoria subordinata alla demolizione di parte delle opere; Sez. 3, n. 291 del 26/11/2003 (dep. 2004 ) PM in proc. Fammiano, Rv. 226871
[32] Corte cost. n. 232 del 8/11/2017. V. anche Corte cost. n. 77 del 21/4/2021
[33] Corte cost. n. 107 del 11/5/2017
[34] Corte cost. n. 101 del 29/5/2013
[35] Corte cost. n. 50 del 10/3/2017
[36] Cass. Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci ed altro, Rv. 260971 in Riv. Giur. Ed. n. 1\2015 pag. 125 con nota di TANDA L'orientamento (a volte contrastante) dei giudici amministrativi e penali sull'ammissibilità della c.d. sanatoria giurisprudenziale. Sul tema della sanatoria giurisprudenziale v. anche GRAZIOSI Attualità della questione dei titoli edilizi postumi. nuove ragioni e vecchi argomenti (ancora a proposito della c.d. sanatoria giurisprudenziale), ibid. n. 1\2020, pag. 53; BRIGANTE Accertamenti di conformità: tracce di una controversa evoluzione, ibid. n. 3\2018 pag. 173; SEMENTILLI Declino e continuità della c.d. “sanatoria giurisprudenziale”: il ruolo dei principi, ibid., n. 1\2018, pag. 170
[37] V.. ad es. Sez. 5, n. 1796 del 19/4/2005
[38] Cons. Stato Sez. 4, n. 4838 del 17/9/2007
[39] Cons. Stato Sez. 4, n. 6784 2/11/2009. Nella Relazione illustrativa al testo Unico dell'edilizia, come ricordato in Cass. Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci ed altro cit., veniva dato conto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale il quale impediva la formazione di un diritto vivente tale da consentire la modifica del dato testuale e del parere nettamente contrario espresso dalla Camera.
[40] Cons. Stato Sez. 5, n. 3220 del 11/6/2013
[41] Cons. Stato Sez. 5, n. 1324 del 17/3/ 2014. Conf. Sez. 5, n. 2755 del 27/5/ 2014
[42] V., ad es., Cass. Sez. 3, n. 21206 del 26/2/2008, Melluso, non massimata, dove viene dato atto del contrasto rinvenibile nella giurisprudenza amministrativa; Sez. 3, n. 24451 del 26/4/2007, P.G. in proc. Micolucci, Rv. 236912
[43] Sez. 3, n. 40969 del 27/10/2005, Olimpio, Rv. 232371
[44] Oltre alla già citata Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci ed altro, v. Sez. 3, n. 26425 del 11/2/2016, Danese, non massimata; Sez. 3, n. 45845 del 19/9/2019, Caprio, Rv. 277265 che richiama anche recenti pronunce del Consiglio di Stato conformi all’ormai consolidato indirizzo che nega la legittimità della sanatoria giurisprudenziale.
[45] V. ad esempio, tra le più recenti, Cons. di Stato Sez. 6, n. 7351 del 22/8/2022; Sez. 6, n. 7291 del 19/8/2022, ove vengono ribadite nel dettaglio le ragioni per le quali la sanatoria giurisprudenziale non è applicabile
[46] V., ex pl., Cass. Sez. 3, n. 889 del 29/11/2011 (dep.2012), Falconi e altri, Rv. 251641. Conf. Sez. 3, n. 9060 del 4/10/2017 (dep. 2018), Veillon, Rv. 272450; Sez. 3, n. 44189 del 19/9/2013, Tognotti, Rv. 257527
[47] Cass. Sez. 3, n. 10110 del 21/1/2016, Navarra ed altro, Rv. 266250. In senso conforme Sez. 3, n. 14479 del 7/12/2016 (dep. 2017), Italiani ed altro, non massimata
[48] In dottrina v. GRAZIOSI Il divieto di sanatoria paesaggistica tra sopravvenienza del vincolo e sopravvenienza del divieto in Urb. App. n. 6\2019, pag. 761
[49] Cass. Sez. 3, n. 190 del 12/11/2020 (dep. 2021), Susana, Rv. 281131, cui si rinvia per l’analisi della precedente giurisprudenza penale ed amministrativa
[50] Cass. Sez. 3, n. 23427 del 29/4/2022, Sharov ed altri, non massimata; Sez. 3, n. 30426 del 24/5/2022, Polizzotto, non massimata; Sez. 3, n. 31924 del 17/5/2022, Bove, non massimata
[51] V. Cons. di Stato Sez. 6, n. 6113 del 18/7/2022.
[52] Cass. Sez. 3, n. 11960 del 22/12/2010 (dep. 2011), Comotti, Rv. 249747
[53] V., ex pl., Cass. Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212; Sez. 7, n. 11254 del 20/10/2017 (dep. 2018), Franchino ed altri, Rv. 272546; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792
[54] Per una generale (e recente) disamina v. CANAL La sanatoria edilizia e la sanatoria sismica in amministrativistiveneti.it, 27 Giugno, 2022
[55] Secondo la giurisprudenza il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma terzo sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali come stabilito da Sez. 3, n. 6371 del 7/11/2013 (dep. 2014), De Cesare, Rv. 258899 ed in altre prec. conf.
[56] In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa in TAR Campania (NA) Sez. 8 n. 1347 del 1/3/2021 ove si esclude che le disposizioni di cui agli artt. 96 e ss. del TU diano “in alcun modo vita a un procedimento amministrativo di autorizzazione in sanatoria su istanza del privato, limitandosi a consentire la conservazione del manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica preventiva, una volta che la vicenda penale sia stata comunque definita”.
[57] Lo ha precisato, sotto la vigenza della l. 74\64 Cass. Sez. 3, n. 1509 del 6/12/1983 (dep. 1984), Pone, Rv. 162710
[58] Cass. Sez. 3, n. 1710 del 12/12/1984 (dep. 1985), Barone, Rv. 167984
[59] Cass. Sez. 3, n. 5611 del 13/5/1986, Marani, Rv. 173133
[60] Cons. di Stato Sez. 3, n. 4142 del 31\5\2021 la definisce “presupposto indispensabile”. Anche la Corte costituzionale (sent. 101\2013) ha affermato che “l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare”.
[61] V., tra le più recenti, Cass. Sez. 3 n. 49679 del 18/5/2018, Paccusse, non massimata, ove si è ritenuto irrilevante il deposito a sanatoria del progetto e la mancanza di violazioni sostanziali delle norme tecniche che disciplinano l'edificazione nelle zone sismiche ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
[62] CANAL La sanatoria edilizia e la sanatoria sismica cit.
[63] V. ad es. TAR Campania (NA) Sez. 7 n. 3450 del 20/5/2022; TAR Campania (NA) Sez. 8 n. 1347 del 1/3/2021; TAR Lazio (LT) Sez. 1 n. 376 del 13/10/2020. V. anche TAR Abruzzo (AQ) Sez. 1 n. 415 del 13/7/2022
[64] TAR Lazio (LT) n. 376\2020, cit.
[65] TAR Campania (NA) n. 1347/2021, cit.
[66] Cons. di Stato n. 4142\2021, cit. nell’indicare, come già detto, la natura di indispensabile presupposto dell’autorizzazione sismica per ottenere il rilascio del titolo edilizio aggiunge, tra parentesi, le parole “anche quello in sanatoria” implicitamente riconoscendo, dunque, tale possibilità, come fa anche Cons. di Stato Sez. 6, n. 3096 del 15/4/2021
[67] Così Cons. di Stato Sez. 6, n. 3963 del 19/5/2022
[68] CANAL La sanatoria edilizia e la sanatoria sismica cit.
[69] Corte cost. n.101 del 29/5/2013 e n. 2 del 13/1/2021, quest’ultima commentata da AMANTE Appunti sulla sanatoria sismica in Urb. e App., n. 2\2021, pag, 197
[70] In CANAL La sanatoria edilizia e la sanatoria sismica cit. correttamente si osserva come, in caso di intervento da regolarizzare ubicato in zona sismica, “non sia concepibile un rilascio della sanatoria in assenza della doppia conformità anche strutturale/sismica dell’intervento e ciò senza che sussista alcuna possibilità di prescrivere adeguamenti strutturali di sorta”.
[71] Così CANAL, op. cit.
[72] CANAL, op. cit. Sollecita invece “una più approfondita valutazione del complessivo rapporto che viene ad instaurarsi tra il rilascio dell'autorizzazione sismica in sanatoria (o postuma) e la (eventuale) lesione del relativo bene tutelato”, TANDA La rilevanza dell'autorizzazione sismica in sanatoria (o postuma) ai fini della sussistenza dell'illecito di cui agli artt. 94 e 95 t.u. edilizia in Riv. Giur. Ed. n. 3/2019, pag. 815
[73] Tra le più recenti, Cass. Sez. 3, n. 19196 del 26/2/2019, Greco Rv. 275757; Sez. 3, n. 11271 del 17/2/2010, Braccolino, Rv. 246462. Le stesse conclusioni sono state peraltro tratte con riferimento ai reati in materia di costruzioni in cemento armato in Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212
[74] Come stabilito nella risalente Cass. Sez. 3 n. 6648 del 16/3/1990, Talamo, Rv. 184243
[75] V. Cass. Sez. 3, n. 3209 del 29/1/1998, Lombardi, Rv. 210291
[76] Cass. Sez. 3, n. 26123 del 12/4/2005, Colturri, Rv. 231940
[77] Cass. Sez. 3, Sentenza n. 32706 del 7/4/2015, Tufano, Rv. 264520. Con riferimento al decreto penale v. Cass. Sez. 3, n. 6050 del 27/9/2016 (dep. 2017), Verga, Rv. 268832
[78] Corte cost. n. 294 del 22/7/1996. La Corte ha infatti chiarito che in tal caso la sanatoria interviene “ (…)in un momento successivo al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, la cui definitività si è realizzata quando l'imputato si trovava ancora in situazione di illegalità (formale) per avere compiuto opere edilizie abusive senza avere il titolo abilitativo; (…) rientra nella discrezionalità del legislatore, una volta individuata una causa estintiva del reato, fissare, in relazione allo status dell'azione penale, i limiti temporali di questa causa estintiva, che deriva, si noti, da una iniziativa dello stesso responsabile dell'abuso (richiesta di concessione in sanatoria il cui rilascio è subordinato al pagamento a titolo di oblazione di una misura maggiorata del contributo di concessione, perfino in caso di concessione gratuita”
[79] Cass. Sez. 3, n. 28530 del 11/5/2018, Vivolo, Rv. 273350
[80] Cass. Sez. 3, n. 27982 del 2/3/2021, Di Sano, Rv. 281711
[81] Cass. Sez. 3, n. 19982 del 17/1/2020, Vitale, Rv. 279503. Conf. Sez. 3, n. 51599 del 28/9/2018, Mauracheea, Rv. 274095
[82] Cass. Sez. 3, n. 15752 del 16/1/2020, Campagna, Rv. 279384 ed altre prec. conf.
[83] Si tratta di questione sulla quale la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciata per oltre un ventennio, ma che talvolta continua ad essere oggetto di discussione a causa di distorte letture di principi reiteratamente affermati, tanto che recentemente, in due diverse sentenze, la Corte di cassazione, nel tentativo di fare definitivamente chiarezza, ha ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza in materia (Cass. Sez. 3, n. 49687 del 7/6/2018, Bruno, non massimata, Sez. 3, n. 56678 del 21/9/2018, PM in proc. Iodice, Rv. 275565 annotata in questa Riv. n. 2\2019 da DI LANDRO Reati in tema di «assenza» di autorizzazione e responsabilità del titolare di autorizzazione: un problema ancora aperto. V. anche Sez. 3, n. 17866 del 29/3/ 2019, PM in proc. De Simone, non massimata).
[84] Cass. Sez. 3, n. 33419 del 8/4/2021, Gavioli, Rv. 282234, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 26834 del 8/9/2020, Barletta, Rv. 280266. Con specifico riferimento al permesso in sanatoria v. Sez. 6 , n. 13148 del 8/3/2022 , Calabrò, Rv. 283111 nonché la più recente Sez. 3, n. 30586 del 8/6/2022, Avellone ed altri, non massimata relativa a rilascio di sanatoria in violazione dell’art. 36 TU Ed.
* Articolo già pubblicato nel n. 3\2022 di lexambiente.it

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
