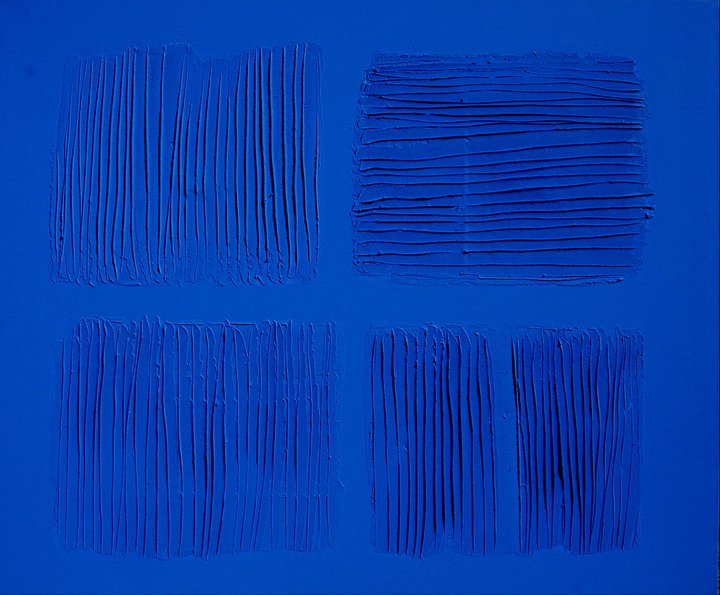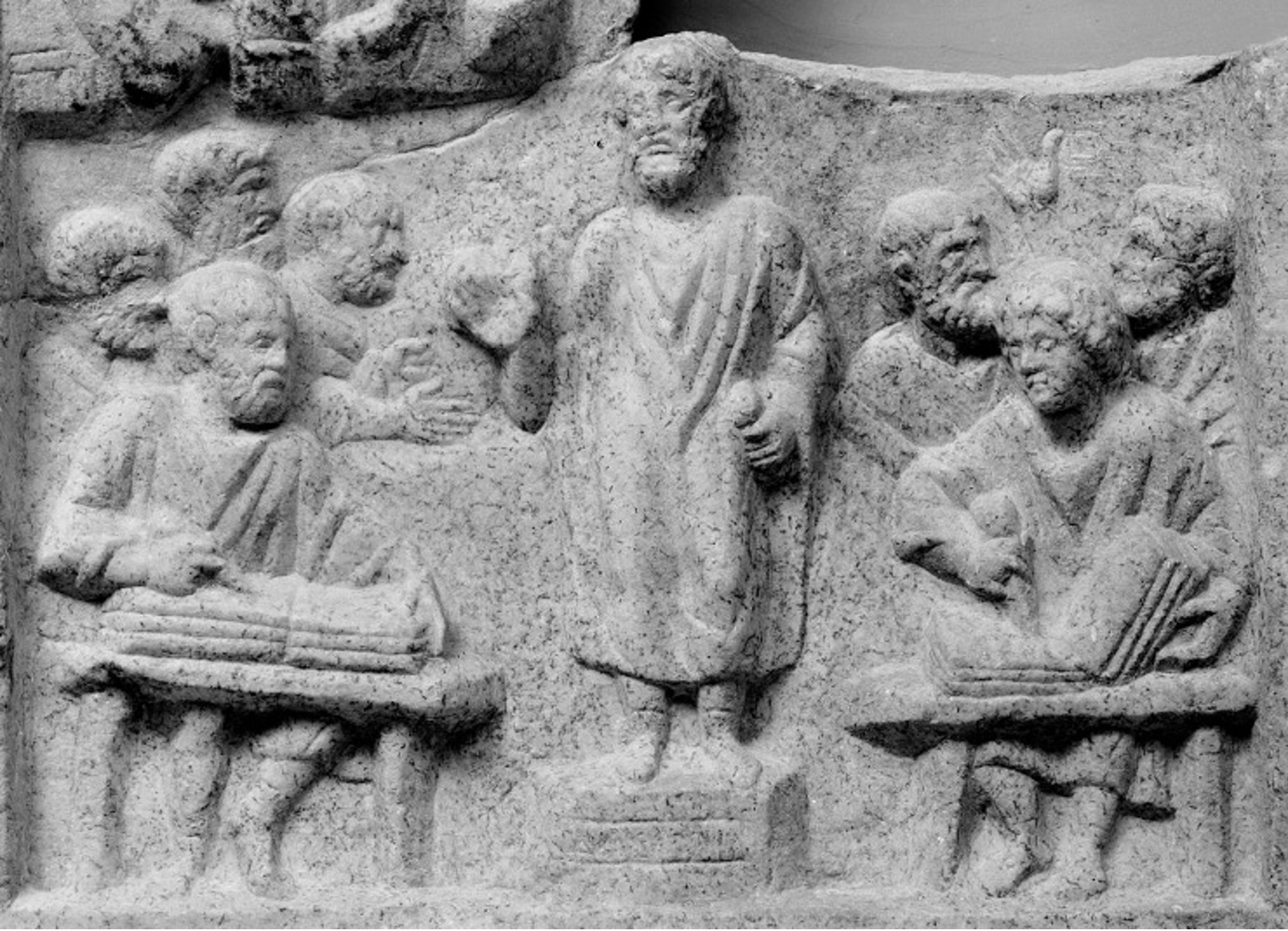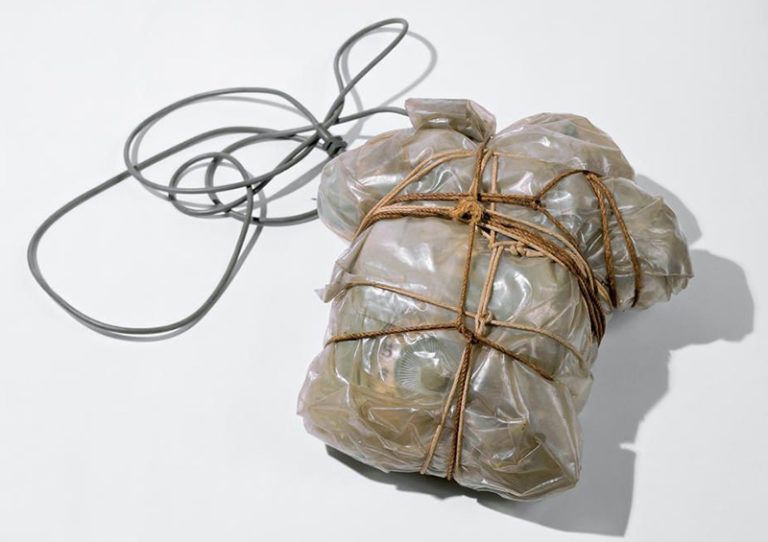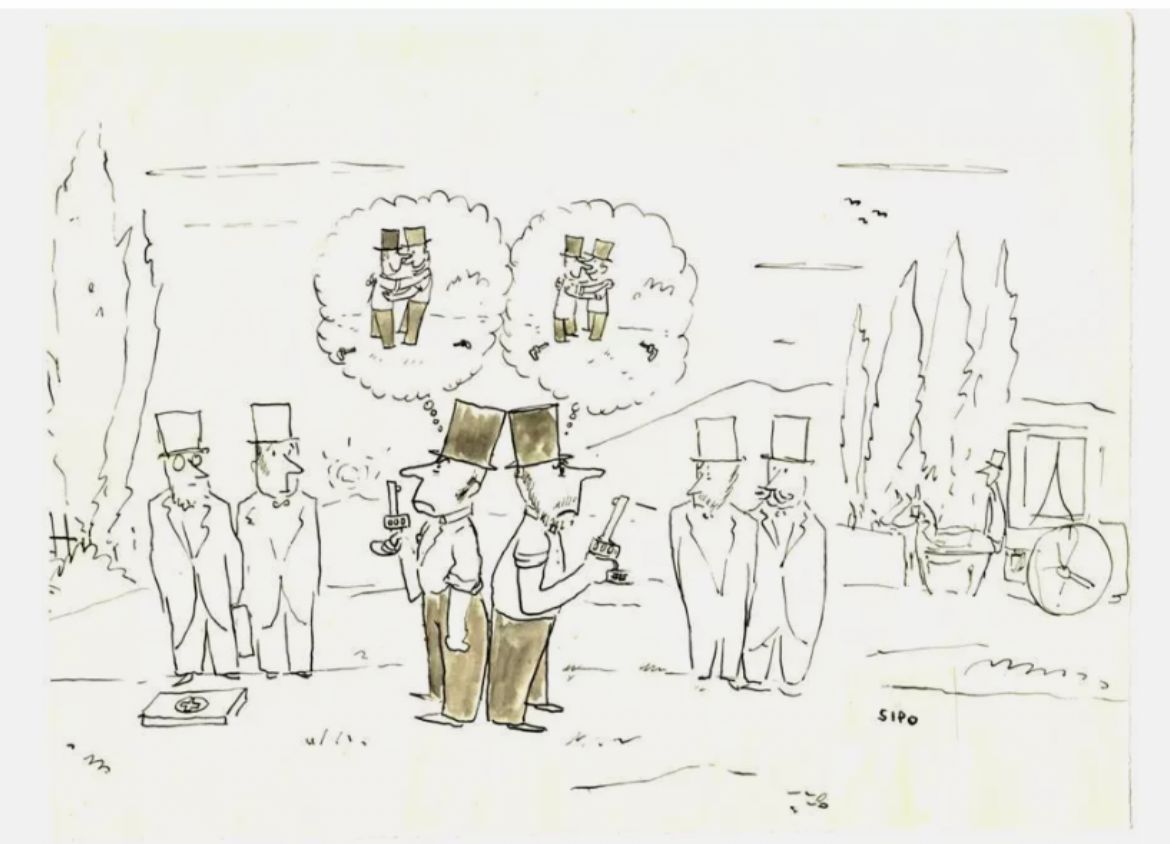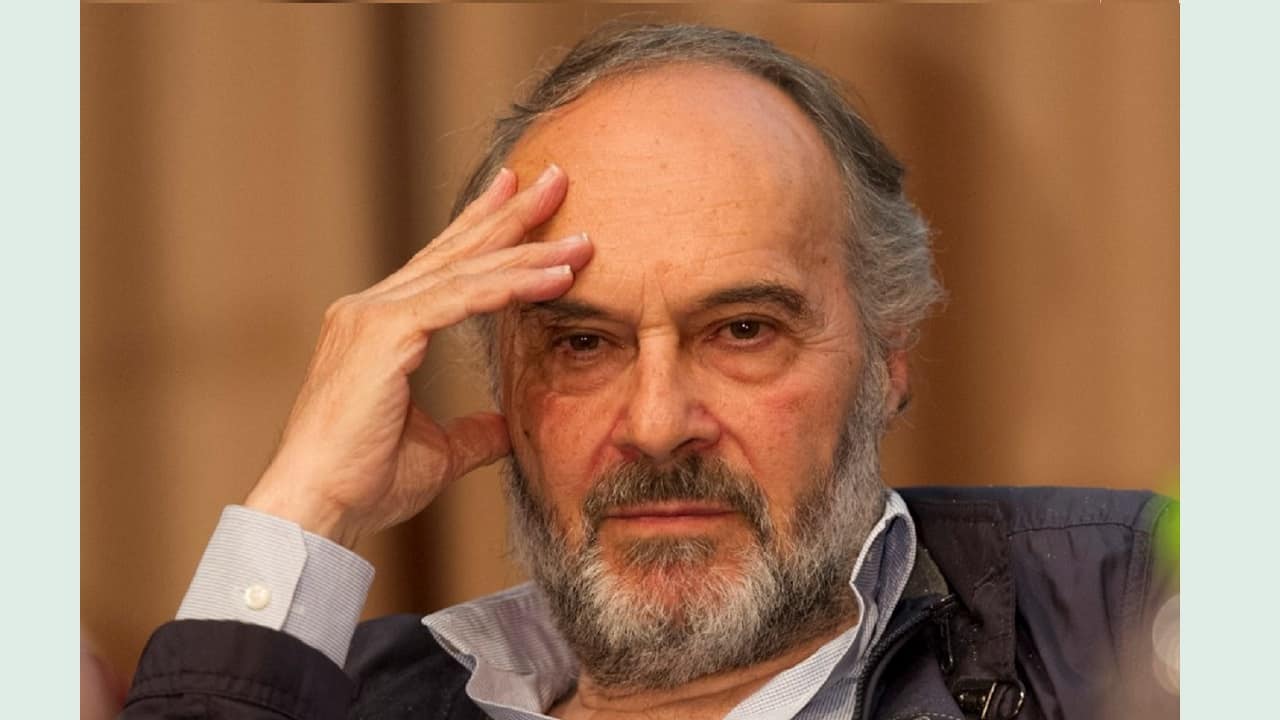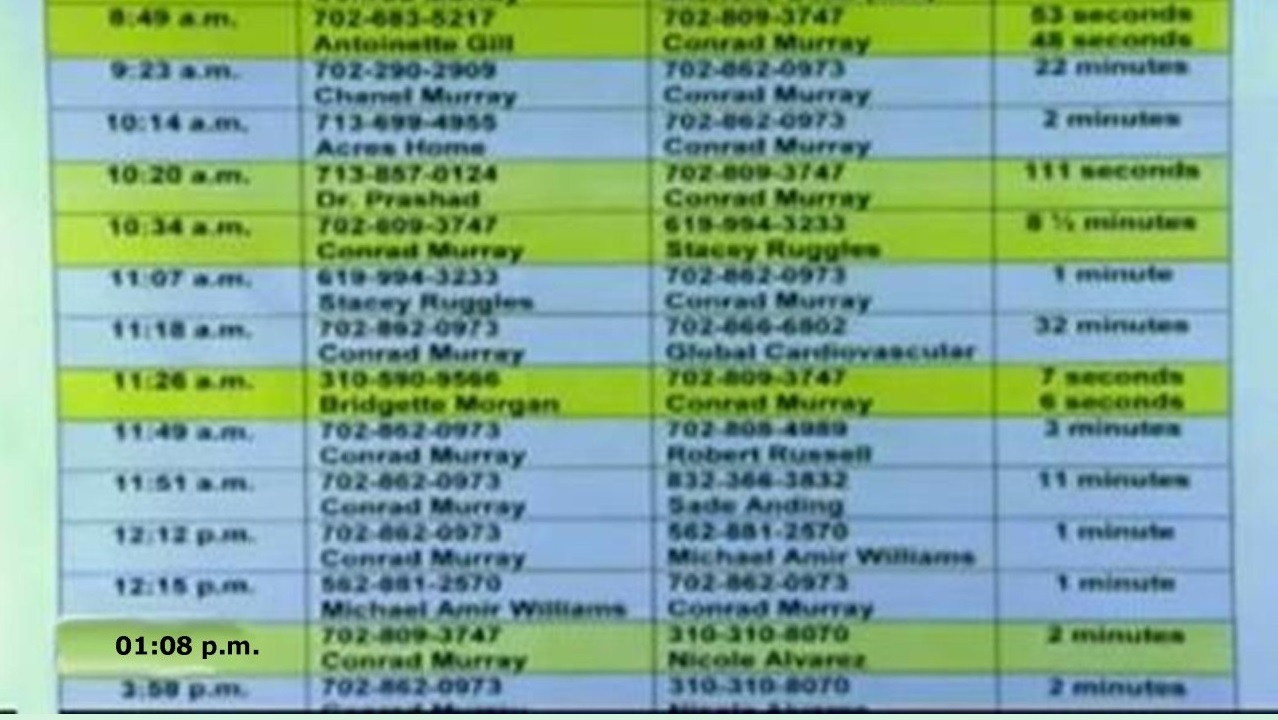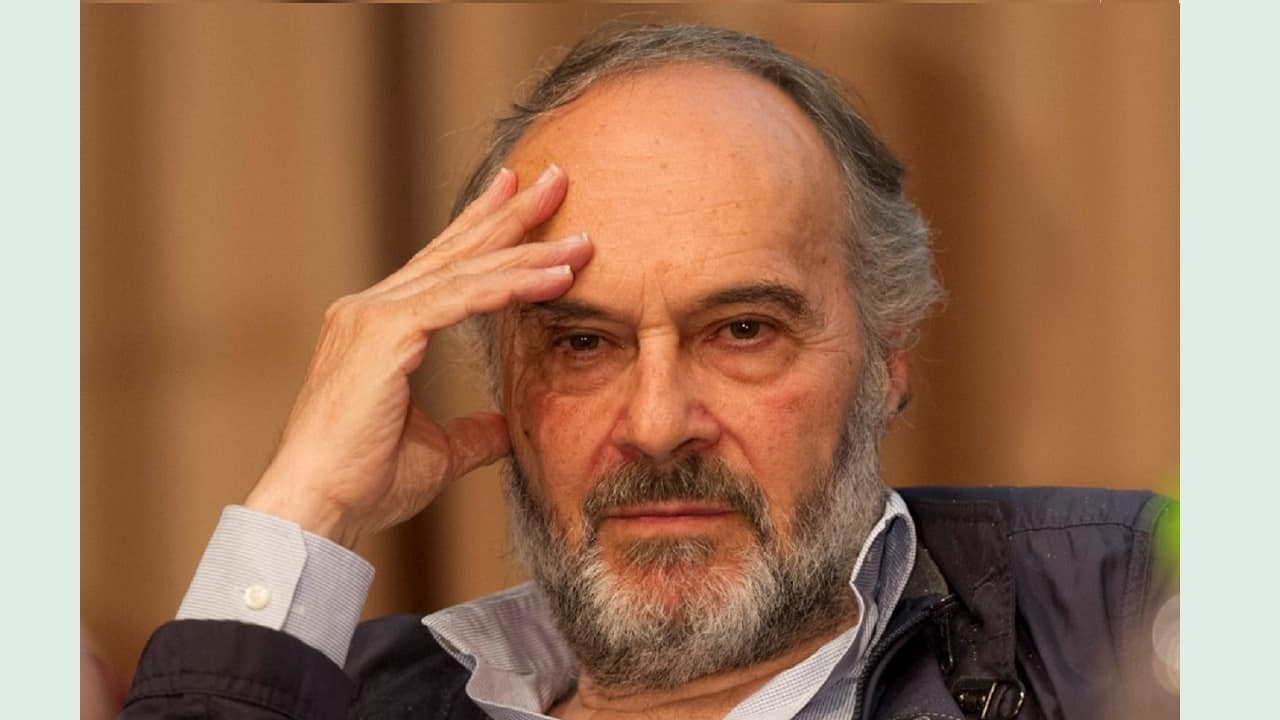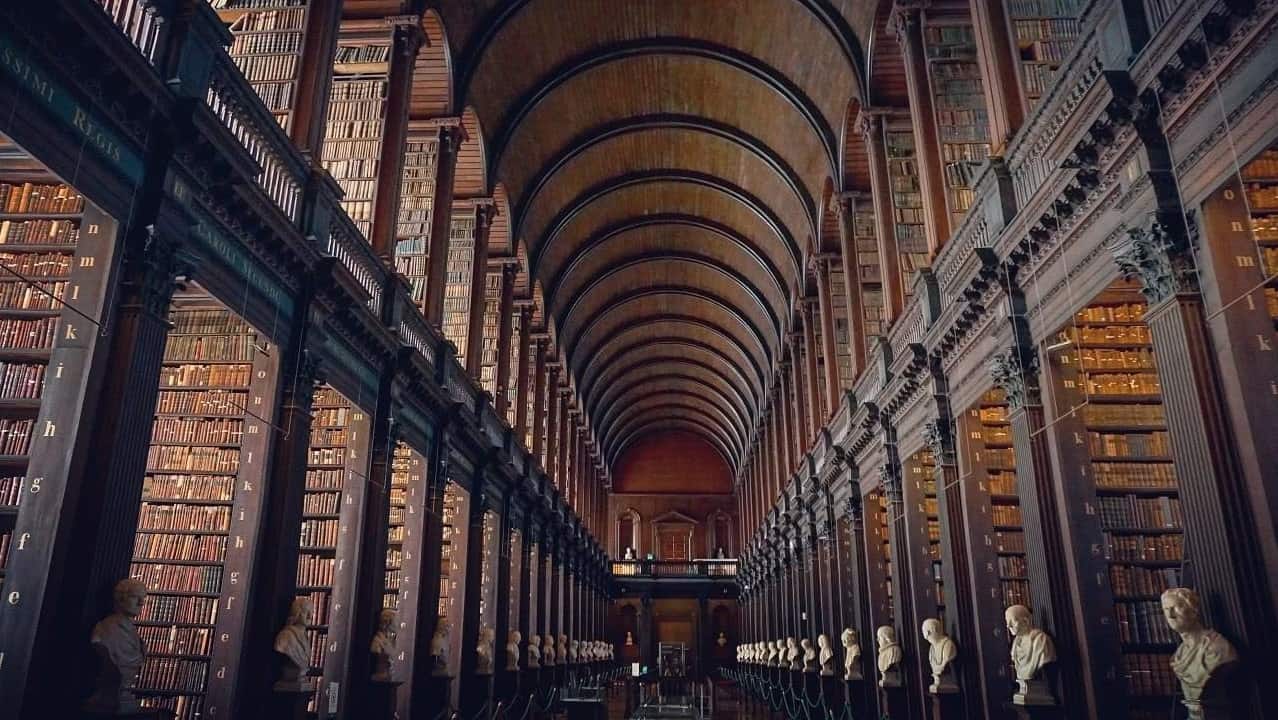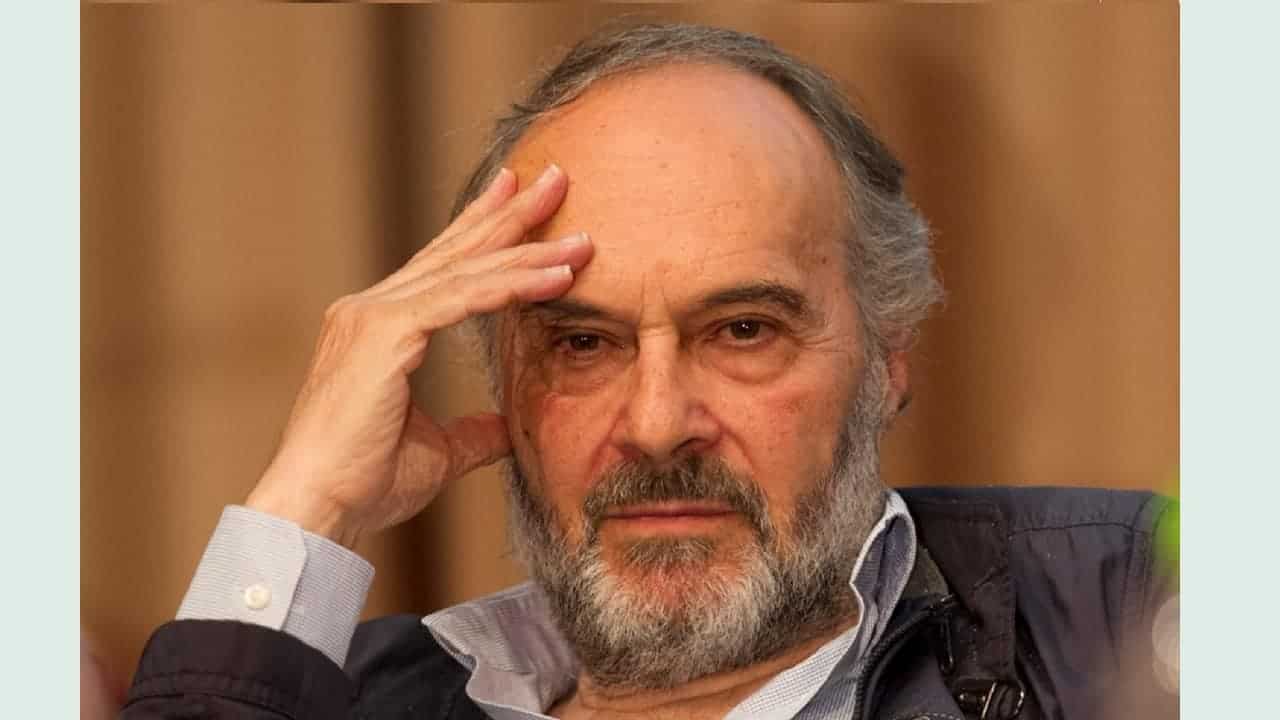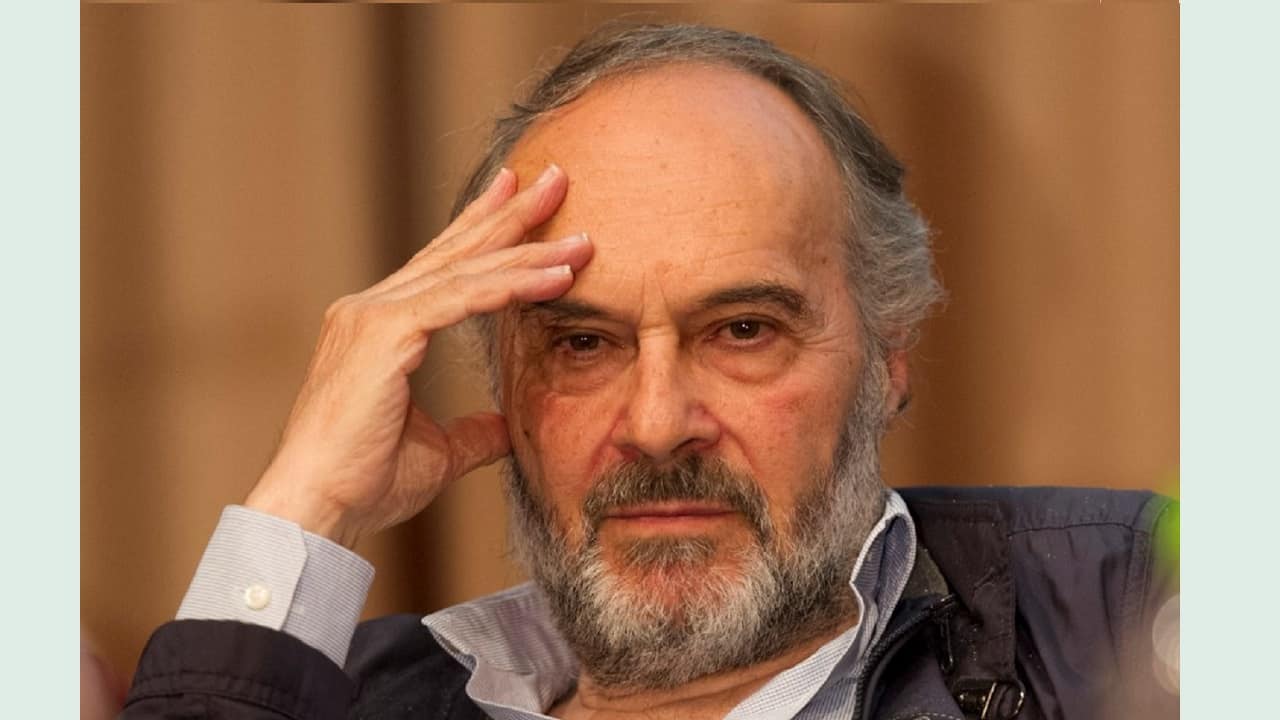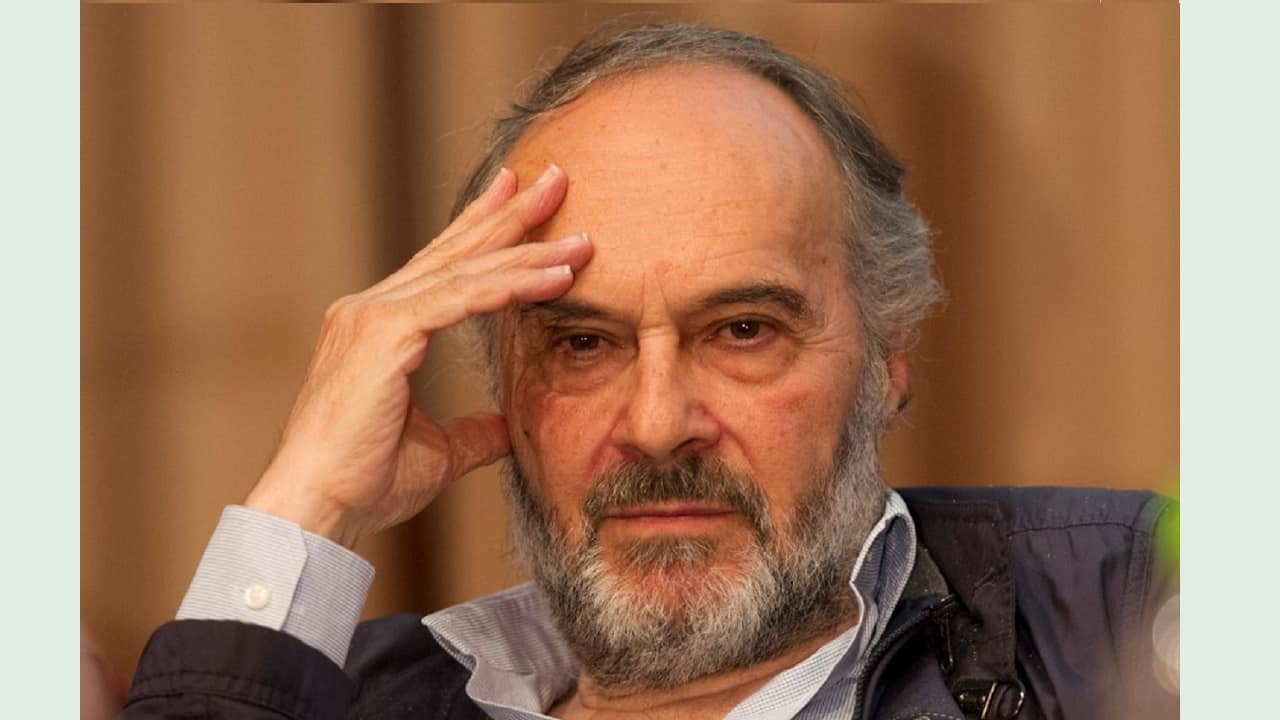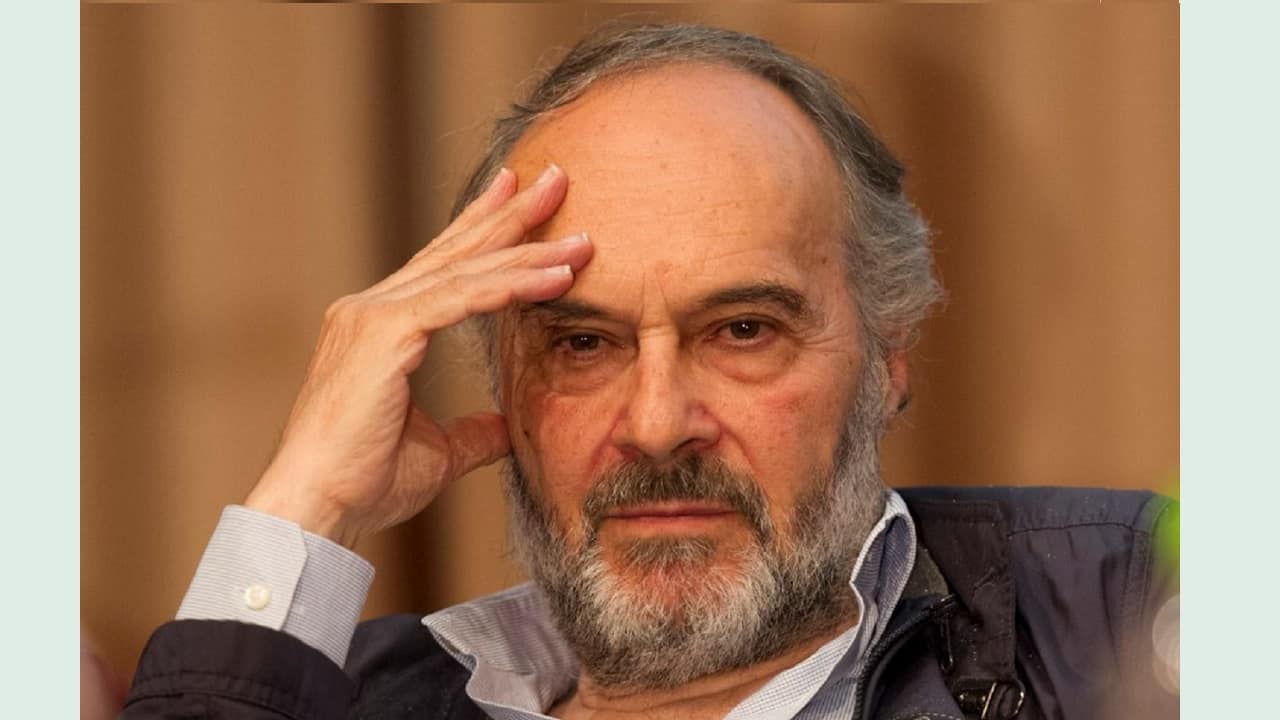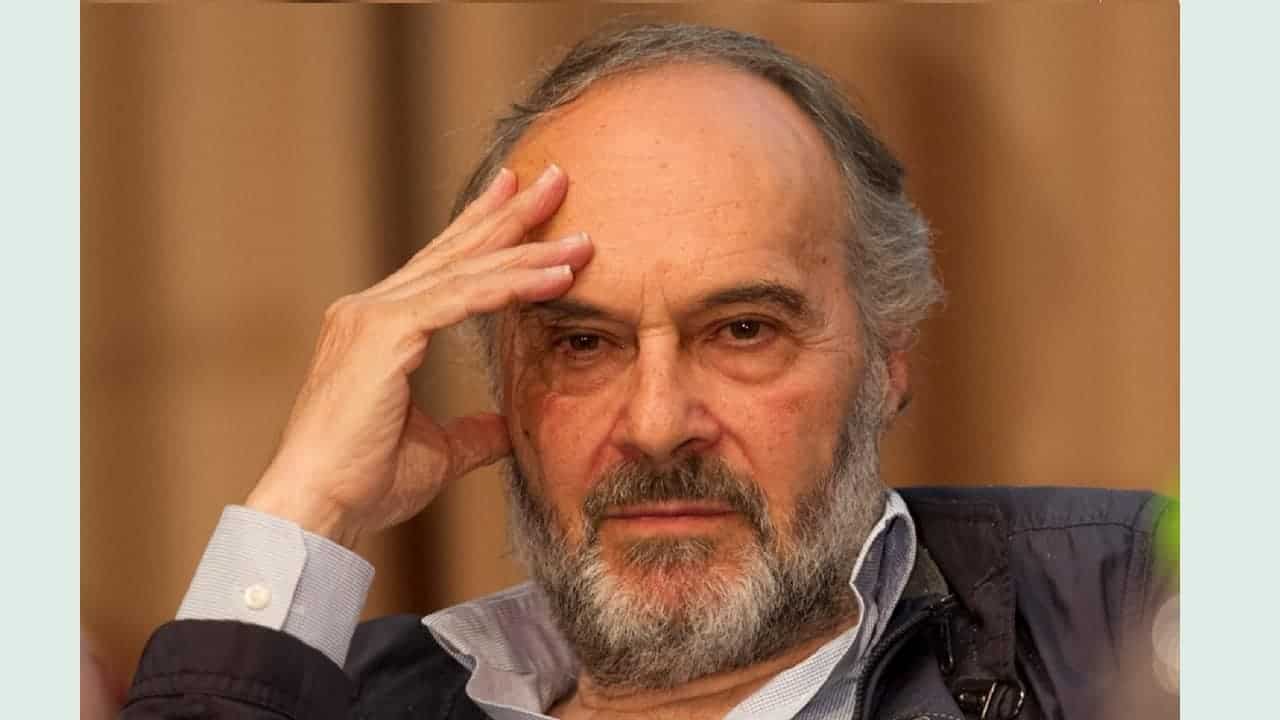
Referendum e art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p.: meglio un intervento del Parlamento
di Giorgio Spangher
Se c’è una parte della Costituzione che è in qualche modo datata è sicuramente – seppure parzialmente – quella dove sono regolati i diritti e doveri dei cittadini, ed in questo contesto, quella dei rapporti civili, che risentono profondamente dell’impianto ordinamentale e di quello processuale dell’epoca in cui fu redatta.
Soffermandosi sul tema della libertà personale, in relazione alla specificità del tema qui affrontato il riferimento va ad alcuni profili dell’art. 13 Cost.
In primo luogo, lo stesso riferimento alla libertà appare riduttivo dovendosi ormai fare il più ampio riferimento “alle libertà” in quanto capaci di coprire più ampi spazi rispetto a quella più strettamente personale.
In secondo luogo, va evidenziato il superato riferimento all’autorità giudiziaria quale soggetto garante della libertà e legittimato alla riduzione della libertà. Invero, il riferimento era riconducibile alla struttura ordinamentale, che accumunava giudici e pubblici ministeri, capaci di funzioni spesso fungibili, oggi largamente superate nel nuovo modello processuale che vede una titolare dell’iniziativa tesa alla restrizione delle libertà, l’altra titolare del potere decisorio.
Nel contesto del modello processuale del 1930 e di quello costituzionale del 1948, la restrizione della libertà prima della condanna prevedeva, come risulta dal comma quinto dell’art. 13 Cost., la carcerazione preventiva di cui il legislatore doveva fissare solo i termini di durata massima. Era evidente, in un sistema inquisitorio nel quale, dopo l’archiviazione, già iniziava il processo (morte del reo; art. 150 c.p. e morte dell’indagato/imputato: art. 69 c.p.p.) che potesse esserci l’anticipazione della restrizione (preventiva) della libertà con la misura del carcere (unica misura prevista). Il provvedimento era obbligatorio o facoltativo (a discrezionalità vincolata) disposto – come detto – dal p.m. e dal giudice istruttore, in presenza di sufficienti indizi di colpevolezza.
Addirittura anticipata rispetto alla riforma processuale (l. n. 330 del 1988), la disciplina della libertà personale prima della condanna nel nuovo processo risulta modificata radicalmente e subisce progressivamente assestamenti in senso garantista che ne modificano gli assetti: essendo peraltro questi elementi noti, non richiedono particolari notazioni ed approfondimenti.
Il riferimento si indirizza alle correzioni delle distorsioni del c.d. rito ambrosiano, all’anticipazione ed estensione delle garanzie difensive, alla rimodulazione dei presupposti delle esigenze cautelari, al rafforzamento della disciplina del riesame, attuate progressivamente con le ll. n. 332 del 1995 e n. 47 del 2015.
Nel nuovo modello trovano così collocazione le esigenze cautelari, superando quel “vuoto dei fini”, dell’art. 13 Cost., giustificato dalla funzione anticipatrice della condanna, cui si è fatto cenno. Con la l. n. 517 del 1955 per la cattura facoltativa si faceva riferimento alle qualità morali della persona e alle circostanze del fatto.
Si recupera a tal fine quanto la Corte costituzionale ebbe a sottolineare in alcune pronunce così da divenire oggetto delle modifiche di cui all’art. 254, comma 2, introdotto dalla l. n. 532 del 1982, con l’art. 4.
Va sottolineato, del resto, che per effetto della direttiva n. 59 della l. delega, in qualche modo, le misure cautelari si sarebbero dovute applicare dopo l’esercizio dell’azione penale, il che giustifica gli originali riferimenti dell’art. 274 c.p.p. (sintomatico il riferimento non chiaro al pericolo di fuga dell’”imputato”: dalla pena, dalla prova o dal processo).
Ricalibrata la lett. a dell’art. 274 c.p.p., con il rafforzamento (attualità e concretezza, nonché con l’esclusione di implicazioni della mancata collaborazione, con tempi determinati della durata della misura), anche dell’invalidità motivazionale, già presente nell’ordinanza ex art. 292 c.p.p., la dottrina (almeno una parte di essa) non ha mancato di evidenziare la precarietà di quanto previsto dalla lett. c dell’art. 274 c.p.p., sotto il profilo della presunzione di innocenza.
Invero, la condizione di un soggetto gravemente indiziato di delitto si sostanzia a fini cautelari nel pericolo attuale e concreto di reiterazione di “delitti” (la lett. c contiene l’unico riferimento del codice alle parole “criminalità organizzata”).
Il dato risulta deducibile dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla pericolosità del soggetto desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti, senza che i citati elementi possano essere desunti esclusivamente dalla gravità del titolo del reato per cui si procede. L’inserimento di quest’ultima precisazione (l. n. 47 del 2015, pure alla lett. b dell’art. 274 c.p.p.) è stato previsto anche in considerazione del fatto che questo si innesta nella ricostruzione che ne prospetta il pubblico ministero, seppur con il controllo del giudice, peraltro sulla base del solo materiale d’accusa, spesso frutto della informativa di p.g.
L’elemento della criticità, nella prospettiva indicata, è quello relativo all’ampia categoria dei “reati della stessa specie”.
Anche se i presupposti soggettivi e fattuali del pericolo, pur discutibili, sono precisati, anche se le situazioni di esclusione sono delineate, anche se l’ambito della quantità e qualità delle misure da applicare sono definite (in coerenza con il sistema ex art. 280 c.p.p., pur con l’eccentricità dell’unica presenza espressa del finanziamento illecito ai partiti politici), resta una certa fluidità del concetto di reato della stessa specie, definito dalla giurisprudenza non solo in termini di offensività al medesimo bene giuridico, ma anche di identità della natura in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive ma soprattutto resta la sua estraneità alla dimensione endoprocessuale del pericolo sotteso alla cautela, in favore di una valutazione prospettica di possibili comportamenti tesi alla protezione (anticipata) della collettività rispetto ad una premessa (ancora da verificare) di una prognosi non certa. Sotto questo profilo, si giustifica la riferita tensione con l’art. 27, comma 2, Cost. senza considerare ulteriormente che l’art. 5, comma 1, lett. c della Cedu fissa in termini più stringenti (motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato) il presupposto di operatività della cautela.