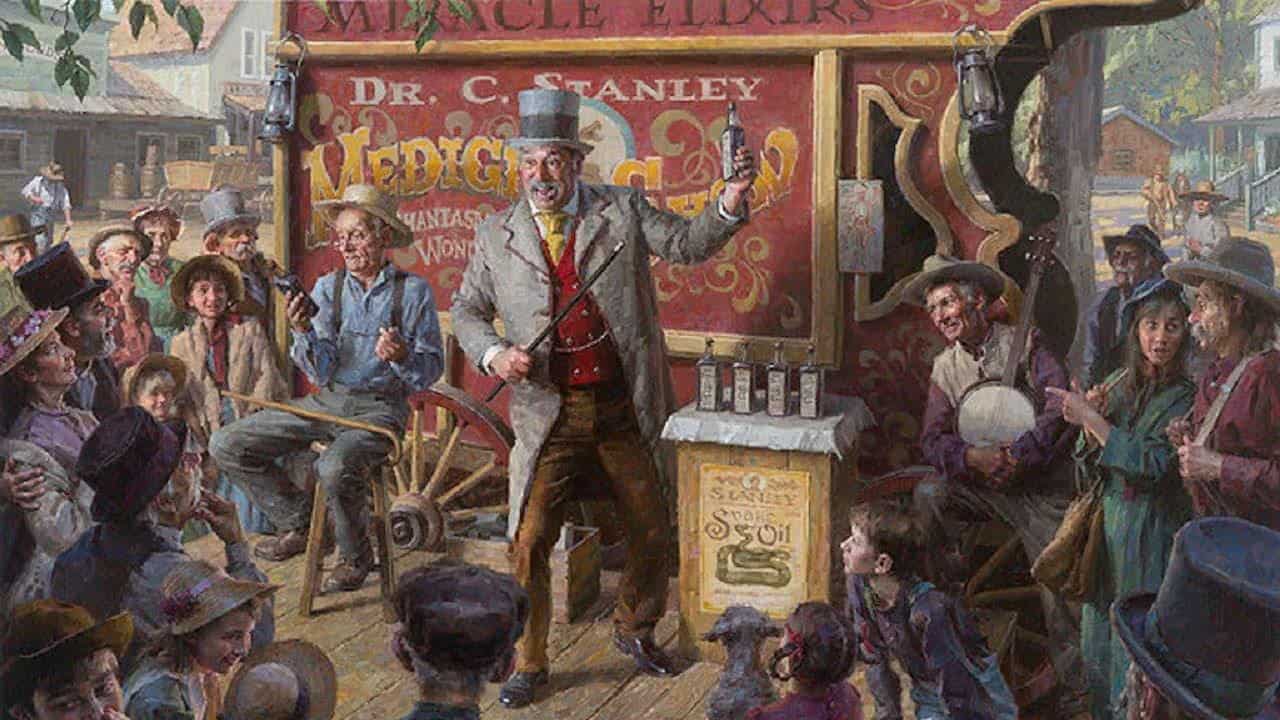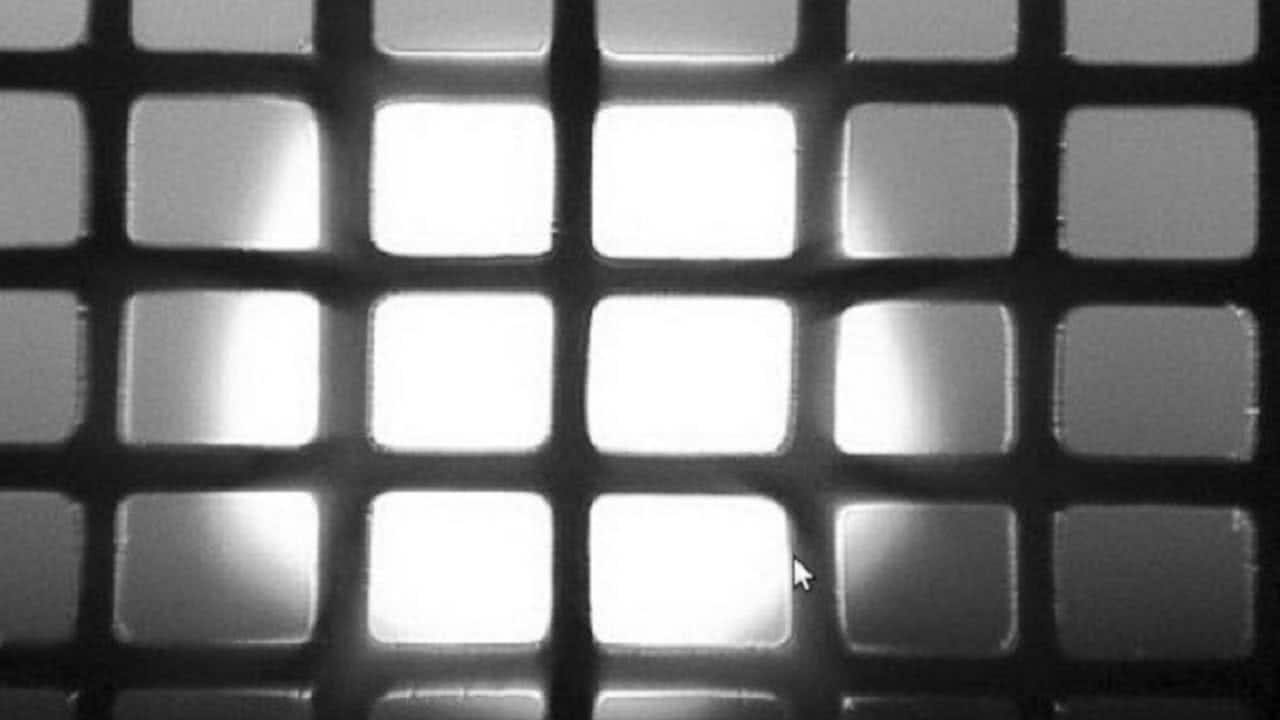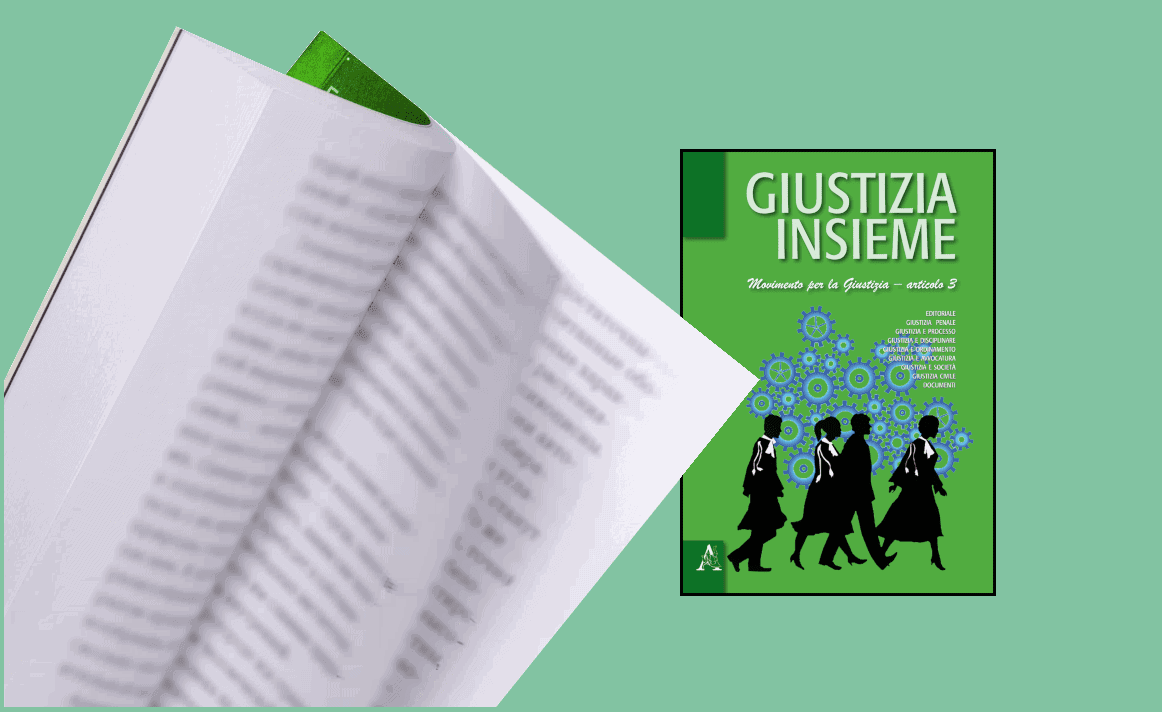Appunto per una giustizia non solo più efficiente, ma anche più giusta*
di Glauco Giostra
1. Il dibattito sulla riforma del processo penale ha suscitato un grande interesse non soltanto da parte degli addetti ai lavori, ma anche della politica, dei media e di ampi settori della società civile. Ed è questo un dato confortante perché sembra attestare la consapevolezza che la giustizia penale esprime la cifra della civiltà di un Paese. Non si può purtroppo non aggiungere, però, che il confronto ha spesso conosciuto sgangherate argomentazioni e accenti scomposti, rimandando una sensazione di deprimente rozzezza. Che ciascun locutore potesse ritenere di avere la giusta ricetta e la proclamasse stentoreamente può essere comprensibile, anche se poco giustificabile: mai, come in questa materia, vale il monito di Voltaire secondo cui «il dubbio può non essere piacevole, ma la certezza è ridicola». Ma a segnare un preoccupante degrado del confronto pubblico è la contagiosa tendenza a demonizzare le idee avverse, usando linguaggi e toni da stadio, o a invocare a sproposito l’usbergo di sacri principi costituzionali o di prescrizioni sovranazionali, con argomenti che, avrebbe detto Cordero, non valgono più di un pugno battuto sul tavolo.
Ciò può trovare spiegazione, non certo giustificazione, nella peculiarità dell’attuale situazione politica. Proprio perché, come si è detto, la giustizia penale è la più fedele carta di identità di un Paese, le scelte che la riguardano non sono semplici soluzioni di ingegneria giuridica per elaborare un efficiente e affidabile strumento di conoscenza, ma, presupponendo opzioni valoriali che definiscono lo statuto dell’individuo di fronte all’Autorità, hanno sensibilissime implicazioni culturali e politiche. Nella situazione data, un Governo che si avvale del sostegno di forze con opposte idealità, in particolare con speculari concezioni del rapporto tra Stato e cittadino, non può non incontrare insormontabili difficoltà ad approntare una riforma della giustizia penale razionale e coerente. La necessità di provvedere anche per ottenere gli ingenti finanziamenti dall’Europa può avere funzionato da collante, insieme alla capacità del Ministro della Giustizia e del Presidente del Consiglio di tenere insieme forze congenitamente centrifughe. Tuttavia, il compromesso cui inevitabilmente si è talvolta dovuti ricorrere non è di per sé un buon risultato, poiché per la giustizia penale non si tratta – come per molte altre trattative politiche – di trovare una linea mediana che soddisfi, con reciproci sacrifici, i contrapposti fronti ideologici, né di concedere qualcosa sia all’uno, sia all’altro per bilanciare le opposte pretese: il sistema giustizia rischia di perdere credibilità e di sommare gli errori di entrambi i poli dialettici, come talvolta è puntualmente avvenuto[1].
I toni manichei che hanno accompagnato e che verosimilmente continueranno ad accompagnare gli sviluppi della riforma trovano spiegazione o nella mancata consapevolezza della complessità della materia e delle controindicazioni di ogni soluzione, oppure nel desiderio di collocarsi, di marcare il proprio posizionamento politico-culturale, per il timore che approcci più problematici – di questi tempi distorsivamente percepiti come esitanti – condannino all’invisibilità mediatica o, peggio, siano causa di un’emorragia di consensi. Difficile dire quale spiegazione sia meno preoccupante.
2. Molti e molto autorevolmente interverranno qui a commento degli aspetti qualificanti dell’importante progetto all’esame del Parlamento: indugiare sui medesimi, da parte mia, potrebbe aggiungere ben poco. A me preme parlare di ciò su cui il disegno riformatore sostanzialmente tace, e di cui invece non si può non parlare nel momento in cui ci si ripromette di miglio rare il nostro modo di rendere giustizia. Almeno, se si vuole non soltanto una giustizia più efficiente e più rapida, secondo il meritorio e non disinteressato obbiettivo del momento, ma anche una giustizia più giusta[2]. Beninteso, per essere giusta la giustizia deve potersi realizzare in modo efficiente e in tempi ragionevoli, ma prima di ogni altra cosa deve costituire il più credibile sforzo per conseguire la verità, dando fondo a tutte le risorse conosciute, compatibilmente con il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.
3. Il tornante epistemologico imboccato dal Codice di rito dell’89 – come è noto – aveva il suo punto di svolta nella prova dichiarativa. Si affermò un nuovo verbo processuale: tendenzialmente, l’unica prova attendibile, l’unico mattone utilizzabile per costruire la sentenza doveva essere la prova formata in contraddittorio. Le acquisizioni della psicologia cognitiva avevano da tempo «sbugiardato» la convinzione sottesa all’impianto del Codice del 1930, secondo cui il fatto storico, come un mosaico frantumato, lascia nella realtà fisica e nella percezione sensoriale umana tracce che è compito dell’investigatore rinvenire (investigazione come ricerca delle vestigia facti, cioè impronte del fatto). Non importa la tecnica di acquisizione di questi «reperti cognitivi”: più tessere del mosaico vengono recuperate, più agevole e attendibile sarà il compito del giudice che deve ricomporlo. Opzione metodologica che sarebbe senz’altro da sottoscrivere se la persona informata sui fatti fosse una res loquens e il suo prodotto narrativo non fosse destinato a cambiare a seconda di chi, come, dove, quando la compulsa. Le scienze della mente, invece, avevano da sempre dimostrato che la rievocazione del ricordo viene sensibilmente influenzata dalla tecnica maieutica: con il mutare del forcipe muta, talvolta anche in modo radicale, la conformazione del feto della memoria. Si convenne allora – e ancor oggi nessuna evidenza scientifica induce a riconsiderare quell’opzione – che la migliore levatrice del ricordo fosse la formazione dialettica della prova testimoniale. Quanto l’inquirente pubblico o privato raccoglie per mettere a punto la linea accusatoria o difensiva è materiale conoscitivo di scarto: ad avere valore probatorio, di regola, è soltanto ciò che il teste riferisce al giudice incalzato dalle domande delle parti.
4. Questa scelta gnoseologicamente qualificante del Codice vigente ha dovuto convivere con incongruenze normative e con degenerazioni delle prassi giudiziarie[3], che hanno compromesso la coerenza del sistema. Quanto alle prime, basterebbe ricordare la regola secondo cui, solo che sopraggiunga un’impossibilità di «interrogare» il testimone in dibattimento, si possono recuperare con valore di prova le sommarie informazioni rese dal soggetto durante le indagini (art. 512 c.p.p.) e che, senza l’accidente occorsogli, non sarebbero state neppure conoscibili dal giudice del dibattimento. Oppure la disposizione che conferisce valore di prova alle dichiarazioni testimoniali assunte in contraddittorio in altro procedimento (art. 238, primo comma, c.p.p.): un contraddittorio evidentemente privo di qualsiasi valore epistemologico nel processo a quem, a cui con tardiva e insufficiente resipiscenza il legislatore ha cercato di conferire senso, pretendendo che per essere traslabili in altro procedimento le dichiarazioni de quibus debbano essere state assunte con la presenza del medesimo difensore che assiste l’imputato nel processo di destinazione (art. 238, comma 2-bis, c.p.p.). Oppure, ancora, la norma che riconosce valore di prova alla testimonianza de relato, anche quando il teste indiretto sin dall’inizio fa riferimento a persona che sa già non essere più in grado di deporre e, quindi, di smentirlo (art. 195, terzo comma, c.p.p.). Per non dire, più in generale, dell’incongruenza di un appello tendenzialmente e sostanzialmente cartolare, in esito al quale può essere censurata e riformata una sentenza di primo grado fondata su testimonianze assunte dialetticamente davanti al giudice che l’ha emessa.
Queste e altre incongruenze non andrebbero sottovalutate, pena la credibilità del sistema: se vi fosse la volontà di rimuoverle, peraltro, non sarebbe complicato porvi rimedio, e in parte la giurisprudenza e il legislatore si stanno muovendo in questa direzione. Ma vi è una criticità molto più insidiosa, sotterranea, corrosiva; una criticità, soprattutto, a cui non è facile apprestare un antidoto: inutile cercare nella «farmacia giuridica» un medicinale che prevenga o sani questa patologia. Bisogna attrezzarsi per imparare a diagnosticarla e per ridurne al minimo gli effetti con una pluralità di interventi sinergici.
Se il Codice vigente ha rimosso l’ingenuità epistemologica su cui poggiava quello precedente – vale a dire l’irrilevanza della tecnica di elicitazione nella prova testimoniale −, temo che esso stesso poggi su un presupposto non meno fallace: l’inalterabilità del patrimonio mnestico. L’attuale sistema è costruito intorno all’idea che alla fonte dichiarativa possa attingere chiunque in qualsiasi fase del procedimento e con qualsiasi metodo, purché l’unico sapere testimoniale utilizzabile in sentenza resti quello assunto in contraddittorio dinanzi al giudice della decisione. Ciò presuppone che il ricordo costituisca una sorta di reperto archeologico che giace, inerte, nello scantinato della memoria; che il problema sia soltanto quello di ritrovarlo, usando la potente «torcia» del contraddittorio e di riportarlo nell’appartamento dell’attualità, a disposizione di coloro che ne chiedono notizia. Il ricordo, invece, è materia viva e deteriorabile. Talvolta, addirittura, frutto di un’involontaria creazione. Ciò che il contraddittorio è in grado di garantire è la sincerità, non la veridicità delle risposte: nessun esame incrociato riuscirà a far riferire fedelmente quanto originariamente percepito a un dichiarante che crede nella verità del suo falso ricordo[4].
5. «L’oblìo e la memoria – scriveva Borges – sono inventivi». Già l’azione silente di Cronos inavvertitamente sbiadisce un volto, offusca un particolare, confonde le parole ascoltate, oblitera un dato, scuce una sequenza: il ricordo con il trascorrere del tempo diviene spesso «impresentabile» e talora la ragione, solerte, provvede creativamente a ricomporlo. Capita, altre volte, che tra il momento della percezione e quello della rievocazione del percepito invisibili «neuro-sherpa» prendano dall’esterno informazioni, le trasportino nello scantinato e le impastino con il materiale conoscitivo che vi è stato conservato, trasformandolo. Con una sintesi che anche l’ultimo degli studiosi di psicologia forense troverebbe grossolana potremmo dire che tra i fattori in grado di adulterare il ricordo potrebbe essere utile distinguere: il decorso del tempo; i condizionamenti endo-processuali (soprattutto gli «interrogatori») e le suggestioni esterne (soprattutto mediatiche). Sono fattori che, naturalmente, possono concorrere tra loro e con altri, ma che è opportuno tenere separati perché differenti possono essere gli strumenti per neutralizzarne l’azione. Il decorso del tempo. Forse nell’idea originaria del Codice, che prevedeva indagini agili e sommarie e un dibattimento improntato al rispetto del principio di concentrazione, ove realizzata, il de corso del tempo avrebbe dovuto avere meno modo di esercitare la sua azione corrosiva sulla memoria. Ma con il nuovo carico funzionale assegnato alle indagini e con un’articolazione della fase dibattimentale in cui tra le udienze ormai intercorrono mesi e talvolta anni, a essere rievocati con la testimonianza assunta nel contraddittorio delle parti sono, di regola, fatti avvenuti diversi anni prima[5]. Essendo il patrimonio mnestico – come si diceva – materia deteriorabile, sempre più spesso si susseguono i «non ricordo». E altrettanto spesso questi «falli» nel tessuto della memoria vengono rammendati ricorrendo impropriamente a ciò che quello stesso teste aveva dichiarato agli inquirenti: quando non ci si limita a sollecitarne una mera conferma, gli si leggono sue dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero e gli si chiede se si riconosce in quanto a suo tempo affermato, ottenendo quasi sempre una risposta del tipo «Certo, se l’ho detto sarà senz’altro vero». Prassi palesemente illegittima e che tanto rievoca il mortificante dibattimento previgente.
Il supporto normativo sarebbe costituito dall’art. 499, quinto comma c.p.p., a norma del quale «Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti»; ma cosa questa disposizione abbia a che fare con la prassi di un pubblico ministero (o di un difensore) che al teste immemore si rivolge dicendo: «Ora le leggo cosa ricordava in prossimità dei fatti e lei mi dice se si sente di confermare», è difficile capire. Soprattutto quando il vuoto di memoria investe l’intero oggetto della testimonianza, questa surrettizia forma di «aiuto alla memoria» finisce per realizzare di fatto proprio ciò che il vigente Codice si riprometteva di evitare: cioè, che si conferisse valore probatorio agli atti di indagine.
6. «Prima di valutare se una risposta è esatta – ammoniva Kant – si deve valutare se la domanda è corretta». Ciò è tanto più vero nel procedimento penale, durante il quale la persona interrogata cerca istintivamente di intuire dalla domanda quale sia la risposta preferita dal suo esaminatore. Le domande corrette sono quelle (c.d. «aperte») che rendono questa ricerca vana, ma possiamo senz’altro affermare – con un eufemismo – che non sono le più frequenti. In genere, l’interrogato coglie nelle parole o nell’intonazione della domanda l’aspettativa di una risposta che abbia un certo segno.
Ci sono poi domande che tendono intenzionalmente a condizionare la risposta, quando non a suggerirla; e queste, in particolare, quand’anche non sortiscano da subito l’effetto voluto, vanno a depositare il loro sottotesto nel fondaco mentale del dichiarante, che senza rendersene conto difficilmente in futuro riuscirà a prescinderne[6]. Questa subdola suggestione della domanda che punta a farsi risposta risulterà tanto più condizionante quanto più autorevole sarà la figura dell’interrogante agli occhi dell’interrogato[7], che successivamente opererà in modo inconsapevole ogni possibile rielaborazione mnestica per cercare di non discostarsi da quanto l’interrogante aveva lasciato intendere fosse la «sua» verità[8]. Considerazione che da sola dovrebbe bastare per prendere convintamente posizione rispetto al contrasto giurisprudenziale insorto in merito alla possibilità per il giudice di rivolgere domande suggestive al teste: pur riconoscendo che argomentazioni strettamente esegetiche possono essere spese per sostenere l’orientamento opposto, si deve escludere che il giudice possa suggerire le risposte con le proprie domande, perché in tal modo inquina irreversibilmente il giacimento mnestico del testimonio.
È pur vero che la giurisprudenza più avvertita ha di recente annullato una decisione basata sulle dichiarazioni rese dal teste a seguito di domande suggestive rivoltegli dal giudice[9]. Ma ciò, pur essendo esito ineccepibile, non risolve il problema. Quando si rinnoverà la testimonianza, le interferenze esercitate da quell’insinuante condizionamento operato dal giudice non mancheranno di produrre i loro effetti, che paradossalmente verranno «validati» dall’esame in contraddittorio del medesimo teste, il quale difenderà con incrollabile fermezza il ricordo che ha ormai inconsapevolmente e irreversibilmente rielaborato.
La sollecitazione a riplasmare la memoria di alcuni eventi può anche essere indotta dall’ascolto dell’esame di altri soggetti sugli stessi[10]. Di qui, non soltanto la regola fondamentale che vieta l’esame contestuale di più testimoni (art. 497, primo comma, c.p.p.), ma anche la prescrizione, non di rado inosservata, di evitare che la persona citata, prima di deporre, «possa assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza» (art. 149, disp. att., c.p.p.)[11]. Quasi sempre, peraltro, i testimoni stazionano insieme e a lungo nella «astanteria» del tribunale prima di deporre, avendo modo di condividere ricordi e propositi testimoniali[12].
7. La memoria di un testimone è esposta non soltanto agli input interni al processo, ma anche a fattori esogeni non meno condizionanti. Per lo spazio che i nostri organi di informazione riservano alla cronaca nera è tutt’altro che infrequente la narrazione mediatica delle vicende giudiziarie che ne conseguono; narrazione quasi mai limitata alla sobria pubblicazione del contenuto degli atti del procedimento non più segreti, come pretende l’art. 114 c.p.p., di cui l’art. 684 c.p. blandamente sanziona l’inosservanza. I «riflettori dell’attualità» vengono puntati con scomposta bulimia non soltanto sugli sviluppi giudiziari del fatto di cronaca che per la sua gravità o per i soggetti coinvolti ha suscitato la preoccupata attenzione dell’opinione pubblica, ma anche sul contesto familiare o sociale che ne fa da sfondo, captando febbrilmente con la telecamera o con il microfono immagini e dichiarazioni dei protagonisti del processo e di coloro che su quel fatto o sul possibile responsabile si presume abbiamo qualcosa da dire[13].
In un frastornante rimbalzo multimediale, si alternano o affastellano: interviste a conoscenti o a parenti dell’accusato o della vittima; filmati-highlights predisposti dagli organi di polizia, anche tramite un montaggio ad arte, per promuovere un’operazione in vestigativa; conferenze stampa degli organi inquirenti o, talvolta, dei questori; dichiarazioni rilasciate dall’indagato, dalla vittima o dai loro avvocati; imitazioni foniche di intercettazioni; reportage; raccolta delle voci correnti nel contesto sociale dei presunti protagonisti del fatto di reato. Quando non si allestiscono addirittura talk show, in cui spesso improbabili esperti ricostruiscono movente e dinamica del delitto, con ciò raggiungendo il massimo della contaminazione mediatica: una sorta di foro alternativo nel quale si scimmiottano liturgie e terminologie della giustizia ordinaria. È con il contorno di un siffatto contesto che sovente si sviluppano le più delicate vicende giudiziarie[14]. Riesce difficile immaginare che la persona informata sui fatti non rimoduli subliminalmente il proprio ricordo per raccordarlo con ciò che vede e che sente a proposito dei medesimi. Molto spesso subirà una sorta di inespugnabile «subornazione mediatica», impermeabile a ogni contraddittorio, che rende inservibile, quando non fuorviante, il relativo contributo testimoniale. La giurisprudenza più avvertita ha già preso atto dell’insidiosità del fenomeno: talvolta ha dichiarato inaffidabile l’apporto del testimone, avendo il clamore mediatico irreversibilmente compromesso la sua credibilità[15], altre volte ha di fatto permesso di recuperare dichiarazioni del teste, rese quando verosimilmente la manipolazione mediatica non aveva ancora esercitato i suoi effetti[16]. Ma non è difficile rendersi conto di come siffatti rimedi presentino problemi non meno delicati di quelli che sono chiamati a risolvere[17].
8. Sembra dunque di poter concludere che la visione stereoscopica del contraddittorio consente, sì, di scrutare meglio nel patrimonio mnestico della persona informata sui fatti al momento in cui la si esamina, ma è impotente nei confronti delle manipolazioni che questo può aver subìto rispetto alla sua conformazione originaria. Il Codice dell’89 non ha tenuto conto dell’evenienza – sempre più frequente con l’esponenziale incremento dei media – che testi sinceri e dialetticamente escussi potessero riferire il falso: è un sistema imbelle rispetto alla prospettiva di un’ingiustizia fondata sulla sincerità[18]. Ignorare questo problema di fondo sarebbe atteggiamento irresponsabile ed eticamente deplorevole; pensare di risolverlo con un ritocco normativo, sarebbe espressione di sprovveduto velleitarismo.
Ciò che si può e si deve fare è anzitutto porre le condizioni affinché maturino una conoscenza e una consapevolezza dei rischi connessi alla inconscia trasfigurazione della traccia mnestica. È indispensabile che fin dal percorso universitario e poi, a seguire, negli incontri di aggiornamento professionale per magistrati, avvocati e appartenenti alla polizia giudiziaria si forniscano gli elementi di base del funzionamento della memoria: non già perché il giurista debba avere una competenza scientificamente approfondita dei meccanismi neuronali, ma perché sia culturalmente avvertito della complessità e dei limiti della percezione, del suo immagazzinamento, della sua deteriorabilità e della sua rievocazione. Condizione necessaria, ancorché largamente insufficiente, per cercare di contenere le deleterie conseguenze legate alla adulterazione del vissuto testimoniale.
Quanto agli antidoti di carattere normativo, non essendovi una soluzione univoca e facilmente percorribile, si deve lavorare a una serie di accorgimenti in grado di ridurre la contaminazione del convincimento giudiziale per falsi ricordi del testimone. Vi è, anzitutto, una precondizione di efficacia rispetto a ogni soluzione: che sia ridotto il tempo tra la percezione del fatto e la sua rievocazione con valore probatorio. Più questo intervallo temporale si dilata, più aumentano i rischi che il ricordo non soltanto deperisca, ma si contamini con sopravvenuti elementi spuri. Da questo punto di vista, la riforma in discussione – puntando prioritariamente a ridurre i tempi del procedimento penale – potrebbe indirettamente produrre effetti positivi al riguardo.
Come è noto, il sistema conosce anche un espediente «artificiale» per avvicinare il momento della prova ai fatti da provare, quando la fase del giudizio si prospetta pericolosamente lontana: l’incidente probatorio. La difficoltà, tuttavia, consisterà nel prefigurare presupposti che riescano sì ad assicurare la formazione anticipata della prova quando l’entità del tempo che presumibilmente trascorrerà prima del giudizio o l’abnorme risonanza mediatica del caso rischierebbe di deteriorare il contributo dichiarativo, ma che non si prestino a un abuso del rimedio, con conseguente anticipazione del baricentro probatorio alla fase delle indagini. Se non riuscirà ad affermarsi un indirizzo vòlto a far rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 392, primo comma, lett. a), c.p.p., anche la non rinviabilità del contributo testimoniale verosimilmente destinato ad arrivare «inquinato» alle soglie del dibattimento[19], sarebbe opportuna una circoscritta interpolazione normativa per riservare l’incidente alla situazione di evidente esposizione del teste a condizionamenti mediatici o ambientali.
A inquinare la fonte dichiarativa, tuttavia, non sono soltanto il fattore tempo o i condizionamenti mediatici, ma anche le stesse domande formulate per compulsarla: specialmente se formulate in un certo modo «conducente», possono ripercuotersi sul tenore delle risposte che la stessa persona informata sui fatti darà subito o nel prossimo esame[20]. E le risposte date dal teste vanno a sedimentarsi «silenziosamente» nella sua memoria: dopo la prima, ogni «testimonianza» rischia di fondarsi sul ricordo non già dei fatti, ma della testimonianza precedente[21]. Di qui l’esigenza di evitare al massimo la ripetizione degli «interrogatori», ma soprattutto di conoscerne effettivamente le concrete modalità di svolgimento. Il dogma della tendenziale irrilevanza probatoria delle indagini ha indotto a non preoccuparsi troppo di questo aspetto: se condotte con inaffidabili modalità dalla parte – si è ragionato – le conseguenze negative ricadranno sull’azione di questa, dal momento che i risultati conseguiti non reggeranno alla corretta formazione della prova in giudizio. Ebbene, almeno con riguardo ai contributi dichiarativi, si tratta di assioma smentito da accreditati e indiscussi studi sulla psicologia della memoria. Ciò che in superficie incontra la intransigente dogana della separazione delle fasi e dei fascicoli, sotterraneamente e incontrollatamente «passa» – per gli insidiosi meccanismi di manipolazione del ricordo – veicolato da un inconsapevole contrabbandiere: il testimone. Questi, in giudizio, andrà a ripescare nel magazzino della memoria, un ricordo rimodellato alla luce delle informazioni implicitamente o esplicitamente contenute nelle domande ricevute. Una insinuazione, una suggestione, una velata minaccia, un bluff, un dato presupposto nella domanda rivolta dall’inquirente alla persona informata sui fatti spesso inciderà sulla risposta che quella persona darà in giudizio, rispondendo con sincerità alle domande delle parti e del giudice.
La prevista inutilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rilasciate all’inquirente, dunque, è strumento impotente. È necessario che le parti possano vedere e sentire ciò che ha subìto «a monte quel teste»[22], per infirmarne eventualmente le affermazioni rese in giudizio o, all’opposto, per recuperare le dichiarazioni rese durante un inappuntabile «interrogatorio», quando successivamente la fonte dovesse risultare irrecuperabilmente compromessa. I verbali degli atti di indagine – approssimativi sempre, talvolta «addomesticati» – non possono essere sufficienti. Una video-registrazione degli atti è dunque necessaria[23] e oggi anche realizzabile senza particolari difficoltà di carattere organizzativo o economico[24]. Bisognerebbe, per contro, che gli «interrogatori» svolti senza questa garanzia restino non soltanto fuori dal giudizio, ma anche dal procedimento e che possano eventualmente costituire illecito disciplinare.
Si dovrebbero, poi, predisporre ulteriori misure a presidio della «verginità» del contributo testimoniale. Tra le altre: evitare che in caso di amnesie la sollecitazione in aiuto alla memoria si risolva nella lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, secondo una prassi purtroppo ormai invalsa, e bandire di regola la possibilità di rivolgere domande suggestive, da chiunque provengano. Una volta fatto tutto il possibile per «proteggere» la genuinità del ricordo e della sua rievocazione, la rinnovazione della prova in appello, già in difficoltà di senso allo stato attuale, da simulacro di garanzia diverrebbe elemento di probabile inquinamento decisorio: non soltanto non potrebbe apportare alcun valore aggiunto, ma probabilmente nel bacino probatorio del giudice di secondo grado sfocerebbe un affluente che ha raccolto lungo il percorso detriti ed elementi inquinanti. Difficile immaginare che la prova dichiarativa replicata in appello possa esprimere un contenuto altrettanto affidabile di quello espresso in primo grado, impossibile – se in questo hanno dispiegato i loro effetti tutte le dovute garanzie – che ne possa esprimere uno migliore.
9. Si è certo consapevoli che gli accorgimenti sopra grossolanamente abbozzati necessiterebbero di ben più curata messa a punto, ma ciò che più premeva era richiamare l’attenzione su questa ineludibile criticità del nostro sistema processuale. Un sistema che ha verosimilmente individuato il miglior metodo per far sì che il testimone riferisca quel che ricorda, ma trascura di considerare che «quel che ricorda» potrebbe non essere più rispondente al vero: un sistema la cui ossatura epistemologica è affetta da una grave forma di osteoporosi.
Se non si vuole ancora una volta registrare mezzo secolo di ritardo rispetto alle ormai consolidate acquisizioni della scienza della mente; se si ha a cuore una giustizia più giusta e non soltanto più rapida; se si intende preservare e rivitalizzare l’idealità che permeava il Codice dell’89 – quella cioè di apportare al processo il miglior contributo testimoniale possibile – l’epistemologia forense deve fare un altro passo avanti: non basta più apprestare la miglior tecnica maieutica per la rievocazione del ricordo, nell’implicito presupposto che questo abbia un’inalterabilità minerale, ma bisogna cercare di evitare che l’argilla di cui è composto subisca la manipolazione del tempo e delle suggestioni esterne. Non si tratta di sconfessare le scelte di quarant’anni fa, ma, al contrario, di raccoglierne il testimone, poiché – come diceva Gustav Mahler – «tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco».
*Il presente contributo è apparso sul n. 4/2021 della Rivista "Politica del diritto".
[1] Esempio emblematico, l’introduzione di una iugulatoria causa di improcedibilità, irrealistica e discutibile, e di una non meno discutibile e insidiosa discrezionalità riconosciuta ai giudici procedenti di dilatare tali limiti quando la complessità del caso non consentirebbe loro di rispettarli
[2] Dal Ministero dell’Economia e delle Finanze apprendiamo che nel 2020 sono state indennizzate 766 persone per l’ingiustizia subìta (numero comprensivo sia delle riparazioni per ingiusta detenzione, sia di quelle per condanna inflitta a soggetti risultati innocenti a seguito di revisione). Si tratta di un numero che sottostima largamente la dimensione reale del fenomeno, sia perché l’innocente – uscito dall’incubo giudiziario – non sempre presenta istanza di revisione, sia perché talvolta le istanze presentate vengono respinte per una ritenuta «corresponsabilità» dell’imputato nella decisione errata. Beninteso, niente potrà mettere i pronunciamenti umani al riparo dall’errore, ma niente può esonerarci dal dovere di dar fondo a tutte le nostre risorse per contenerlo nei limiti. Cfr. postea, nota 18.
[3] Per una importante esemplificazione, si veda, al riguardo, il prossimo paragrafo.
[4] Quando una sollecitazione esterna entra nella mente del testimone capita qualcosa di simile a ciò che succede quando qualcuno si introduce senza le doverose cautele sul luogo del crimine: il lavoro della polizia scientifica ne risulta alterato, spesso irreversibilmente.
[5] Non è soltanto la distanza tra la percezione dei fatti – la codifica della percezione sensoriale, per dirla con il linguaggio delle neuroscienze – e la rievocazione del relativo ricordo a pesare sulla attendibilità della ricostruzione giudiziaria, ma anche quella, non meno deleteria per una giusta decisione, tra il momento di assunzione della testimonianza e la sua valutazione da parte del giudice.
[6] Dato che le scienze cognitive considerano ormai acquisito da circa mezzo secolo, cioè dai primi fondamentali studi della Loftus (E.F. Loftus, J.C.Palmer, Reconstruction of Automobile Destruction, in Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13, 1974, pp. 585 ss.; E.F. Loftus, G. Zanni, Eyewitness Testimony: The Influence of the Wording of a Question, in Bulletin of the Psychonomic Society, 5, 1975, pp. 86 ss.) e di Gudjonsson (G.H. Gudjonsson, A New Scale of Interrogative Suggestibility, in Personality and Individual Differences, 7, 1984, pp. 195 ss).
[7] Un fenomeno che si accentua quando si ha a che fare con testimoni bambini: cfr. le considerazioni e gli ampi riferimenti bibliografici di G. Mazzoni, Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 107 ss., 137 ss.; nonché, sul tema specifico, G. Gulotta, D. Ercolin, La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico, in Psicologia e Giustizia, 5, 2004, pp. 1 ss. Inaccettabilmente restrittivo, dunque, appare l’orientamento della Suprema Corte secondo cui la suggestionabilità del minore è rilevante ai fini del giudizio di attendibilità della sua deposizione solo quando il grado di influenzabilità individuale assume forme patologiche, come nelle personalità isteriche o immature (Cass., Sez. III, 4.10. 2007, dep. 21.11.2007, Rv. 238065 – 01)
[8] In tali circostanze opera al massimo grado l’effetto compliance, cioè quella tendenza a cercare di compiacere l’interlocutore che può portare «ad una modifica del resoconto testimoniale», quando non addirittura, «nel tempo, ad un vero e proprio cambiamento della memoria» (G. Mazzoni, Si può credere a un testimone?, cit., p. 89). Effetto sicuramente rafforzato qualora l’interrogante mandi segnali di approvazione o disapprovazione delle risposte (c.d. «bias dell’intervistatore»): cfr., anche per riferimenti bibliografici, G. Gulotta, Innocenza e colpevolezza sul banco degli imputati, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 269-270.
[9] Cfr. Cass., Sez. IV, 6.02.2020, in Proc. pen. e giust., 2020, pp. 1204 ss., la quale ebbe a rilevare che «le modalità di assunzione della testimonianza, condotta in prima battuta e in gran parte dal consigliere relatore, e il contenuto delle domande da questi rivolte alla persona offesa ne hanno gravemente pregiudicato l’attendibilità, di talché la motivazione fondata sulle dichiarazioni rese da costei […] appare radicalmente viziata sotto il profilo della tenuta logica della sentenza impugnata».
[10] Parlano di «paradigma del contagio sociale», dandone interessante dimostrazione sperimentale, M.L. Meade, H.L. Roediger, Explorations in the Social Contagion of Memory, in Memory & Cognition, 2002, pp. 995 ss.
[11] L’inosservanza del divieto per il testimone di assistere all’esame delle parti e degli altri testimoni non determina, peraltro, alcuna nullità o inutilizzabilità della testimonianza assunta, «potendo semmai influire sulla valutazione di attendibilità di quest’ultima da parte del giudice» (Cass., Sez. VI, 10.03.2010, dep. 8.06.2010, Rv 247107-01).
[12] Sulla tendenza a conformare le proprie versioni quando i testimoni dei medesimi fatti hanno l’opportunità di interloquire tra loro, cfr. F. Gabbert, A. Memon, D.B. Wright, Memory Cnformity: Disentangling the Steps toward Influence During a Discussion, in Psyconomic Bullettin & Review, 13, 2006, pp. 480 ss., che ricreando artificialmente una simile situazione hanno dimostrato l’inequivoca osmosi delle memorie.
[13] Si aggiunga che pure il semplice «fenomeno sociale del “sentito dire”» e del pettegolezzo ha certamente un’influenza importante sul resoconto di un testimone (cfr. G. Mazzoni, Psicologia della testimonianza, Roma, Carocci, 2011, p. 23).
[14] È pur vero che i processi che guadagnano la ribalta mediatica nazionale sono statisticamente pochi. Ma, a parte che è su di essi che il teleutente si forma una malsana e perniciosa idea della giustizia e di ciò che viene valorizzato ove si fosse chiamati a offrire il proprio contributo testimoniale, si ha ragione di ritenere che anche per i processi che esauriscono la loro rilevanza a livello locale, si ripete spesso, in sedicesimo, lo stesso fenomeno. Si tratterà di suggestioni operate da fonti mediatiche da un lato a minor raggio di diffusione, dall’altro però più prossime.
[15] Nel famigerato caso del «mostro di Firenze», si ritenne «totalmente inattendibile la deposizione di A.B., emblematica dei possibili effetti nocivi che all’imputato possono derivare dalle suggestioni dei mezzi di informazione»; un riconoscimento operato «a distanza di circa 11 anni, quando televisione e giornali avevano ormai messo in moto il meccanismo dello “sbatti il mostro in prima pagina” ed il Pacciani era divenuto il possibile oggetto di tutte le suggestioni popolari» (Corte di assise d’appello, 13 febbraio 1996, in Foro it., 1997, 2, c. 65 ss.).
[16] La Corte di cassazione ha ritenuto ineccepibile la decisione della Corte di assise di appello di Milano che – nel processo per l’omicidio di Chiara Poggi – giornalisticamente noto come «delitto di Garlasco» – non aveva ammesso la rinnovazione delle deposizioni di due testimoni in ragione della perdita di genuinità nel frattempo delle loro dichiarazioni, «avendo il “tema bicicletta” […] costituito oggetto di una esagerata attenzione mediatica, tale da influenzare il ricordo delle testi, rendendo difficile, se non impossibile, distinguere tra ciò che le stesse avevano effettivamente visto quella mattina e quello che in seguito ricordavano di aver visto» (Cass., Sez. V, 12.12.2015, in Dir. pen. cont., 29.06.2016).
[17] Rinunciare al contributo di un teste ritenendolo irrimediabilmente condizionato dal martellamento mediatico è decisione delicata che può ledere gravemente le prerogative dell’accusa o della difesa, in base a una valutazione dagli incerti e opinabili parametri. Recuperare dichiarazioni già rese dal teste, poi, supponendo che siano state rilasciate prima che queste suggestioni operassero, è rimedio che ha senz’altro una sua plausibilità, ma che risente anch’esso dell’opinabilità del presupposto. E ancora: se i fattori di condizionamento fossero intervenuti nelle more del giudizio di primo grado, cosa dovremmo recuperare con valore di prova? Le dichiarazioni rese durante le indagini?
[18] Nel 1992 ha preso avvio negli Stati Uniti un programma, denominato Innocence Project, con l’obbiettivo di scagionare – soprattutto tramite l’utilizzo del test del DNA – le persone ingiustamente condannate. Da questa iniziativa sono germinate, specie nei Paesi anglosassoni, organizzazioni la cui azione, pur declinata in diverse modalità, ha precipuamente la stessa finalità istituzionale (da noi opera, dal 2014, l’Italy Innocence Project), nonché quella di elaborare tecniche e metodologie in grado di contenere gli errori giudiziari; con il medesimo obbiettivo sono state redatte in Italia, nel 2013, le Linee Guida Psicoforensi. Per un processo sempre più giusto (su cui si veda, per tutti, G. Gulotta, Innocenza e colpevolezza, cit.). Estremamente significativo, in questa sede, è il fatto che nella maggioranza dei casi l’ingiusta condanna scoperta grazie alle organizzazioni de quibus si basasse su un contributo testimoniale, su una errata ricognizione personale o su una falsa confessione (Cfr. G. Mazzoni, Si può credere a un testimone?, cit., pp. 160 ss.).
[19] Per una lungimirante apertura esegetica in tal senso, cfr. F. Cordero, Codice di procedura penale commentato, II ed., Torino, UTET, 1992, p. 467.
[20] Decisivi spesso gli stessi «interrogatori» a cui il teste viene sottoposto prima del dibattimento, cfr. E. Gora, I. Rampoldi, Come nell’interrogatorio la domanda può influenzare la risposta, in G. Gulotta (a cura di), Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 539 ss.
[21] Verità, sempre conosciuta da grandi scrittori. In un noto racconto di Borges, il protagonista va a incontrare un vecchio colonnello per sapere come erano andate le cose durante una certa battaglia. Il colonnello gli racconta con tale dovizia di parti colari, «con periodi così precisi e in modo tanto vivo» da fargli temere che avendo egli «narrato molte volte quelle stesse cose, […] dietro le sue parole non rimanessero quasi ricordi» (J.L. Borges, L’altra morte, in Id., L’Aleph, 1952, p. 71). Scrive Hector Bianciotti che «il signor Tenant avrebbe sempre ripetuto le stesse cose; forse le aveva dimenticate e gli rimaneva solo quel racconto imparato a memoria che si ripeteva senza più figurarsele» (Senza la misericordia di Cristo, Palermo, Sellerio, 1985, p. 71).
[22] Nella notissima e inquietante vicenda giudiziaria, giornalisticamente conosciuta come «Diavoli della bassa modenese», la Cassazione ha rigettato i ricorsi contro le assoluzioni pronunciate della Corte di appello, che aveva trovato sorprendente che dei colloqui avuti dalle due psicologhe con i bambini non sia restata traccia, mentre «sarebbe stato del tutto fisiologico provvedere alla registrazione». L’omissione era stata sostanzialmente giustificata con il tempo che avrebbe richiesto la trascrizione delle conversazioni. La Corte di secondo grado l’aveva ritenuta ragione insufficiente e considerato grave che nulla si potesse sapere «in ordine alle vivide modalità espressive, alle esitazioni, alle incertezze, agli imbarazzi, alle contraddizioni recate nelle narrazioni». La Cassazione ha condiviso i rilievi della Corte territoriale, rilevando come che ciò che «ha un peso indubbio sul piano della prova è che non esiste un reperto documentale afferente alle uniche informazioni selettive: le prime dichiarazioni dei piccoli, quelle cioè più genuine e meno aperte al dubbio di contaminazioni e suggestioni» (Cass., Sez. IV, 3.12.2014, dep. 23.01.2015, Rv. 3279-15).
[23] Cfr. al riguardo, per incisive considerazioni e per riferimenti comparatistici, G. Mazzoni, Si può credere a un testimone?, cit., pp. 92 ss. Nella legge delega per la riforma del processo penale di recente approvata, si fa riferimento alla video-registrazione o, almeno all’audio-registrazione, dei contributi testimoniali (art. 1, ottavo comma, lett. a e b), con previsioni il cui vincolo precettivo, peraltro, è piuttosto blando per la presenza di formule «esonerative»: molto dipenderà da come il legislatore delegato interpreterà il mandato politico del delegante.
[24] Non si ignora che la videoregistrazione costituisca un ulteriore elemento di «soggezione» per la persona informata sui fatti, già in una condizione di «inferiorità» psicologica, quando viene sentita per fini di giustizia, ma è costo più che compensato dai vantaggi che riesce a offrire.