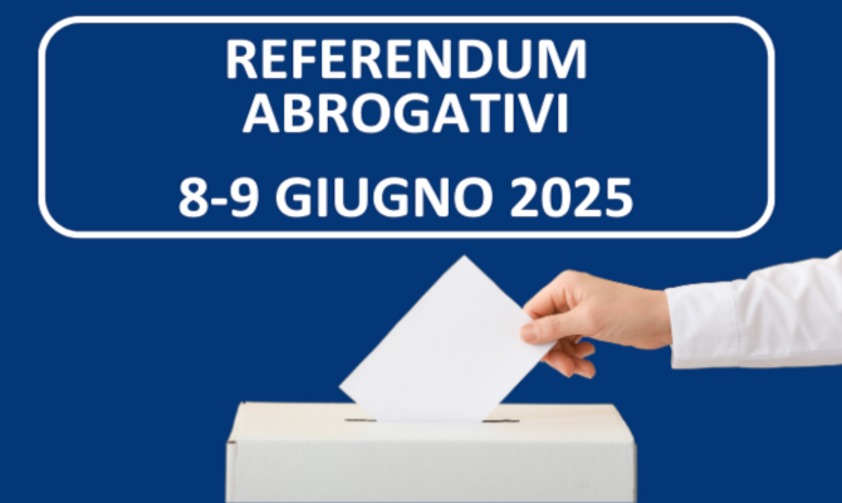La Corte di Giustizia risponde alle S.U. sull’eccesso di potere giurisdizionale. Quali saranno i "seguiti" a Corte Giust., G. S., 21 dicembre 2021 -causa C-497/20, Randstad Italia?
Editoriale
Interviste di R. Conti a Fabio Francario, Giancarlo Montedoro, Paolo Biavati, Renato Rordorf ed Enzo Cannizzaro.
Eccoci alla tanto attesa Corte Giust., Grande Sezione, 21 dicembre 2021,C-497/20, Randstad Italia, pubblicata il 21 dicembre 2021, che ha esaminato il rinvio pregiudiziale proposto dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con l’ormai nota ordinanza n.19598/2020, con la quale si chiedeva, tra l’altro, di valutare la compatibilità con il principio di effettività di matrice UE del sistema giurisdizionale interno che si era andato assestando sul principi resi dalla sentenza n.6/2018 della Corte costituzionale, escludendo il riesame da parte delle Sezioni Unite della cassazione, sotto il paradigma dell’art.111 c.8, Cost., delle sentenze del giudice speciale che avessero dato luogo ad una violazione del diritto UE capace di vulnerare l’uniforme applicazione del diritto eurounitario e l’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di rilevanza. Nella stessa occasione il giudice remittente aveva parimenti domandando alla Corte UE “Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, TUE e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’articolo 47 della [Carta], ostino alla interpretazione e applicazione degli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma (...), e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice [del] processo amministrativo, quale si evince dalla prassi giurisprudenziale nazionale, secondo la quale il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per “motivi inerenti alla giurisdizione”, sotto il profilo del cosiddetto “difetto di potere giurisdizionale”, non sia proponibile come mezzo di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato che, decidendo controversie su questioni concernenti l’applicazione del diritto dell’Unione, omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla [Corte], in assenza delle condizioni, di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate [a partire dalla sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., C-238/81], che esonerano il giudice nazionale dal suddetto obbligo, in contrasto con il principio secondo cui sono incompatibili con il diritto dell’Unione le normative o prassi processuali nazionali, seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, anche temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il rinvio pregiudiziale, con l’effetto di usurpare la competenza esclusiva della [Corte] nella corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere irrimediabile (e favorire il consolidamento del)l’eventuale contrasto interpretativo tra il diritto applicato dal giudice nazionale e il diritto dell’Unione e di pregiudicare la uniforme applicazione e la effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell’Unione.”
Preceduta dalle conclusioni rese dall’Avvocato generale G. Hogan il 9 settembre 2021, dalle quale si intravedeva, in controluce, il possibile esito della vicenda approdata a Lussemburgo, la Grande Sezione della Corte di giustizia, decidendo in via prioritaria il ricorso (art.53, par.3 reg. proc. Corte UE) ma senza attivare la richiesta procedura accelerata sollecitata dalle Sezioni Unite, ha affermato che L’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.
Quanto al secondo quesito sopra riportato la Corte di giustizia lo ha ritenuto irrilevante, considerando che la società ricorrente innanzi alle Sezioni Unite non aveva dedotto motivi vertenti sul fatto che il Consiglio di Stato, in violazione dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, avesse omesso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, per modo che il giudice del rinvio non era stato investito della questione se, alla luce degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri siano tenuti a prevedere, nei loro ordinamenti giuridici, la possibilità di presentare ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo qualora il supremo organo della giustizia amministrativa si sia astenuto dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte.
Fatta questa premessa, per consentire al lettore qualche elemento di contesto nel quale collocare la decisione della Grande Sezione della Corte UE, è sufficiente rammentare che negli ultimi tre lustri la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione è andata delineando un concetto ampio di giurisdizione ai fini del sindacato ad essa riservato sulle decisioni dei giudici speciali di ultima istanza dall’art.111, c.8, Cost., al cui interno sistemare non solo le norme sulla giurisdizione che individuano "i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale", ma anche quelle che stabiliscono "le forme di tutela" attraverso cui la giurisdizione si estrinseca, nei casi nei quali la violazione delle stesse comporti un diniego di giustizia. A tanto sono giunte le Sezioni Unite ricorrendo ad una nozione di giurisdizione definiti "dinamica" (o "funzionale" o "evolutiva"), secondo cui risulterebbe sindacabile anche la violazione di legge (sostanziale e/o processuale) in relazione alla giurisdizione, qualora sia conseguenza di un'interpretazione "abnorme o anomala" – Cass., S.U. 20/05/2016, n. 10501 – tale da ingenerare un vero e proprio diniego di giustizia, ovvero uno "stravolgimento" – Cass., S.U., 17 gennaio 2017, n. 956 – delle "norme di riferimento" –di rito o di merito, Cass. S.U., 17 gennaio 2017, n. 964; Cass., S.U., 11 maggio 2017, n. 11520 –, in particolare nel caso di violazione di norme sovranazionali – Cass., S.U., 17 gennaio 2017, nn. 956 e 953–.
A giustificazione di tale indirizzo sulla portata di senso del concetto di giurisdizione sono stati via via evocati la primazia del diritto comunitario, il giusto processo, il principio di effettività della tutela, il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina, tenuto conto dell'ampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva –Cass., S.U., 23 dicembre 2008, n. 30254, Cass., S.U., 6 febbraio 2015, n. 2242; Cass., S.U., 13 maggio 2013, n. 11345; Cass. S.U., 29 dicembre 2017, n. 31226, tutte ricordate da Cass., S.U., 11 novembre 2019 n.29082 –. A tali conclusioni avevano dato un decisivo impulso alcune pronunzie delle stesse Sezioni Unite – Cass.S.U. 23 dicembre 2008, n. 30254 in tema di pregiudizialità amministrativa; Cass., S.U. sentt. nn. 13559 e 13660/2006;Cass., S.U.n.30254/2008– alle quale si collegava, senza soluzione di continuità, Cass., S.U. n.2242/2015, giungendo a riconoscere il proprio sindacato in punto di giurisdizione nei confronti di una pronunzia del Consiglio di Stato distonica rispetto alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di aggiudicazione di appalti resa però in epoca successiva alla decisione del G.A. L’ampliamento del controllo sull’operato del g.a. era stato in tale ultima occasione ritenuto doveroso, in relazione alla peculiarità del caso concreto, nel quale l’intervento interpretativo della Corte di giustizia era giunto in epoca successiva alla decisione del Consiglio di Stato ad esso non conforme, “...oltre che al fine di delineare gli ambiti giurisdizionali del GA nel senso voluto dalla normativa europea (come, in questo caso, interpretata dalla Corte di giustizia), anche al fine di sottrarre lo Stato dalla responsabilità risarcitoria per i danni cagionati dagli organi giurisdizionali di ultima istanza.” Da qui la posizione espressa da Cass. (ord.) S.U. n.6891/2016 che, prendendo le mosse dai principi espressi da Cass., S.U. n.2242/2015, non ritenendo di potere ‘disapplicare’ il giudicato interno in ragione della diversità di approccio al diritto di matrice convenzionale, si rivolse alla Corte costituzionale, ipotizzando un contrasto fra la norma interna – art.69, c.7, d. lgs. n.165/2001– sulla quale si era fondato il giudicato amministrativo nazionale e i parametri convenzionali che la Corte edu aveva riconosciuto violati con le sentenze rese nei casi Stabbiano c. Italia e Mottola c. Italia del 4.2.2014. E fu proprio nel “rispondere” a tale questione di costituzionalità che la Corte costituzionale, con la sentenza n.6/2018 si è detto avere pronunziato una forte battuta di arresto all’idea di giurisdizione dinamica, di fatto comprimendo in modo significativo la portata del sindacato previsto dall’art.117 c.8 Cost.
Cass.S.U. n.19283/2018, nel decidere il procedimento che aveva originato la decisione della Corte costituzionale n.6/2018, ritenne dunque l’inammissibilità del ricorso proposto avverso la decisione del Consiglio di Stato inammissibile “…alla stregua delle considerazioni svolte dalla citata sentenza n. 6/2018 della Corte cost., che nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, d.lgs. 30.03.01 n. 165 del 2001 sollevata in relazione all'art. 117, comma 1, Cost., ha negato in radice che con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, possano censurarsi anche errores in procedendo o in iudicando”, inoltre aggiungendo che “…Nel presente giudizio la citata sentenza n. 6/2018 ha efficacia vincolante perché basata sull'asserito difetto di rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, in ragione della mancanza di legittimazione del giudice a quo (espressamente in questi termini si è, conclusivamente, pronunciata la Corte cost.).”
In epoca successiva, Cass.S.U.9 novembre 2018 n.28652 ha ritenuto che “il sindacato che queste Sezioni Unite hanno ricondotto sotto il cono d'ombra dell'art.111, c.8, Cost. riguarda, per l'appunto, esclusivamente i casi di vero e proprio rifiuto dell'esercizio della giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo rispetto ad una questione concernente materia riservata alla cognizione di altri organi costituzionali – cfr.Cass., S.U. 15 febbraio 2013 n.3731, Cass., S.U.,1 febbraio 2008 n.2439, Cass.S.U., 1 dicembre 2016, n.24624– o di difetto assoluto di giurisdizione, ipotizzabile soltanto ove il Consiglio di Stato o la Corte dei conti abbia affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (c.d. invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, l'abbia negata sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (c.d. arretramento) – cfr. Cass., S.U., 19 luglio 2018 n.19283 –.”
Altre volte si è dato esplicito rilievo al carattere vincolate della sentenza n.6/2018 – Cass.S.U. n. 7926/2019 – in relazione al fatto che il giudice costituzionale aveva premesso che la questione allo stesso demandata "rientra...nella competenza naturale di questa Corte, quale interprete ultimo delle norme costituzionali e – nella specie – di quelle che regolano i confini e l'assetto complessivo dei plessi giurisdizionali". Cass.S.U.n.29082/2019 non mancava ulteriormente di chiarire che la soluzione espressa dalla sentenza n.6/2018 non vulnera il canone del giusto processo, né quello dell’effettività della tutela giurisdizionale come protetta a livello UE.
Su tale ultimo punto, Cass.S.U.17 dicembre 2018 n.32622 affermava che la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111 Cost., comma 8, delle violazioni del diritto dell'Unione Europea ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali, è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, essendo il sistema correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione – conf. Cass.S.U., 1^ aprile 2019 n.9042 –.
Questo era dunque, sia pur per sommi capi, prima dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale delle Sezioni Unite n.19598/2020, il quadro dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di eccesso di potere giurisdizionale, con particolare riferimento alle violazioni di diritto UE a carico del giudice speciale si è arricchito di alcune pronunzie che senza entrare nel merito del rinvio pregiudiziale appena ricordato, hanno tuttavia espresso alcuni principi che occorre brevemente ricordare.
Per un verso, si è ritenuto che costituisce motivo di ricorso attinente alla giurisdizione quello con il quale si denunzia che il Consiglio di Stato abbia esercitato i poteri inerenti alla giurisdizione esclusiva al di fuori dei casi in cui la legge lo consente, per avere esso invaso la sfera dei poteri riservati alla esclusiva competenza della Commissione Europea in materia di aiuti di stato dove non sono attribuiti poteri al giudice nazionale – Cass., S.U., 11 marzo 2020, n. 7012-.
Per altro verso, si è affermato che non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, in relazione al diritto eurounitario la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre, motivatamente, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il controllo che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione europea- Cass.S.U. n.24107/2020-.
In tale ultima occasione le S.U. hanno ritenuto che “…la questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia costituisce elemento processuale interno al processo, senza che essa risulti suscettibile di divenire oggetto di autonoma valutazione nell’ambito del sindacato di cui all’art. 111 Cost., comma 8”, aggiungendo che quando il giudice amministrativo abbia espressamente deciso di non attivare il rinvio pregiudiziale motivando la sua decisione e dunque esaminando le ragioni poste a sostegno della richiesta di rinvio pregiudiziale sollecitata da una delle parti – ovvero escludendo direttamente di operare il rinvio pregiudiziale sulla base di una valutazione sganciata dall’iniziativa di una parte processuale, a tanto potendo comunque procedere proprio in relazione alla finalità dell’istituto normato dall’art. 267 TUEF – il diniego di rinvio pregiudiziale ha “ quale suo presupposto la giurisdizione del giudice interno che l’ha appunto pienamente esercitata, proprio escludendo la ricorrenza dei presupposti per l’attivazione del meccanismo di cui all’art. 267 TUFE…” Sicchè deve escludersi che la decisione della questione controversa da parte del giudice nazionale, nell’ipotesi in cui la stessa imponeva il rinvio pregiudiziale alla Corte UE – invece motivatamente negato – determini un travalicamento dei limiti della giurisdizione amministrativa in danno della Corte di Giustizia. Ciò perché il rapporto che corre fra il giudice nazionale e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea non è di alternatività ma di complementarietà, nel senso che il giudice nazionale è egli stesso interprete del diritto dell’Unione Europea, indicandosi tale ruolo spesso con la dizione di giudice comunitario di diritto comune. Per modo che “spetta unicamente al giudice nazionale il compito di valutare se la corretta applicazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, di decidere se astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad esso”… In defintiva, secondo questa prospettiva “La decisione se attivare o meno il rinvio pregiudiziale va dunque risolta dal giudice nazionale sotto la propria responsabilità”- Cass.S.U. n.24107/2020, cit.-
Per altro verso, Cass.S.U. 28 luglio 2021 n.21641, nel confermare i principi espressi a proposito del mancato rinvio pregiudiziale "di interpretazione" da parte del giudice speciale, ha poi escluso che il giudice speciale abbia invaso la competenza della Corte di Giustizia nel motivatamente escludere la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale "di validità" alla Corte di Giustizia UE e nel ritenere la piena validità dell'atto impugnato sotto il profilo della violazione di diritti garantiti dall'UE, atteso che tale decisione non incide sulla competenza esclusiva della medesima Corte di Giustizia in tema di accertamento della validità degli atti dell'UE che, per converso, lascia libero il giudice nazionale di respingere i motivi di invalidità dedotti dinanzi ad essi contro un atto di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione.
Occorre infine rammentare che Cass. S.U. 3 novembre 2021 n.31311, nel confermare i principi espressi da Cass.S.U. n.24107/2020 in tema di mancata sollevazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice speciale, ha ritenuto inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale su questione di interpretazione del diritto UE che implichi in realtà la devoluzione al giudice dell'Unione europea del compito di decidere la controversia oggetto di lite, in quanto il giudice nazionale con il rinvio non si spoglia in alcun modo del proprio potere giurisdizionale, ma lo esercita "pleno iure", formulando, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, la richiesta incidentale alla Corte UE, in esito alla quale avrà il compito di applicare l'interpretazione del diritto fornita appunto da quel giudice.
Senza peraltro dimenticare l’apporto non meno rilevante fornito medio tempore dal Consiglio di Stato nella delimitazione della sua giurisdizione e nel rapporto fra la tutela dal medesimo offerta, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e, da ultimo, il ruolo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia nelle ipotesi di prospettata violazione del diritto UE ascrivibile al supremo giudice amministrativo, per usare un’espressione che si riscontra proprio nella sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia, Randstad Italia - per cui v. Cons. St., 18 marzo 2021, n. 2327-.
In questo scenario composito e complesso la decisione della grande Sezione della Corte di giustizia anche per il lasso di tempo trascorso dalla sentenza n.6/2018, rende indilazionabile un’analisi della questione che dovrebbe allontanarsi dall’idea di creare o favorire una contrapposizione muscolare fra “plessi giurisdizionali” per lasciare invece il passo ad approfondimenti capaci di analizzare gli aspetti tuttora controversi e, fra questi, quello che riguarda, sul versante interno, la verifica in termini di effettività delle tutele approntata in sede giudiziaria e di vincolatività della sentenza n.6/2018 che dichiarò inammissibile la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni Unite, fornendo un apparato motivazionale destinato dichiaratamente ad operare, almeno nelle intenzioni della Corte costituzionale, in funzione nomofilattica, proprio in ragione dell’interpretazione secundum Constitutionem fornita dal “giudice della Costituzione”.
Nel solco di queste riflessioni Giustizia insieme intende aprire il dibattito con autorevoli esponenti del mondo accademico, della giurisdizione e dell’Avvocatura.
Numerosi fin qui i contributi apparsi sulla Rivista in tema prima della decisione della Corte di Lussemburgo: F. Francario, Quel pasticciaccio brutto di piazza Cavour, piazza del Quirinale e piazza Capodiferro (la questione di giurisdizione), in questa Rivista, 11 novembre 2020; M. Lipari, Il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione tra l’art. 111, co. 8, della Costituzione e il diritto dell’Unione europea: la parola alla Corte di Giustizia, in questa Rivista, 11 dicembre 2020; B. Nascimbene e P. Piva, Il rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di giustizia: violazioni gravi e manifeste del diritto dell’Unione europea?, in questa Rivista, 24 novembre 2020; M.A. Sandulli, Guida alla lettura dell’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte dicassazione n. 19598 del 2020, in questa Rivista, 29 novembre 2020; G. Tropea, Il Golem europeo e i «motivi inerenti alla giurisdizione» (Nota a Cass., Sez. un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598), in questa Rivista, 7 ottobre 2020; R. Conti, Nomofilachia integrata e diritto sovranazionale. I “volti” delle Corte di Cassazione a confronto, in questa Rivista, 4 marzo 2021; R. Pappalardo, La corsa al dialogo nella discordia sulla giurisdizione (nota a Cons. St., ord. 18 marzo 2021, n. 2327), in questa Rivista, 6 aprile 2021.
La parola passa ora a Fabio Francario, ordinario di diritto amministrativo e avvocato, Giancarlo Montedoro, Presidente di sezione del Consiglio di Stato, Paolo Biavati, ordinario di procedura civile e avvocato, Renato Rordorf, già Primo presidente aggiunto della Cassazione ed Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale, i quali hanno accettato di rispondere a qualche domanda suscitata dalla lettura a caldo della sentenza della Corte di Giustizia nelle cinque interviste che saranno pubblicate nei prossimi giorni ed alle quali, per una precisa scelta di campo, non seguiranno le consuete conclusioni che sarà il diritto vivente, attingendo alla dottrina ed alle voci del giuristi pratici, ancora una volta a decodificare e forgiare, in ciò sicuramente avvantaggiato dalle riflessioni plurali degli ospiti che hanno animato, da par loro, questo primo dibattito a distanza.





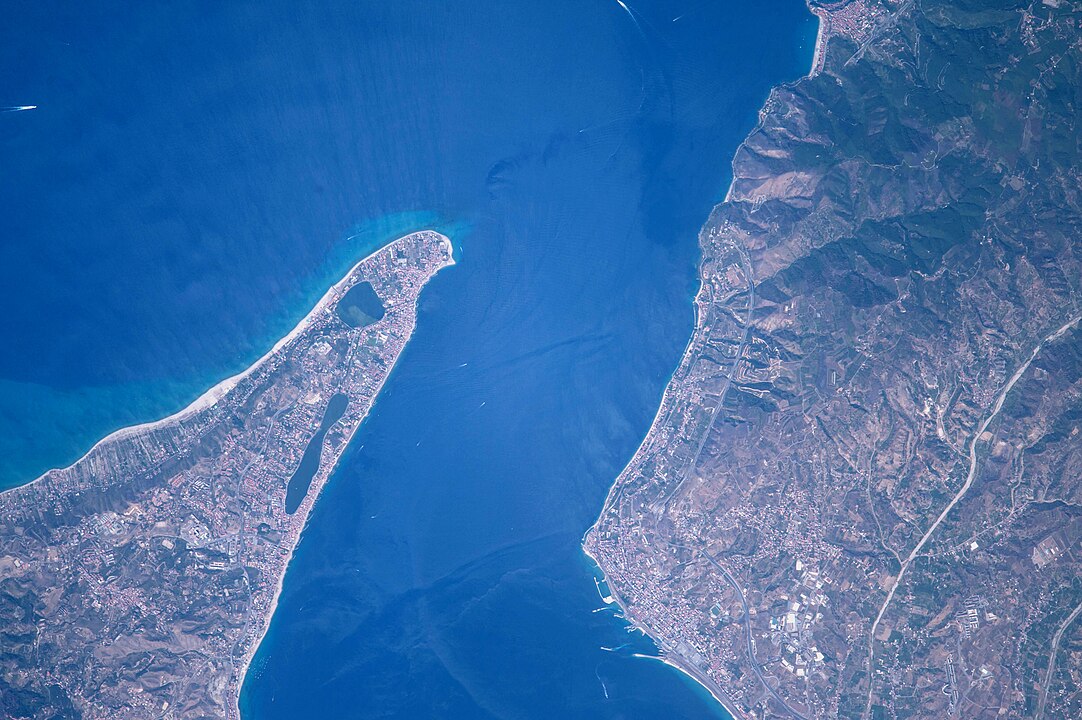
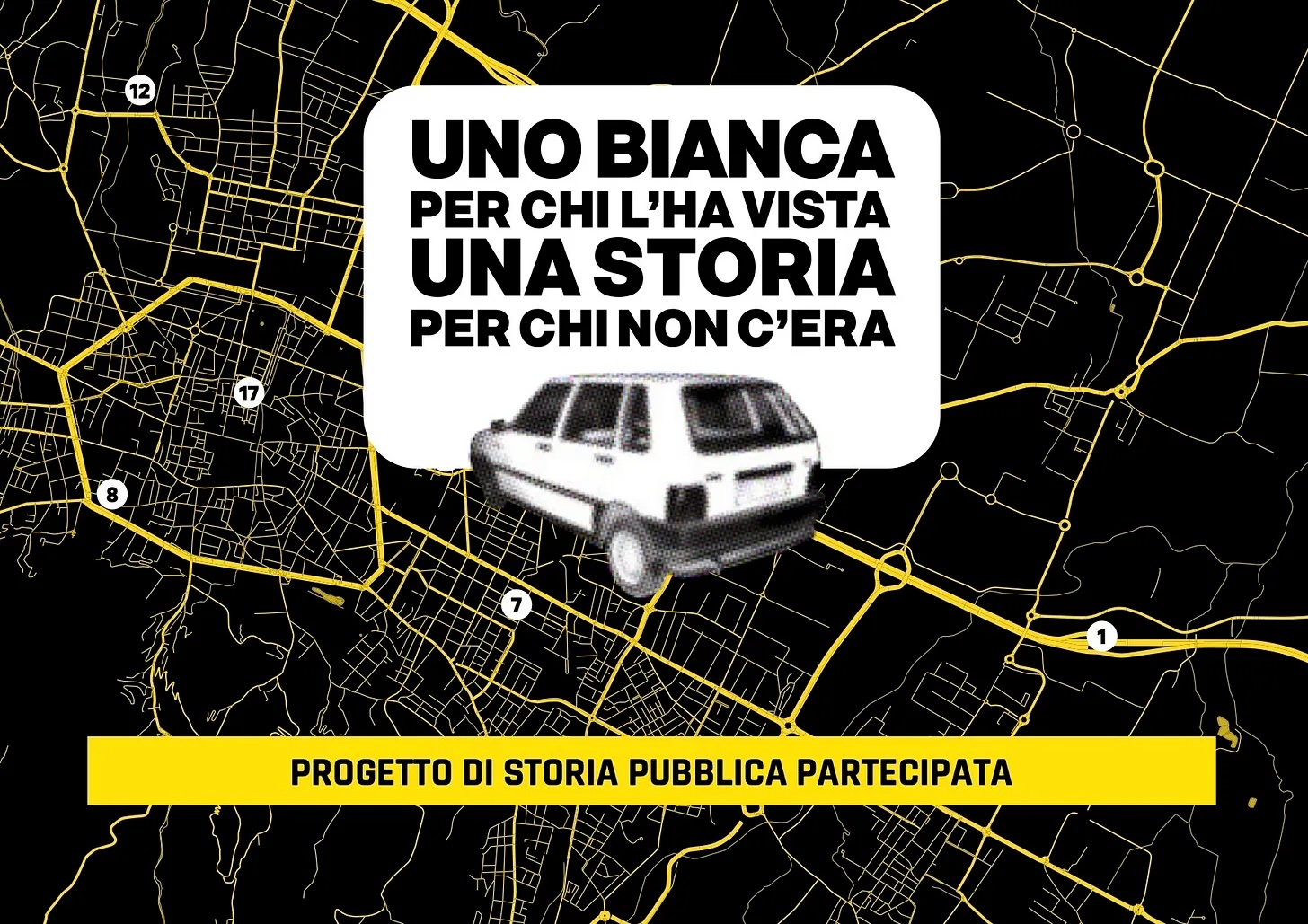


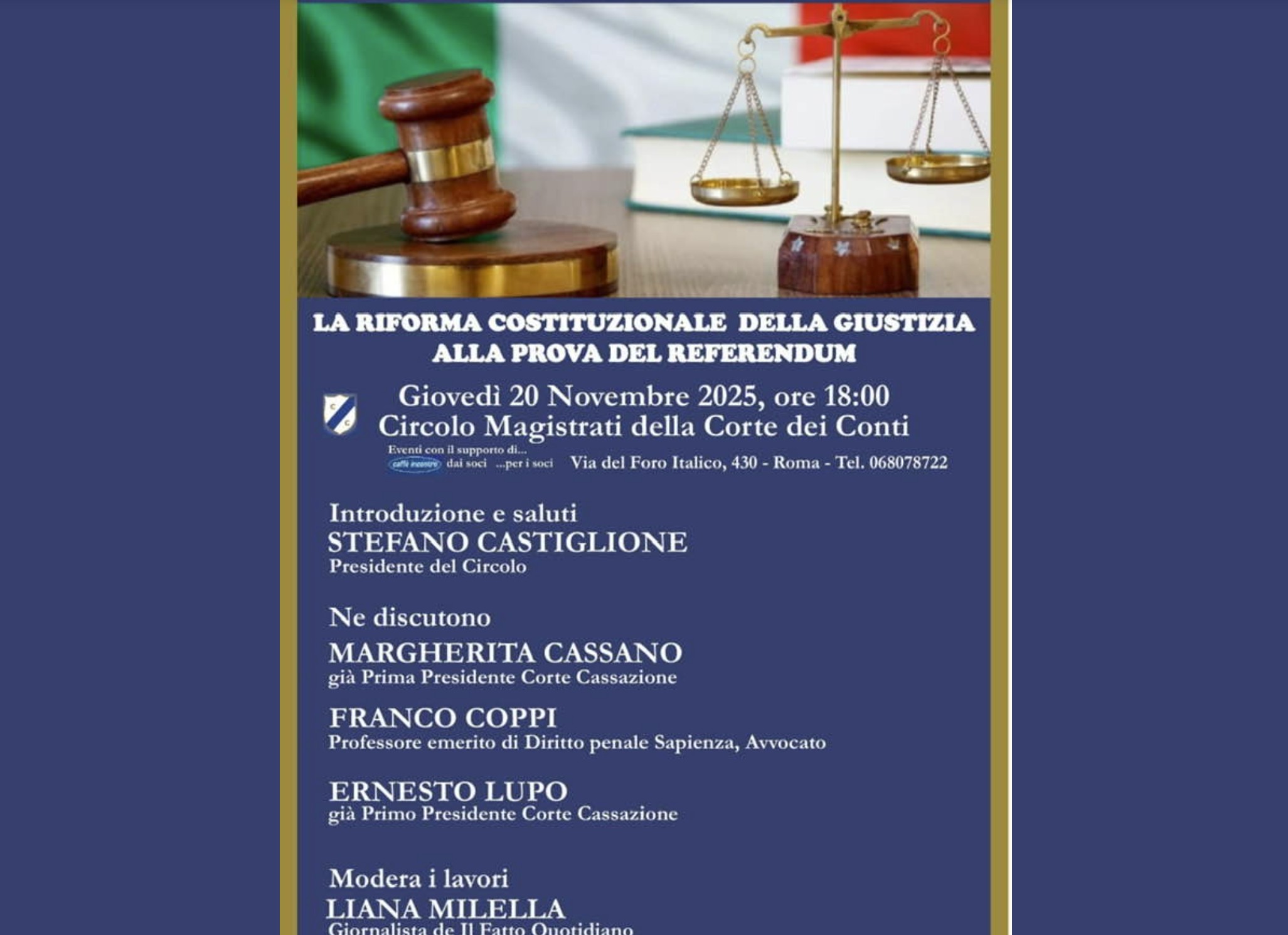





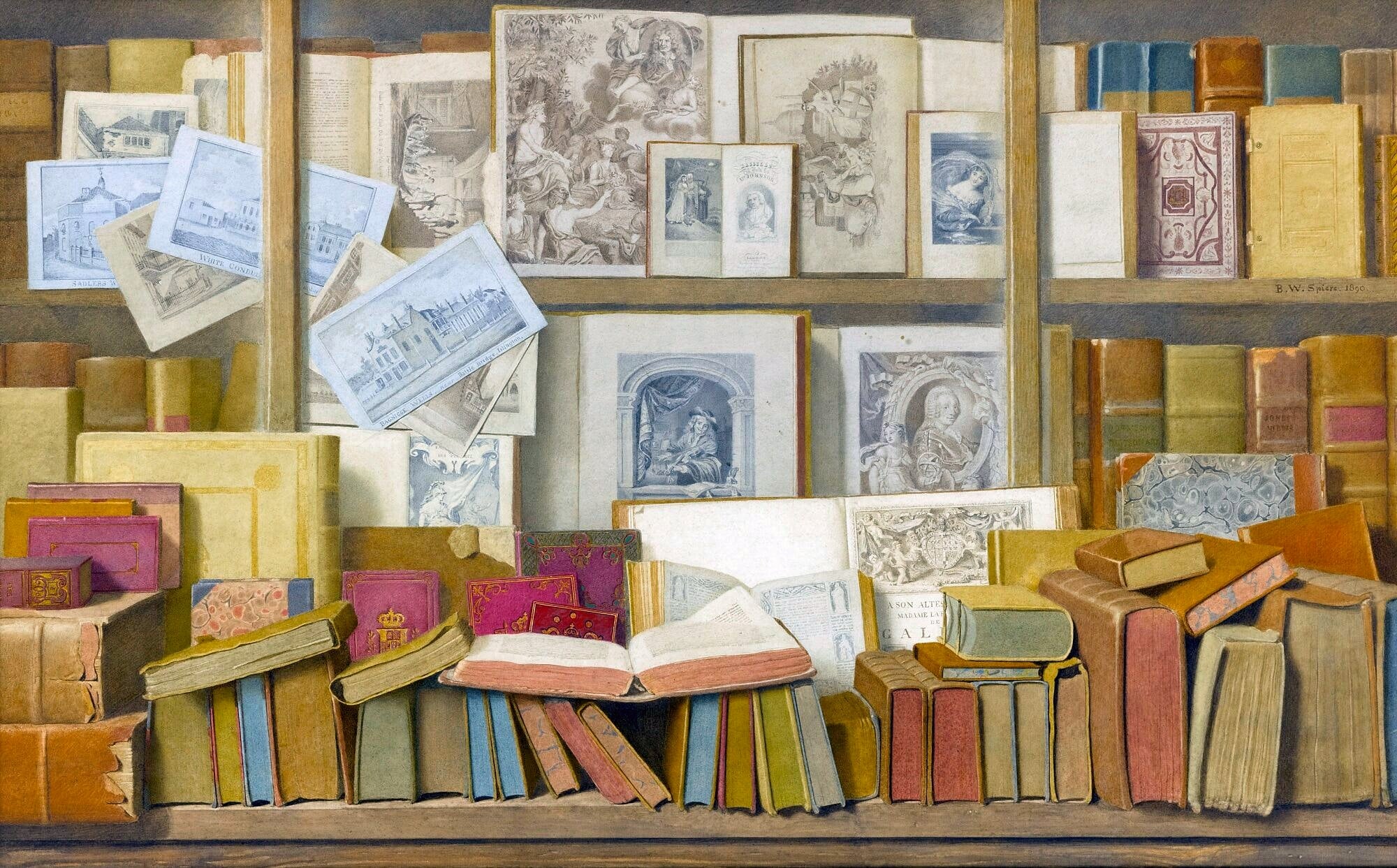



![La Corte di giustizia sulla nozione di “paese sicuro” e l’esclusione di particolari categorie soggettive- Corte giust, 1 agosto 2025, Cause riunite C‑758/24 [Alace] e C‑759/24 [Canpelli]](/foto/3586.jpeg)