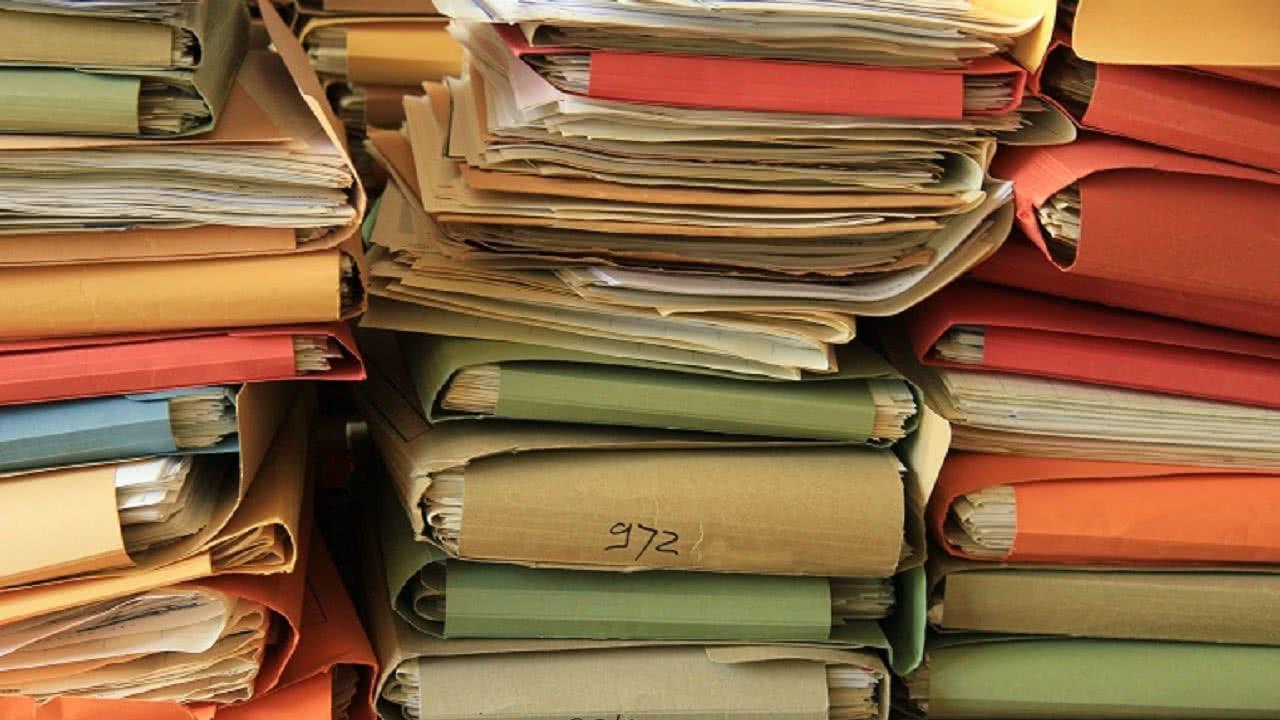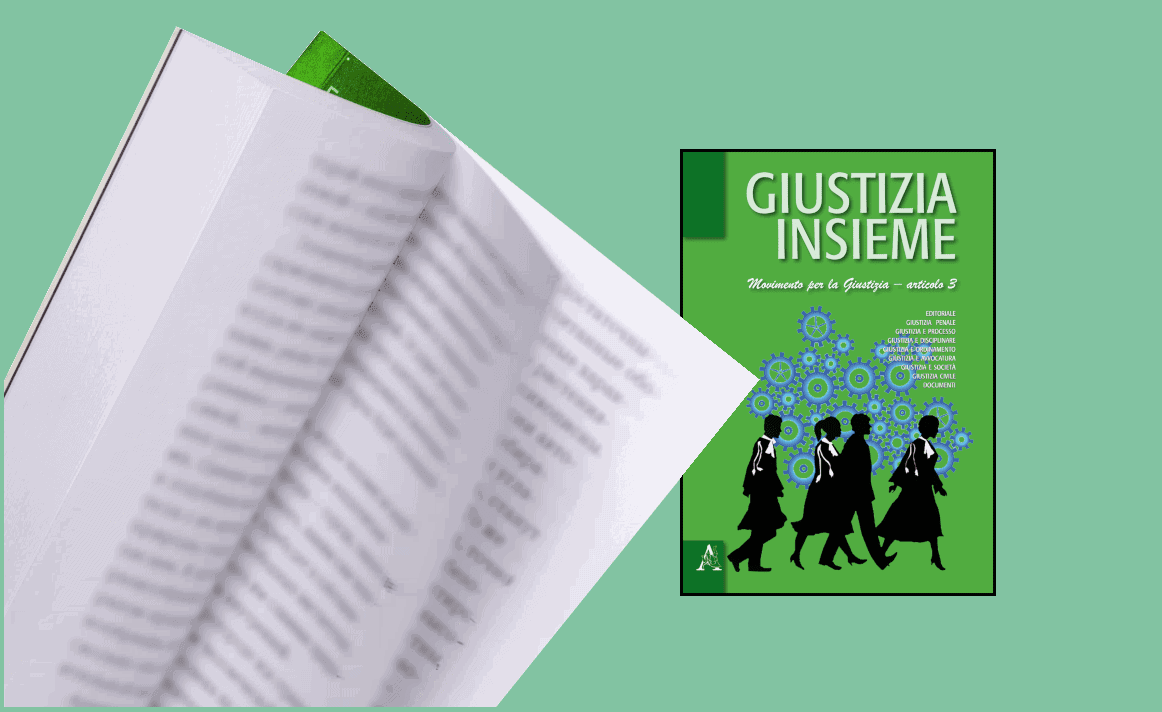Sommario: 1. La trattazione scritta dopo il d.lgs. 164/2024 – 2. La finzione di lettura (fictio recitationis). – 3. La decisione tardiva.
1. La trattazione scritta dopo il d.lgs. n. 164/2024
Con l’intervento legislativo in sede di “correttivo” della riforma del codice processuale civile (d. lvo n. 164/2024) è stata, come noto, integrata anche la disciplina relativa alla c.d. trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.[i] dirimendo, innanzitutto, il dubbio sorto in ordine alla compatibilità tra la trattazione “cartolare” e l’udienza di discussione che, ai sensi dell’art.128 c.p.c, “è pubblica a pena di nullità”[ii].
Nello stesso art. 128 c.p.c. è, infatti, ora chiarito che anche “l’udienza in cui si discute la causa” può essere dal giudice “sostituita” dal deposito delle note scritte previste dall’art.127ter c.p.c. se non sopravviene una opposizione anche di una sola parte.
Mentre, quindi, secondo la confermata disciplina generale, di regola, il giudice è tenuto a revocare la disposta trattazione scritta solo quando l’opposizione provenga da tutte le parti, nel caso invece di “sostituzione” della discussione è ora previsto espressamente che anche di fronte all’opposizione di una sola parte il giudice debba senz’altro revocare il proprio provvedimento e fissare l’udienza pubblica (art.127ter, comma 2, terzo periodo, c.p.c.)[iii].
È da ritenere, tuttavia, che in linea di principio per l’opposizione valga l’onere di proposizione entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto dispositivo della trattazione scritta, così come stabilito in via generale dallo stesso art. 127ter c.p.c., al fine di salvaguardare le esigenze difensive delle altre parti, in prossimità della già fissata udienza, oltre che le incombenze dell’”agenda” del giudice.
Nei confronti della parte non ancora costituita il decreto dispositivo della trattazione “cartolare” non può essere, invero, oggetto di specifica comunicazione; è però senz’altro esigibile la conoscenza di tale decreto quanto meno alla scadenza del termine per la costituzione in giudizio, alla stregua del più generale onere di esame degli atti già depositati in causa, con conseguente decorrenza contestuale del termine per l’opposizione alla modalità ex art.127ter c.p.c..
All’udienza di discussione partecipano i difensori delle parti costituite e, quindi, non opera l’ulteriore specifica preclusione alla trattazione scritta introdotta dall’intervento “correttivo” relativamente ai casi nei quali la comparizione personale delle parti sia prevista dalla legge o disposta dal giudice: preclusione che opera, a rigore, per tutte le prime comparizioni in primo grado ai fini dello svolgimento dell’interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione (artt. 183, 320, 420, 473bis.21 c.p.c.), anche se, in effetti, in caso di violazione, in difetto di una sanzione specifica di nullità, la rilevanza invalidante sarebbe comunque subordinata ai sensi dell’art.156 c.p.c. alla dimostrazione di una concreta pregiudizievole incidenza sul diritto di difesa.
La “correzione” più singolare apportata dal legislatore delegato è, poi, inserita all’ultimo comma dell’art. 127ter c.p.c. laddove era già previsto che “il giorno di scadenza del termine” per la trattazione cartolare “è considerato data di udienza a tutti gli effetti”: si aggiunge, infatti, una disposizione attinente alla modalità decisoria prevedendo che “il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza”.
Viene così integrata la finzione dell’udienza anche riguardo al giudice: non solo, quindi, il deposito delle note sostituisce per le parti la trattazione orale “a tutti gli effetti” ma anche la decisione giudiziale, se depositata entro il giorno successivo, è da considerarsi come se fosse letta all’udienza stessa.
2. La finzione di lettura (fictio recitationis)
L’innovazione della finzione di lettura trova una ragione giustificatrice nell’esigenza pratica di contemperare i tempi dei depositi delle note delle parti con la concentrazione, nella stessa udienza, del provvedimento decisorio: ai sensi dell’art. 196sexies disp. att. c.p.c., infatti, il deposito della nota è tempestivamente eseguito quando la conferma del completamento della trasmissione “è generata entro la fine del giorno di scadenza”, con conseguente possibilità della inevitabile dilazione della decisione almeno al giorno successivo.
È da considerare, tuttavia, che nella giurisprudenza di merito è già riscontrabile la prassi di integrare la fissazione del termine per le note ex art.127ter mediante la prescrizione, oltre che del giorno, anche di un orario (le 9.00 o 10.00 a.m.) compatibile con l’esame degli atti nel medesimo giorno da parte del giudice.
In ogni caso, qualora il “giorno successivo” all’udienza coincida con il sabato o con un giorno festivo, ai sensi dell’art.155, commi 4 e 5 c.p.c., espressamente richiamati dall’art.196sexies disp. att. c.c., il termine è prorogato al primo giorno ulteriore non festivo: quindi nel caso di udienza cartolare di discussione di venerdì, è da considerarsi letta in udienza la sentenza depositata il successivo lunedì.
La contestualità tra la discussione e la lettura del dispositivo è stata, come noto, dapprima introdotta nel rito del lavoro dagli artt. 429, comma 1 (per il primo grado, ove è stata successivamente estesa anche alla motivazione) e 437 (per l’appello), c.p.c., quale connotato sintomatico dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione che ispiravano il processo lavoristico; anche se non è stata prevista una espressa previsione di nullità in caso di violazione, tuttavia la giurisprudenza di legittimità si è orientata sin dagli anni settanta nel senso che la lettura del dispositivo è un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto e, quindi, la sua omissione implica la nullità insanabile della sentenza ai sensi dell’art.156, comma 2, c.p.c., venendo meno una modalità “strutturalmente ordinata al perseguimento delle finalità di concentrazione processuale, e di sollecita definizione delle controversie” attraverso la previsione di una pronuncia immutabile all’esito dell’udienza di discussione[iv].
La lettura dell’intera sentenza - cioè del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che lo motivano - è stata successivamente, come noto, “esportata” dal rito del lavoro anche nel rito ordinario di cognizione sia pure come scelta discrezionale del giudice monocratico (art.281sexies c.p.c.) e, da ultimo, si è imposta come regola nel procedimento semplificato di cognizione avanti al giudice monocratico ( art.281terdecies, comma 1, c.p.c.), avanti al giudice di pace (art.321 c.p.c.) ed anche nel processo ordinario di appello nei casi nei quali il gravame sia ritenuto suscettibile di essere deciso senza la nomina del consigliere istruttore o, comunque, sia valutato dal consigliere istruttore di pronta soluzione (artt. 349bis, comma 1, c.p.c.; 350bis, comma 1, c.p.c.).
Tuttavia, è da sottolineare che a seguito della riforma ex d.lgs n. 149/2022 si è eliso il nesso originario di tra discussione e lettura della decisione in quanto ora l’art.281sexies c.p.c. – richiamato dagli artt. 281terdecies, 321 e 350bis c.p.c. - consente comunque al giudice, in alternativa alla lettura contestuale, di depositare la decisione nei successivi trenta giorni
Ora, la finzione di lettura non appare, invero, espressamente limitata, nel suo ambito di applicazione, né quanto al rito (ordinario o speciale) né relativamente allo stato del procedimento (trattazione o discussione): è, infatti, prevista non già dall’art.128 c.p.c., relativo all’udienza pubblica di discussione, bensì dalla disciplina generale della trattazione scritta, all’ultimo comma dell’art.127ter, ad integrazione della disposta assimilazione della modalità cartolare all’udienza (“a tutti gli effetti”).
Potrebbe, quindi, teoricamente applicarsi a tutte le decisioni adottate all’esito delle udienze comunque “sostituite” dalla trattazione scritta ai sensi dell’art.127ter, comma 1, c.p.c., ivi compresi, quindi, i provvedimenti aventi contenuti ordinatori o istruttori.
Tuttavia, non sono da trascurare i rischi di tale interpretazione estensiva della finzione di lettura: in ragione dell’espressa assimilazione del tempestivo deposito della decisione (“entro il giorno successivo”) alla effettiva lettura in udienza, infatti, il provvedimento adottato non dovrebbe neppure essere comunicato alle parti a cura del cancelliere, ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., essendo tale adempimento previsto solo per l’ordinanza “pronunciata fuori dall’udienza”[v], con la conseguenza che le parti sarebbero private dell’utilità della comunicazione ogniqualvolta il giudice emetta la sua decisione entro il primo dei trenta giorni previsti in via generale per il deposito del provvedimento ai sensi dell’art.127ter, comma 3, c.p.c..
È, quindi, preferibile seguire la intentio legis – desumibile dalla relazione al d. lgs n. 164/2024[vi] - orientata chiaramente soltanto a sostituire per equivalente una modalità decisoria già specificamente prevista per l’udienza in presenza delle parti, in tal senso circoscrivendo la fictio alle sole ipotesi in cui il codice processuale già contempli la lettura in udienza della decisione; ipotesi, pertanto, nelle quali le parti ben possono essere onerate della verifica dello stato del procedimento a prescindere da ogni avviso da parte della cancelleria, ai sensi dell’art.136 c.p.c., che non è previsto per la sentenza contestuale all’udienza
La finzione temporale dovrebbe, altresì, implicare che la sentenza si debba intendere emessa il giorno precedente anche ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c., con elisione cioè di un giorno del periodo c.d. lungo: sarebbe, tuttavia, preferibile argomentare, in senso contrario, che il sacrificio di diritti essenziali della difesa è estranea alla ratio dell’innovazione, finalizzata soltanto a promuovere la tempestività della decisione nei limiti consentiti dalla trattazione “cartolare”, così ammettendo la decorrenza del termine per l’impugnazione solo dal giorno di deposito “effettivo” del provvedimento.
3. La decisione tardiva
La questione più delicata è senz’altro quella di stabilire le conseguenze dell’eventuale deposito della sentenza oltre il termine previsto per l’integrazione della finzione di lettura (c.d. fictio recitationis), oltre cioè il giorno immediatamente successivo all’udienza, tenuto conto anche del differimento ex art.155, commi 4 e 5 c.p.c..
Si è già ricordato l’orientamento giurisprudenziale, affermatosi nel 1977, che ha individuato nella omessa lettura della decisione in udienza una nullità assoluta pur non prevista espressamente dal codice processuale ma derivante, ex art.156, comma 2, c.p.c., dal difetto di un requisito essenziale per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuato nel valore della concentrazione processuale.
È utile risalire, tuttavia, anche ad una delle critiche che a suo tempo furono rivolte in dottrina alla pronuncia delle Sezioni Unite, vale a dire che l’enfasi posta sulla concentrazione nella sola sequenza finale del processo (discussione-decisione) risulta del tutto sproporzionata rispetto all’assenza di qualsiasi sanzione al difetto di concentrazione nelle scansioni processuali precedenti, inerenti alla fase introduttiva, alla trattazione ed alla assunzione delle prove, governate da termini meramente ordinatori, già stigmatizzati come “canzonatori”[vii].
In effetti si può osservare che la qualità della decisione potrebbe, in astratto, ritenersi condizionata dal tempo trascorso rispetto all’assunzione degli elementi di prova assai più che dal difetto di immediatezza e contestualità rispetto alla discussione tecnica tra i legali delle parti.
A distanza di poco più di venti anni dall’arresto delle Sezioni Unite il legislatore costituzionale (l. n. 2/1999) ha finalmente ridefinito il valore della concentrazione affermando, nell’ambito del c.d. giusto processo ex art.111 Cost., il principio della ragionevole durata del processo, in forza del quale il valore della concentrazione dovrebbe essere predicato con riguardo non già a singoli segmenti processuali bensì all’intero tempo occorrente per la tutela giurisdizionale.
Ora, anche nell’ambito della trattazione meramente “cartolare” il termine previsto all’ultimo comma dell’art.127ter c.p.c. non è affatto presidiato da una esplicita nullità né ad esso è ricollegata alcuna decadenza, essendo piuttosto espressamente da osservare soltanto ai fini della integrazione della finzione di lettura della decisione.
Si può, al riguardo, ritenere che l’eventuale deposito tardivo della sentenza, oltre il giorno successivo all’udienza, sia comunque idoneo ad integrarne la funzione ex art.156, comma 3, c.p.c. – quale decisione sulla domanda – tenuto anche conto che la discussione si è svolta solo attraverso il deposito delle note e senza il dialogo immediato con il giudice, così difettando anche quei connotati di oralità ed immediatezza che caratterizzano la discussione ordinaria in presenza.
Una volta, quindi, intervenuto il pur tardivo deposito del provvedimento, l’atto è cioè idoneo a produrre gli effetti propri della sentenza in ottemperanza al principio di conservazione formulato all’art.159, comma 3, c.p.c.
L’ipotetica nullità, del resto, sarebbe da far valere attraverso il rimedio dell’impugnazione ex art.161, comma 1, c.p.c. ed implicherebbe la rinnovazione del giudizio di merito, sia pure nella medesima sede di gravame e senza il regresso del grado [viii], con conseguente dilatazione della durata complessiva del processo verosimilmente ben superiore all’entità del ritardo della decisione; la lettura della sentenza sarebbe, altresì, rimessa ad un giudice diverso da quello avanti al quale sono state raccolte originariamente le prove.
Appare, pertanto, evidente che il valore della concentrazione, circoscritto alla sequenza finale discussione-decisione, rischia di essere non più compatibile con il valore preminente del tempo nel c.d. giusto processo e, quindi, con lo stesso interesse della parte alla pronuncia sulla rispettiva domanda in tempi ragionevoli.
Di tale considerazione sembra avere tenuto conto proprio il legislatore della riforma processuale del 2022 allorché ha consentito nel rito ordinario al giudice, in forza di una valutazione discrezionale, di non decidere contestualmente all’udienza di discussione e di riservarsi la decisione nei successivi trenta giorni (art.281sexies, comma 3, c.p.c.), così superando l’originario nesso di conseguenzialità tra discussione e lettura della sentenza.
Si può, quindi, in conclusione, auspicare che nella sede di impugnazione si possa utilmente discutere, tra i vizi del provvedimento, solo sulla offerta “lettura” degli atti processuali piuttosto che sulla “finzione di lettura” della decisione giudiziale.
[i] Per una prima riflessione sulle novità apportate dal “correttivo” al regime della trattazione “scritta” v. G. AMMASSARI, Focus sul correttivo della riforma della giustizia civile: le novità in tema di udienze atti e processo telematico, su www.questionegiustizia.it, 23.12.2024; A. CARBONE, Udienza cartolare e D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Nuove questioni e vecchi problemi in attesa delle Sezioni Unite, www.questionegiustizia.it, 28.1.2025.
[ii] La questione relativa alla compatibilità del rito del lavoro con la trattazione ex art.127ter c.p.c. è stata rimessa alle Sezioni Unite a seguito di Cass., sez. lav., ord. 3 maggio 2024 n. 11898.
[iv] Così Cass., sez. un., sent. 22 giugno 1977, n. 2632, cui si è conformata la giurisprudenza successiva: Cass. sez. VI-III sent. 28 novembre 2014 n. 25305,; Cass. sez. II, sent. 4 gennaio 2018 n. 72; Cass. VI-II, ord. 6 dicembre 2021, n. 38521. In dottrina, la tesi della nullità assoluta fu sottoposta a rilievi critici già da V. ANDRIOLI, Dir.proc.civ.,1978,I,495 e G.GUARNERI, In tema di omessa lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro, Dir.proc.civ.,1978,I,546; successivamente anche da M.VELLANI, Alcune considerazioni in tema di lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro, Riv.trim.dir.proc.civ., 2008, 435.
[v] Nel senso che il provvedimento adottato all’esito dell’udienza “cartolare” debba essere comunicato dalla cancelleria alle parti costituite ai fini della legale conoscenza dello stesso, Cass. sez. I, ord. 18 maggio 2023 n. 13735.
[vi] In tal senso la Relazione illustrativa dello schema del d.lvo 31 ottobre 2024 n. 164:”si è scelto di considerare….il dato esperienziale in base al quale l’udienza di cui all’art. 420, che in virtù dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione dovrebbe condensare in una sola udienza l’intera vicenda processuale, si snoda invece in una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del primo comma, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali sono destinate due o più udienze. Le disposizioni di cui si è detto (cioè la discussione in modalità ex art.127ter c.p.c.) troveranno quindi applicazione in relazione al segmento decisorio”.
[vii] G. Fabbrini, Della tutela eccessiva di talune forme processuali, Riv. Dir. Lav., 1978, II,721, che richiama la nota stigmatizzazione dei termini “canzonatori” di Redenti.
[viii] In conformità ad un principio consolidato: Cass. 25305/2014 cit.; Cass., sez. III, sent. 9 marzo 2010, n. 5659; Cass., sez. lav., sent. 8 giugno 2009, n. 13165.
Immagine: illustrazione di Günter Grass per la copertina del suo L'incontro di Telgte (1979).