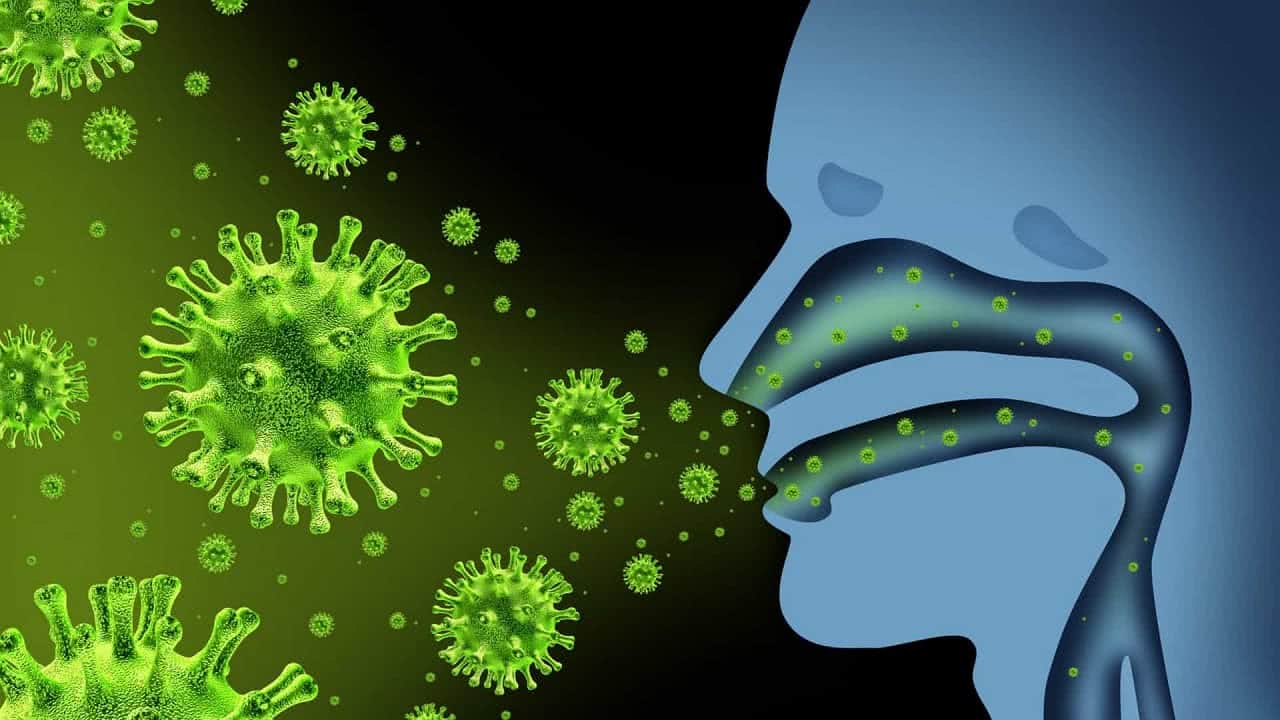“La fine di un sogno”. Una lettura epistemologica
di Bruno Montanari
Sommario: 1. Per una introduzione - 2. Una parola-chiave: “legittimazione” - 3. La colpa e il ragionevole dubbio - 4. L’accusa e la sua plausibilità argomentativa.
1. Per una introduzione
Il testo scritto da Tomaso Epidendio su “Giustizia Insieme “, La grande decostruzione del disegno costituzionale della magistratura, ha un titolo inquietante, che invita il lettore ad una riflessione spregiudicata e a sua volta inquieta. Partiamo da alcune parole dell’autore: “Stiamo tutti vivendo − proprio tutti, magistrati e non – la fine di un grande sogno, quello del disegno costituzionale della magistratura…la fondazione di una magistratura interclassista cui si accede per meriti tecnico - giuridici accertati da pubblico concorso (art. 106 Cost.), costituita come ordine istituzionale… [autonoma e indipendente e dotata di potere effettivo disponendo della polizia giudiziaria] e dal radicamento della legittimazione giudicante in una soggezione -quella alla legge, ma ‘soltanto’ alla legge -…:un’autonomia e una indipendenza che si legittima in una sottomissione quella a una ‘legge’ di fronte alla quale… (art.3 Cost.)”.
Epidendio usa in questo brano un termine-chiave per l’ordinamento giuridico, e non solo per il nostro novecentesco, ma “chiave” per ogni potere effettivo, che abbia inteso assumere nella storia una configurazione di “sistema”, fondata su regole stabilizzanti: il termine è “legittimazione”. Termine, che sottolinea l’esigenza di giustificare un potere che un essere umano esercita, introducendo una disuguaglianza (comando-obbedienza), su di un altro essere umano, antropologicamente pari. Ecco perché ho qualificato quel termine come “chiave” e a buon diritto Epidendio lo ricorda, data la configurazione del potere affidato alla magistratura, nel suo complesso.
Tuttavia, il sogno è finito: il tema della “soggezione alla legge” (pur nelle diverse modalità di interpretazione consentite dall’ordinamento) è nei fatti superato, per le ragioni proprie della attuale visione del mondo, passate in rassegna dall’autore. Tale tema, infatti, nella prospettiva di molti, magistrati e dottrina, non sarebbe in grado di fronteggiare efficacemente le richieste di giustizia della società contemporanea. Occorre incamminarsi, allora, in quello che ormai viene definito “diritto vivente”, che si costruisce non più tramite l’interpretazione, ma attraverso una sorta di “oltrepassamento”, secondo la felice definizione di Mario Barcellona ([1]). “Il giudice – scrive Epidendio - è sempre meno il tecnico che effettua operazioni di ‘sussunzione’ del fatto nella fattispecie descritta dalla norma ed è sempre più l’autore diretto di ‘bilanciamenti’ di valori, attraverso i quali ricostruisce il senso e seleziona le disposizioni applicabili….Da organo soggetto ‘soltanto’ alla legge’…il giudice finisce per risultare non più soggetto a nulla: inebriato da una libertà mai prima conosciuta, non si avvede di perdere la radice costituzionale della sua legittimazione giudicante…”
È vero, per restare ancora nel testo, che non si può restare laudatores temporis acti, ma neppure è possibile assumere l’accadere come l’ineluttabilità del fato (avrebbero detto gli antichi), ma occorre ancora esercitare la libertà intellettuale propria dello spirito critico formatosi nella tradizione filosofica e culturale della Modernità (con tutti i suoi inevitabili difetti).
2. Una parola-chiave: “legittimazione”
La riflessione che intendo prospettare può sintetizzarsi nel modo seguente. La parola-chiave è appunto, come ho già ricordato, “legittimazione”. Il potere funzionale esercitato dalla Magistratura, in quanto Organo indipendente dello Stato (il quale ultimo, perciò, si definisce “di Diritto”), ha il suo fondamento in quella determinazione costituzionale che ne stabilisce sia i modi di investitura nelle funzioni, sia i modi di esercizio del relativo potere (la subordinazione alla Legge). Allora il punto è in questa considerazione che contiene un interrogativo: se si è investiti in una determinata funzione, che si esprime attraverso l’esercizio di un potere, secondo le norme dettate dalla Costituzione, come è possibile esercitare quel potere, così formalmente fondato e determinato, secondo modalità in fatto diverse, che lo trasformano da “funzionale” in meramente “effettivo”? Detto con una sintesi rozza: l’ordinamento va bene per l’investitura e acquisire il potere, ma è possibile poi mettere da parte l’ordinamento allorché quel potere viene esercitato. Con una conseguenza assai rilevante per uno Stato di Diritto: mentre il primo potere è per definizione responsabile, il secondo potere è per definizione irresponsabile. È una mera questione epistemologica: mentre l’esercizio di una funzione implica sempre un giudizio conformità; al contrario, il fatto, in quanto accadimento, non si conforma a nulla, se non al suo stesso accadere, se così si può dire secondo l’epistemologia funzionalistica ([2]).
Ho ritenuto di affrontare un tema così delicato seguendo il paradigma epistemologico, che garantisce da interpretazioni politico-ideologiche. Intendo applicare questo medesimo paradigma ad un altro tema, altrettanto delicato, che ancora ho trovato nel testo di Epidendio: quello della differenza tra magistratura inquirente e requirente, innescato dalla riforma del processo penale che ha trasformato l’inquisitorio (sia pure temperato) in accusatorio. Dico subito, che la differenza tra inquisitorio e accusatorio è fondamentalmente epistemologica, in quanto dipende dalla differenza concettuale tra “colpa” e “accusa”: la “colpa” è oggettiva, l’accusa è soggettiva (ma di questo più avanti). E’ una distinzione così radicale che richiede, per coerenza, la distinzione delle carriere.
3. La colpa e il ragionevole dubbio
Andiamo per ordine. Innanzitutto il tema della verità processuale, come oltrepassamento ragionevole del dubbio: un marchingegno logico ma socialmente necessario.
Entrano in gioco, come è noto, due capisaldi del processo: il complesso probatorio ed il libero convincimento del giudice. Non si tratta di formule matematiche (lato sensu) per una possibile determinazione dell’evento, ma di due sguardi (rubo l’idea ad un autorevole filosofo del ‘900, Ernst Cassirer ([3]): quello dell’investigatore e quello del giudice. Alla fine del percorso, la necessità del diritto: la “certezza” del giudicato, intesa come rappresentazione corrispondente ad una “verità” detta, appunto, “processuale”. Fictio terminologica, per la quale assume senso, esclusivamente pratico, il “dubbio”, nella sua trasmigrazione dal necessariamente soggettivo al ragionevolmente oggettivo, per cui poi si spiega l’“oltre”.
La scienza giuridica ha sempre avuto contezza che operava tramite una fictio, per altro necessaria; ha perciò aggirato il problema, spostandone la soluzione sul tipo di legittimazione dei soggetti processuali, sulla legittimazione dei loro “sguardi”. In breve, la “verità” del giudizio dipende dalla legittimazione degli sguardi dei soggetti processuali. È questo il contesto nel quale prende forma la configurazione dei due modelli processuali: l’inquisitorio e l’accusatorio.
Prova ne sia, che in quel tempo in cui si riteneva che la verità del giudizio non potesse essere una fictio dell’uomo, lo “sguardo” cui si ricorreva era quello di Dio (che stava dietro anche alla confessione del supposto reo). Lo mostra bene Franco Cordero in quel bellissimo libro che è Riti e sapienza del diritto ([4]), evocando l’origine del modello processuale che ne verrà fuori: l’“inquisitorio”. Il suo contrappunto epistemologico è il modello “accusatorio”. Contrappunto che, come ho già sottolineato, è legato al significato dei due termini-chiave, che danno il nome ai rispettivi modelli: la “colpa” e l’“accusa”. Il contrappunto: la “colpa” esige la dimostrazione della verità; l’“accusa”, al contrario, chiede l’argomentazione logica di una possibile e plausibile ricostruzione dell’evento, operata dal magistrato dell’istruzione.
La “colpa”, quindi, si inscrive nell’orizzonte logico del vero/falso. Il modello inquisitorio è tutto raccolto in questa configurazione razionale, ed il ricorso al giudizio di Dio, di cui parla Cordero, ne è la testimonianza più suggestiva ed immaginifica. A ciò segue che l’attribuzione della colpa è, dal punto di vista razionale, un atto di verità. È necessario, perciò, che un tale atto sia posto in essere da un soggetto strutturalmente legittimato ad esprimerla e deve essere fondato su di un dispiegamento probatorio analogo a quello di un esame scientifico. Nell’esperienza storico-istituzionale della “Modernità”, un tale compito appartiene allo Stato, ente sovrano, guardiano ed anche creatore della giustizia. Il giudizio ricostituisce l’ordine sociale turbato solo se è giusto; ed è giusto solo se è vero. Il mezzo per affermare la colpa è l’applicazione della legge tramite la sentenza, la quale conferma e qualifica come vero ciò che è già stato già ricostruito come vero.
In definitiva, affinché la giustizia soddisfi il suo legame con la verità, occorre che il magistrato inquirente sia un ricercatore di verità. Magistrato inquirente e magistrato giudicante si presentano entrambi sulla scena processuale, sia pure in momenti differenti, come “bocca della legge”, poiché è quest’ultima - la legge – che realizza la giustizia, declinando insieme ricerca della verità e diritto. È epistemologicamente corretto, perciò, che le due figure siano indifferenziate nella loro qualificazione e configurazione ordinamentale.
4. L’accusa e la sua plausibilità argomentativa
Il paradigma concettuale dell’“accusa” è del tutto differente.
“Accusare”, nella tradizione storica e nella sua struttura concettuale, riposa sull’idea che la verità umana si manifesti in via argomentativa e dialettica: un individuo accusa un altro individuo dell’offesa ricevuta e l’offensore, a sua volta, contesta l’accusa su di un piano di parità. In un tale contesto, l’offesa colpisce l’uomo e la società, prima ancora che il “cittadino” in quanto membro dello Stato. Quest’ultimo, lo Stato, assolve ad una funzione organizzativa e strumentale. Emergono allora due caratteristiche legate al modello. La prima: nella possibile tensione tra libertà individuale e difesa sociale, di principio prevale la prima. La seconda caratteristica ha per oggetto il profilo retorico – epistemologico. Alla “verità”, sia pure nella sua accezione processuale, si sostituisce il concetto di ipotesi sostenibile, che porta con sé, a sua volta, due conseguenze teoriche dagli importanti riflessi pratici. Accusa e difesa corrispondono a soggetti processuali pari ordinati, coerentemente con la premessa che il magistrato che promuove l’azione penale non attribuisce una “colpa” con le relative “prove”, ma prospetta solo una ipotesi argomentativamente sostenibile, attraverso elementi di prova; e la difesa, a sua volta, potrà fornire una diversa ipotesi, attraverso altri elementi di prova.
Insomma, nel modello processuale accusatorio l’uomo sperimenta tutta la sua finitudine. Non presume di conoscere la verità, ma solo cerca, a volte drammaticamente, di inseguire una possibilità, nella quale la dimensione epistemologicamente “ipotetica” può essere corroborata solo dalla sostenibilità retorica messa alla prova attraverso il confronto tra parti, processualmente pari. Al giudice, non solo super partes, ma soggetto altro dalle parti, spetta di formarsi una “opinione”, che valga come “giudizio”. Tutto ciò significa che il confronto tra ipotesi retoricamente ed argomentativamente sostenibili si traduce, nella mente del giudice, in una rappresentazione plausibile, che dà luogo alla sentenza. E non senza significato: appellabile.
In definitiva, nel modello accusatorio l’investigatore è sicuramente un magistrato, sia per l’indipendenza della sua investitura sia per il modello argomentativo che lo porta a rappresentare determinati eventi come “fatti” costitutivi di “elementi” di prova, per prospettarli come ipotesi per una accusa sostenibile, da sottoporre alla valutazione probatoria dell’organo giudicante. Ne segue, per coerenza epistemologica, che si tratta di due profili di magistrati, quello requirente e quello giudicante, concettualmente e strutturalmente distinti; di qui la distinzione delle carriere.
In altre parole, nel modello accusatorio prende forma la “verità” intesa, in generale, come “rappresentazione possibile del mondo”.
Non v’è dubbio: il testo di Tomaso Epidendio suscita davvero l’esercizio di un pensiero “critico” (nel senso kantiano del termine) su tematiche che investono e turbano nel profondo il nostro attuale sistema istituzionale.
[1] Cfr., Norme e prassi giuridiche: giurisprudenza usurpativa e interpretazione funzionale, Mucchi ed. Modena 2022
[2] Cfr., N.Luhmann, Come è possibile l’ordine sociale, tr.it Laterza, Bari 1985.
[3] Cfr., I problemi filosofici della relatività. Lezioni 1920-1921, tr.it a cura di R. Puttello (con Premessa e note del traduttore-curatore editoriale), Mimesis, Milano-Udine 2015
[4] Laterza, Bari 1981.