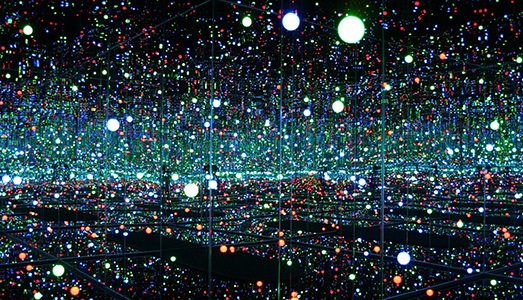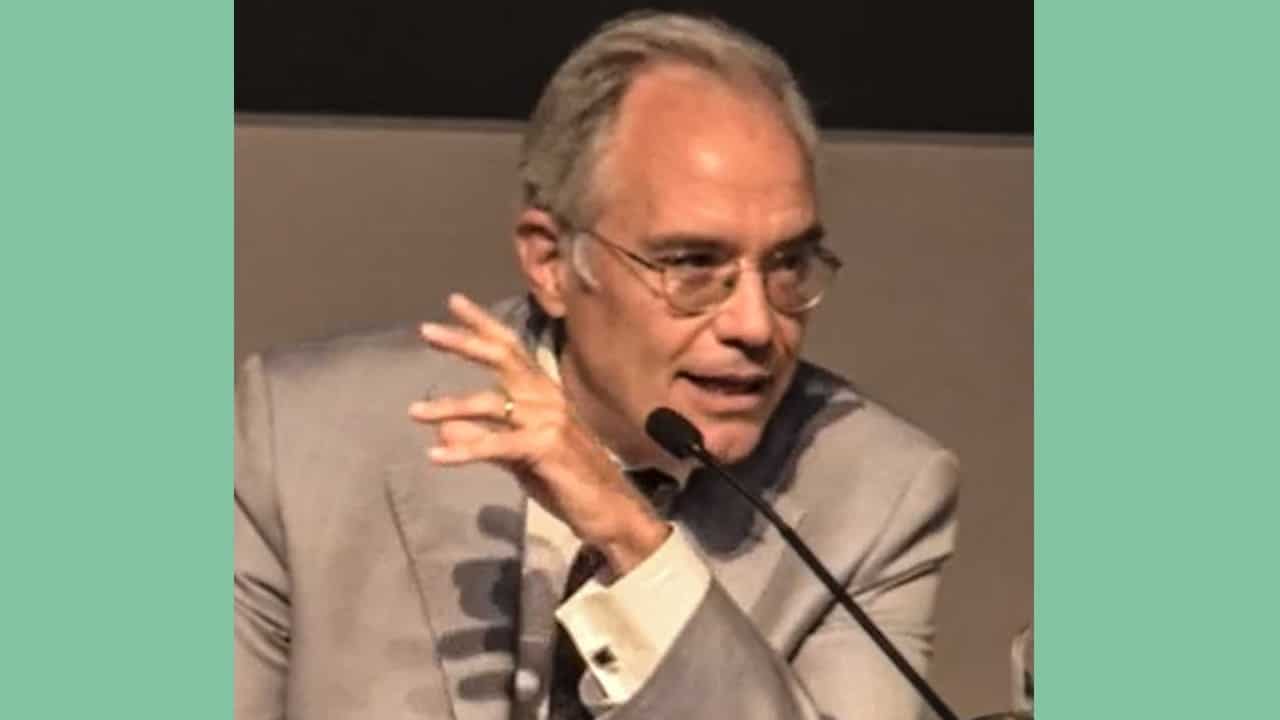Crisi della legge o crisi del giudice? Considerazioni a margine di un recente scritto di Tomaso Epidendio
di Antonello Cosentino
Sommario: 1. La crisi della soggezione del giudice alla legge. - 2. Legge e principio di legalità. - 3. La crisi del giudice. - 4. Le prospettive.
1. La crisi della soggezione del giudice alla legge.
In un recente articolo su questa Rivista Tomaso Epidendio[1] ha tracciato il profilo della progressiva decostruzione del modello di magistratura tratteggiato nella nostra Costituzione.
In tale articolo si analizzano, con indubbia acutezza, i fattori, interni ed esterni alla magistratura, che hanno concorso al dissolvimento del sogno dei Padri costituenti di una magistratura interclassista, costituita come un “ordine” non gerarchico, autonomo e indipendente da ogni altro “potere”, legittimato dalla soggezione “soltanto” alla legge.
Nella scia del vivace dibattito suscitato dalle dense riflessioni sviluppate in quell’articolo, vorrei soffermarmi sul primo dei fattori ivi indicati tra le cause della fine di quel sogno: la crisi della soggezione del giudice alla legge.
Secondo l’Autore, «il giudice è sempre meno il tecnico che effettua operazioni di “sussunzione” del fatto nella fattispecie descritta dalla norma ed è sempre più l’autore diretto di “bilanciamenti” di valori, attraverso i quali ricostruisce il senso e seleziona le disposizioni applicabili per garantire la soluzione che, in base alla sua “precomprensione” (convinzioni personali di varia natura), risulta più “giusta” nel caso concreto».
Il tema della relazione tra la posizione della norma da parte del legislatore e la sua interpretazione da parte del giudice è tra i più antichi, controversi ed arati.
Vorrei iniziare le mie riflessioni partendo dalla metafora - utilizzata da Maria Rosaria Ferrarese a chiusura del suo bel libro Diritto sconfinato - del diritto-ragno e diritto-ape[2]; in tale metafora[3] il diritto-ragno - tipico delle tradizioni dei moderni stati nazionali europei, caratterizzati dal monopolio statale del diritto - era quello che, al pari, appunto, di un ragno, «stava ben radicato sul suo territorio, era statico ed autopoietico, e la sua tela non ammetteva intrusioni da parte di elementi estranei»; il diritto-ape - tipico del mondo pre-moderno e riemergente, secondo molti studiosi, della presente fase storica – è invece - al pari, appunto, di un’ ape - «instancabile, sempre in movimento, che cerca di nutrirsi proprio di elementi diversi e che vive di contatti numerosi e variabili con altri mondi … un diritto che sembra non volersi privare dell'ironico pendolarismo tra il grande e il piccolo, il nobile e il vile, che consente di vedere la verità umana contemporanea nelle sue contraddizioni e nelle sue illusioni».
Ecco, a me pare che questa immagine sintetizzi bene la dialettica culturale di questi anni, anni nei quali il diritto perde sempre più vistosamente il suo collegamento con la legge e diventa sempre più simile all’ape che al ragno; anni nei quali la funzione legislativa, come il potere che in essa si esprime, sembra indebolirsi progressivamente, a fronte dell’ampliamento dello spazio riservato alla creatività, da un lato, della giurisprudenza, e d’altro lato, delle prassi mercantili, delle esperienze di soft law, dei protocolli organizzativi (e talvolta normativi) tra ceti professionali e, addirittura, tra ceti professionali e poteri pubblici. Basta pensare, per percepire quasi tangibilmente cosa significa creazione del diritto “dal basso”, alla stupefacente esperienza delle prassi interpretative condivise - prassi interpretative, si badi, non soltanto prassi organizzative - elaborate negli osservatori sulla giustizia civile sorti in tutta Italia dalla fine degli anni ’90 del secolo scorso[4]. Su questo sfondo si parla di “diritto giurisprudenziale”, di “dottrina delle corti”, di “crisi della fattispecie normativa”, di “comunità interpretante”, di “tramonto del mito del legislatore onnipotente”, e così via[5].
Su tali problematiche, però, mi sembra necessario svolgere qualche considerazione più specifica.
Lo stato moderno, come chiarì Giovanni Tarello[6], nasce con il superamento del particolarismo giuridico, vale a dire con il duplice superamento, da un lato, della coesistenza di diverse autorità regolatrici nello stesso contesto e, d’altro lato, della coesistenza di regimi giuridici differenziati in ragione dell’autorità regolatrice, delle qualità personali del destinatario della regola, dello spazio e del tempo in cui la regola deve trovare applicazione[7] .
È l’esigenza di superare il particolarismo giuridico, conseguente all’evoluzione della società e dell’economia europea sviluppatasi tra il XVIII e il XIX secolo, che ha imposto la codificazione del diritto privato, vale a dire la sistematizzazione, razionalizzazione e omogeneizzazione delle regole che lo compongono. La codificazione era foriera di eguale trattamento dei consociati davanti alla legge: era il presupposto del principio di eguaglianza formale: “dallo status al contratto”, per dirla con Summer Maine.
Emmanuel de Las Cases, nel suo Memoriale di Sant’Elena, riporta una frase pronunciata da Napoleone nell’ esilio atlantico: “Appena il codice comparve fu tosto seguito come supplemento da commentarii, spiegazioni sviluppi e che so io ? Io era solito esclamare: Eh! Signori, noi abbiamo spazzato le stalle di Augia, per Dio, non lordiamole un'altra volta”.[8] La frase viene commentata da Renato Rordorf[9] con la considerazione che «Napoleone, dopo tutto, era pur sempre figlio di una stagione nella quale al pensiero dell’illuminismo era toccato il compito di sgomberare il campo da una selva di consuetudini e di ordinamenti di ceto la cui opacità aveva generato, sul piano applicativo, gli abusi più gravi, sicché facilmente si comprende la ragione per cui in quel torno di tempo l’esigenza di riaffermare il primato di una legge scritta, chiara e da tutti ben conoscibile, era assolutamente prioritaria (come non menzionare qui Cesare Beccaria; e si può allora anche comprendere la crudezza del paragone napoleonico tra lo sterco delle stalle e l’attività interpretativa dei primi commentatori del suo codice)».
Oggi difficilmente qualcuno potrebbe seriamente pensare di paragonare l’attività interpretativa allo sterco delle stalle di Augia. Perché l’epoca nostra - l’epoca della pos-modernità, per dirla con Paolo Grossi[10] - «ha sperimentato la caduta di molte tra le illusioni suscitate dalla stagione dell’illuminismo, o che vi hanno fatto seguito, e tra esse anche quella di un diritto positivo in grado di esprimere comandi sempre così chiari ed univoci da consentirne l’applicazione quasi meccanica ad opera di un giudice destinato a fungere da mera “bocca della legge”»[11].
Oggi è chiarissimo che il “calculemus” di Leibenitz[12] non può funzionare.
Stanno entrando in crisi, d’altra parte, entrambi i presupposti fondativi del diritto moderno, l’accentramento della produzione del diritto nello Stato nazionale e il principio di eguaglianza formale.
Sotto il primo profilo, è evidente che la produzione normativa non è più monopolio degli Stati nazionali, i quali devono ormai dividere (o contendere) la funzione di produzione del diritto con soggetti pubblici interni ai confini (si pensi, per esempio, agli enti territoriali o alle autorità amministrative indipendenti nazionali) o esterni ai confini (si pensi al diritto dell’Unione europea o al diritto convenzionale derivante da trattati internazionali, in alcuni casi presidiato da specifici organi giurisdizionali, come la CEDU); o addirittura con soggetti privati investiti di compiti di regolazione settoriale (si pensi, per esempio, al sistema delle norme Uni-Iso o ai principi contabili emanati dall’ Organismo italiano di contabilità).
Sotto il secondo profilo, il principio di eguaglianza formale patisce la crisi del “soggetto unico di diritto”; come è stato efficacemente rilevato[13] «si hanno regole per i “cittadini” e per i “non cittadini” (a loro volta distinti in cittadini Ue e cittadini non Ue); si hanno regole per i cittadini di una certa regione e altre regole per i cittadini di un’altra regione; si hanno regole per i “consumatori” e regole per i “professionisti”; regole per gli “uomini” e regole per le “donne”; e così via».
Stiamo tornando, insomma, dal contratto allo status.
La contemporaneità pone allora in questione direttamente il ruolo della legge e la sua capacità ordinante; e, specularmente, pone in questione il ruolo del giudice, che è chiamato a tradurre la lettera della legge in un comando rivolto ad un individuo e, dunque, a far camminare la legge con le gambe degli uomini.
È innegabile, infatti, che l’aumento quantitativo della produzione normativa, l’opacità derivante dallo scadimento qualitativo della fattura delle disposizioni (a volte conseguente alla consapevole scelta del legislatore di rimettere all’interprete l’individuazione del punto di caduta finale di processi di mediazione di interessi sociali non interamente risolti in sede politica), la pluralità di fonti nazionali e sovranazionali di livello diverso, la crescente diffusione di disposizioni che esprimono regole elastiche (clausole generali) e di disposizioni che non esprimono regole ma principi[14], finisce con il potenziare il ruolo dell’interprete e con il conferirgli una funzione che può addirittura apparire creativa (inventiva, secondo la formula di Paolo Grossi[15]). Siamo molto lontani, oggi, dalle condizioni di stabilità e chiarezza delle leggi sul cui presupposto Montesquieu invitava ad accostarsi alle stesse “con mano tremante”.[16]
Fin qui, la mia consonanza con la riflessione di Tomaso Epidendio è completa.
2. Legge e principio di legalità.
Tale riflessione, tuttavia, cessa di persuadermi là dove descrive «la lunga parabola, che parte dalla celebre Assemblea della ANM di Gardone, attraversa la stagione dei cd. “Pretori d’assalto”, per approdare poi alle metodiche ermeneutiche delle cd. interpretazioni “costituzionalmente orientate” e, successivamente, “convenzionalmente o comunitariamente orientate”» come un percorso al cui esito «il giudice finisce per risultare non più soggetto a nulla: inebriato da una libertà mai prima conosciuta, non si avvede di perdere inconsapevolmente la radice costituzionale della sua legittimazione giudicante e non sa prevedere che, prima o poi, la tendenza all’omeostasi del sistema gli avrebbe chiesto il conto, avrebbe individuato nuove forme di responsabilizzazione, così da mettere a rischio quell’autonomia e indipendenza che il costituente voleva garantita da una soggezione, che, ormai non solo più scientificamente, ma sempre di più anche nella pratica, si riconosce impossibile, quella alla legge».
Non mi sembra, infatti, che la crisi della legge possa farsi coincidere tout court con la crisi del principio di legalità.
Soccorre, mi pare, l’antichissima distinzione tra jura e leges[17], su cui ancora pochi giorni fa è tornato, con l’usuale acutezza, Aurelio Gentili nel suo intervento al convegno “Nell’Ottantesimo del Codice civile. Giurisprudenza e Dottrina a confronto”, svoltosi in Cassazione nei giorni 20 e 21 giugno 2022.
La crisi della legge non si identifica con la crisi del diritto.
Come ha chiarito lucidamente Luigi Ferrajoli[18], il principio di legalità è un principio formale, in duplice senso. In primo luogo, nel senso che la legge può avere qualunque contenuto (Piero Calamandrei scriveva che «nello stampo della legalità si può calare oro o piombo»[19]). In secondo luogo, nel senso che esso non allude necessariamente alla legge quale legge dello Stato; esso allude, piuttosto alla logica del diritto. «Fa riferimento alla legge nel senso di norma generale ed astratta che predispone effetti in presenza dei presupposti, quali che siano, da essa prestabiliti; garantisce la prevedibilità, sia pure relativa, di tali effetti e dei loro presupposti e, insieme, del giudizio su di essi»[20].
In sostanza, sottolinea Ferrajoli, non ha nessuna importanza che le norme generali ed astratte richieste dal principio di legalità siano leggi dello Stato, o leggi regionali, o regolamenti dell’Unione europea o trattati internazionali o anche norme consuetudinarie. Ciò che importa, ai fini del ruolo garantistico svolto dal principio di legalità, è la predeterminazione normativa in astratto e formalmente vincolante dei presupposti delle decisioni giudiziarie.
Se infatti è innegabile che l’interpretazione di un testo, di qualunque testo - giuridico, religioso, letterario - può spesso offrire risultati non univoci e che, in particolare, accade sovente che un testo normativo mostri la pluralità di significati che esso racchiude solo quando viene chiamato ad essere applicato ad una concreta situazione di vita, è però altrettanto innegabile che esiste un limite nelle possibilità espansive dell’interpretazione e tale limite è fissato dal testo della disposizione, che l’interprete non può infrangere. Tale limite è stato tenuto ben presente e ben fermo nella giurisprudenza elaborata dalla magistratura italiana, anche dopo Gardone. Le interpretazioni costituzionalmente orientate, convenzionalmente orientate, eurounitariamente orientate che rispettano tale limite non sono contra jus e nemmeno contra legem; quelle che non lo rispettano sono, semplicemente, interpretazioni sbagliate.
Su questo punto la giurisprudenza della Suprema Corte è nettissima. Il chiaro rifiuto di un dictum giudiziale che fuoriesca dalla proposizione prescrittiva espressa dall’enunciato è stato affermato molte volte: cito solo due pronunce, entrambe provenienti dalla Sezioni Unite civili: la sentenza n. 15144/11, dove si afferma che «Nel quadro degli equilibri costituzionali (ispirati al principio classico della divisione dei poteri) i giudici (estranei al circuito di produzione delle norme giuridiche) sono appunto (per disposto dell'art. 101, comma 2, Cost.), "soggetti alla legge". Il che realizza l'unico collegamento possibile, in uno Stato di diritto, tra il giudice, non elettivo né politicamente responsabile, e la sovranità popolare, di cui la legge, opera di parlamentari eletti dal popolo e politicamente responsabili, è l'espressione prima»; e la sentenza n. 24413/21 dove si afferma che «l'interpretazione giurisprudenziale non può che limitarsi a portare alla luce un significato precettivo (un comando, un divieto, un permesso) che è già interamente contenuto nel significante (l'insieme delle parole che compongono una disposizione, il carapace linguistico della norma) e che il giudice deve solo scoprire. L'attività interpretativa, quindi, non può superare i limiti di tolleranza ed elasticità dell'enunciato, ossia del significante testuale della disposizione che ha posto, previamente, il legislatore e dai cui plurimi significati possibili (e non oltre) muove necessariamente la dinamica dell'inveramento della norma nella concretezza dell'ordinamento ad opera della giurisprudenza».
Ed allora, se la giurisprudenza di legittimità non teorizza in alcun modo una funzione creativa della giurisprudenza, il tema che oggi si pone a me pare essere, più che quello della crisi della soggezione del giudice alla legge, quello della caduta di fiducia dei cittadini nei confronti della magistratura[21]; in altri termini, il tema della crisi del giudice.
3. La crisi del giudice.
Il tema della crisi del giudice si declina sotto diversi profili; essi investono, tra l’altro:
- il modello ordinamentale, specialmente con riferimento all’appannamento del principio, fissato dall’articolo 107 Cost., per cui i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni; principio inverato nella storia della magistratura italiana grazie alla spinta culturale dell’Associazione Nazionale Magistrati, che nel congresso di Gardone del 1965 seppe cogliere il messaggio della Costituzione repubblicana con straordinaria lucidità e consapevolezza;
- il sistema dell’autogoverno, specialmente con riferimento ai meccanismi di valutazione dei magistrati, all’esercizio della discrezionalità nel conferimento di uffici direttivi e semidirettivi, alle prospettive della giustizia disciplinare;
- il ruolo costituzionale del giudice ordinario come giudice naturale dei diritti soggettivi, in un contesto normativo che rende sempre più complessa la ripartizione della giurisdizione tra i giudici ordinario, amministrativo e contabile e in un contesto politico e culturale che vede rilevanti settori delle classi dirigenti nazionali mettere in discussione il disegno costituzionale della «unità non organica, ma funzionale di giurisdizione, che non esclude, anzi implica, una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali fa parte a sé» [22].
- da ultimo, ma non per ultimo, il senso e le prospettive dell’associazionismo giudiziario, per come esso si è evoluto nell’ultimo decennio, gradatamente appannando la propria capacità di elaborazione culturale ed appiattendosi su un ruolo di mera gestione del potere nel sistema dell’autogoverno, secondo un percorso per molti aspetti analogo a quello compiuto dai partiti politici italiani; pur consapevole del «gigantesco processo antropologico e sociale che vi è stato fra noi e la Carta scritta nel 1948»[23], io credo che a Gardone si debba ancora continuare a guardare (anzi, si debba tornare a guardare), perché, se è vero che (quasi) tutto è cambiato, dagli anni ’60, nella società italiana, mi pare altrettanto vero che le ragioni che impongono di presidiare il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione con una magistratura disegnata come potere orizzontale non sono oggi meno forti di quanto lo fossero negli anni ’60.
Si tratta, evidentemente, di temi molto vasti, ognuno dei quali richiederebbe un approfondimento specifico. A me interessa sottolineare, in questa sede, la saldatura, ben messa in luce da Enrico Scoditti, tra indipendenza e responsabilità[24]: responsabilità, voglio aggiungere, multilivello: responsabilità del singolo magistrato, nel suo lavoro quotidiano (si tratti della conduzione di una udienza o dell’esame di un testimone o della redazione di una sentenza), così come nella sua attività associativa; responsabilità dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con gli altri uffici, con l’avvocatura, con il territorio di riferimento; responsabilità del sistema dell’ autogoverno (che, sottolineo, non si risolve esclusivamente nel circuito CSM - Consigli giudiziari - Dirigenti degli uffici, ma coinvolge tutti i magistrati, perché ogni magistrato è titolare del dovere, prima che del diritto, di critica e di proposta) nell’esercizio della propria discrezionalità.
Un tema, tuttavia, mi pare che si imponga, prima di tutto e sopra tutto.
Io credo che la ricostruzione di un rapporto di fiducia, vorrei dire di una “connessione sentimentale”[25], tra la magistratura e la società italiana passi ineluttabilmente dal miglioramento del servizio reso ai cittadini, in termini di celerità di risposta, di capacità di ascolto, di accuratezza del lavoro giudiziario.
È nella quotidianità della vita giudiziaria che i magistrati si mostrano ai cittadini ed è lì, assai più che sui giornali e davanti ai dibattiti televisivi, che i cittadini si formano la loro opinione della magistratura. È lì che i cittadini possono sperimentare concretamente la fattiva presenza di un giudice che risponda tempestivamente alle loro domande. È decisivo, allora, affrontare il problema della durata dei processi, penali e civili.
Tale problema - che poi si risolve in quello del rapporto tra definizioni e sopravvenienze - è al centro del dibattito pubblico sulla giustizia da almeno trent’anni.
Esso è in parte legato a dati strutturali della società italiana; se si riflette su quanto pesano sull’amministrazione della giustizia le controversie in cui una delle parti è una pubblica amministrazione (basta pensare al contenzioso tributario e previdenziale) si coglie immediatamente come sul processo finiscano per scaricarsi anche molte inefficienze degli apparati amministrativi e come la magistratura italiana sia investita della gestione di tensioni nel rapporto tra mano pubblica e cittadini di cui le magistrature di altri Paesi a noi vicini non sono chiamate a farsi carico.
Al netto di tali profili strutturali, comunque - e per quanto più direttamente concerne l’amministrazione della giustizia, e, in particolare, l’amministrazione della giustizia civile - molto è stato fatto, non sempre utilmente, e molto c’è da fare.
Negli ultimi venti anni il legislatore è più volte intervenuto, nella materia civile, con iniziative volte sia a ridurre le sopravvenienze che ad aumentare la capacità del sistema di produrre decisioni.
Sotto il primo profilo, sono stati introdotti articolati meccanismi di mediazione, preventiva e successiva all’introduzione della lite, volti a favorire soluzioni stragiudiziali e, per altro verso, sono stati aumentati gli oneri fiscali del processo, rendendolo più costoso, in una prospettiva esplicitamente deflattiva (l’esempio più evidente è il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione[26]).
Sotto il secondo profilo, si è reiteratamente operato sul rito, irrigidendo preclusioni e termini e disciplinando le modalità redazionali degli atti, sia delle parti [27] che del giudice (si pensi ai rifermenti normativi alla concisione dei provvedimenti).
Questo insieme di interventi - che pure qualche risultato, in termini quantitativi, ha portato - non ha colto, a mio avviso, il cuore del problema ed ha recato non irrilevanti svantaggi di sistema.
Le limitazioni dell’accesso alla giustizia civile, sia sotto il profilo dell’incremento dell’onere economico imposto all’attore, sia sotto il profilo dell’introduzione di meccanismi di conciliazione limitativi della procedibilità, ha evidentemente un costo in termini di riduzione di tutele; un costo che mi sembra più allarmante in relazione al primo profilo, perché inequivocabilmente censitario.[28]
Gli interventi effettuati sul processo, per contro, sembrano perdere di vista che la disciplina processuale non è funzionale al tempo del processo ma alla qualità del medesimo. Essa deve, cioè, modellare un processo idoneo a pervenire a risultati di giustizia, ossia a produrre una decisione fondata sull’esatta interpretazione della legge applicata a fatti ricostruiti nel rispetto del contraddittorio delle parti secondo modalità che favoriscano la massima possibile approssimazione della verità processuale alla verità storica. Il tempo del processo è una variabile indipendente rispetto al rito.
Anche le esortazioni del legislatore alla brevità degli atti, sia delle parti che del giudice, non mi paiono congruenti al fine di ridurre la lunghezza dei processi. Non è in dubbio che la sinteticità sia un pregio: gli atti devono essere sintetici perché la sinteticità favorisce la chiarezza. Ma la sinteticità - o, per meglio dire, la diffusione generalizzata tra gli avvocati e i magistrati di uno stile di redazione dei rispettivi atti caratterizzato da sinteticità ed asciuttezza - non si impone per legge: è una conquista che richiede un lavoro culturale di lunga lena, che deve iniziare nelle università, proseguire nelle scuole di formazione, consolidarsi con l’esempio dei colleghi più anziani e nella pratica quotidiana. La regola di chi scrive di diritto, atti defensionali o sentenze, è quella di esporre, secondo l’aurea formula cartesiana, idee “chiare e distinte”, dicendo tutto quello che serve e solo quello che serve[29]; ma l’applicazione di tale regola è funzionale a farsi capire, non a ridurre i tempi dei processi.
4. Le prospettive.
Il problema di oggi, dunque, è quello di ricostruire il rapporto di fiducia tra la magistratura e la società italiana e, come ho sopra accennato, tale opera di ricostruzione passa imprescindibilmente dal potenziamento della capacità del sistema giudiziario di tutelare tempestivamente i diritti dei cittadini. Non è solo, va sottolineato, un problema di quantità: è anche, forse soprattutto, un problema di qualità. Le decisioni frettolose, le decisioni che comprimono ingiustificatamente l’istruttoria, quelle che non si confrontano con le argomentazioni delle parti, quelle che trascurano i precedenti giurisprudenziali, non definiscono un procedimento; si limitano a trasferirlo davanti al giudice dell’impugnazione. Da qui la necessità che i programmi che gli uffici sono chiamati a predisporre per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non si risolvano in una rincorsa a spazzare in qualunque modo le scrivanie, ma valorizzino l’esigenza che le controversie, civili e penali, siano definite con pronunce che - sia che provengano da magistrati togati, sia che provengano da magistrati onorari – abbiano una tenuta che le renda sufficientemente accettate dalla comunità e, quindi, non vengano impugnate oltre le percentuali fisiologiche.
Per migliorare la risposta del sistema alle domande di giustizia provenienti dalla società mi pare che si debba puntare sulla realizzazione di tre convergenti obiettivi:
-aumentare il numero dei magistrati in operatività, coprendo interamente gli organici ampliati dal Ministero in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 30.12.2018 n. 145 e, ovviamente, facendo corrispondere all’aumento dei magistrati in servizio un corrispondete aumento del personale amministrativo;
- aumentare la capacità di lavoro dei giudici, sollevandoli dall’ onere di attività che sottraggono tempo e possono essere svolte da persone dotate di profili professionali meno sofisticati (e meno retribuiti);
- aumentare la prevedibilità degli esiti delle controversie, mettendo la Corte di cassazione in condizione di svolgere con celerità la sua funzione di nomofilachia e, quindi, di offrire agli operatori un quadro interpretativo stabile.
Mi soffermo brevemente su ciascuno di tali punti.
Quanto al primo, le difficoltà mostrate dal tradizionale meccanismo del concorso in magistratura nel selezionare un numero di nuovi magistrati corrispondente ai posti messi a bando dimostra, a mio avviso, la necessità di ripensare a fondo il meccanismo di accesso alla magistratura. È certamente positiva l’innovazione introdotta dalla riforma Cartabia che consente la partecipazione al concorso con la semplice laurea. Ma, probabilmente, è il momento di cominciare a riflettere sulla possibilità di coinvolgere maggiormente la Scuola Superiore della Magistratura sia nella formazione dei laureati nella fase precedente al concorso, sia nello stesso meccanismo di selezione degli aspiranti magistrati, ragionando su modelli di “corso-concorso” utilizzati per altre pubbliche amministrazioni[30].
Quanto al secondo punto, ritengo realmente felice, e potenzialmente decisiva, l’innovazione dell’Ufficio per il processo. Pur con i limiti legati alla temporaneità del rapporto di lavoro degli addetti, alla carenza di spazi negli uffici, alle difficoltà della formazione dei nuovi assunti, l’Ufficio del processo rappresenta, tuttavia, una grandissima opportunità, che la magistratura non deve farsi sfuggire. Esso è la concretizzazione di un progetto al quale alcuni magistrati, con la fattiva collaborazione di una parte dell’avvocatura (penso, nuovamente, agli osservatori sulla giustizia civile) hanno cominciato a lavorare una ventina di anni fa, con i primi tirocinanti negli uffici giudiziari; un progetto (all’inizio si chiamava ufficio del giudice) che prendeva le mosse dalla considerazione dell’inadeguatezza di una organizzazione del lavoro che non prevedeva alcuno staff di supporto per il giudice. Il profilo più interessante di quei primi esprimenti fu che ai tirocinanti venivano affidate funzioni miste, in parte riconducibili a quelle di un “assistente di studio” (ricerche giurisprudenziali, redazione bozze), in parte tipiche del personale amministrativo (verbalizzazione delle attività di udienza, scarico dei ruoli); da qui la ridenominazione (che esprimeva un programma preciso) da “ufficio del giudice” ad “ufficio del processo”. Oggi l’ufficio del processo è una realtà che non solo può alleggerire il magistrato di taluni incombenti - liberando spazi da destinare allo studio, all’aggiornamento giurisprudenziale e, in ultima analisi, alla qualità del prodotto giurisprudenziale - ma che, in sinergia con l’informatizzazione del processo, può essere valorizzata per incidere in profondità sull’organizzazione del lavoro giudiziario, trasformando la pronuncia giudiziaria nel frutto del lavoro, non più di un singolo, ma di una équipe di cui il magistrato è il direttore.[31]
Quanto al terzo punto, va ribadito con la massima energia che l’efficienza della Cassazione è decisiva ai fini del funzionamento di tutti gli uffici giudiziari. Perché, se la nomofilachia funziona bene, cioè se la Cassazione è in grado di offrire interpretazioni delle leggi chiare e stabili e riesce ad intervenire rapidamente nella risoluzione delle questioni nuove che via via si presentano, i giudici di merito possono risolvere i casi al loro esame in maniera sicura ed uniforme. Ciò, per un verso, invera il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto assicura che lo stesso caso sia deciso secondo la stessa regola di diritto davanti a tutti gli uffici giudiziari d’Italia, e, per altro verso, favorisce la graduale riduzione del contenzioso, conseguentemente abbreviando i tempi di definizione dei processi; se la questione di diritto è chiara, infatti, è più facile per le parti misurare la concreta convenienza di una controversia.
Sulla funzione di nomofilachia, tuttavia, è necessaria una puntualizzazione.
Tale funzione è attribuita dalla legge - e, precisamente, dall’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario - alla Corte di cassazione, dinanzi alla quale il Pubblico Ministero conclude nell’interesse della legge. Ma nessuno oggi potrebbe ragionevolmente immaginare la nomofilachia come “ordine” di conformità che discende dal vertice e, certamente, ha ragione Giovanni Canzio, quando scrive che «dobbiamo guardarci da una nomofilachia verticale, riservata alla Corte di cassazione e declinata in senso gerarchico» e sottolinea che «la nomofilachia moderna non può essere che “orizzontale”, “circolare” e “cetuale”»[32]. Proprio l’esperienza, già sopra evocata, degli osservatori sulla giustizia civile, del resto, dimostra che la ricerca di prassi - non solo organizzative, ma anche interpretative - condivise tra giudici e avvocati costituisce una fortissima leva di miglioramento dell’amministrazione della giustizia, con particolare riguardo al profilo della prevedibilità delle decisioni. Anche alla luce di quella esperienza è evidente che oggi la nomofilachia non può essere intesa che come sintesi ed espressione di cultura e valori condivisi, come processo che coinvolge circolarmente la dottrina, l’avvocatura, i giudici di merito, i giudici speciali, le Corti sovranazionali[33]. Le Sezioni Unite – come esse stesse ci hanno spiegato nella sentenza n. 24414/21, «non sono sole» e la loro opera di nomofilachia «è un farsi, un divenire che si avvale dell'apporto dei giudici del merito e delle riflessioni del Collegio della Sezione rimettente, dell'opera di studio e di ricerca del Massimario, degli approfondimenti scientifici e culturali offerti dagli incontri di studio organizzati dalla Formazione decentrata presso la Corte, delle sollecitazioni e degli stimoli, espressione di ius litigatoris, derivanti dalle difese delle parti e del contributo, ispirato alla salvaguardia del pubblico interesse attraverso il prisma dello ius constitutionis, del pubblico ministero. Le Sezioni Unite sono dunque inserite in un contesto di confronto, di dialogo e di contraddittorio tra le parti, che consente alla Corte di legittimità di svolgere il suo ruolo con quella prudenza "mite" che rappresenta un connotato del mestiere del giudice».
Si tratta, all’evidenza, di un’attività che richiede studio, riflessione, dialogo e, quindi, postula condizioni operative difficilmente conciliabili con i numeri dei procedimenti che annualmente vengono iscritti davanti alla Corte di legittimità italiana.
Il tema del sovraccarico della Corte di cassazione è troppo noto per aver bisogno di essere illustrato. Tra le varie ipotesi affacciatesi nel dibattito pubblico per affrontare tale tema (rimodulazione del principio costituzionale della impugnabilità per cassazione di tutte le sentenze, eliminazione o riduzione del controllo della Cassazione sull’accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, contingentamento e specializzazione degli avvocati abilitati al patrocinio in sede di legittimità) il legislatore ha scelto, per quanto concerne il civile, la strada della distinzione tra i procedimenti con valenza nomofilattica e quelli privi di tale valenza, con la cameralizzazione del giudizio relativo a questi ultimi; ciò, evidentemente, sull’implicito presupposto che la cameralizzazione riduca il tempo di lavoro necessario per la trattazione del procedimento e, quindi, consenta di destinare quel tempo all’incremento del numero dei procedimenti trattati.
In questa sede non è evidentemente possibile nemmeno accennare ai termini del problema. Quello che è certo, tuttavia, è che, proprio nel quadro della vasta e complessa azione riformatrice portata avanti dall’attuale Governo in materia di giustizia, appare non più differibile un serio esame della “questione Cassazione”, con un’assunzione di responsabilità collettiva che coinvolga l’intera magistratura – a partire dal suo organo di autogoverno - l’avvocatura, il modo accademico ed il mondo politico.
[1] Tomaso Epidendio, La grande decostruzione del disegno costituzionale della magistratura, in questa Rivista, 24 maggio 2022.
[2] Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Laterza, 2006, si veda cap. V, § 10.
[3] L’immagine che identifica le api con gli antichi e i ragni con i moderni - riferita non specificamente al diritto, bensì alla cultura in generale - risale a Jonathan Swift, che la usa nel suo La battaglia dei libri, ed è stata vigorosamente rilanciata da Marc Fumaroli in Le api e i ragni. La disputa degli Antichi e dei Moderni, Adelphi, 2005.
[4] Sulle implicazioni di sistema dell’esperienza degli osservatori sulla giustizia civile, resta sempre centrale R. Caponi, L’attività degli osservatori sulla giustizia civile nel sistema delle fonti del diritto, in Foro It. 2007, V, col. 7.
[5] In questi termini, R. Rordorf, Editoriale del numero monografico Il giudice e la legge di Questione Giustizia (trimestrale) , 4/2016 , pag. 3.
[6] G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto. Il Mulino, Bologna, 1976.
[7] Così A. Natale, Introduzione al numero monografico Il giudice e la legge di Questione Giustizia (trimestrale) , 4/2016 , pag. 6.
[8] E. de Las Cases, Memoriale di Sant’Elena, Milano, Tipografia Editrice Verri, s.d., vol. II, pag. 217.
[9] Op. cit. pag. 4
[10] P. Grossi, Percorsi nel giuridico pos-moderno, Editoriale Scientifica, 2017.
[11] Così, ancora, R. Rordorf, op. loc. cit.
[12]Il riferimento è, ovviamente, alla Dissertatio de arte combinatoria, 1666. «Secondo ciò, quando sorga una controversia, non ci sarà più necessità di discussione tra due filosofi di quella che c’è tra due calcolatori. Sarà sufficiente prendere una penna, sedersi al tavolo e dirsi l’un l’altro: calcoliamo!» (la citazione è tratta da L. Catalani, “Calculemus!”: il sogno di Leibniz, https://medium.com/@luigicatalani/calculemus-il-sogno-di-leibniz-196b11a55766)
[13] A. Natale, op. cit., pag. 7
[14] Sull’aumento di incertezza indotto dall’operare dei principi al livello dell’interpretazione, sono preziose le brevi ma dense considerazioni di A. Proto Pisani, Brevi note in tema di regole e principi, Foro It., 2015, V, col. 455 e segg.
[15] Cfr. P. Grossi, L’invenzione del diritto, Laterza, 2017
[16] Per Montesquieu «È vero che talvolta occorre cambiare qualche legge. Ma il caso è raro; e quando avviene, bisogna ritoccarle con mano tremante: con tanta solennità e con tante precauzioni che il popolo debba concluderne che le leggi sono veramente sante; e soprattutto con tanta chiarezza che nessuno possa dire di non averle capite» (Lettere Persiane, lettera LXXVI).
[17] Sul tema, M. Donini, Iura et Leges. Perché la legge non esiste senza il diritto, in Sistema Penale, 20.12.2019, http://www.antoniocasella.eu/archica/Donini_iura.et.leges_20dic19.pdf
[18] L. Ferrajoli, Contro la giurisprudenza creativa, nel numero monografico Il giudice e la legge di Questione Giustizia (trimestrale) , 4/2016 , pagg. 13 e segg., da cui traggo le considerazioni svolte nel testo.
[19] P. Calamandrei, Prefazione a C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Le Monnier, 1945; la citazione è tratta da L. Ferrajoli, op. cit. pag. 23
[20] L. Ferrajoli, loc. ult. cit.
[21]In G. De Amicis, Per l’alto mare aperto…: la Magistratura tra sogni spezzati e nuove speranze, in questa Rivista, 25.6.22., si dà conto degli esiti di una indagine dell’Eurispes da cui emerge che solo l’8% dei cittadini ritiene che il settore giustizia funzioni bene, mentre più del 65% non serba fiducia nel sistema giudiziario.
[22] Così C. Mortati, nei lavori dell’Assemblea costituente (seduta pomeridiana del 27 novembre 1947), citato nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, par. 2.2. Quanto al menzionato contesto politico e culturale, mi riferisco ai progetti germogliati negli ultimi anni per modificare la composizione dei collegi e le funzioni delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione; penso al “Memorandum sulle tre giurisdizioni” presentato il 15 maggio 2017 al Presidente della Repubblica, su cui A. Travi, Rapporti fra le giurisdizioni e interpretazione della Costituzione. Osservazioni sul Memorandum dei presidenti delle tre giurisdizioni superiori, in Foro it. 2018, V, 109, nonché, volendo, A. Cosentino, Brevi considerazioni a proposito del Memorandum sulle giurisdizioni, ivi, col. 117; penso al “Tribunale superiore dei conflitti”, oggetto di una proposta di legge presentata alla Camera il 22 maggio 2018, su cui F. De Stefano, I discutibili presupposti del Tribunale dei conflitti, in Questione Giustizia on line, 30.5.2019, nonché, volendo, A. Cosentino, Note critiche sull'ipotizzato tribunale superiore dei conflitti, in questa Rivista 27.2.2019; penso all’”Alta Corte”, oggetto di un disegno di legge costituzionale presentato al Senato il 28 ottobre 2021, su cui l’intervista di P. Filippi e R. Conti a A. Rossomando, in questa Rivista 5.2.2022, nonché, volendo, A. Cosentino, L'Alta Corte. È davvero una buona idea? in Questione Giustizia on line, 25.3.2022.
[23] Così E. Scoditti, L’ora della responsabilità per la magistratura, in Questione Giustizia on line, 17.6.2022.
[24] E. Scoditti, op. cit., dove si legge: «Non c’è indipendenza senza responsabilità, e non c’è responsabilità senza indipendenza: l’una è l’altra faccia dell’altra. La responsabilità non è un principio concorrente con quello di indipendenza, ma ne è il rovescio. Non è un limite dell’indipendenza, ma il suo contenuto. Il giudice per davvero responsabile, che è consapevole del dovere di rendere conto del proprio operato, è quello in grado di assumere il dovere di indipendenza da se stesso»
[25] La formula è di Gramsci: «non si fa politica-storia senza questa passione, cioè senza questa connessione sentimentale tra intellettuali e popolo-nazione. In assenza di tale nesso i rapporti dell’intellettuale col popolo-nazione sono o si riducono a rapporti di ordine puramente burocratico, formale; gli intellettuali diventano una casta o un sacerdozio». A. Gramsci, Quaderni del carcere, Einaudi, Tomo II (Q. XVIII), p. 1505.
[26] Introdotto dall’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013).
[27] Paradigmatico è l’art. 13 ter del codice del processo amministrativo, alla cui stregua «le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato» e, conseguentemente, «L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.»
[28] Quanto all’enfasi posta dal legislatore sui meccanismi di definizione conciliativa della lite, una valutazione molto critica si legge in G. Scarselli, Osservazioni sul disegno di legge delega di riforma del processo civile, in questa Rivista 27.10.2021
[29] Nel recente convegno “Giurisdizione e motivazione. Dialoghi a più voci tra linguaggio e organizzazione del lavoro” organizzato da Area DG presso la Corte di cassazione lo scorso 8 giugno 2022, il Primo Presidente della Corte di cassazione, Piero Curzio, discorrendo delle sentenze, specialmente di legittimità, inutilmente prolisse, ha icasticamente indicato i tre vizi capitali da cui deve rifuggire l’estensore di una sentenza in quelli della incompetenza, del narcisismo e del carrierismo.
[30] In Francia, all'esito del tirocinio presso l’École Nationale de la Magistrature, è prevista una valutazione finale che «può avere quattro decisioni: 1) attitudine a tutte le funzioni giudiziarie; 2) Non idoneità; 3) Previsione di un ulteriore anno di stage in uffici giudiziari;4) raccomandazioni in ordine a specifiche funzioni. Rarissima la dichiarazione di inidoneità (negli ultimi corsi l’1%), più frequente il rinnovo dello stage in giurisdizione» (così M.G. Civinini ed E. Bruti Liberati, La formazione iniziale dei magistrati. Analisi di una esperienza e una proposta, in
in Questione Giustizia on line, 28.4.2021.
[31] in M.G. Civinini, Il "nuovo ufficio per il processo" tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!, in Questione Giustizia on line, 28.4.2021, si legge la seguente, persuasiva, considerazione: «Si passa da una modalità fieramente individuale e artigianale a una modalità organizzata e collettiva che esalta la funzione del giudicare mentre rende più efficiente il sistema».
[32] G. Canzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Diritto Pubblico, 2017, 25.
[33] Sul tema, si veda l’ampia analisi di R.Conti, Nomofilachia integrata e diritto sovranazionale. I "volti" delle Corte di Cassazione a confronto, in questa Rivista 4.3.2021. Si veda anche F. De Stefano, Giudice e precedente: per una nomofilachia sostenibile, in questa Rivista 3.3.2021, nonché A. Scarpa, Nomofilachia codificata e supremazia dei precedenti, in questa Rivista 23.2.2021.