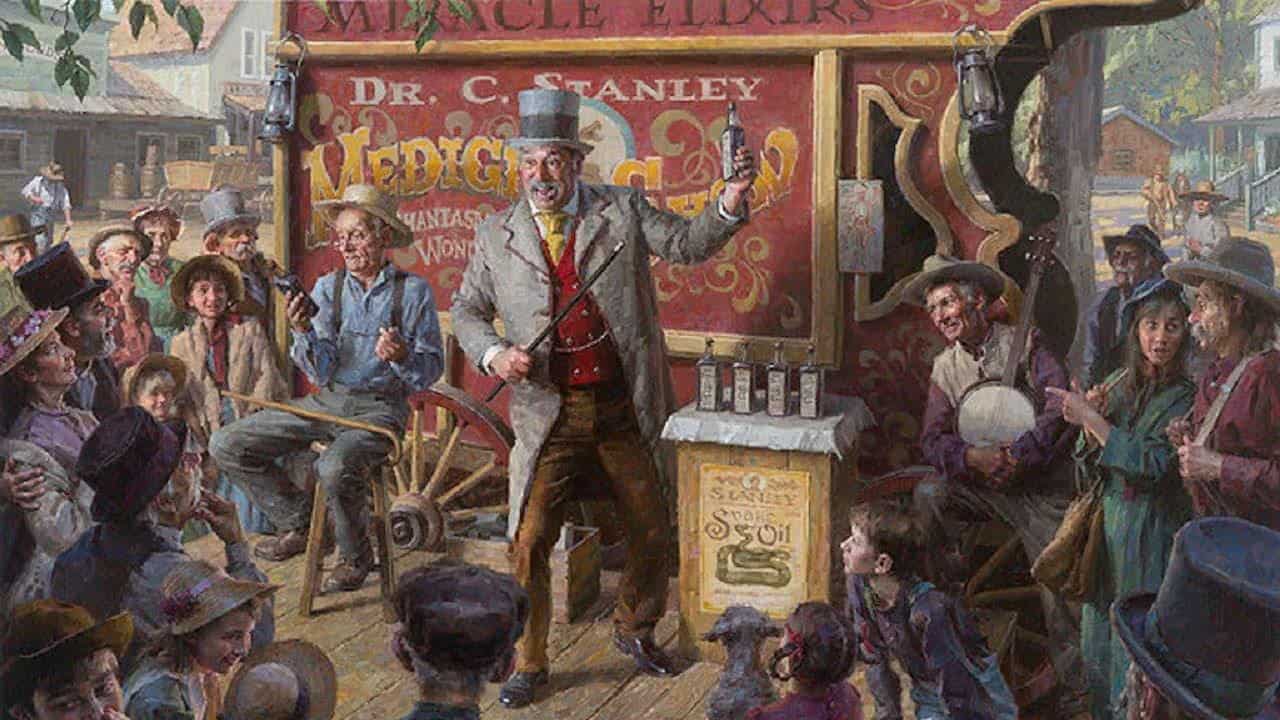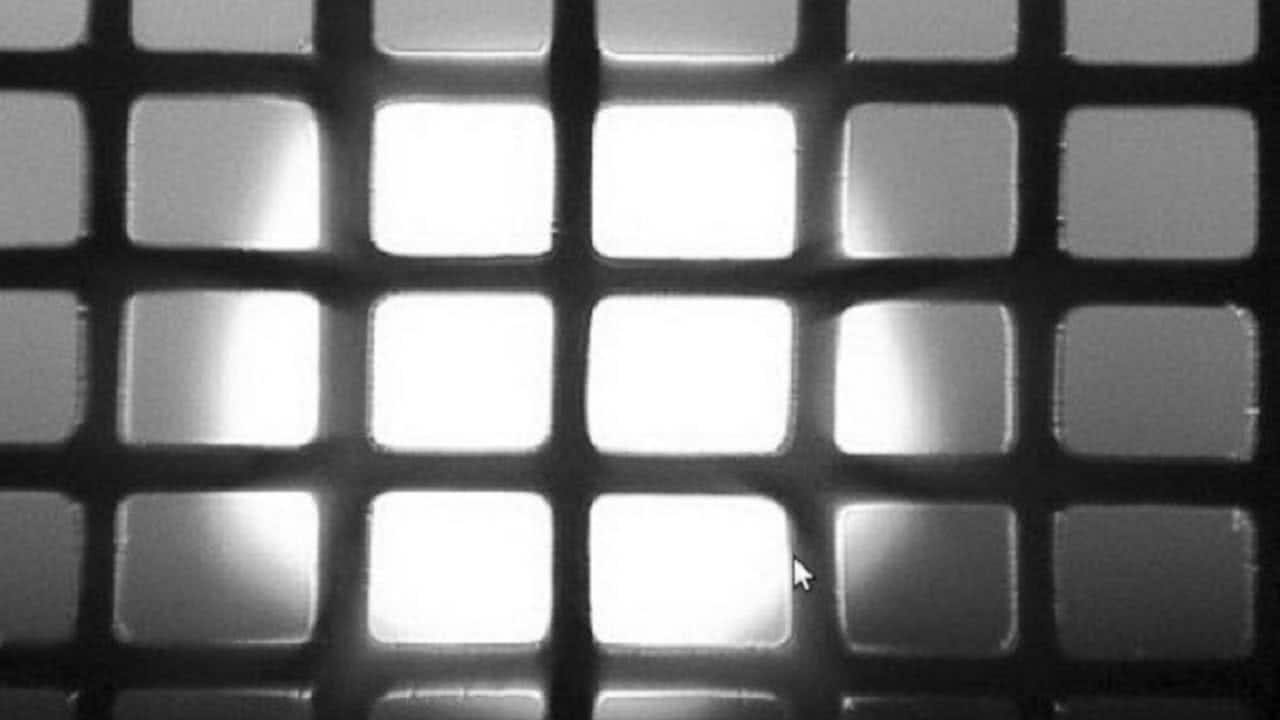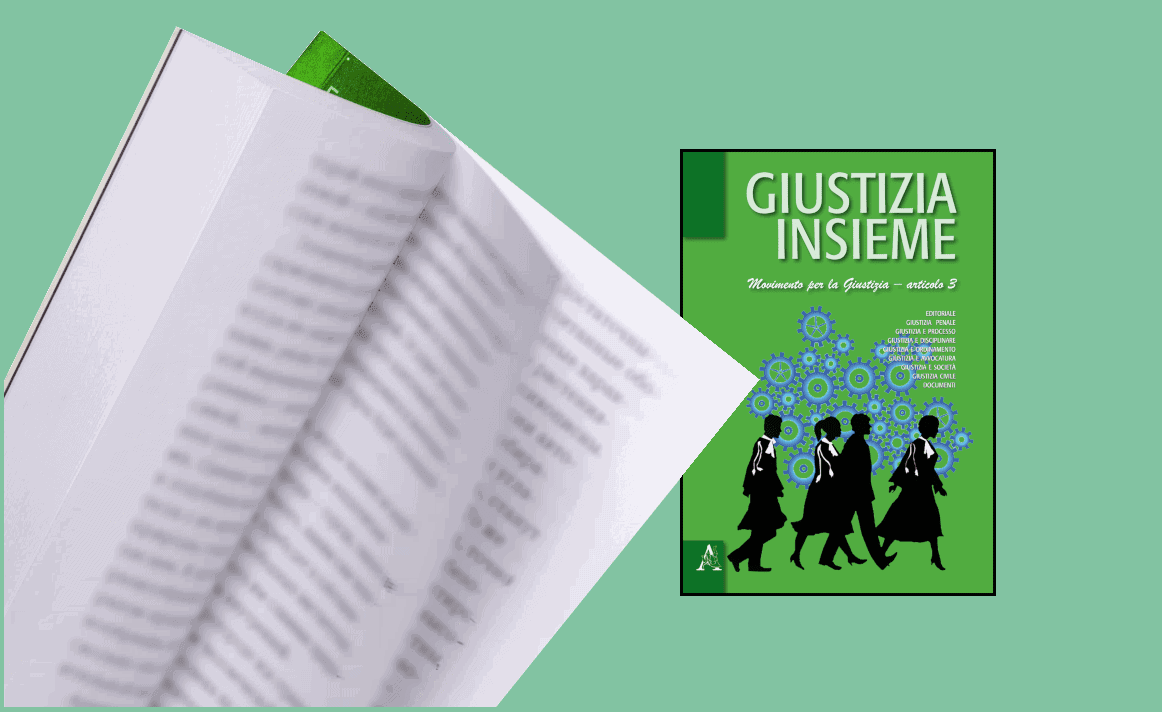POLITICA E MAGISTRATURA: FERMATE L’ANDIRIVIENI
(Criticità di una contaminazione da superare)
Se il rispetto della politica per la magistratura può considerarsi un affidabile termometro della salute democratica di un Paese, il nostro non se la passa molto bene. Non si tratta soltanto della tendenza a considerare le inchieste giudiziarie “sacrosante” o “persecutorie” a seconda che riguardino, rispettivamente, gli avversari o i militanti del proprio schieramento. È una tentazione questa, cui pochi nostri rappresentanti hanno saputo resistere. Preoccupante è il manifesto proposito di delegittimare la magistratura: irridendone l’azione, disconoscendole l’autorità di pronunciarsi in nome di un popolo da cui non è stata eletta, dubitando della sua imparzialità per i trascorsi politici di alcuni suoi esponenti, concionando sul fatto che la realtà non può attendere i tempi della giustizia e che quindi è necessario prescinderne.
Andrei ultra crepidam se cercassi di inquadrare il fenomeno nelle sue coordinate storico-culturali, per stabilire in che misura ciò possa dipendere dal vento di un arrogante autoritarismo che sta soffiando gelido a diverse latitudini e longitudini del Pianeta. Posso al più tentare di analizzare se nel nostro Paese ci siano peculiari fattori ordinamentali predisponenti. Risulta assai difficile non rispondere affermativamente. Da un lato, la tutela della funzione politica è da noi degenerata al punto, nelle norme e nella prassi, da assicurare aree di sostanziale impunità o, almeno, di pretesa di impunità; dall’altro, ai magistrati è consentito un inaccettabile pendolarismo dall’ufficio giudiziario ad attività di natura politico-amministrativa, che non può non ripercuotersi sulla credibilità della funzione giurisdizionale svolta.
Sul primo versante. La nostra Costituzione prevedeva originariamente l’istituto dell’autorizzazione a procedere, che doveva servire al Parlamento per preservare la funzione della rappresentanza politica da indebite iniziative giudiziarie volte ad alterarne il fisiologico esercizio. L’indecoroso utilizzo di tale garanzia da parte del Parlamento, che ne ha fatto uno scudo per mettere i suoi componenti al riparo di ogni azione giudiziaria, ha poi indotto alla sua soppressione. Si è pensato di sostituirla con un sindacato della Camera di appartenenza dell’indagato sulla esperibilità di determinati atti investigativi: «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene nessun membro del Parlamento può essere sottoposto» a perquisizione personale o domiciliare, ad intercettazione di conversazioni o comunicazioni, a sequestro di corrispondenza (art. 68 Cost.). Si tratta all’evidenza di una facezia normativa, che sfregia la credibilità di una fonte così autorevole come la Costituzione. L’autorità giudiziaria, prima di procedere al compimento di atti investigativi che ripongono tutta la loro efficacia nel fattore sorpresa, dovrebbe avvertire –oltre all’indagato- più di trecento e talvolta più di seicento suoi colleghi affinché valutino se la richiesta obbedisca effettivamente a fini investigativi. Ad esempio, il pubblico ministero per intercettare le conversazioni di un parlamentare dovrebbe ottenere prima il disco verde alla Camera di appartenenza; dopodiché, verosimilmente, dovrebbe sperare che non gli venga concesso, ben sapendo quali risultati controproducenti potrebbe sortire una intercettazione con preavviso.
Ma anche là dove la guarentigia costituzionale è in sé ineccepibile, la prassi si è incaricata di trasfigurarla in insopportabile privilegio. La Costituzione giustamente pretende che l’autorità giudiziaria, per poter privare della libertà personale un parlamentare, debba ottenere il nulla osta con cui la Camera di appartenenza esclude l’esistenza di un intento persecutorio vòlto ad alterare il fisiologico atteggiarsi degli equilibri politici. Il Parlamento, invece di avvalersi di questa prerogativa negli eccezionalissimi casi in cui l’iniziativa giudiziaria avesse esondato dall’alveo legale, ha usato il potere di non autorizzare l’arresto come insuperabile riparo ordinario del parlamentare contro l’azione giudiziaria, strumentalmente adducendo – tranne rarissimi casi che si contano sulle dita di una mano rispetto a decine e decine di richieste – l’asserita presenza del fumus persecutionis. Insomma: tanto fumus, poco arresto.
Sul secondo versante. L’attuale sistema consente al magistrato, assolte le sue funzioni, di togliersi la toga e di andare ad indossare i panni di sindaco o di assessore in un comune viciniore rispetto alla circoscrizione nella quale amministra giustizia (o anche ad assumere cariche elettive in una regione diversa). È difficile accettare l’idea che la mera distanza chilometrica consenta al magistrato-sindaco di liberarsi sulla strada di ritorno delle convinzioni politiche che lo hanno indotto ad assumere determinate decisioni amministrative e, indossata nuovamente la toga, di esercitare imparzialmente le funzioni di magistrato. E’ ancor più improbabile che i soggetti da lui giudicati non dubitino della sua serenità di valutazione, specie se la loro attività o la res iudicanda abbia collegamenti più o meno diretti con la politica.
Tuttavia, non vi è soltanto un problema di sostanziale o anche soltanto di apparente perdita di imparzialità, come di solito si sottolinea. Politica e giurisdizione hanno statuti metodologici opposti. Secondo la nota distinzione luhmanniana, infatti, l’agire politico segue un programma di scopo, che si orienta a certi effetti desiderati e cerca i mezzi più idonei per conseguirli; mentre l’attività giurisdizionale deve obbedire ad un programma condizionale, che ha a che fare con dati legati al passato ed opera secondo lo schema «se è accaduto questo… allora…». Il giudice, proprio affinché la sua attività sia sottratta alla critica politica, deve rispondere esclusivamente della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale al caso di specie, non essendogli non solo richiesto, ma neppure consentito di farsi carico delle conseguenze della propria decisione. Ebbene. il magistrato che “torna” ad esercitare la giurisdizione dopo essersi impegnato in un’attività politico-amministrativa non può non averne assorbito metodi e finalità: fatalmente avrà un approccio più attento al risultato che alla legalità del procedere e del decidere. Sarebbe quindi estremamente opportuno pretendere che per svolgere tali attività il magistrato debba essere posto fuori ruolo e che, terminato l’impegno politico, non possa tornare a svolgere funzioni giurisdizionali in senso stretto. E un tale divieto dovrebbe riguardare, a più forte ragione, anche il magistrato che abbia svolto un mandato parlamentare o assunto incarichi di natura politica (si pensi ai ruoli apicali nei ministeri).
In sintesi: la promiscuità di funzioni e di abiti mentali talvolta pregiudica metodo e imparzialità dell’azione giudiziaria; più spesso incrina la fiducia della collettività nella giustizia; sempre espone la funzione giudiziaria ad attacchi ed insinuazioni strumentali. Impedire tali contaminazioni tra magistratura e politica forse può frustrare qualche comprensibile aspirazione dei magistrati, ma fa bene all’autorevolezza della funzione svolta e questa, oggi più che mai, fa bene alla democrazia. Nel contesto attuale, infatti, in cui le ragioni si pesano in base ai voti, in cui siamo arrivati ad un tal punto di analfabetismo democratico che un ministro ritiene di poter contestare ad un magistrato l’autorità di giudicarlo perché non eletto, avere una giustizia autorevole e inattaccabile significa offrire alla società forse l’ultimo punto di riferimento condiviso, senza il quale si schiuderebbero orizzonti poco rassicuranti. Screditata ed esautorata la giurisdizione, i cittadini cercherebbero altrove un’autorità che sappia imporre il rispetto delle regole; si rivolgerebbero ad altri poteri (politici, economici, corporativi, se non, talvolta, criminali), ritenuti più forti e affidabili per la soddisfazione delle loro rivendicazioni e per la tutela dei loro interessi. Una china quanto mai democraticamente scivolosa per uno Stivale come il nostro, sempre pronto a calzare il piede dell’uomo della provvidenza.
(da “La lettura”, supplemento del “Corriere della Sera” del 16.12.2018)