
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Ripensando allo Statuto, come modello di una Carta dei diritti che tuteli i nuovi lavori
intervista di Marcello Basilico a Vincenzo Di Cerbo
Il cinquantenario dello Statuto dei lavoratori è l’occasione per un bilancio non solo d’una stagione ormai superata, ma anche d’un modo di legiferare che oggi viene facile rimpiangere. In realtà nelle scelte di allora si annidano non solo luci, ma anche alcune ombre, che hanno inciso sul mondo del lavoro e delle relazioni industriali. D’altra parte del superamento di alcuni capisaldi dello Statuto, come quello dell’art. 18, non può darsi una lettura solo negativa, soprattutto se le nuove norme vengano calate opportunamente nel quadro costituzionale. Rimane un modello, quello d’una Carta dei diritti, di cui oggi si avverte una esigenza rinnovata, per assicurare le stesse garanzie di sicurezza e dignità ai lavoro svolti nel contesto tecnologico moderno.
Lo Statuto compie 50 anni. La prima domanda è scontata, ma inevitabile: ha ancora una sua attualità?
Si dice abitualmente che lo Statuto fu modellato a immagine del lavoratore della grande impresa. Non è un giudizio un po’ sbilanciato in un’ottica di centralità dell’art. 18, norma fondamentale, ma certamente inserita in un contesto assai più ampio?
La rigidità imputata allo Statuto è figlia anche del ricorso a norme imperative, vincolanti per la contrattazione individuale e collettiva. È tramontata l’epoca della norma imperativa a protezione della parte debole nel contratto di lavoro?
E. Di Cerbo: Preferisco rispondere unitariamente alle prime tre domande, in quanto presuppongono un ragionamento unitario.
Si tratta di domande sicuramente attualissime e la risposta ad esse impone al giurista del lavoro, oggi più che mai, a 50 anni dall’entrata in vigore dello Statuto, una riflessione ad ampio raggio che tenga conto, in particolare, della complessità e varietà dei principi affermati dallo Statuto e delle disposizioni normative dallo stesso previste. Se è vero, infatti, che i suddetti principi costituiscono generalmente irrinunciabili momenti di progresso nella civiltà giuridica del rapporto di lavoro, è anche vero che alcune disposizioni dello Statuto appaiono fortemente datate, e quindi oggi del tutto inadeguate, in quanto concepite in un particolare momento storico, caratterizzato da un assetto dell’apparato industriale, da modelli di organizzazione aziendale e da livelli tecnologici non più attuali.
È opinione comune, da me profondamente condivisa, che lo Statuto dei lavoratori abbia segnato una tappa fondamentale nella storia del diritto del lavoro italiano che, grazie ad esso, si è rinnovato profondamente ed è diventato più moderno e vicino ai modelli europei.
Tale importante risultato è stato raggiunto dal legislatore dello Statuto attraverso la promozione di un nuovo equilibrio tra le contrapposte posizioni delle parti del rapporto di lavoro, equilibrio, da un lato, basato sulla previsione di un articolato apparato normativo a tutela della “persona” del lavoratore, il che ha determinato, come conseguenza immediata, una apprezzabile limitazione dei tradizionali poteri autoritativi dell’imprenditore; dall’altro fondato sull’introduzione di norme finalizzate alla tutela e alla promozione dell’attività sindacale.
Mi pare utile sottolineare che l’evoluzione complessiva dell’equilibrio nel rapporto di lavoro introdotta dallo Statuto e la conseguente maggiore consapevolezza, da parte del prestatore di lavoro, dei suoi diritti e della sua dignità, ha riguardato tutto il mondo del lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia e dalle dimensioni del datore di lavoro; e ciò a dispetto del fatto che la finalità originaria del legislatore dello Statuto è stata dichiaratamente quella di riformare i rapporti di lavoro nella grande fabbrica. Finalità che si evince chiaramente dalla previsione di requisiti dimensionali (sussistenza di un numero minimo di dipendenti nell’ambito della stessa unità produttiva) quale presupposto per determinare l’ambito di applicazione della disciplina vincolistica in tema di licenziamento, come pure dell’azione sindacale organizzata all’interno dell’azienda.
All’interno dello Statuto coesistono due distinti plessi normativi: il primo è costituito da norme con finalità garantistica, destinate ad incidere sul rapporto individuale di lavoro; il secondo comprende norme di sostegno all’attività sindacale; plessi normativi che si pongono in funzione complementare l’uno con l’altro, essendo evidente che il rafforzamento del ruolo del sindacato all’interno dell'impresa contribuisce all’effettività dell’esercizio dei diritti individuali del prestatore di lavoro.
Ciò premesso, è possibile iniziare ad articolare una risposta alla domanda sulla attualità dello Statuto.
Con riferimento al rapporto individuale di lavoro, nell’ambito del quale la realizzazione del nuovo equilibrio fra i contrapposti interessi delle parti del rapporto, al quale ho in precedenza accennato, è stata ottenuta attraverso la previsione di norme vincolistiche ed inderogabili a favore del lavoratore subordinato, la mia risposta è sicuramente affermativa.
Considero cioè pienamente attuali quelle norme dello Statuto che assoggettano la libertà dell'iniziativa economica e le sue forme di esercizio al vincolo della compatibilità con i valori costituzionali della sicurezza, libertà e dignità umana.
Mi limiterò a citare le norme che mi sembrano più significative.
Penso in primo luogo all’art.1 che riconosce in favore dei lavoratori il diritto di manifestare liberamente, nei luoghi di lavoro, il proprio pensiero senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali o di fede religiosa. Penso all’art. 8, logicamente connesso all’art. 1, che prevede il divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore, divieto che riguarda non solo le indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali, ma anche quelle su fatti non rilevanti al fine della valutazione della sua attitudine professionale. In sostanza con tale norma viene esplicitamente attribuito al prestatore di lavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il diritto alla riservatezza, qualificato come diritto fondamentale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 38 dell’aprile 1973 e quindi pochissimi anni dopo l’entrata in vigore dello Statuto.
Altra materia che è stata regolata in maniera fortemente innovativa dallo Statuto dei lavoratori e che mantiene intatta, a mio avviso, la sua attualità è quella dei controlli concernenti malattie e infortuni del prestatore di lavoro (art. 5). La norma infatti limita il potere di controllo del datore di lavoro nei confronti del lavoratore assente per infermità o infortunio, controllo che in precedenza veniva effettuato dai medici di fabbrica, ed affida il relativo accertamento esclusivamente a soggetti pubblici a ciò specificamente deputati. Rimane infatti assolutamente valida ed attuale la ratio della norma, finalizzata a garantire l'imparzialità del controllo sullo stato di salute del prestatore di lavoro, attraverso l’affidamento dell’esclusiva di tale controllo a strutture del tutto autonome dal datore di lavoro, in posizione di terzietà rispetto ai contrapposti interessi delle parti del rapporto di lavoro e pertanto idonee a garantire correttezza ed imparzialità del loro operato. Soluzione questa che è stata oggetto di specifiche prescrizioni da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e che è stata pienamente acquisita alla moderna cultura giuslavoristica.
Su un piano nettamente distinto ma parallelo va posto l’art. 9 che, per la finalità perseguita (tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore in azienda), conserva in pieno la sua attualità. La norma, che affida al potere contrattuale delle parti collettive il grado di effettività della tutela, richiederebbe tuttavia di essere ulteriormente perfezionata e integrata, atteso che i risultati fin qui ottenuti in tema di sicurezza sul posto di lavoro non possono considerarsi soddisfacenti. Basta verificare in proposito i dati, del tutto insoddisfacenti e sicuramente molto preoccupanti, relativi all’evoluzione statistica degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
L’art. 4 dello Statuto, in tema di controlli audiovisivi, costituisce un tipico esempio di norma sicuramente attuale, quanto alle finalità perseguite, ma altrettanto sicuramente obsoleta ed inadeguata rispetto allo sviluppo tecnologico e all’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali. Come è noto la norma è finalizzata a proteggere il lavoratore da controlli invasivi da parte del datore di lavoro senza essere tuttavia di ostacolo allo svolgimento dell'attività aziendale; è peraltro del tutto evidente la necessità di adattare la disciplina ivi prevista, concepita in un’epoca nella quale perfino le fotocopiatrici avevano scarsa diffusione, ad una organizzazione aziendale ormai governata prevalentemente da tecnologie informatiche che implicano la immediata disponibilità dei dati concernenti la quantità e spesso la qualità del lavoro svolto dal singolo prestatore. Dati che potrebbero essere utilizzati in modo invasivo nei confronti del singolo lavoratore. La norma è stata già sostanzialmente riformulata dall’art. 23, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151, emesso sulla base della legge delega 10 dicembre 2014 n. 183 (sul c.d. jobs act) ma, a mio avviso, nonostante la nuova formulazione, rimane ancora sostanzialmente irrisolto il problema di coniugare, nell’attuale contesto dell’evoluzione tecnologica, le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Il tema dei controlli del lavoratore in azienda si pone, del resto, in termini analoghi a quello della tutela della privacy del singolo nella società informatizzata, che costituisce sicuramente uno dei più delicati problemi giuridici della nostra epoca.
Una norma dello Statuto fortemente innovativa e che, quanto meno nelle sue regole fondamentali, deve considerarsi pienamente attuale è quella dell’art. 7 che disciplina l’esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare sottoponendolo al rispetto di passaggi procedurali finalizzati a garantire la posizione contrattuale del lavoratore.
A conclusioni diverse quanto all’attualità deve pervenirsi con riferimento alla disciplina delle mansioni (art. 13 che aveva introdotto una nuova formulazione dell’art. 2103 cod. civ.). Con tale norma il legislatore aveva posto limiti precisi all’esercizio dello ius variandi che, come è noto, costituisce uno dei poteri tipici del datore di lavoro. Lo ius variandi poteva essere esercitato solo nell’ambito delle mansioni professionalmente equivalenti, con diritto alla promozione definitiva in caso di assegnazione a mansioni superiori protrattasi oltre un determinato periodo e con previsione della nullità dei patti modificativi in peius delle mansioni. Si trattava di norma caratterizzata da un notevole grado di rigidità, e che ha costretto la giurisprudenza a sforzi interpretativi certamente non facili per mitigare almeno in parte gli effetti di tale rigidità. Basti pensare a quella giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla disposizione che sancisce la nullità dei patti modificativi in peius delle mansioni, ha stabilito che tale nullità non opera nelle ipotesi in cui il patto di demansionamento sia finalizzato a scongiurare un licenziamento, nel caso in cui il lavoratore, a causa di una sopravvenuta inabilità, non sia più abile a svolgere le mansioni in precedenza svolte. Nel corso degli anni sono progressivamente aumentate le difficoltà applicative della norma in relazione all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in azienda, difficoltà determinate, da un lato, dall’evoluzione tecnologica e, dall’altro, dall’esigenza di far fronte alle sempre più impegnative sfide della concorrenza imposte dalla globalizzazione. Nel 2015 la norma suddetta è stata (opportunamente) modificata in modo significativo (d.lgs. n. 81 del 2015) e resa così più coerente con i nuovi assetti organizzativi aziendali. In particolare, è stata resa più elastica la disciplina dello ius variandi consentendone l’esercizio non già nei ristretti limiti delle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, bensì nell’ambito delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Sono state inoltre previste ipotesi di legittima assegnazione del lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.
Anche le disposizioni poste a tutela della libertà sindacale mantengono la loro piena attualità atteso che il diritto di associazione e di attività sindacale e il divieto di atti discriminatori, appartengono alla tradizione consolidata del diritto del lavoro italiano ed europeo.
In particolare, l’art. 14, nel riconoscere, da un lato, il diritto dei lavoratori di costituire associazioni sindacali e di aderirvi e, dall’altro, quello di svolgere attività sindacale, ribadisce una garanzia di rango costituzionale (art. 39, primo comma, Cost.) fatta propria anche dall’art. 12 della Carta europea dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. Costituiscono irrinunciabili applicazioni della norma suddetta gli artt. 15 e 16 che pongono il divieto di atti e trattamenti discriminatori. In particolare, l’art. 15, che costituisce la prima e più ampia affermazione del principio di non discriminazione nel rapporto di lavoro, ha mostrato nel corso degli anni una forte capacità espansiva. Ed infatti nella sua originaria formulazione della norma il divieto di discriminazione era riferito ai motivi sindacali, ai quali erano assimilati i motivi religiosi e politici. Successivamente la norma si arricchita con l’aggiunta dei divieti di discriminazione per ragioni di sesso, razza e lingua (art. 13 legge n. 903 del 1977). Da ultimo l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE, ha ulteriormente aggiunto, sempre nel secondo comma della disposizione, le ipotesi di discriminazione per handicap, età, orientamento sessuale e convinzioni personali.
Per quanto riguarda le altre disposizioni in materia sindacale e cioè quelle di cui al titolo III dello Statuto, finalizzate alla promozione dell'attività sindacale nell'impresa in modo da consentire una maggiore effettività dell’azione sindacale all’interno dell’organizzazione produttiva, vorrei focalizzare l’attenzione sull’evoluzione dell’art. 19 che prevede la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, individuate come i soggetti destinatari della disciplina incentivante. L’evoluzione della norma, con riferimento ai criteri di individuazione dei soggetti sindacali abilitati a fruire del trattamento privilegiato appare significativa di una sostanziale sopravvenuta inadeguatezza di tali criteri rispetto all’evolversi dei rapporti sindacali e della necessità dell’intervento del legislatore in questa delicatissima matetria.
Nella sua formulazione originaria la norma faceva riferimento alle associazioni sindacali dotate di un collegamento con sindacati esterni e, in particolare, con le “confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. In esito a referendum in data del 13 giugno 1995, scompare il sindacato maggiormente rappresentativo e la nuova formulazione dell’art. 19 attribuisce il potere di costituire rappresentanze aziendali alle sole associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva di qualunque livello essi siano, dunque anche di livello aziendale. La Corte costituzionale con sentenza n. 231 del 2013, modificando il proprio precedente orientamento, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. In sostanza, sul presupposto che il criterio della sottoscrizione del contratto collettivo, risultante dall’esito della consultazione referendaria, sia inidoneo rispetto alla sua primigenia funzione di selezionare i soggetti sindacali in ragione della loro rappresentatività, la pronuncia (additiva) della Corte ha introdotto il criterio della verifica della partecipazione del sindacato alle trattative.
Più in generale, per rispondere alla domanda sull’attualità dello Statuto con riferimento alle norme in tema di garanzia e sostegno dell’attività sindacale, osservo che, sotto un primo profilo, il principale merito di tali norme è stato quello di aver favorito in modo significativo la crescita della sindacalizzazione e delle rappresentanze sindacali specie nelle aziende medio-grandi, il riconoscimento del sindacato quale attore delle relazioni industriali, nonché lo sviluppo della contrattazione collettiva come strumento principale di governo di rapporti collettivi, tutti elementi appunto caratteristici degli ordinamenti sindacali dei paesi occidentali. In tale ottica ritengo che lo Statuto conservi intera la sua attualità a condizione che il sindacato sappia utilizzare al meglio, come ha fatto talvolta in passato, degli spazi di libertà e dei diritti riconosciuti all’attività sindacale.
Ritengo tuttavia doveroso rilevare che il legislatore dello Statuto ha evitato di prevedere ogni possibile forma di partecipazione del sindacato nell’impresa e questo ha condizionato e condiziona (negativamente, a mio avviso) l’assetto delle relazioni industriali nel nostro Paese, esasperandone, particolarmente in alcuni passaggi, la conflittualità. La mancata promozione della partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori alla gestione dell'impresa costituisce, a mio avviso un difetto di fondo nell’impostazione complessiva dello Statuto. Ciò ha determinato che la contrattazione collettiva ha avuto carattere essenzialmente rivendicativo e non si è interessata, almeno tendenzialmente, a verificare le compatibilità aziendali ovvero l’esistenza di eventuali obiettivi comuni fra le parti, quali ad esempio il miglioramento delle performance qualitativo/quantitative della produzione. Un modello di rapporti, quello promosso dallo Statuto, che si rivela sempre più inadeguato rispetto alle trasformazioni in atto nel tessuto economico sociale e nella composizione socioculturale del lavoro dipendente come del resto emerge chiaramente dal confronto con i risultati ottenuti attraverso formule partecipative sperimentate con successo in alcuni Paesi europei (mi riferisco, in particolare all’esperienza della Mitbestimmung in Germania).
L’art. 18 dello Statuto è stato sostituito adeguatamente? In un quadro di politiche attive obiettivamente inadeguate è mancato forse il compimento d’un disegno legislativo coerente.
Di Cerbo: Storicamente la disciplina delle conseguenze del licenziamento illegittimo prevista dall’art. 18 nella sua originaria formulazione è stata considerata la novità più rilevante e politicamente significativa dello Statuto dei lavoratori. Come è noto la norma ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la stabilità reale del rapporto stesso in luogo della stabilità c.d. obbligatoria prevista dalla l. n. 604 del 1966; e quindi una stabilità effettiva che sostituisce il precedente regime risarcitorio. Stabilità reale che di fatto risulta peraltro limitata dalla pacifica (secondo consolidata giurisprudenza) incoercibilità dell’obbligo di reintegrazione.
La disciplina dell’art. 18 è stata completamente riformulata con la legge n. 92 del 2012 (c.d. legge Fornero) che ha fortemente limitato l’ambito di applicazione della tutela reintegratoria. In sostanza con la nuova disciplina si è passati da un unico regime di tutela reintegratoria a quattro regimi di tutela differenziata, dei quali due prevedono la tutela reale e due la tutela indennitaria con la predeterminazione di limiti minimi e massimi per la determinazione dell’indennità.
Successivamente il quadro normativo è mutato ulteriormente ad opera del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23 recante disposizioni in attuazione della legge di delega 10 dicembre 2014 n. 183 (c.d. Jobs Act), che ha modificato il regime di tutela dell’art. 18 pur senza intervenire direttamente e testualmente su tale disposizione. L’art. 1 d.lgs. n. 23 del 2015 riferisce la nuova disciplina del licenziamento illegittimo ai «lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» (quindi si applica esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati dopo il 6 marzo 2015). In sostanza il d.lgs. n. 23 del 2015 conferma anche per i “nuovi” contratti (quelli a tutele crescenti), il reticolo delle tutele differenziate della l. n. 92 del 2012, ridisegnando i confini di applicazione delle tutele ivi previste in termini di maggiore flessibilità in uscita (e quindi di minor favore) per il lavoratore licenziato.
Deve sottolinearsi che, anche dopo le suddette riforme, è rimasto immutato il principio cardine della giustiziabilità delle ragioni del licenziamento essendo rimasta ferma la prescrizione secondo cui il licenziamento è possibile solo per giusta causa o per giustificato motivo; canone generalissimo che marginalizza la libera recedibilità a limitate ipotesi di natura eccezionale. Tale garanzia di carattere generale, che risale alla legge n. 604 del 1966 prima citata, è del resto coerente con l’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008 n. 130 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
Recentemente la Corte costituzionale (C. cost. n. 194 del 2018), con una decisione di notevole rilievo sistematico, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 prima citato, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018 (c.d. decreto dignità, medio tempore intervenuto), convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 del 2018, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, con ciò eliminando il meccanismo (previsto dalle due norme suddette) di determinazione automatica dell’indennità da licenziamento illegittimo sulla base di un unico criterio (quello dell’anzianità di servizio) e valorizzando uno spazio rilevante per il giudice nella determinazione dell’indennità sulla base di una gamma più articolata di elementi di valutazione. Inoltre con un comunicato stampa del 25 giugno 2020, la Corte Costituzionale ha preannunciato la pubblicazione di una sentenza con la quale dichiara incostituzionale l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015 sulla indennità risarcitoria legata ai vizi di motivazione del licenziamento, ex art. 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966, o ai vizi della procedura ex art. 7 della legge n. 300 del 1970, con riferimento all’inciso “di importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio“.
Tutto ciò premesso, la mia valutazione sulla riforma dell’art. 18 nel senso di ridurre l’ambito di applicazione della tutela reintegratoria è sostanzialmente positiva, fermo restando che occorre migliorare in modo sostanziale i meccanismi di tutela del lavoratore licenziato attraverso una più efficace politica di riqualificazione e di supporto al reperimento di un nuovo posto di lavoro. Ciò alla stregua di quanto avviene in altri Paesi europei dove la tutela del lavoratore più che essere affidata a meccanismi reintegratori, è garantita da un forte apparato pubblico di sostegno al lavoratore licenziato.
In particolare, a prescindere da ogni valutazione sulle ragioni di politica industriale e del lavoro poste alla base delle nuove discipline introdotte con le norme sopra citate, mi pare condivisibile l’esclusione, in esse prevista, della tutela reintegratoria nei casi di licenziamento viziato da violazioni procedurali. In tali casi infatti accadeva, sotto il vigore della disciplina precedente, che il lavoratore dovesse essere reintegrato nello stesso posto di lavoro precedentemente occupato a prescindere dalla fondatezza o meno dell’addebito disciplinare che gli veniva contestato.
Quanto all’efficacia disincentivante dei meccanismi sanzionatori di tipo indennitario, mi pare che la sentenza della Corte costituzionale da ultimo citata consenta al giudice di calibrare in modo adeguato l’indennità.
Resta peraltro ferma la necessità di razionalizzare i diversi regimi sanzionatori di tipo indennitario; basti rilevare, ad esempio, che in determinate ipotesi l’indennità spettante ai sensi dell’art. 18 Stat. lav. come modificato dalla legge Fornero è inferiore a quella liquidabile, in ipotesi analoghe, al lavoratore licenziato al quale si applichi la disciplina di cui al d.lgs. n. 23 del 2015.
Dell’art. 28 dello Statuto si valorizzano soprattutto destrutturazione e celerità del procedimento. Non crede che la sua attualità stia soprattutto nella ricerca dell’effettività della tutela e della decisione, oggi connotato ancora fondamentale anche grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea?
E. Di Cerbo: La mia risposta è assolutamente positiva.
Con l’art. 28 dello Statuto il legislatore ha introdotto nel sistema delle relazioni industriali a livello di azienda uno strumento, dalle caratteristiche fortemente innovative, destinato a garantire l’effettività del principio della libertà sindacale e dei diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori. La norma, che ha mantenuto sostanzialmente invariata nel corso del tempo la sua originaria formulazione, ha svolto un ruolo fondamentale nella tutela dell’azione sindacale a garanzia, ad esempio, della salute e della sicurezza in fabbrica, attraverso la rimozione di eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro ai controlli esercitati dai lavoratori sull’ambiente di lavoro, come pure a tutela del principio di non discriminazione.
L’esperienza applicativa ha dimostrato che la tecnica di individuazione della fattispecie protetta, tipizzata solo dal punto di vista dei beni da tutelare (libertà, attività antisindacale e sciopero) e non dei comportamenti ha consentito alla giurisprudenza di reprimere non solo comportamenti contrari agli interessi del sindacato, ma anche atti lesivi dei diritti di singoli individui connessi all'esercizio delle libertà sindacali (cosiddetta plurioffensività della condotta). Ciò grazie anche alle peculiarità del procedimento che si caratterizza non solo per la legittimazione ad agire, attribuita ad un soggetto collettivo portatore dell’interesse sovraindividuale protetto, ma anche per la natura sommaria ed urgente del procedimento e per la particolare efficacia attribuita al provvedimento col quale il giudice ordina la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione dei suoi effetti
Lo Statuto fu concepito come una carta dei diritti del lavoratore. Non crede che ancora oggi – e forse oggi non meno di allora – una Carta che raccolga la disciplina fondamentale delle tutele del lavoratore in modo organico serva a fornire un quadro uniforme e completo dei diritti usciti dalla stagione della flexsecurity? Ma uno Statuto oggi avrebbe prospettive di durata in uno scenario in cui ogni nuovo Governo interviene per imporre la propria visione del mercato del lavoro?
E. Di Cerbo: Condivido pienamente l’affermazione secondo cui lo Statuto fu concepito e, aggiungerei, costituisce ancor oggi una carta dei diritti dei lavoratori.
La risposta alle domande suddette richiede peraltro alcune considerazioni preliminari e una brevissima disamina dell’evoluzione più recente del diritto del lavoro, quale emerge dagli interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni. Tale disamina mostra chiaramente che il legislatore non si è limitato a incidere sulla disciplina degli istituti lavoristici tradizionali, ma ha reso necessaria ed indifferibile una profonda rimeditazione di concetti fondamentali del diritto del lavoro quali, in particolare, quelli della subordinazione e dell’autonomia nell’ambito del rapporto di lavoro.
Con la legislazione più recente la nozione di subordinazione sembra sfumare – ovvero, secondo alcuni, dilatarsi – in relazione all’emergere di una moltitudine di forme di collaborazione fra prestatori di lavoro e imprese che non appaiono facilmente inquadrabili nella suddetta nozione pur concretandosi, almeno tendenzialmente, in prestazioni di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale (e quindi nella definizione fornita dall’art. 409, n. 3, cod. proc. civ.).
In particolare, l’entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2015 (in tema di disciplina dei contratti di lavoro e di revisione della normativa concernente le mansioni) e della legge n. 81 del 2017, che ha introdotto misure in tema di lavoro autonomo non imprenditoriale e misure “volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, impongono, a mio avviso, un mutamento di prospettiva nel diritto del lavoro che non può essere più limitato alla valutazione dell’efficacia delle tutele e alla capacità di contemperamento, da parte del legislatore, degli opposti interessi ma che, in una situazione di cambiamento epocale dei sistemi economici e produttivi, deve estendere la propria riflessione a tutte le forme di prestazione aventi a oggetto un facere a favore di altri.
Occorre in altre parole ripensare alla sfera di applicazione delle tutele e trovare una diversa ed equilibrata modulazione delle stesse in relazione alle singole manifestazioni che le nuove modalità del lavoro esprimono.
Tutto ciò in un quadro economico-sociale reso ancor più complesso dal continuo evolversi dell’organizzazione aziendale, imposto, in particolare, dalla globalizzazione e dalla connessa esigenza di far fronte alla concorrenza internazionale, e reso possibile dall’evoluzione tecnologica e, in particolare, dal proliferare delle c.d. piattaforme informatiche; basti pensare ai casi dei riders di Foodora (3) o degli autisti di taxi di Uber, casi che rappresentano solo la prima emersione delle suddette problematiche.
In questo contesto emerge in modo sempre più evidente la necessità di porre nuove regole di garanzia, analoghe a quelle che nel 1970 hanno ispirato il legislatore dello Statuto dei lavoratori, a tutela dei prestatori di lavoro che operano nell’ambito dei nuovi lavori. In sostanza una nuova carta dei diritti, peraltro non più concepita sul modello del rapporto di lavoro subordinato, come è accaduto nel caso dello Statuto dei lavoratori, ma che individui una soglia di garanzie minime ed irrinunciabili da attribuire a tutti i lavoratori impegnati nella variegata costellazione di nuove tipologie di lavori, non sempre inquadrabili nell’ambito del rapporto subordinato, rese possibili dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e dai nuovi modelli organizzativi che il mondo della produzione e della distribuzione è riuscito o riuscirà in futuro a escogitare.
Si tratta di una sfida in primo luogo culturale, che richiede alla dottrina giuslavoristica un grande sforzo di elaborazione. In secondo luogo, occorre che il legislatore sappia operare una sintesi efficace ed innovativa, alla stregua di quanto riuscì a fare nel 1970.
La storia dei prossimi anni ci dirà se i suddetti auspici si avvereranno.
Ottemperanza di chiarimenti e appellabilità della decisione (nota a Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2020, n. 4004).
di Michele Ricciardo Calderaro
Sommario: 1. Il caso di specie. – 2. La questione di diritto. – 3. L’appellabilità della sentenza di ottemperanza del giudice amministrativo: il difficile percorso evolutivo della giurisprudenza. - 4. La possibilità di impugnazione della sentenza di ottemperanza che fornisce chiarimenti sull’esecuzione del decisum del giudice amministrativo: la (corretta) soluzione adottata dal Consiglio di Stato. – 5. Osservazioni critiche.
La questione giunta all’esame del Consiglio di Stato, con la sentenza che si annota, è di particolare complessità, già nelle sue articolazioni fattuali, e deve essere pertanto ricostruita con attenzione.
Il caso trova la sua origine in una questione di natura edilizia, con dei chiari risvolti però per quanto concerne l’esercizio di un’attività commerciale, dato che il primo grado di giudizio, tenutosi presso il T.A.R. Puglia, Bari, concerneva il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza che i ricorrenti avevano precedentemente presentato al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia e/o decadenza della comunicazione di inizio lavori di una Società che gestiva un supermercato in un locale attiguo e confinante con un locale simile per tipologia dei ricorrenti, in ordine ai lavori di abbattimento del muro perimetrale del condominio (di separazione tra i due locali) eseguiti senza previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
Il T.A.R Puglia, adito a’ sensi dell’art. 117, cod. proc. amm., accoglieva il ricorso avverso il silenzio e conseguentemente dichiarava l’obbligo dell’Amministrazione di adottare tutte le determinazioni necessarie in ordine all’istanza presentata dai ricorrenti in un termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando contestualmente, avvalendosi del potere concesso dal co. 3 della medesima disposizione, un commissario ad acta, che provvedesse in luogo dell’Amministrazione comunale qualora questa fosse rimasta inadempiente nel termine a lei assegnato.
La sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, n. 754/2019, passava in giudicato in quanto l’appello proposto dalla Società titolare del supermercato veniva dichiarato irricevibile dalla V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 13 novembre 2019, n. 7775.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione comunale per adeguarsi alla statuizione del giudice amministrativo, l’Amministrazione individuata per svolgere le funzioni di commissario ad acta, ovvero la Prefettura, delegava un proprio funzionario a delineare le misure necessarie per ottemperare alla pronunzia del T.A.R. Puglia.
Il commissario ad acta, a seguito di apposita istruttoria, dichiarava inefficace e decaduta, in seguito a sentenza, la comunicazione di inizio lavori asseverata della Società titolare del supermercato, ordinandole contestualmente di “reintegrare i ricorrenti nel compossesso del muro divisorio di cui è, mediante la sua ricostruzione con le caratteristiche preesistenti al momento dell’abbattimento”, non disponendo però nulla in ordine all’eventuale annullamento dell’autorizzazione rilasciata in favore dell’impresa per lo svolgimento dell’attività commerciale.
Alla determinazione del commissario ad acta non veniva data alcuna esecuzione, in quanto i ricorrenti di primo grado non venivano reintegrati nel compossesso del muro divisorio e contestualmente l’attività commerciale della Società continuava ad essere esercitata nei locali abusivamente trasformati, anche perché sul punto non era intervenuta alcun tipo di disposizione da parte dei provvedimenti commissariali.
Così, a seguito di istanza dei ricorrenti, il commissario ad acta, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 112, co. 5, cod. proc. amm., si rivolgeva al T.A.R. Puglia, Bari, al fine di ottenere tutti i chiarimenti necessari in ordine ad eventuali specifici provvedimenti di sospensione da adottare nei confronti dell’esercizio dell’attività commerciale da parte della Società titolare del supermercato.
Il T.A.R., con sentenza 10 aprile 2020, n. 479, ha risposto alla richiesta di chiarimenti, disponendo, sulla base della consolidata giurisprudenza anche del Consiglio di Stato che ravvisa un rapporto di presupposizione giuridica tra il titolo edilizio ed il provvedimento di autorizzazione commerciale[1], che il commissario ad acta provveda senza indugio a comunicare la propria determinazione di inefficacia della scia all’apposito ufficio comunale, per le determinazioni di competenza di quest’ultimo in ordine all’inevitabile e conseguenziale decadenza dell’autorizzazione commerciale rilasciata, in favore della Società titolare del supermercato, essendo i locali oramai rimasti privi di titolo abilitativo, presupposto indispensabile per lo svolgimento dell’attività commerciale.
Proprio dalla sentenza di ottemperanza, adottata dal T.A.R. Puglia per fornire i chiarimenti richiesti dal commissario ad acta, sorge la questione di diritto controversa che occorre esaminare.
2. La questione di diritto.
La Società titolare del supermercato, non condividendo le statuizioni contenute nella sentenza del giudice dell’ottemperanza, interpone appello al Consiglio di Stato per una serie di ragioni di diritto, attinenti in particolari alla mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il T.A.R. Puglia non avrebbe considerato separatamente i locali di cui dispone la Società, alcuni dei quali non inficiati da irregolarità edilizia, con la conseguenza che evidentemente la statuizione di decadenza in toto dell’autorizzazione commerciale non troverebbe ragion d’essere.
Le ragioni di censura avanzate avverso la sentenza del T.A.R. sono molteplici, ma non saranno oggetto di approfondimento in questa sede, perché ciò che deve essere esaminato riguarda un aspetto particolare, ovvero l’appellabilità della sentenza di ottemperanza per i chiarimenti richiesti dal commissario ad acta.
Difatti, sia alcuni degli originari ricorrenti che l’Amministrazione comunale, costituendosi in giudizio dinnanzi al Consiglio di Stato, hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di ottemperanza pronunciata ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., a seguito della richiesta di chiarimenti sull’esecuzione di un precedente giudicato, trattandosi di mero incidente di esecuzione sfociato in statuizioni di natura ordinatoria e non decisoria, come tali non impugnabili.
Ed è proprio su questo punto che la sentenza del Consiglio di Stato, qui annotata, si sofferma primariamente, sia perché in ogni caso si tratta di una questione di rito da risolvere prima di definire il merito sia perché è un punto controverso, che coinvolge aspetti importanti del rapporto processuale nel sistema di giustizia amministrativa e che merita perciò un chiarimento.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di inammissibilità, anzitutto, in quanto i precedenti giurisprudenziali invocati dai ricorrenti in primo grado a suffragio dell’eccezione si riferiscono a casi, nei quali la sentenza resa su richieste di chiarimenti ex art. 112, co. 5, cod. proc. amm. atteneva a mere questioni di natura ordinatoria e quindi si risolveva in un mero incidente di esecuzione volto a chiarire le modalità materiali di esecuzione della sentenza cognitoria ottemperanda.
Nel caso di specie, invece, l’appellata sentenza di ottemperanza non si è limitata a impartire disposizioni ordinatorie di esecuzione materiale della sentenza cognitoria, ma ha per la prima volta affrontato ex professo la tematica della ripercussione della dichiarazione di inefficacia e decadenza del titolo edilizio sull’autorizzazione commerciale, affermando la sussistenza di “una correlazione nettissima tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale”, peraltro già prevista espressamente dall’art. 20, Legge della Regione Puglia n. 24 del 2015.
Ne consegue, secondo il Consiglio di Stato, che il T.A.R. Puglia, in piena aderenza alla funzione assolta dal giudizio di ottemperanza, che involge la necessità di un’interpretazione della sentenza ottemperanda al fine di individuare il comportamento doveroso dell’Amministrazione in sede di esecuzione della sentenza, e che, secondo la tesi tradizionale, si configura come giudizio misto di cognizione ed esecuzione che dà luogo a un giudicato a formazione progressiva[2] – con la sentenza di ottemperanza ha deciso su un tratto di interesse non espressamente affrontato dalla sentenza ottemperanda e quindi su aspetti cognitori non esaminati nel giudizio definito con la sentenza resa sul silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione comunale.
La statuizione del Consiglio di Stato sul punto è meritevole di attenzione, perché affronta in maniera netta e decisa la natura del giudizio di ottemperanza nel processo amministrativo, in particolare della c.d. ottemperanza di chiarimenti, e deve essere esaminata a partire dagli orientamenti giurisprudenziali che sul punto si sono formati.
3. L’appellabilità della sentenza di ottemperanza del giudice amministrativo: il difficile percorso evolutivo della giurisprudenza.
Come è noto, il giudizio di ottemperanza è lo strumento mediante il quale nel processo amministrativo si esercita l’azione di esecuzione, che, a’ sensi dell’art. 112 del Codice, può essere oggi esercitata, seppur con modalità differenti quanto ai poteri del giudice amministrativo, sia nei confronti delle sentenze passate in giudicato che nei confronti delle sentenze immediatamente esecutive quali sono quelle dei Tribunali Amministrativi Regionali[3].
Il giudizio di ottemperanza è previsto nel nostro ordinamento sin dalla legge Crispi del 1889, ed in particolare dall’art. 4, n. 4 di quella legge 31 marzo 1889, n. 5992[4], che, istituendo la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, ha disciplinato il potere del giudice amministrativo di decidere, pronunziando anche in merito, dei ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dei tribunali che avessero riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico[5].
Questa tipologia di giudizio nasce, perciò, come necessario completamento della tutela giudiziale dei diritti che il giudice ordinario non era in grado di assicurare se non parzialmente[6].
I poteri del giudice amministrativo dal 1889 ad oggi sono sostanzialmente mutati e sono stati evidentemente ampliati e così anche il giudizio di ottemperanza ha subito un’evoluzione sino ad avere ad oggetto prima, con la legge istitutiva dei T.A.R. del 1971, anche il giudicato dei giudici amministrativi[7] ed infine, mediante l’innovazione apportata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, le sentenze esecutive del giudice amministrativo non ancora passate in giudicato[8].
Il giudice amministrativo, in accoglimento del ricorso presentato, ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento o la sua emanazione in sostituzione dell’Amministrazione che avrebbe dovuto adottarlo.
Il Codice prevede, inoltre, sulla base del combinato disposto degli articoli 112, co. 5 e 114, co. 7, che il giudizio possa essere attivato altresì per fornire chiarimenti sulle modalità di ottemperanza, anche laddove la richiesta pervenga dallo stesso commissario ad acta.
Nel caso di specie su cui si è pronunziata la sentenza del Consiglio di Stato che si annota, la questione è sorta proprio dall’applicazione di queste norme.
Difatti, a seguito dell’accoglimento di un ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione ex art. 117 del Codice, il commissario ad acta[9] nominato con quella sentenza ha azionato il rimedio dell’ottemperanza per chiedere al T.A.R. Puglia quale fosse l’ambito del giudicato e quali fossero, pertanto, i provvedimenti da adottare per dar seguito al decisum contenuto nella prima sentenza.
Il T.A.R. Puglia ha dettato le prescrizioni necessarie nella sentenza di ottemperanza, che è stata però appellata a’ sensi dell’art. 100 dinnanzi al Consiglio di Stato.
In questa sede è stata sollevata una questione giuridica precipua sulla stessa ammissibilità del ricorso in appello: la sentenza di ottemperanza pronunciata ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., a seguito della richiesta di chiarimenti sull’esecuzione di un precedente giudicato non sarebbe impugnabile, trattandosi di un mero incidente di esecuzione sfociato in statuizioni di natura ordinatoria e non decisoria, come tali non impugnabili.
Questo specifico aspetto può essere esaminato solamente dopo aver chiarito quali siano i limiti generali dell’appellabilità della sentenza di ottemperanza pronunziata dal giudice amministrativo di primo grado.
La questione è stata ampiamente dibattuta e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sin dalla sentenza n. 23 del 1978, ha cercato di risolvere la problematica, tentando anzitutto di delineare quale sia la natura del giudizio di ottemperanza.
L’Adunanza Plenaria, difatti, con questa pronunzia, ha ritenuto inammissibile l’appello avverso le sentenze di ottemperanza dei T.A.R., in quanto la speciale natura del procedimento di ottemperanza, il carattere peculiare e pregnante delle relative statuizioni e la sua funzione esaustiva della vicenda processuale fornirebbero una valida spiegazione logica del perché il legislatore non abbia ritenuto il doppio grado di giudizio rispondente alle caratteristiche e alla funzione proprie di tale procedimento in relazione alla esigenza che il giudizio – già eventualmente sviluppatosi in più gradi – pervenga finalmente a conclusione in tempi rapidi ed in forme concentrate, cosi come richiede sia l'interesse alla tempestività dell'azione amministrativa sia l'interesse del privato alla realizzazione della posizione di vantaggio che gli deriva dalla sentenza da eseguire[10].
Il Consiglio di Stato, in questa prima statuizione, pareva pertanto molto risoluto, date le caratteristiche del giudizio in questione, nell’escludere qualsivoglia tipologia di impugnazione delle sentenze di ottemperanza, salvi solamente i casi eccezionali di pronunzie abnormi o comunque esorbitanti dall’ambito di applicazione del giudizio di ottemperanza[11].
Questo primo orientamento, così restrittivo, è andato incontro, già precedentemente all’entrata in vigore del Codice, ad una modifica ampliativa, da parte della stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, nel senso di delimitare specificamente le ipotesi nelle quali l’appello avverso le sentenze di ottemperanza dei T.A.R. deve ritenersi ammissibile.
Così, tenendo conto della natura del giudizio di ottemperanza[12] e dell’effetto devolutivo del giudizio di appello[13], si è affermato il principio secondo cui l'appello proposto avverso la sentenza di ottemperanza del tribunale amministrativo regionale è ammissibile solo quando questa non si limiti a disporre mere misure applicative, ma risolva questioni giuridiche in rito e in merito, "pronunciandosi sulla regolarità del rito instaurato, sulle condizioni oggettive e soggettive dell'azione e sulla fondatezza della pretesa azionata”[14].
In altri termini, l’appello non è possibile ove la sentenza che si impugna ha provveduto solamente a dettare prescrizioni operative e/o materiali per ottemperare a quanto deciso nella sentenza di cognizione.
Successivamente all’entrata in vigore del Codice, il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che, in applicazione dell'art. 125 della Costituzione, il Codice del processo amministrativo prevede l'appellabilità di ogni sentenza di primo grado, altresì ove resa in sede di ottemperanza, ha chiarito che deve considerarsi pacifico l’assunto relativo all’impugnabilità delle sentenze emesse in sede di ottemperanza, allorquando il gravame non investa mere questioni esecutive, ma anche quello concernente l'effetto devolutivo pieno che deve riconoscersi ove, in sede di appello, debbano risolversi questioni giuridiche in rito e in merito, in relazione alla regolarità del rito instaurato, alle condizioni soggettive ed oggettive dell'azione ed alla fondatezza della pretesa azionata[15].
Se le statuizioni rese nel giudizio di ottemperanza, dunque, non hanno effetti meramente esecutivi e carattere sostanzialmente ordinatorio, queste sono appellabili, così come peraltro avevano già statuito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 1986.
Queste, difatti, avevano affermato che il giudizio d'ottemperanza davanti al tribunale amministrativo regionale, all’epoca disciplinato dall'art. 37 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 ed oggi dall’art. 112 del Codice, pur presentando modalità processuali di tipo sommario, ed essendo rivolto ad una sostituzione di detto tribunale all'autorità amministrativa inadempiente in ordine all'esecuzione di un precedente giudicato, ha natura giurisdizionale, con la conseguenza che le pronunce che lo concludono sono soggette, senza eccezioni o limitazioni, al principio dell'appellabilità davanti al Consiglio di Stato, non potendo invece essere direttamente impugnate con ricorso per Cassazione[16].
Oggigiorno, pur in presenza di una disposizione del Codice, l’art. 114, co. 8, che sembrerebbe ammettere in via generale l’impugnabilità di tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza, si deve ritenere, sulla base dell’evoluzione giurisprudenziale sinora descritta, che siano appellabili le sentenze contenenti statuizioni cosiddette aberranti, ovvero dotate di un contenuto del tutto estraneo all'ambito ed alla funzione propri del giudizio di ottemperanza, nonché le sentenze contenenti statuizioni cosiddette esorbitanti, che cioè travalichino i confini dell'esecuzione per affrontare direttamente questioni di cognizione[17].
Affermata con chiarezza l’appellabilità di queste sentenze rese in sede di ottemperanza, occorre adesso soffermarsi sulla problematica relativa all’impugnabilità nei casi in cui la sentenza di ottemperanza sia stata resa per fornire chiarimenti al commissario ad acta.
4. La possibilità di impugnazione della sentenza di ottemperanza che fornisce chiarimenti sull’esecuzione del decisum del giudice amministrativo: la (corretta) soluzione adottata dal Consiglio di Stato.
Partendo dalla riconosciuta natura mista[18], di cognizione e di esecuzione, del giudizio di ottemperanza[19] e dalla funzione della sentenza conclusiva di questo giudizio di interpretazione della pronunzia ottemperanda al fine di individuare il comportamento che l’Amministrazione deve assumere in sede di esecuzione di quanto stabilito dal giudice amministrativo[20], vi è la necessità di chiarire quali siano i limiti entro i quali si può ritenere appellabile la sentenza di ottemperanza che sia intervenuta per fornire chiarimenti in merito all’esecuzione del giudicato.
La sentenza del Consiglio di Stato che si annota, difatti, interviene in un percorso giurisprudenziale complesso ove le posizioni non sono sempre state così definite.
La natura della c.d. ottemperanza di chiarimenti è al centro di un dibattito interno allo stesso Consiglio di Stato, che al riguardo ha elaborato due differenti tesi, una che propende a riconoscerle il rilievo di mero incidente di esecuzione e l’altra che, invece, sembra attribuirle il carattere di accertamento autonomo dell’esatto contenuto della sentenza da eseguire.
Secondo un primo orientamento, la c.d. ottemperanza di chiarimenti, ex art. 112, co. 5, Cod. proc. amm., costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato[21] - utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del titolo esecutivo - e non un'azione o una domanda in senso tecnico, con la conseguenza che non può trasformarsi in un'azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un'impugnazione mascherata, che porti di fatto a stravolgere il contenuto della pronuncia, la quale non può più venire riformata né integrata dal giudice dell'ottemperanza ove la pretesa avanzata sia de planoricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire.
I quesiti interpretativi da sottoporre al giudice dell'ottemperanza devono attenere alle modalità dell'ottemperanza e devono avere i requisiti della concretezza e della rilevanza, non potendosi sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma solo questioni specifiche che siano effettivamente insorte durante la fase di esecuzione dello stesso[22]. Ne discende che lo strumento in esame non può trasformarsi in un pretesto per investire il giudice dell'esecuzione, in assenza dei presupposti suindicati, di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione del decisum, nell'ambito del rapporto tra parti e amministrazione, salvo che successivamente si contesti l'aderenza al giudicato dei provvedimenti così assunti[23].
La conseguenza di questa tesi è che, trattandosi di un mero incidente di esecuzione, non è ammissibile alcun tipo di impugnativa nei confronti della relativa sentenza[24].
Di diverso orientamento è invece la tesi che, valorizzando la possibilità che il ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5 preceda la instaurazione del giudizio di ottemperanza vero e proprio - ha attribuito a questo ricorso la specifica natura di azione autonoma volta all'accertamento dell'esatto contenuto della sentenza (o del provvedimento ad essa equiparato) proponibile, per giunta, esclusivamente dalla Amministrazione tenuta ad adempiere posto che la parte vittoriosa non avrebbe altro interesse che quello alla ottemperanza[25].
Ciò in quanto il ricorso, previsto dall'art. 112, co. 5, cod. proc. amm., per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza ad una sentenza del giudice amministrativo, ha natura giuridica diversa dall'azione di ottemperanza propriamente detta, non potendo essere qualificato né quale semplice strumento di attuazione del comando giudiziale (ex art. 112, co. 2), né come mera azione esecutiva in senso stretto (ex art. 112, co. 3)[26].
Dinnanzi a questa contrapposizione di orientamenti, in radicale contrasto già relativamente alla natura della c.d. ottemperanza di chiarimenti, il Consiglio di Stato nel 2018 ha cercato di porre chiarezza, proponendo un’ipotesi ricostruttiva univoca anche per quanto concerne la possibilità di impugnazione, nel solco di quanto era già stato fatto con riferimento all’appellabilità generale della sentenza di ottemperanza.
Il Consiglio di Stato, anzitutto, ha escluso che la richiesta di chiarimenti introduca un’azione autonoma, distinta da quella per l’ottemperanza vera e propria, così come peraltro già chiarito dall’Adunanza Plenaria[27].
Questo in considerazione della ratio delle norme che prevedono la possibilità di richiedere i chiarimenti in sede esecutiva: rendere piena ed effettiva la tutela giurisdizionale, esigenza vieppiù avvertita quando si deve finalmente attribuire in concreto il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
I chiarimenti, di per sé, attengono, difatti, all’individuazione delle modalità esecutive dell’ottemperanza.
Ciò posto, ferma restando la regola generale della impugnabilità di tutte le decisioni rese dal giudice di primo grado in sede di ottemperanza secondo il percorso evolutivo della giurisprudenza cui si è precedentemente fatto cenno, per comprendere se una sentenza di ottemperanza resa su una richiesta di chiarimenti è appellabile è necessario valutare il contenuto concreto delle statuizioni in essa contenute[28].
Se le statuizioni hanno effetti meramente esecutivi e la pronunzia si caratterizza per un’indole segnatamente non decisoria e tanto meno definitiva, questa non potrà considerarsi appellabile, secondo i principi processuali generali che affermano la non impugnabilità, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dei provvedimenti non decisori e comunque non definitivi quali sono i provvedimenti esecutivi[29].
La sentenza del giugno 2020 che si annota si pone correttamente nel solco di quest’ultima pronunzia.
Dato che la sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia resa per i chiarimenti richiesti dal commissario ad acta ha affrontato questioni non meramente esecutive, non si è limitata ad impartire istruzioni operative allo stesso, ma ha affrontato per la prima volta, con un contenuto cognitorio e decisorio, un profilo fondamentale per l’esecuzione della sentenza che era stata pronunziata sul silenzio serbato dall’Amministrazione, ovvero il rapporto giuridico esistente tra titolo edilizio ed autorizzazione commerciale, non si può ritenere che questa si concretizzi in un mero incidente di esecuzione e che quindi non sia appellabile.
La sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia ha un contenuto decisorio su aspetti di cognizione che non erano stati esaminati dalla sentenza ottemperanda e correttamente la si deve ritenere suscettibile di appello.
L’arresto, peraltro reso nella forma della sentenza breve[30] ex art. 60 del Codice, del Consiglio di Stato deve essere perciò condiviso perché, data la natura mista del giudizio di ottemperanza[31], occorre individuare correttamente il contenuto della sua pronunzia conclusiva per determinare o meno la possibilità di impugnazione, anche allorché si tratti di pronunzia resa su una richiesta di chiarimenti da parte del commissario ad acta.
Ciò è necessario affinché venga garantita anche in questo caso l’effettività della tutela[32] nel processo amministrativo[33].
5. Osservazioni critiche.
La sentenza di ottemperanza su cui è intervenuto il Consiglio di Stato presenta dei caratteri di certa peculiarità, che occorre tenere in debita considerazione allorché vi siano dei dubbi sull’appellabilità della c.d. ottemperanza di chiarimenti.
Nei paragrafi precedenti si è ricostruita la vicenda processuale e si è ricordato come il T.A.R. Puglia sia intervenuto in ottemperanza a seguito della richiesta di chiarimenti del commissario ad acta nel momento in cui il giudicato si era formato sul silenzio-inadempimento[34] che era stato serbato dall’Amministrazione.
L’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato del giudice amministrativo ed il commissario ad actanominato già nel giudizio avverso il silenzio ex art. 117, co. 3 del Codice[35] ha stimolato il giudice, mediante il rimedio dell’ottemperanza, affinché dettasse le determinazioni necessarie per una corretta esecuzione di quanto statuito in fase di cognizione[36].
La particolarità deve essere ravvisata all’interno proprio di questo contesto.
La sentenza resa sul silenzio dal T.A.R. Puglia non affrontava tutti i profili cognitori della vicenda sottoposta al suo esame[37], limitandosi ad ordinare all’Amministrazione di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché trovasse riscontro l’istanza precedentemente presentata dai ricorrenti, su cui si era formato il silenzio-inadempimento, in merito alla declaratoria di inefficacia o di decadenza della comunicazione di inizio lavori della Società titolare del supermercato.
Il T.A.R. non esaminava tutti i profili concernenti il rapporto di presupposizione giuridica esistente tra il titolo edilizio e l’autorizzazione commerciale, per cui illegittimo il primo viene meno la seconda, e così, previa propulsione del commissario ad acta, la sentenza di ottemperanza nel fornire i chiarimenti richiesti ha affrontato profili cognitori che sino ad allora non erano stati definiti.
La sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia non può, pertanto, definirsi meramente esecutiva, in quanto non detta solamente prescrizioni materiali per l’esecuzione del giudicato, proprio perché uno dei profili cognitori fondamentali per la definizione del medesimo, cioè la definizione del rapporto tra titolo edilizio ed autorizzazione commerciale, è stato affrontato solamente in sede di ottemperanza.
Così, allorché l’ottemperanza di chiarimenti completa la cognizione come in questo caso, con un giudicato che si forma in modo progressivo, non può certamente affermarsi che la stessa sia meramente un’azione esecutiva.
Contribuendo alla definizione della parte decisoria della statuizione del giudice amministrativo, la sentenza adottata non è un provvedimento segnatamente esecutivo.
Correttamente, quindi, il Consiglio di Stato ha ritenuto la sentenza di ottemperanza appellabile.
Ciò per due ordini di ragioni, che tra loro sono assolutamente interdipendenti: la prima è che il giudicato si era formato sul silenzio inadempimento dell’Amministrazione, accertando l’illegittimità dello stesso senza giungere però all’attribuzione del bene della vita cui aspirava il ricorrente; la seconda è che, proprio in considerazione di quest’aspetto[38], la sentenza di ottemperanza non si è preoccupata soltanto di delineare le modalità operative del contenuto stabilito in fase di cognizione ma ha dovuto integrarlo, esaminando anche aspetti di cognizione che il giudizio non aveva affrontato affinché l’esecuzione del giudicato fosse tale da garantire piena tutela alla pretesa sostanziale che i ricorrenti avevano dedotto nel rito avverso il silenzio.
Allorquando la sentenza di ottemperanza, resa anche per la richiesta di chiarimenti da parte del commissario ad acta, presenta queste caratteristiche, non può che essere suscettibile di appello dinnanzi al Consiglio di Stato.
Rimangono aperti i problemi dei limiti oggettivi del giudicato che può formarsi su una sentenza resa sul silenzio, ma è questione che non può essere affrontata ed esaurita nell’ambito delle presenti note[39].
[1] Come ricordato, ad esempio, da Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3793, in www.giustizia-amministrativa.it, nel rilascio dell'autorizzazione commerciale occorre tenere presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l'attività commerciale si va a svolgere, con la naturale conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi legittimo ove fondato su rappresentate e accertate ragioni di abusività e/o non regolarità delle opere edilizie in questione con le prescrizioni urbanistiche; da ultimo, si rinvia anche a Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3419, in www.giustizia-amministrativa.it, che ha affermato la sussistenza del rapporto di presupposizione giuridica tra il rilascio del titolo edilizio e quello per l’esercizio di un’attività commerciale, rapporto di presupposizione che comporta l’automatica caducazione dell’altro di cui il primo costituisce presupposto.
[2] La letteratura sul giudicato amministrativo è diffusa; anzitutto il riferimento corre alla fondamentale voce di F. Benvenuti, Giudicato (dir. amm.), in Encicl. dir., Milano, Giuffrè, 1969, Vol. XVIII, 893 ss.; si rinvia poi, ex multis, a F. Satta, Brevi note sul giudicato amministrativo, in Dir. proc. amm., 2007, 302 ss.; A. Travi, Il giudicato amministrativo, in Dir. proc. amm., 2006, 919 ss.; C. Cacciavillani, Giudizio amministrativo e giudicato, Padova, Cedam, 2005, 1 ss.; P.M. Vipiana, Contributo allo studio del giudicato amministrativo, Milano, Giuffrè, 1990, 1 ss.; M. Clarich, Giudicato e potere amministrativo, Padova, Cedam, 1989, 145, che ricorda come il giudicato cada non solo sull’atto, ma sulla fattispecie del potere; da ultimo, si rinvia ai recenti contributi di S. Vaccari, Il giudicato nel nuovo diritto processuale amministrativo, Torino, Giappichelli, 2017, 1 ss.; S. Valaguzza, Il giudicato amministrativo nella teoria del processo, Milano, Giuffrè, 2016, 1 ss.; sugli effetti della sentenza di annullamento del giudice amministrativo e sul giudicato a formazione progressiva si rinvia a C.E. Gallo, I poteri del giudice amministrativo in ordine agli effetti delle proprie sentenze di annullamento, in Dir. proc. amm., 2012 280 ss.; nonché a M. Andreis, L’attività successiva alla sentenza di annullamento tra acquiescenza e principio di assorbimento, in Dir. proc. amm., 2003, 1201 ss.; da ultimo a S. Valaguzza, L’illusione ottica del giudicato a formazione progressiva, in Dir. proc. amm., 2018, 296 ss.
[3] Per un’ampia trattazione in merito occorre far riferimento a C.E. Gallo, Manuale di giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli, 2018, 287 ss.; F. Francario, Sentenze di rito e giudizio di ottemperanza, in Dir. proc. amm., 2007, 52 ss.; A. Travi, Il giudizio di ottemperanza ed il termine per l’esecuzione del giudicato, in Giorn. dir. amm., 1995, 976 ss.; L. Mazzarolli, Il giudizio di ottemperanza oggi: risultati concreti, in Dir. proc. amm., 1990, 226 ss.; R. Villata, Riflessioni in tema di giudizio di ottemperanza ed attività successiva alla sentenza di annullamento, in Dir. proc. amm., 1989, 369 ss.
[4] Per una ricostruzione storica si rinvia a G. Crepaldi, Le pretese risarcitorie nel giudizio di ottemperanza: resistenze e sviluppi, in Resp. civ. e prev., 2012, 717 ss.
[5] Sulla conformazione originaria del giudizio di ottemperanza, quale mezzo di esecuzione delle sentenze del giudice civile, si rinvia allo studio di M.S. Giannini, Contenuto e limiti del giudizio di ottemperanza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 442 ss.; nonché ad E. Guicciardi, L'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dei tribunali, in Arch. dir. pubbl., 1938, 250 ss.
[6] Sul punto si rinvia a N. Saitta, Sistema di giustizia amministrativa, Napoli, Esi, 2015, 442 ss.
[7] L'opera di estensione del giudizio di ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo è stata definita di “filiazione” da M. Nigro, Il giudicato amministrativo ed il processo di ottemperanza, in Il giudizio di ottemperanza (Atti del XXVII Congresso di studi di scienza dell'amministrazione, Varenna-Villa Monastero, 17-19 settembre 1981), Milano, Giuffrè, 1983, 64 ss.; sul punto si rinvia, altresì, a R. Villata, L’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, Milano, Giuffrè, 1971, 1 ss.
[8] Per l’evoluzione del giudizio di ottemperanza, anche se ancora riferito alla disciplina ante Codice del processo, si rinvia a L. Ferrara, Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione, Milano, Giuffrè, 2003, 1 ss.; nonché a L. Verrienti, Giudizio di ottemperanza, in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 1991, Vol. VII, 257 ss.
[9] Per un inquadramento generale di questa figura si rinvia a V. Caputi Jambrenghi, Commissario ad acta, in Encicl. dir., Milano, Giuffrè, 2002, Aggiornamento, VI, 284 ss.; G. Orsoni, Il commissario ad acta, Padova, Cedam, 2001, 1 ss.; A. Cioffi, Sul regime degli atti del commissario ad acta nominato dal giudice dell'ottemperanza, in I Tar, 2001, II, 1 ss.; nello specifico per la nomina del commissario nel rito avverso il silenzio dell’Amministrazione, nel regime antecedente all’art. 117 del Codice, si rinvia a G. Mari, Il commissario ad acta nel rito sul silenzio quale organo straordinario dell’Amministrazione, in Foro amm. TAR, 2003, 750 ss.
[10] Cons. Stato, Ad. Plen., 14 luglio 1978, n. 23, in Foro it., 1978, III, 449 ss.
[11] Per un commento critico a questa sentenza si rinvia a F.G. Scoca, Sentenze di ottemperanza e loro appellabilità, in Foro it., 1979, III, 4 ss.
[12] Per un approfondimento si rinvia a C.E. Gallo, Il contraddittorio nel giudizio di ottemperanza: un problema aperto, in Foro amm. CdS, 2009, 1264, che ha affrontato il problema della natura del giudizio di ottemperanza con particolare riferimento all’esercizio del diritto di difesa.
[13] Per un’ampia disamina dell’effetto devolutivo dell’appello si rinvia a C.E. Gallo, Appello nel processo amministrativo, in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 1987, Vol. I, 315 ss.; R. Villata, Considerazioni sull'effetto devolutivo dell'appello nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 1985, 131 ss.; N. Bassi, L'effetto devolutivo dell'appello nel processo amministrativo (dalla parte del ricorrente), in Dir. proc. amm., 1985, 342 ss.
[14] In questo senso Cons. Stato, Sez. V, 8 luglio 2002, n. 3789, in Foro amm. CdS, 2002, 1716 ss.
[15] Così Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2018, n. 6907, in Foro amm., 2018, 2155 ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 759, in Foro amm. CdS, 2012, 401 ss.
[16] Cass. civ., Sez. Un., 24 novembre 1986, n. 6895, in Giust. civ., 1987, I, 310 ss.
[17] Sul punto si rinvia a S. Tarullo, Ottemperanza (giudizio di), in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, VII appendice, 2017, 559 ss.
[18] Secondo F. Figorilli, La difficile mediazione della Plenaria fra effettività della tutela e riedizione del potere nel nuovo giudizio di ottemperanza, nota a Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2, in Urb. e app., 2013, 952 ss., il Codice sembra “ridefinire il giudizio per l'esecuzione del giudicato come una sorta di contenitore in grado di offrire una serie di strumenti, tra loro profondamente diversi, a disposizione della parte che vuole conseguire l'utilitas consacrata dalla pronuncia divenuta cosa giudicata. Ed invero, all'interno dello schema proposto dall'art. 112, comma 2, c.p.a., è possibile rintracciare una pluralità di azioni che possono ben contenere tutte le sfumature in passato prospettate dalla giurisprudenza sulla natura dell'istituto”.
[19] Come chiarito da C.E. Gallo, Ottemperanza (giudizio di), in Encicl. giur., Milano, Giuffrè, 2008, Annali, II, 818 ss., “il giudizio di ottemperanza può consistere vuoi nell'attuazione di statuizioni puntuali contenute nel giudicato, rispetto alle quali occorre una semplice attività materiale o giuridica esattamente delineata nel giudicato stesso; vuoi nella individuazione, al termine di un'autonoma fase di cognizione in cui il giudice è chiamato a definire un assetto di interessi, di quale sia il portato del giudicato, con una pronunzia che può avere un contenuto caducatorio, e perciò costitutivo, oppure conformativo, e perciò condannatorio”. Sulla possibilità che il giudizio di ottemperanza serva anche a completare l’accertamento giudiziale, che avrebbe dovuto aver il suo esito nella fase di cognizione, si rinvia alle opinioni di E. Cannada Bartoli, Processo amministrativo (considerazioni introduttive), in Noviss. Dig. It., Torino, Utet, 1966, 1077 ss.; Id., Specialità del giudizio di ottemperanza, in Giur. it., 1999, 2414 ss.; M. Nigro, Il giudicato amministrativo ed il processo di ottemperanza, in Riv. trim. proc. civ., 1981, 1157 ss.; G. Corso, Processo amministrativo di cognizione e tutela esecutiva, Milano, Giuffrè, 1989, 1 ss.; A. Pajno, Il giudizio di ottemperanza come giudizio di esecuzione, in Foro amm., 1987, 1648 ss.; da ultimo, F. Manganaro, Il giudizio di ottemperanza come rimedio alle lacune dell’accertamento, in Dir. proc. amm., 2018, 534 ss.
[20] Come evidenziato da P.M. Vipiana, L’ottemperanza al giudicato amministrativo fra l’attività del commissario ad acta e quella dell’amministrazione “commissariata”, in Urb. e app., 2015, 1049 ss., la fase dell’ottemperanza è fondamentale nel processo amministrativo, in quanto “serve ad assicurare l’effettività del dictum del giudice, nell’ambito dell’equilibrato assetto tra giudicato e riedizione del potere amministrativo”.
[21] Così Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2014, n. 4722, in Foro amm., 2014, 2337 ss.
[22] In questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5409, in Foro amm., 2015, 2774 ss.
[23] Così, ad esempio, Cons. Stato, Sez. V, 6 settembre 2017, n. 4232, in Foro amm., 2017, 1829 ss.
[24] Secondo quanto ritenuto da Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6151, in Urb. e app., 2015, 482 ss.
[25] In questi termini Cons. Stato, Sez. IV, 17 dicembre 2012, n. 6468, in Foro amm. CdS, 2012, 3228 ss.
[26] Così Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2015, n. 4141, in Foro amm., 2015, 2262 ss.
[27] Cons. Stato, Ad. Plen., 15 gennaio 2013, n. 2, in Foro it., 2014, III, 712 ss., con nota di A. Travi, che riconduce il ricorso previsto dall'art. 112, co. 5, Cod. proc. amm. al novero delle azioni di ottemperanza.
[28] Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141, in Foro it., 2018, 6, III, 302 ss.
[29] Ribadita di recente, ad esempio, da Cass. civ., Sez. Un., 1˚ febbraio 2017, n. 2610, in Guida dir., 2017, 10, 32 ss.
[30] Sulla sentenza in forma semplificata o c.d. breve si può rinviare a R. De Nictolis, Le sentenze del giudice amministrativo in forma semplificata. Tra mito e realtà, in www.giustizia-amministrativa.it, 2017, 1 ss.; A. Police, Le decisioni in forma semplificata (cosiddetto giudizio immediato), in G.P. Cirillo (a cura di), Il nuovo diritto processuale amministrativo, Cedam, Padova, 2014, 541 ss.; A. Clini, La forma semplificata della sentenza nel giusto processo amministrativo, Padova, Cedam, 2009, 1 ss.; M. Sinisi, La disciplina della decisione in forma semplificata, la garanzia del contraddittorio e il giusto processo. Profili di dubbia legittimità, in Foro amm. TAR, 2008, 413 ss.
[31] L’affermazione è oramai consolidata in letteratura: si rinvia, ad esempio, a C. Calabrò, Giudizio amministrativo per l'ottemperanza ai giudicati, in Enc. giur., Aggiornamento, Roma, 2002, Vol. XV, 3; V. Caianiello, Esecuzione delle sentenze nei confronti della pubblica amministrazione, in Encicl. dir., Milano, Giuffrè, 1999, Aggiornamento, III, 614; M. Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna, Il Mulino, 1983, 387; A.M. Sandulli, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato, Napoli, Morano, 1963, 169.
[32] F. Francario, La sentenza: tipologia e ottemperanza nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2016, 1025 ss., osserva correttamente come, “nel sistema tradizionale, dunque, il giudizio di ottemperanza non nasce per garantire l'esecuzione forzata di sentenze di condanna, ma come strumento volto a garantire l'effettività della tutela costitutiva di annullamento erogata in fase di accertamento dal giudice amministrativo”; in tema si v. anche G. Mari, Giudice amministrativa ed effettività della tutela: l’evoluzione del rapporto tra cognizione e ottemperanza, Esi, Napoli, 2013, 1 ss. In linea generale, secondo I. Pagni, La giurisdizione tra effettività ed efficienza, in G.D. Comporti (a cura di), La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed efficienza), Firenze, Firenze University Press, 2016, 85, il concetto di effettività deve valorizzare il principio chiovendiano, “in virtù del quale il processo deve dare al titolare di una situazione soggettiva tutto quello e proprio quello che il diritto sostanziale riconosce”; l’affermazione del principio è di G. Chiovenda, Della azione nascente dal contratto preliminare, in Saggi di diritto processuale civile, Milano, Giuffrè, 1930, Vol. I, 101 ss.; Id., Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, Editoriale Scientifica, 1923, ora in Principi di diritto processuale civile, Napoli, Editoriale Scientifica, 1965, 81, secondo cui "il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire".
[33] C.E. Gallo, Servizio e funzione nella giustizia amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 2020, 73 ss., nell’affermare che la giustizia amministrativa non può essere qualificata come servizio pubblico ma come funzione, ricorda che il sindacato prestato dal plesso giurisdizionale T.A.R. – Consiglio di Stato deve essere pieno e completo sull’attività dell’amministrazione: in questo senso occorre leggere l’effettività della tutela nell’ambito del processo amministrativo; in merito si rinvia altresì alle osservazioni di M.A. Sandulli, Processo amministrativo, sicurezza giuridica e garanzia di buona amministrazione, in Il Processo, 2018, 45 ss.
[34] Sull’istituto del silenzio dell’Amministrazione si rinvia, in generale, agli studi classici di F.G. Scoca, Il silenzio della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 1971, 1 ss.; S. Cassese, Inerzia e silenzio della pubblica amministrazione, in Foro amm., 1963, 30 ss.; nonché, più di recente, a V. Parisio, Il silenzio della pubblica amministrazione tra prospettive attizie e fattuali, alla luce delle novità introdotte dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, in Foro amm. TAR, 2006, 2798 ss.
[35] Sulle caratteristiche del rito in questione si può rinviare ad A. Scognamiglio, Rito speciale per l’accertamento del silenzio e possibili contenuti della sentenza di condanna, in Dir. proc. amm., 2017, 450 ss.
[36] S. Caggegi, L’esecuzione della pronuncia silenziosa, in www.giustiziainsieme.it, 2020, evidenzia la particolarità della nomina del commissario ad acta nel rito avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione: in questo caso si potrebbe parlare di “un’ottemperanza “anomala” o “speciale”, dove la specialità risiede nella circostanza per la quale si prescinde dal passaggio in giudicato della sentenza”.
[37] M. Ramajoli, Forme e limiti della tutela giurisdizionale contro il silenzio inadempimento, in Dir. proc. amm., 2014, 709 ss., evidenzia, correttamente, come l'effetto conformativo della sentenza avverso il silenzio è pressoché nullo, limitandosi alla mera necessità di provvedere; l'attività richiesta al commissario risulta invece di tipo sostitutivo pieno, in un ambito di piena discrezionalità, non collegata alla decisione giudiziale se non per quanto attiene all'accertamento dell'obbligo di provvedere; della stessa opinione, anche se riferita alla disciplina antecedente al codice, è A. Travi, Giudizio sul silenzio e nuovo processo amministrativo, in Foro it., 2002, III, 233 ss.; nonché v. ancora E. Cannada Bartoli, Ricorso avverso il silenzio-rifiuto e mutamento della domanda, in Foro amm., 1993, 310 ss.; in tema si rinvia anche alle osservazioni di E. Sticchi Damiani, Il giudice del silenzio come giudice del provvedimento virtuale, in Dir. proc. amm., 2010, 1 ss.
[38] E. Picozza, Il processo amministrativo, Milano, Giuffrè, 2009, 1 ss., osserva, con riferimento al rito avverso il silenzio, che, qualora l’Amministrazione non provveda il giudizio di cognizione si estende “con una fase (non un giudizio autonomo) di esecuzione”; v. altresì F.G. Scoca,Il silenzio della pubblica amministrazione alla luce del suo nuovo trattamento processuale, in Dir. proc. amm., 2002, 239 ss.; nonché, in generale, G.B. Garrone, Silenzio della pubblica amministrazione (ricorso giurisdizionale amministrativo), in Dig. disc. pubbl., Torino, Utet, 1999, Vol. XIV, 191 ss.
[39] Sotto questo profilo ci si limita a rinviare a S. Caggegi, L’esecuzione della pronuncia silenziosa, cit.
Note sul processo civile dopo l’emergenza sanitaria
di Paolo Biavati
Sommario. 1. – Il processo civile e la normazione di emergenza. 2 – L’esperienza del periodo emergenziale. 3. – Nuove forme di udienza e diritto di difesa. 4. – Protocolli locali e unità della giurisdizione. 5. – Le prospettive: qualche prima anticipazione normativa. – 6. Una riflessione sul ruolo della Cassazione. – 7. Brevi annotazioni conclusive.
1.Il processo civile e la normazione di emergenza.
Riflettere sulle conseguenze della pandemia legata alla diffusione del Covid 19 è un compito difficile e non soltanto per i giuristi. Da un lato, si corre il rischio di pensare che non si tornerà più alla situazione precedente e che nuovi scenari si apriranno in ogni settore della società, mentre è chiaro che consuetudini e rapporti sociali consolidati non verranno spazzati via in modo così semplice, ma tenderanno a riprodursi e a ripetersi. Dall’altro, si può cadere nell’eccesso opposto e pensare all’emergenza che abbiamo vissuto (e che, mentre scrivo, non è certo definitivamente archiviata) come ad una spiacevole parentesi, che resterà nel mondo dei ricordi. In realtà, a mio avviso, senza cadere nell’illusione di un’improbabile palingenesi, occorre prendere atto che non potremo non assorbire molti elementi di novità, emersi nei mesi trascorsi. Occorre quindi confrontarsi con questi elementi, senza pensare a priori che il vecchio era meglio del nuovo, o che il nuovo è sempre meglio del vecchio, ma cercando di orientarci a valorizzare ciò che di positivo si sta proponendo.
Ometto qui un’analitica ricostruzione (peraltro, tuttora in progress) delle norme emergenziali e rimando in particolare ai commenti, chiari e puntuali, che Franco De Stefano ha costantemente offerto ai lettori di Giustizia insieme. Mi limito ad una rapidissima citazione di quelle principali: l’art. 2, comma 2°, lett. h) del d.l. n. 11 del giorno 8 marzo 2020, abrogato perché superato; l’art. 83 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge con la l. n. 27 del 24 aprile 2020, modificato dal d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, convertito in legge con la l. n. 70 del 25 giugno 2020; l’art. 36 del d.l. n. 23 del giorno 8 aprile 2020, convertito in legge con la l. n. 40 del 5 giugno 2020. Ulteriori novità sembra vengano dalla legge di conversione del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, vale a dire il c.d. decreto rilancio.
Non mi soffermo, in specie, sul tema della sospensione dei termini processuali ovvero delle relative eccezioni, mentre vorrei dedicare qualche annotazione alle modalità provvisorie di svolgimento delle udienze civili, anche sulla base dell’esperienza maturata sul campo.
2. L’esperienza del periodo emergenziale.
Come è ben noto, in concreto, le modalità previste sono due. Entrambe tengono conto, in modo primario, dell’esigenza di distanziamento sociale, che tuttora costituisce uno degli elementi cardine nell’impegno per contenere gli effetti negativi della pandemia e che ha raggiunto il suo apice nelle settimane di chiusura del Paese[1].
La prima è quella che prevede lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e quindi, la maggior parte di esse) mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (art. 83, comma 7°, lett. h), d.l. n. 18/20).
La seconda è quella che, invece, prevede lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza – così la norma – deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità del collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà; di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale (art. 83, comma 7°, lett. f), d.l. n. 18/20).
Mi pare preferibile chiamare le prime “udienze telematiche”, dato che la modalità telematica per il deposito delle note scritte è obbligatoria e totalmente sostitutiva della presenza in aula dei difensori: circola peraltro anche la denominazione di “udienze cartolari”, che allude al modo necessariamente scritto della trattazione. Per le seconde è invalso chiamarle “udienze da remoto”.
Le settimane di applicazione delle disposizioni emergenziali hanno messo in luce vantaggi e svantaggi delle soluzioni prescelte e hanno aperto il dibattito, non tanto sulla loro legittimità, anche costituzionale (anche perché l’eccezionalità della situazione impone un atteggiamento costruttivo, che apprezza tutto ciò che si poteva fare per non bloccare interamente la giustizia civile, sia pure pagando qualche prezzo), ma soprattutto sulla loro idoneità a sopravvivere alla fase della pandemia e a rimanere come possibili modelli, alternativi o perfino esclusivi, dell’udienza civile dopo il ritorno alla normalità.
Prima di affrontare questo tema, è forse utile sottolineare qualche profilo problematico delle forme di udienza governate dalla disciplina dettata nel periodo dell’emergenza.
Ora, mentre le udienze da remoto hanno trovato spazio limitato, molto più frequente è stato l’impiego delle udienze telematiche (o cartolari, che dir si voglia). Al riguardo, segnalo, in primo luogo, che un ruolo decisivo è assunto dal provvedimento che le dispone. Infatti, l’atto dell’organo giurisdizionale disegna il perimetro della trattazione a distanza, talora restringendolo rispetto a ciò che il precedente provvedimento di fissazione dell’udienza in presenza avrebbe permesso alle parti di fare.
Ancora, il provvedimento relativo alla trattazione a distanza incide, sia pure di solito in modo leggero, sulle modalità e sui tempi di difesa delle parti. Viene specificato, in base a ciò che le linee guida e i protocolli locali prevedono, il termine anteriore alla data di udienza entro il quale le note scritte devono essere depositate: ne segue che una semplice istanza orale, che il giudice avrebbe raccolto a verbale, è sostituita da un atto scritto, da preparare con un certo anticipo. Dato che la sinteticità è un obiettivo ancora difficile da raggiungere, non di rado le note appesantiscono il materiale di causa e complicano (ripeto: in modo leggero) l’impegno dei difensori.
Naturalmente, si è posto il tema di stabilire, se i termini fissati per il deposito siano perentori o no. A mente dell’art. 152 c.p.c., occorre trovare la disposizione di legge che affida al giudice il potere di renderli tali. A me pare che, allo stato, una disposizione diretta non ci sia e che questa facoltà venga esercitata in base ad una catena di norme: da quella (art. 83, comma 6°, del d.l. n. 18) che affida ai capi degli uffici l’adozione delle opportune misure organizzative per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica sullo svolgimento dell’attività giudiziaria (fra cui quelle del comma 7° della norma e, pertanto, le udienze telematiche), alle disposizioni che si riscontrano nei protocolli concordati con i Consigli degli ordini forensi. Troppo poco, a mio parere, perché se ne possa dedurre la perentorietà del termine.
Ciò non significa, però, che il rispetto del termine sia ininfluente. Infatti, la mancata presentazione delle note equivale, nella normazione emergenziale come governata dai protocolli, a mancata comparizione: se nessuna delle parti scrive, si applicano gli artt. 181 e 309 c.p.c. Questa equiparazione è discutibile, perché si può cogliere una (per quanto lieve) differenza fra la mancata comparizione fisica e il mancato deposito di note, contenenti istanze e conclusioni: infatti, si potrebbe dare il caso (pensiamo ad un interveniente adesivo dipendente o a un chiamato iussu iudicis, contro il quale nessuna altra parte abbia preso conclusioni) di una parte processuale che intende essere presente all’udienza, ma non ha istanze da proporre: vuole esserci e basta. Questa parte sarebbe comunque tenuta a depositare note, pur non volendo assumere alcuna iniziativa processuale.
Ne segue, in ogni caso, che questa equiparazione finisce per consentire al giudice di decidere, avendo letto solo le note depositate entro il termine fissato. In qualche modo, l’avvocato che non deposita nel termine è equiparato a quello che arriva in udienza a verbale già chiuso. Quindi, non decadenza per mancato rispetto di un termine perentorio, ma semmai preclusione e inefficacia pratica di un’attività compiuta quando la fase processuale a cui essa inerisce si è già consumata.
Del resto, vi sarebbero non pochi inconvenienti se si attribuisse al termine una valenza meramente esortativa. Il principale è quello dell’equilibrio e del contraddittorio fra le parti. Già di per sé uno dei limiti dell’udienza telematica consiste nell’elisione della facoltà di replica, invece possibile durante la trattazione in presenza. Occorre ricordare che il contraddittorio non consiste solo nell’imporre al giudice di sentire tutte le campane (audiatur et altera pars, secondo gli antichi), ma comporta anche la possibilità, per ogni parte, di contrastare ciò che è affermato dall’altra. Se, poi, a questa diminutio delle facoltà difensive si aggiunge il rischio che una parte possa scrivere le sue note dopo avere letto quelle dell’altra, senza incorrere in alcuna decadenza, lo squilibrio si aggrava.
E’ poi evidente che chi non presentasse le note per causa non imputabile avrebbe diritto a beneficiare della rimessione in termini: né più né meno, di un avvocato che arrivasse a udienza finita per un guasto al treno prenotato tempestivamente o per un documentato improvviso problema di salute fisica.
3. Nuove forme di udienza e diritto di difesa.
I rilievi appena svolti ci introducono alla domanda di maggiore significato; se cioè, le nuove modalità, una volta superata la fase emergenziale, possano trovare posto stabile nel processo civile e se, in tal caso, siano compatibili con il giusto processo, previsto dalla carta costituzionale all’art. 111. Il dibattito è già vivace, anche se non ha ancora trovato ampio spazio sulle riviste tradizionali e si è sviluppato, invece, nei blog e nelle reti sociali.
Prendo le mosse dal comunicato emesso il 10 aprile 2020, in piena situazione di chiusura, dall’esecutivo di Magistratura democratica, in cui si legge, fra l’altro: “Tuttavia, riteniamo necessario ribadire che una volta cessata la situazione di emergenza – e mettendo in conto come anche per la giustizia, al pari di altri settori della vita del paese, si tratterà di un processo graduale – occorrerà tornare alla “normalità” e, con essa, alla pienezza di tutte quelle regole processuali che non sono neutre, essendo state previste dal legislatore in funzione dell’effettività del diritto di difesa e del ruolo di garanzia della giurisdizione. Da questo punto di vista, l’udienza da remoto e la trattazione scritta nel processo civile rischiano di vanificare i positivi risultati della trattazione effettiva dei processi in udienza, a partire da un tasso di definizione conciliativa molto elevato”.
Nei giorni successivi, queste affermazioni hanno dato vita ad un nutrito scambio di opinioni. Accanto a molti consensi (fra i quali, come meglio dirò, il mio), sono state espresse numerose e articolate posizioni di dissenso, il cui filo conduttore (e scusandomi per l’indispensabile sintesi) è quello di non legarsi allo scenario dell’udienza in presenza, che spesso si riduce ad un teatrino burocratico, ma di aprirsi, senza paura, alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia, in vista di una maggiore efficienza del processo civile.
Ora, a me pare che altro sia (o sia stato) fare funzionare la giustizia, per quanto possibile, nella situazione di distanziamento sociale imposta dall’emergenza sanitaria, e altro è trasformare queste soluzioni provvisorie in una stabile modalità di governo del processo civile. E’ pure vero che non si deve diffidare nelle soluzioni sempre più avanzate che la tecnologia propone: certo, occorre valutarle e pesarne l’efficacia, ma senza escluderne a priori l’impiego.
Il punto di partenza per una riflessione corretta (e qui sta la mia condivisione con il comunicato che ho citato) sta nella presa d’atto che in nessun caso vi può essere perfetta identità fra l’udienza tradizionale, con la presenza fisica del giudice e dei difensori e i vari possibili surrogati che – necessariamente – danno qualcosa di meno. Solo affermando con chiarezza che l’udienza telematica e l’udienza da remoto non sono la stessa cosa dell’udienza prevista dal codice si può aprire la discussione, sul livello di utilizzabilità delle forme sorte con il diritto emergenziale.
L’udienza telematica finisce per essere una razionalizzazione di un modo deteriore (seppure, spesso imposto dalle necessità pratiche) di gestire le udienze civili. Se i difensori delle parti si presentano a verbalizzare le rispettive istanze e il giudice, senza alcun dialogo, decide di riservare la decisione (quale che sia) fuori udienza, è chiaro che, in qualche misura, si può affermare che poco cambia. Il codice, però, prevede altro: si pensi alle ipotesi di un percorso di conciliazione, ovvero la (per quanto negletta) richiesta di chiarimenti e individuazione dei punti fondamentali della controversia, ex art. 183, comma 4°, c.p,c. Si aggiunga che, come sopra accennavo, i difensori vengono privati del potere di replicare alle istanze (in ipotesi, nuove e inammissibili) della controparte.
Il difetto dell’udienza telematica, quindi, è soprattutto quello di ingessare il processo nella contrapposizione delle parti, limitando sia il reciproco diritto di replica, sia il ruolo attivo e propositivo del giudice. Si ha, quindi, un oggettivo impoverimento della trattazione, lontano dai migliori modelli europei.
A queste osservazioni, si replica spesso (e qui penso soprattutto al mondo forense) che le udienze a distanza possono essere comode, non solo perché evitano trasferte e comunque investimenti di tempo, ma anche perché assicurano -si dice- il medesimo risultato di quelle tradizionali. L’esempio che viene portato con maggiore frequenza è l’udienza di precisazione delle conclusioni in sede di appello.
Queste obiezioni pratiche hanno un senso e, infatti, mi permetteranno di dire che, a date condizioni, l’esperienza del periodo emergenziale può offrire spunti utili anche per il futuro. In sé, però, sono argomenti che provano troppo. A ben guardare, infatti, le udienze che meglio sono sostituibili con una trattazione telematica o da remoto sono, in sostanza, udienze inutili, che potrebbero e dovrebbero essere evitate. I giudici di appello, in punta di codice, già alla prima e unica udienza dovrebbero fare precisare le conclusioni (artt. 188 e 189 c.p.c.). Ciò non accade, non per imposizione del codice, ma per le note esigenze di carico di lavoro, che inducono a fare dell’udienza di precisazione delle conclusioni un momento di smistamento del compito decisorio. Quindi, un’udienza che non ci dovrebbe essere e, pertanto, normalmente gestibile in via telematica. Quando invece l’udienza ha un significato effettivo nella trattazione del caso, la qualità dello svolgimento in presenza è certamente preferibile.
Diverso è il profilo dell’udienza da remoto. Dando per scontato che i sistemi di collegamento funzionino (e funzionino ugualmente bene per tutte le parti, mettendole sullo stesso piano comunicativo), si realizza una forma di com-presenza, che sembra rispettare i crismi dell’oralità. In realtà, il rapporto che si svolge sulla piattaforma informatica non consente la stessa immediatezza (per usare, non a caso, una delle tre parole d’ordine chiovendiane) di quello che si svolge nella prossimità fisica e anche le modalità di direzione dell’udienza sembrano segnare una sensibile differenza con quelle comuni.
In effetti, le piattaforme oggi in uso sono strutturalmente più adatte ad un dialogo fra pari, che non ad una situazione in cui vi è pur sempre un iudex che opera super partes. Probabilmente, possono avere maggiore utilità in sedi come la mediazione o la negoziazione assistita, come del resto la stessa legislazione recente sembra riconoscere.
Si deve concludere, quindi, che l’udienza telematica e l’udienza da remoto non assicurano lo stesso livello di contraddittorio di quelle che si svolgono in presenza fisica. Ne è consapevole lo stesso legislatore, che, non a caso, si preoccupa che le nuove modalità di udienza permettano di “salvaguardare il contraddittorio” (art. 83, comma 7°, lett. f) del d.l. n. 18 del 2020): una cura che non avrebbe senso, se non si temesse il contrario.
Sulla scorta di queste annotazioni, occorre chiedersi se e quanto dell’esperienza che si è formata nella situazione di emergenza epidemiologica possa stabilizzarsi, al momento dell’auspicato ritorno ad una sufficiente normalità.
La tecnologia impoverisce fatalmente i rapporti umani: eppure, dalla tecnologia non si torna indietro.
In tutta franchezza, dubito che le nuove modalità, una volta sperimentate, vengano messe in soffitta: in questo senso, già si mostrano i primi segnali. La tecnica italica della proroga è il cavallo di Troia con cui il legislatore cerca di anestetizzare la sensibilità degli operatori: già oggi si prospetta un rinvio fino al 31 ottobre ed è verosimile che non ci si fermi qui. Ritengo che non ci si debba opporre, in modo aprioristico, a queste formule, ma che si debbano salvaguardare almeno due essenziali condizioni.
La prima è che si dovrà trattare, senza eccezioni, di modalità alternative all’udienza in presenza del giudice e dei difensori. Riterrei grave che per determinate materie l’una o l’altra modalità venisse imposta come esclusiva. Invece, la facoltà di scelta può trasformarsi in un positivo elemento di flessibilità, in relazione alla peculiarità dei singoli casi.
La seconda è che il loro impiego non dovrà essere imposto dal giudice, ma dovrà essere condiviso, nel singolo caso, da tutte le parti. Lo strumento può essere semplicemente il seguente: ove il giudice disponga la trattazione mediante udienza telematica o da remoto, qualunque parte potrà opporsi e ottenere la trattazione in presenza. Per converso, le parti potranno chiedere consensualmente al giudice di adottare l’una o l’altra modalità e il giudice sarà libero di accettare o no l’istanza.
Il contraddittorio è un valore costituzionale e non lo si può diminuire in nessun caso. Certo, talora lo si può comprimere, ma dando sempre alle parti la possibilità di riespanderlo.
Una norma che può aiutare, seppure collocata in un contesto diverso, è l’art. 823, comma 1°, in tema di arbitrato. Il lodo può essere deliberato a distanza, secondo prassi ampiamente diffuse specie in sede internazionale, ma ciascun arbitro può chiedere che sia invece deliberato in conferenza personale. Lo stesso meccanismo potrebbe essere applicato alle udienze telematiche o da remoto, affidando a ogni singola parte il diritto di avanzare la relativa richiesta.
4. Protocolli locali e unità della giurisdizione.
L’esame della normazione emergenziale relativa al processo civile richiede una breve sosta su un punto, che non mi pare abbia trovato particolare attenzione. Si tratta dell’effetto di frantumazione della disciplina processuale, causato dalla varietà dei protocolli e delle linee guida, attuati in forza del citato art. 83, comma 6°, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020.
Premetto che non sono affatto ostile ai protocolli e che anzi li apprezzo, come efficace forma di soft law. Altro, però, è la fioritura spontanea di protocolli, per disciplinare spazi non espressamente governati dalla legge (come quelli, per non fare che un esempio, sorti in molte sedi in tema di procedimento sommario), e altra cosa, molto diversa, è la delega sistematica alle sedi locali di scegliere come affrontare, sia pure nel quadro di ampie indicazioni legislative, un fenomeno inedito come l’impatto del Covid 19. Ho letto, nelle scorse settimane, contributi che parlavano di “giurisdizione veneta”, “giurisdizione marchigiana” e simili. Certo, lo scopo di questi scritti era quello di descrivere le scelte pratiche attuate nei diversi fori nei momenti più difficili della chiusura forzata. Tuttavia, il fenomeno non va sottovalutato.
Il quadro istituzionale della Repubblica ha subito notevoli scosse, sul piano del rapporto fra il centro e la periferia, lo Stato e le Regioni. Il localismo ha conosciuto forme inedite, con Presidenti di Regione che hanno assunto decisioni del tutto autonome rispetto alle disposizioni nazionali o hanno perfino minacciato di “chiudere” la loro Regione ad altri cittadini italiani. In questo contesto, l’abdicazione del Governo dal dettare regole uniformi non mi è parsa un atto di rispetto verso le culture particolari, ma soltanto una pura e semplice incapacità di reagire in tempi rapidi, seppure dinanzi ad un fenomeno non prevedibile.
Non aggiungo altre osservazioni: mi limito a dire che su valori come quello dell’unità della giurisdizione e del principio di uguaglianza non si può abbassare la guardia. Mi auguro che non solo al momento del ritorno alla normalità, ma anche in sede di eventuale proroga delle forme alternative, se ne tenga conto.
5. Le prospettive: qualche prima anticipazione normativa.
L’evolversi della legislazione post Covid comincia ad offrire qualche indicazione sulle tendenze future. E’ certo presto per trarre conclusioni di sistema, ma alcuni elementi possono essere tenuti in considerazione.
Intanto, l’art. 20-bis del d.l. 17 marzo n. 18, come convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e ancora modificato dal d.l. 30 aprile n. 28, occupandosi di mediazione, getta un primo sguardo oltre la fase emergenziale. Esso precisa che, anche a regime di normalità, gli incontri di mediazione potranno svolgersi in via telematica, ma con il preventivo consenso – ed è questo il punto – di tutte le parti coinvolte nel procedimento. E’ positivo che della volontà delle parti si tenga conto, come requisito di validità dell’iter della mediazione.
I testi in discussione in sede di conversione in legge del decreto rilancio sembrano valorizzare il consenso delle parti in rapporto alle udienze da remoto, ma non anche – se intendo bene - in rapporto a quelle telematiche.
A me sembra che questa distinzione, se sussistente, non sia condivisibile. Il potere di direzione dell’udienza e del processo si estende certo a tutto ciò che accade davanti al giudice, ma non comporta, di per sé, che il giudice scelga anche le regole con cui le parti si confrontano. Se è vero, come penso, che l’udienza telematica non equivale pienamente a quella in presenza, mi pare indispensabile che anche in questo caso si richieda il consenso (o, a tutto concedere, la non opposizione) delle parti.
Ancora un rilievo. In questo periodo, sono apparsi sulla scena volonterosi tentativi di economisti e tecnici, che propongono riforme alla giustizia civile (su cui rimando alle acute osservazioni di Maria Giuliana Civinini e Giuliano Scarselli[2]). Sembra delinearsi, in modo strisciante, un tentativo di banalizzazione della giustizia, seppure presentato sotto le bandiere dell’efficienza e della modernizzazione[3]. Premesso che noi giuristi di solito ci asteniamo dal presentare progetti di riforma del sistema economico, talché verrebbe facile ripetere il monito di Apelle[4], è necessario ribadire che la ragione e il torto, la giustizia e l’ingiustizia, toccano corde essenziali della persona umana e non si riducono mai, neppure in materia civile, a pure e semplici questioni di denaro, da sbrigare con fastidio.
6. Una riflessione sul ruolo della Cassazione.
Molti osservatori hanno sottolineato come, a prescindere da ogni altro fattore, l’emergenza sanitaria abbia rallentato ulteriormente i tempi della giustizia civile: ad esempio, le modalità di lavoro agile hanno indubbiamente inciso, in senso negativo.
Piove sul bagnato, verrebbe da dire. Ma forse vi è una funzione essenziale del nostro ordinamento che dai ritardi – quelli fisiologici e questi patologici – subisce un attacco al suo stesso significato. Mi riferisco alla funzione di nomofilachia del giudice di legittimità.
Le conseguenze della pandemia sui rapporti giuridici stanno aprendo una gamma di conflitti seriali: basti pensare al tema del mancato adempimento di obbligazioni, dovuto alla situazione di chiusura delle attività commerciali. I fiumi di inchiostro scorrono, le opinioni si fronteggiano, le cause vengono radicate. Eppure, per conoscere l’interpretazione che la Cassazione darà dell’art. 1218 c.c. nel contesto attuale dovremo aspettare molti anni, quando la situazione si sarà evoluta e, probabilmente, la soluzione (almeno, sul piano pratico) interesserà a pochi.
Non intendo certo iscrivermi all’elenco di coloro che (a Costituzione invariata) si sono sforzati di trovare qualche via d’uscita a un problema che l’emergenza ha forse reso più evidente, ma che non ha certo creato. Mi limito a notare che, in via puramente logica, mentre lo ius litigatoris suppone che la Corte parli per ultima, lo ius constitutionis vuole che la Corte parli per prima. Già oggi parla per prima, quando – ad esempio – propone una nuova lettura di una norma con efficacia per il futuro, nelle forme del c.d prospective overruling, oppure quando, all’esito di un regolamento preventivo di giurisdizione, indica ai litiganti l’esatta strada da percorrere per il loro contenzioso. Parla per prima (o almeno, viene interpellata prima) anche quando il legislatore le affida un compito di governo dei conflitti seriali, come nel caso dell’art. 420-bis c.p.c.
Ho qualche ritrosia nell’andare avanti con il ragionamento, perché ne rischia di uscire, al di là delle mie intenzioni, una specie di proposta. Preferisco raccontare un midsummer night’s dream, in cui un’esperienza simile al rinvio pregiudiziale europeo si collega al metodo spagnolo dell’interés casacional[5]. In questo sogno, fermo restando il diritto di chiunque a ricorrere in Cassazione contro le sentenze come da art. 111 cost., ogni giudice di merito, in primo grado, può interpellare la Corte, chiedendo un’interpretazione nomofilattica in caso di questioni nuove. La Cassazione, in un breve termine, mediante una sezione apposita e molto qualificata, semplicemente decide se l’interpello merita o no una risposta immediata: e lo fa, misurando l’interesse generale della questione per l’ordinamento. In caso negativo, non succede nulla e quel contenzioso ritornerà eventualmente alla Corte dopo la trafila ordinaria. In caso affermativo, il processo a quo resta sospeso fino alla pronuncia della Corte, da attuarsi con criteri di priorità ed effetti vincolanti per il caso che l’ha generata e fortemente persuasivi per tutti gli altri.
Mi sveglio dal sogno di una Cassazione che risolve subito le questioni che si vengono ponendo e che in tempi brevi orienta il diritto vivente e torno a guardare la realtà: di certo, qualcosa dovremo fare, perché altrimenti, volendo proteggere la norma costituzionale, che a tutti consente di attingere alla tutela di legittimità, finiamo praticamente per svuotarla di efficacia.
7. Brevi annotazioni conclusive.
Trarre conclusioni di una qualche valenza, in un contesto così variabile e incerto, più che impossibile, è inutile. Se però posso aggiungere una parola finale a questo breve intervento, mi pare il caso di raccomandare al legislatore e agli interpreti di non farsi travolgere dagli eventi, ma di sostare e riflettere.
Le vicende dell’emergenza sanitaria hanno provvisoriamente distolto le luci dei riflettori sul disegno di legge delega di riforma del processo civile, presentato dal governo al Senato appena il 9 gennaio u.s. Ai processualisti quel testo non piace[6]. Potrebbe essere utile cogliere l’occasione per una riflessione di ampio respiro che, senza indulgere alle frettolose semplificazioni dei tecnocrati, individui le modalità strutturali e organizzative più idonee per restituire al paese una giustizia al passo con i tempi.
[1] Situazione che, nel linguaggio mediatico, ha assunto la denominazione inglese di lockdown, forse per attenuarne la connotazione negativa.
[2] CIVININI-SCARSELLI, Ridurre i tempi della giustizia civile ? Osservazioni di un giudice e di un avvocato a margine di una recente proposta, in www.questionegiustizia.it
[3] V. ancora CIVININI, La Giustizia in quarantena, in www.questionegiustizia.it
[4] “Sutor, ne ultra crepidam”, come riporta Plinio il Vecchio nel XXXV libro della Storia naturale, attribuendo il detto al pittore Apelle, che avrebbe così rimbrottato un ciabattino che, inorgoglito dal fatto che l’artista aveva accolto un suo rilievo sulla rappresentazione di una scarpa, si era lanciato a criticare l’operato del pittore su altre parti della figura.
[5] Su cui v. per tutti J. LOPEZ SANCHEZ, El interés casacional, Civitas, 2002.
[6] Si veda il testo del parere del Consiglio direttivo dell’Associazione fra gli studiosi del processo civile, pubblicato su Giustizia insieme il 30 dicembre 2019.
Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari: archivio perché...archivio!
di Rosario Russo
Con il tacito consenso del Ministro della Giustizia, ogni anno il P.G. presso la Suprema Corte emette mediamente oltre 1200 provvedimenti d'archiviazione disciplinare, ma nessuno li può leggere
Lo scandalo delle Toghe Sporche è oggetto di procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Perugia. Inoltre, tutte le condotte dei magistrati inquisiti o coinvolti a diverso titolo dalle intercettazioni pubblicate dalla stampa sono – o saranno –oggetto di indagine disciplinare da parte del P.G. della Suprema Corte. Infatti chi deve garantire il rispetto della legge da parte dei cittadini è tenuto innanzi tutto ad osservare i doveri sommi impostigli dal proprio statuto professionale: «Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni» (art. 1 del D. lgs. n. 109 del 2006).
Per legge, il P.G. ha l’obbligo di esercitare l’azione disciplinare, per prevenire che egli possa agire pro amico vel contra inimicum, mentre il Ministro della Giustizia ne ha soltanto la facoltà, che esercita in base a valutazioni sostanzialmente politiche.
In realtà, a fronte di una notizia disciplinare, con motivato provvedimento il P.G. può discrezionalmente archiviare se il Ministro non si opponga espressamente, giacché, per effetto della riforma Mastella risalente al 2006, è stata abrogata la disposizione che riservava al C.S.M. la declaratoria di non luogo a procedere richiesta dal P.G. Al C.S.M., titolare del potere sanzionatorio nei confronti dei magistrati ordinari, pervengono quindi soltanto le notizie disciplinari discrezionalmente non archiviate dal P.G. È tanto palese quanto cospicua, dunque, la differenza rispetto al procedimento penale, in cui il P.M., altrettanto obbligato all’esperimento dell’azione penale, può soltanto prospettare al Giudice l’archiviazione. Per altro, in sede disciplinare il P.G. può archiviare anche in fattispecie alquanto elastiche perché, per legge, «L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza».
Non è l’unica grave anomalia del sevizio disciplinare: malis mala succedunt. Con sentenza 6 aprile 2020 n. 2309 - in netto contrasto con lo spirito della sentenza dell’Adunanza Plenaria 2 aprile 2020, n. 10 - il C.D.S. ha statuito che l’archiviazione del P.G. è accessibile soltanto al Ministro della Giustizia, restando perciò interamente opaca per l’autore della segnalazione disciplinare e perfino per il magistrato indagato e il C.S.M. Il Giudice amministrativo ha infatti considerato ostativo all’ostensione il decreto n. 115/1996 del Ministero della Giustizia, assumendo tra l’altro che tale provvedimento «si riferisce al rapporto di “dipendenza” lavorativa presso il Ministero, non anche ad un rapporto di dipendenza “gerarchica” del personale dall’amministrazione». È di tutta evidenza, tuttavia, che non solo il rapporto di servizio dei magistrati ordinari, ma anche il loro procedimento disciplinare sono regolati, per disposto costituzionale, da una normativa specifica, ben diversa da quella che regola i dipendenti ministeriali non investiti di funzioni giurisdizionali, sicché è quanto meno azzardato ventilare che il Magistrato ordinario ‘dipenda’ dal Ministro. D’altra parte, neppure il P.G. si adegua alla ricordata decisione del C.D.S., perché di regola egli, allorché l’autore dell’esposto disciplinare chieda di conoscerne l’esito, risponde che l’indagine è stata archiviata, rifiutando l’ostensione della sola motivazione. Talvolta inoltre, sfuggendo al proclamato segreto e alla decennale prassi, è dato leggere in articoli di dottrina giuridica interi stralci della motivazione dell’archiviazione disciplinare.
Perché sono importanti i predetti rilievi? Perché nel periodo 2012-2018 (sette anni) risultano iscritte mediamente ogni anno n. 1380 notizie d’illecito disciplinare (segnalazioni con cui avvocati o cittadini denunciano abusi dei magistrati). Ogni anno il 91,6% di tali notizie (cioè n. 1264) è stato archiviato dal P.G. e quindi soltanto per n. 116 di esse è stata esercitata l’azione disciplinare. Consegue che mediamente ogni anno oltre 1260 archiviazioni sono destinate al definitivo oblio, sebbene conoscerne la motivazione è tanto importante quanto apprendere le ragioni (a tutti accessibili) per cui le sanzioni vengono disposte dal C.S.M. La ‘casa’ della funzione disciplinare, pilastro e primo avamposto della legalità, è dunque velata senza alcuna concreta ragione. Non è così infatti per altre archiviazioni. In ambito penale, se sia stata emessa l’archiviazione, qualunque interessato (indagato, terzo, denunciante o querelante) normalmente ha diritto di averne copia (art. 116 c.p.p.), essendo venute meno le ragioni della segretezza. Le archiviazioni disciplinari nei confronti degli avvocati sono d’ufficio notificate al denunciante; anche quelle nei confronti dei magistrati amministrativi sono ostese a chiunque ne abbia interesse. La segretezza delle archiviazioni disciplinari del P.G. è quindi un inquietante unicum, specialmente a volere considerare che la Corte Costituzionale ha sancito da tempo «l'abbandono di schemi obsoleti, ereditati dalla legislazione anteriore e ancora attivi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, imperniati sull'idea, che rimandava ad antichi pregiudizi corporativi, secondo cui la miglior tutela del prestigio dell'ordine giudiziario era racchiusa nel carattere di riservatezza del procedimento disciplinare» (sent. n. 497/ 2000). Anche il Consiglio Superiore della Magistratura ha sposato il principio generale della trasparenza (delibera del 5.3.2014).
Le indagini penali nei confronti di taluni magistrati membri del C.S.M., coinvolti nello scandalo delle Toghe sporche, inevitabilmente hanno avuto - o avranno – anche un risvolto disciplinare. Se in qualche caso il P.G. archiviasse – com’è in suo potere - non ne sapremo mai la ragione; eventuali archiviazioni in sede penale sarebbero invece accessibili. Absurdissimum, se si considera che, in sede disciplinare (come in sede penale), per il magistrato indagato l’archiviazione rappresenta l’esito più fausto e ambito (una ... medaglia al valore giudiziario), anche rispetto alla sentenza di assoluzione emessa dal C.S.M. o dalle Sezioni Unite (a tutti accessibile).
Mai come in questo momento si rivela fondamentale il principio generale della trasparenza: «Dove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro.» (Filippo Turati, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno 1908, p. 22962). Dopo oltre un secolo, introdotta finalmente la legge sulla trasparenza (D. lgs. n. 33/2013), è tempo che, specialmente in questa grave contingenza storica, anche la casa dell’archiviazione disciplinare cessi di essere opaca senza alcuna plausibile ragione. Se la decisione amministrativa o giurisdizionale si distingue da «un pugno sul tavolo» soltanto in virtù della motivazione, non è ormai accettabile che, al cittadino che abbia segnalato qualche abuso dei magistrati, si risponda dicendo: archivio perché ...archivio!
La rinascita della magistratura, ‘disfatta’ dai recenti scandali, ne presuppone la più ampia, spontanea e convinta trasparenza[1].
[1] R. RUSSO, Giustizia è sfatta. Appunti per un accorato necrologio, 8 gennaio 2020, in Judicium.it, diretto dal prof. B. Sassani.
Il dialogo Habermas-Günther riletto dalla cultura giuridica italiana. I penalisti: Vincenzo Militello intervista Massimo Donini, Luciano Eusebi e Domenico Pulitanò
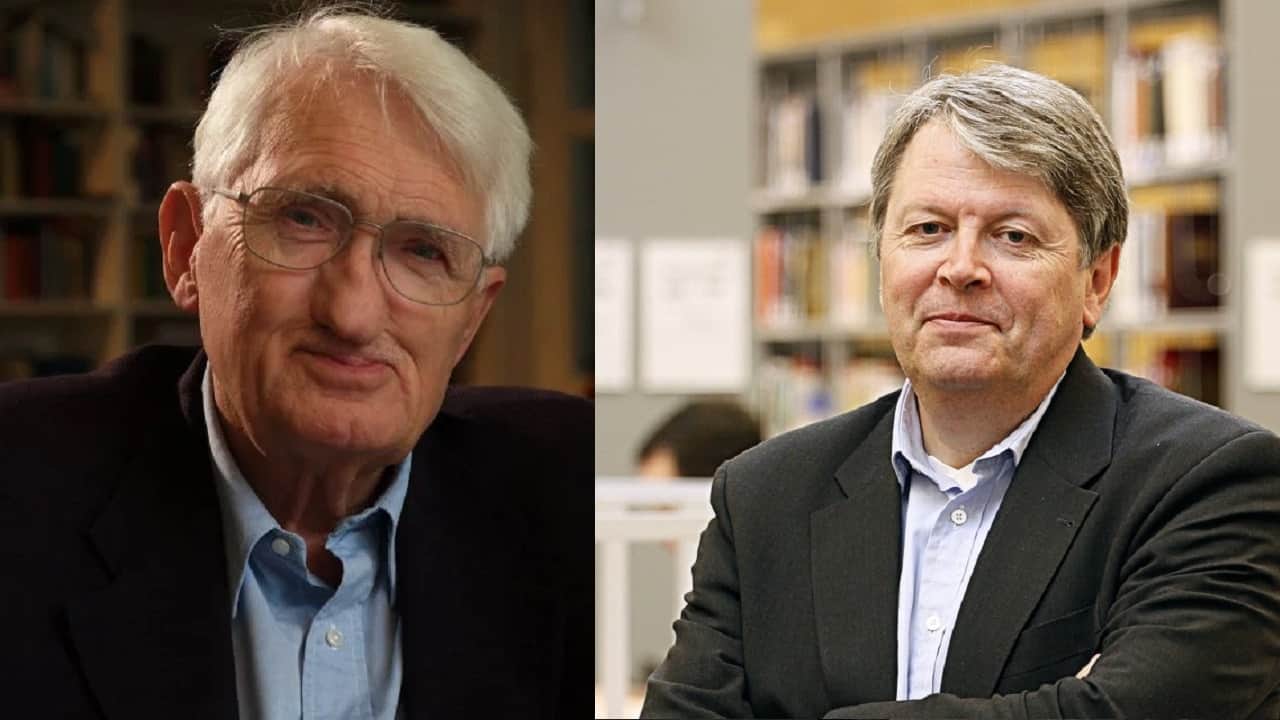
Con le tre interviste oggi pubblicate si chiude il ciclo di approfondimenti che Giustizia Insieme ha riservato al dialogo Habermas-Günter, tratto dal settimanale tedesco Die zeit. Si chiude, così come si era aperto, con le note introduttive di Vincenzo Militello, oggi nella veste di intervistatore di tre suoi illustri colleghi dell’accademia penalistica.
La sensazione è quella di avere offerto delle testimonianze che hanno saputo cogliere dai due pensatori tedeschi spunti, riflessioni, provocazioni e prospettive di altissimo livello che hanno arricchito i lettori della Rivista.
Agli Autori che hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa va, idealmente, il grazie più sincero della Redazione per avere accompagnato un periodo ombroso e cupo dell’esistenza con momenti alti di cultura.
Sommario: 1. Un personale dietro le quinte - 2. Gli attori – 3. Lo scenario – 4. Il canovaccio – 5. Le interpretazioni: Massimo Donini - 6. Luciano Eusebi. Pandemia e diritti fondamentali – 7. Domenico Pulitanò. L’esperienza della pandemia e i problemi del penale - 7.1 L’esperienza della pandemia e del lock down - 7.2 La dimensione costituzionale - 7.3 Obblighi costituzionali di penalizzazione? - 7.4 Limiti del penale e rapporto giustizia/politica - 7.5 Condizioni dell’osservanza. Doveri di solidarietà.
1. Un personale dietro le quinte
Chi si fermasse ad osservare le molteplici discipline coinvolte dalle interviste intorno al dialogo fra i due teorici tedeschi in tema di pandemia e diritti fondamentali potrebbe legittimamente interrogarsi sulla presenza di un penalista come me in un tale dibattito, già dalla pur breve postilla al testo italiano che lo ha avviato. Mi sembra opportuno esplicitare che, se devo alla cortesia e alla fiducia della Direzione di “Giustizia insieme” il coinvolgimento iniziale (per contattare l’editore tedesco che ha pubblicato il contributo in originale), a livello personale la vera ragione del mio interesse si rinviene in un fatto del tutto causale oggettivamente, ma che mi è subito apparso espressione di una ragione immanente alle cose ed altrettanto oggettiva: la sua coincidenza temporale e problematica con un seminario svolto a Palermo proprio nello stesso giorno in cui in Germania appariva il dialogo fra Habermas e Günther.
Nel programmare – insieme ad Alessandro Spena – la discussione seminariale sulle necessità e sui rischi delle restrizioni di libertà connesse al contenimento della diffusione della pandemia è sembrato necessario incrociare prospettive diverse, anche extragiuridiche: all’intervento di un penalista come Massimo Donini si sono aggiunti quelli della sociologa Anna Fici e del psichiatra Daniele La Barbera ("Ritorno al futuro: risposte all'emergenza sanitaria o tappe verso una società autoritaria").
Quando pochi giorni dopo, sempre l’attivissima Direzione della Rivista ha “rilanciato” l’iniziativa, arricchendo il già gustoso piatto offerto dal dialogo di base con la sua apertura ad un confronto a tutto tondo con autorevoli voci della cultura giuridica italiana, non potevo che vedervi un innesto fruttuoso fra le due iniziative, nello spirito di quel “Giustizia insieme” alla base della rivista che ci ospita.
2. Gli attori
Se questo – piccolo e personale – retroscena collega la presenza di Massimo Donini, che aveva già animato il seminario suddetto con un intervento ricco di spunti ora in corso di pubblicazione, le richieste rivolte a Luciano Eusebi e a Domenico Pulitanò si riconducono - quantomeno - alla rispettiva attenzione nei confronti dei temi trattati nel dialogo di Habermas e Günther: il primo, tramite la partecipazione all’analoga iniziativa attivata dalla Rivista subito dopo i primi provvedimenti connessi alla pandemia (Scelte tragiche e Covid 19), il secondo che si è interrogato fra i primi sulle possibili lezioni dall’emergenza per il diritto e la giustizia penale (in Sistema penale, 28 aprile 2020). Tutti hanno accettato di rispondere alle domande predisposte, nello stile delle interviste di Giustizia insieme, più per stimolare l’avvio della discussione sul dialogo dei teorici tedeschi che per porre dei confini tematici ai rispettivi interventi. Il ringraziamento a ciascuno è sentito non solo per aver accettato l’invito, ma soprattutto per averlo declinato – da par loro - con assoluta libertà e autonomia sin dalla struttura dei rispettivi interventi, in un caso rispondendo direttamente alle domande poste, negli altri due trattando variamente e in modo incrociato i temi relativi, oltre ad inserire ampie premesse e collegamenti più generali, sempre attinenti al nucleo dei problemi posti dal dialogo di partenza e agli spunti più direttamente penalistici condensati nelle domande specificamente ad essi rivolte.
3. Lo scenario
Proprio la varietà delle rispettive prese di posizione non rende questa breve introduzione la sede adatta ad un commento adeguato alla portata dei problemi da ciascuno affrontati. Tuttavia, la lettura di esse, specie se incrociata alla luce di quelle precedenti e già numerose provenienti da studiosi di altre discipline, conferma il carattere centrale che ha assunto la questione posta nel dialogo tedesco: il ruolo del bilanciamento fra i beni in gioco e la difficoltà – comune ai vari ambiti - di ricevere da questo principio risposte adeguate di fronte alle scelte tragiche poste con cruda evidenza dalla pandemia. Per i penalisti non è certo una sorpresa: ben prima delle questioni poste dalla pandemia, la questione del bilanciamento si è posta al crocevia della stessa teoria generale del reato, assumendolo come principio che definisce il carattere antigiuridico di un fatto già offensivo del bene penalmente tutelato o piuttosto penetrando già nella delimitazione dell’offesa penalmente rilevante. Ma anche rispetto al dibattito suscitato dal dialogo tedesco sui provvedimenti anti-pandemia, negli interventi di non penalisti il bilanciamento ritorna come tema centrale delle rispettive riflessioni. Si afferma così il suo ruolo di principio teorico generale, benché questa vittoria risulti a ben vedere solo apparente, in quanto proprio il bilanciamento e le sue capacità di offrire risposte alle scelte da operare, per un verso di tutela e d’altra parte di libertà, segna la great division fra le varie risposte fornite alle interviste nei vari settori, e ciò non secondo linee verticali segnate dalle rispettive discipline toccate, ma trasversalmente a queste e in relazione ai singoli punti di vista individuali.
Fondamentalmente si stagliano due approcci differenti se non antitetici, a seconda che il bilanciamento sia ritenuto un principio regolativo necessario per una democrazia rispettosa dei diritti fondamentali, ancorché non risolutivo delle concrete decisioni da assumere in tutti i casi in quanto permane un margine valutativo da riservare alla responsabilità politica; o piuttosto si neghi che di fronte al bene fondativo della vita, altri beni o valori (per quanto più o meno nobili: dalla dignità dell’uomo alla libertà di movimento ed economica) possano avere anche una pur limitata incidenza per delegittimarne la meritevolezza di tutela.
Fra il disincanto realista di chi considera sempre necessario il bilanciamento e il rigore assiologico di chi lo nega in via di principio, per arrendersi solo alla finitudine dei mezzi necessari ad assicurarne la tutela assoluta, si apre però il vero problema. Che è quello posto dai criteri per determinare come operare il bilanciamento nelle molteplici situazioni che si possono dare e specificamente nella tragica concretezza di quelle poste dalla pandemia. Qui i riferimenti teorici, normativi e giurisprudenziali ricorrenti sono proporzione, adeguatezza (e aderenza al sapere scientifico), ragionevolezza: tutti sempre utili per limitare irrazionalità valutative e scelte tiranniche, ma in ultima analisi mai univoci nelle combinazioni reciproche e/o decisivi nelle scelte finali. Anche ad esito delle fertili indicazioni provenienti dal dibattito avviato da Habermas e Günther e sviluppato da tanti autorevoli giuristi italiani nelle interviste connesse si affaccia il rischio che il bilanciamento e le relative regole e discussioni si trasformino in quel “gioco delle perle di vetro”, al quale Hermann Hesse riservava pennellate impareggiabili:
“Queste regole, il linguaggio figurato e la grammatica del Giuoco sono una specie di linguaggio esoterico sommamente evoluto che comprende parecchie scienze e arti (…). Il Giuoco delle perle è dunque un modo di giocare con i valori e col contenuto della nostra civiltà. Esso giuoca con questi come, mettiamo, nei periodi aurei delle arti un pittore può aver giocato coi colori della sua tavolozza…”
4. Il canovaccio
1) Il dialogo fra Hebermas e Günther si incentra su possibilità e limiti in relazione alla pandemia del bilanciamento di beni fondamentali del singolo (vita, salute individuale e d'altra parte libertà individuali, di movimento, di attività economica ecc.), e sottolinea una generale esigenza di proporzionalità e di verifica sull'esistenza di alternative meno limitanti tali libertà, seppure senza pregiudizio del fine di tutelare contro l'infezione. Una prospettiva non dissimile da quella di una politica criminale razionale, che ricorre all' 'arma a doppio taglio' del diritto penale solo in via sussidiaria (extrema ratio) e proporzionata all'offesa che si intende prevenire. Se così è, le difficoltà indicate nel dibattito in merito all'univocità dei risultati che si possono attendere dal giudizio di proporzionalità (ad es. Günther richiama i "fattori di rilevanti insicurezze prognostiche") possono valere se riferite al ricorso al diritto penale?
2) Nella fase acuta della pandemia si è fatto ricorso anche al diritto penale per supportare le forti restrizioni imposte: alla luce del carattere decisamente contenuto dei tassi di disobbedienza rilevati rispetto alle prescrizioni governative, si può ritenere che ciò sia riconducibile all’efficacia general-preventiva dell’apparato sanzionatorio e di controllo, anche penale, o piuttosto – anche alla luce del livello bagatellare delle sanzioni penali inizialmente richiamate – si deve ritenere che l’adesione alle restrizioni imposte sia dovuta più alla presa di coscienza, veicolata capillarmente da vecchi e nuovi media, del carattere estremamente ubiquitario ed elevato del rischio pandemico nella fase della sua maggiore diffusione?
3) Nel confronto fra i riferimenti costituzionali tedeschi a dignità dell’uomo e tutela della vita come elementi da valutare nel bilanciamento con le altre libertà individuali per delineare il livello accettabile del “generale rischio di vita”, il dialogo richiama l’alto rango riconosciuto alla tutela della vita nella sentenza del Bundessverfassungsgericht del 1975 sull’aborto, che per i penalisti tedeschi ed italiani ha avviato il dibattito sugli obblighi costituzionali di penalizzazioni. Pur nella diversità dei riferimenti diretti nella nostra Costituzione rispetto all’art. 1 e all’art. 2 della Legge fondamentale tedesca, l’incidenza tanto della CEDU quanto della Carta U.E. dei diritti fondamentali come incide oggi anche nel nostro ordinamento sulla questione degli obblighi di penalizzazione di fonte sovranazionale?
5. Le interpretazioni: Massimo Donini
1) I bilanciamenti si fanno sempre. Non esistono beni che si sottraggano al bilanciamento in ambito sociale, legislativo e anche penale. Ciò vale sicuramente anche per la vita, che è dunque “relativizzata” e per nulla assolutizzata nel discorso giuridico internazionale e nazionale. Già la dialettica tra vita dei singoli e della collettività esplicita il problema. Salute individuale e collettiva, o pubblica, sono beni che possono entrare in conflitto.
Quando qualcuno dice che esiste un bene non bilanciabile – rammento che per la cultura tedesca dopo il 1945 ha assunto spesso tale preteso carattere il valore della dignità umana consacrato nella legge fondamentale della RFT all’art. 1 – si dimentica di compiere un’analisi lucida della realtà normativa e dei valori in campo. Il carcere, per es., salvo immaginarselo come un hotel a molte stelle, è un luogo che avvilisce la dignità, ma spesso anche le caserme dove si resta in detenzione per varie ore o qualche giorno, lo stesso processo penale con la sua violenza morale, i rapporti con l’autoritarismo dei magistrati, l’esercizio della forza dello Stato contro qualche accusato o imputato, sono forme insuperabili di avvilimento della dignità. In alcuni Paesi i tratti della violenza di Stato sono meno forti, in vari altri sono terribili. Questi però non sono problemi di fatto, ma di diritto: in Germania si pensa che la dignità sia un valore assoluto, ma soprattutto quando si tratta di assicurarla all’interno dei confini nazionali. Non appena l’economia tedesca entra in conflitto con la dignità di altri soggetti di diritto esterni, i bilanciamenti si moltiplicano. Per non parlare della dignità del ladro a cui si può sparare per difendere la proprietà e l’ordinamento se il valore dei beni da proteggere è superiore a 50 euro[1].
Molti hanno pensato che nell’affrontare l’emergenza sanitaria covid-19 lo Stato italiano non avrebbe fatto bilanciamenti, perché ha assunto la salute collettiva come bene primario al quale subordinare tutti gli altri, almeno nella fase più rigorosa del lockdown nei mesi di febbraio-aprile 2020. Chi pensa questo non considera che anche se si sono sacrificati beni quali libertà, affetti, rapporti sentimentali, salute individuale psichica e a volte fisica, lavoro, economia etc. a favore della salute pubblica, un bilanciamento è stato fatto, soppesando come più meritevole, in quella fase ma non in assoluto, un bene rispetto ad altri. E tuttavia le sanzioni non sono state draconiane. Persino il diritto penale ha fatto un passo indietro.
Che poi la salute pubblica sia risultata in seguito del tutto bilanciabile, lo si è visto non appena tutti hanno capito quali sarebbero state le conseguenze economiche della prosecuzione di una segregazione più prolungata. E quando si è visto che il consenso sociale sarebbe venuto meno in caso di mancato allentamento delle misure di contenimento.
Non solo. Anche durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, la situazione nelle strutture ospedaliere più gravate di richieste di ricovero ha comportato ulteriori bilanciamenti ad esempio tra malati gravi e meno gravi, ovvero più anziani e a prognosi infausta e meno anziani o a progni più favorevole, così imponendosi bilanciamenti all’interno della stessa gestione della salute pubblica. In quei momenti si sono compiute scelte vicine a quelle della medicina di guerra, da campo militare.
In tale contesto, e più in generale, il profilo dell’incertezza prognostica è una componente inevitabile della valutazione del rischio.
Ciò accade sempre anche in ambito penale e si riflette nel bilanciamento tra i beni più o meno importanti. Un rischio privo di basi scientifiche collaudate, per es. di tipo puramente “precauzionale” – non: quello tipico di ogni normale regola “prudenziale” – non può sorreggere politiche repressive di beni fondamentali ma deve essere proporzionato a sanzioni più lievi, per es. amministrative.
Il rischio è precauzionale quando manca una base cognitiva ad evidenza scientifica della sua consistenza, misurabilità e predittibilità.
Considerato tale contesto, bisogna apprezzare come ragionevole la scelta legislativa di non ricorrere alla sanzione penale per le inosservanze più formali di contenimento, inizialmente minacciate con la pena dell’art. 650 c.p.
Purtroppo non sempre si registra questa ragionevolezza. La politica legislativa di criminalizzazione a tappeto contro il mercato delle droghe, soprattutto quelle leggere, a fronte della libertà di uccidere o fare ammalare decine di migliaia di persone per effetto del fumo di sigaretta, è una riprova evidente di come siano diverse le politiche in materia di salute pubblica e anche di diritto punitivo.
2) La prova dell’efficacia general-preventiva delle sanzioni penali è da sempre priva di evidenza scientifica. O meglio: la prova quantitativa, la dimostrazione scientifica, la spendibilità di leggi di copertura. È però di common sense la convinzione di una efficacia motivante della paura di pene criminali. Non è dissimile dal principio di precauzione cui abbiamo fatto cenno, salvo che qui la precauzione legittima ogni intervento criminalizzante. Ciò consente, in assenza di leggi – si noti bene – di utilizzare sempre politicamente lo strumento penalistico (il penale incute più timore, se non è penale si può commettere, o si potrebbe mettere nel ‘budget’ la sanzione extra-penale per “comprare” così la violazione) con l’argomento o con il pretesto che sarebbe sempre o più efficace o utilizzabile nel dubbio.
Nel caso della buona tenuta delle regole di isolamento e distanziamento sociale ritengo che siano stati convergenti il timore di sanzioni amministrative pecuniarie (più efficaci delle ammende oblazionabili della contravvenzione inizialmente messa in campo) e la persuasione dell’interesse collettivo al rispetto di regole cautelari che interessavano le famiglie nel loro complesso, gli anziani in primo luogo, ma a scendere proprio tutti: un interesse nazional-popolare vissuto a tratti anche con forte partecipazione massmediatica: una prevenzione generale “positiva”, dunque, che interiorizzava valori e regole, piuttosto che veicolare le paure sanzionatorie proprie della prevenzione generale negativa. La paura più forte è stata quella del virus.
3) Gli obblighi di tutela sono più importanti degli obblighi di penalizzazione. Infatti, la forza vincente degli obblighi di tutela non può affidarsi alle pene come strumento principale.
Anzi. Occorre dire apertamente che solo gli obblighi di tutela sono ciò che le Costituzioni veramente impongono, al di là di quanto opinato in alcune sentenze di organi politico-giurisdizionali come la Corte di Giustizia dell’UE.
Quanto al diritto penale i veri unici obblighi derivano dal rispetto di una doppia sussidiarietà: quella penale e quella europea.
La sussidiarietà penale (che è una declinazione a base empirica e non solo assiologica del principio di ultima ratio), esige che si privilegino strumenti meno invasivi e lesivi della sanzione penale, e che in concreto sia comunque applicata la sanzione penale meno afflittiva, se non necessario. La sussidiarietà europea è anch’essa un principio che va oltre la proporzione e si basa su una valutazione delle conseguenze delle leggi e su una valutazione ex ante ed ex post delle motivazioni delle leggi europee in ordine alla insufficienza delle sanzioni nazionali, se non armonizzate anche in termini punitivi a livello UE.
Qualunque Stato membro, invece di applicare pedissequamente tradizionali penalizzazioni a tappeto, può evitare la criminalizzazione se rispetta i principi ora detti.
Nel complesso devo dire che sino a ora si è avuta l’impressione che l’emergenza abbia rinsavito la fame penalistica dei governi e dei parlamenti, in nome della solidarietà nazionale e internazionale. Quando la bufera sarà passata, aspettiamo di verificare se la bulimia penalistica degli ultimi lustri abbia tratto giovamento da questa terapia d’urto imposta dal Corona Virus, e con essa anche una diversa capacità di dialogo con le competenze scientifiche.
6. Luciano Eusebi. Pandemia e diritti fondamentali
Ritengo necessario far precedere una serie di considerazioni, circa i quesiti proposti, ad alcune risposte sintetiche:
Il rilievo del tema – bilanciamento tra beni giuridici ed esigenze di contrasto della pandemia – è indubitabile. Eppure, riterrei siano da evitarsi, in proposito, eccessi di concettualizzazione giuridica suscettibili di trascurare lo stato dei fatti, offrendo immeritati inquadramenti teorici a scelte (personali o politiche) antisolidaristiche, le quali nulla hanno a che fare con la salvaguardia dei principi di libertà propri dell’ordinamento costituzionale democratico e, a fortiori, con il contrasto di potenziali involuzioni autoritarie dello Stato. Un’esigenza di salvaguardia, questa, che ha bisogno di ben altre battaglie, piuttosto che eluderle sparando cannonate contro obiettivi fittizi: con ciò offuscando, semmai, la percezione del rischio – esso sì effettivo – di perpetuare nel tempo prassi di minor tutela dei soggetti più deboli, non di rado accreditate, oggi, facendo leva su una nozione equivoca di necessità riferita alla fase dell’emergenza sanitaria, o sull’intento – davvero liberal? – di non poter chiedere troppo per esigenze di prevenzione (sovente, nemmeno l’inessenziale) a chi, salvo sorprese, ritenga di non aver molto da temere.
È una preoccupazione, questa, in qualche modo avallata dal fatto per cui si parla quasi sempre, nei dibattiti giuridici in corso, di bilanciamenti tra diritti, rimanendo con ciò nell’ombra che certe rimodulazioni nel loro esercizio sono da correlarsi a un altro termine di pertinenza giuridica esso pure riferibile ai singoli soggetti interessati, che è quello del dovere: non, dunque, all’esercizio di un odioso potere pubblico che – invertendo Robin Hood – toglie (diritti) a qualcuno per dare (diritti) a qualche altro, ma all’attuazione di ciò che costituisce il patto fondativo stesso della democrazia, quale risulta espresso, specie attraverso le sue parole finali, dall’art. 2 della Costituzione.
Si tratta di un termine, nel senso tedesco del sollen, che invero non pochi hanno praticato eroicamente, ben al di là dell’obbligo giuridico, proprio nel periodo della massima emergenza. Sebbene venga menzionato con circospezione in sede politica, quasi vi si veda, oggi, qualcosa di infido, perfino di un po’ totalitario, e, comunque, di poco produttivo sul piano elettorale. In controtendenza (fortunatamente) il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), che nel parere del 28 maggio 2020 su Salute pubblica, libertà individuale e solidarietà sociale argomenta per gran parte con riguardo, per l’appunto, al concetto di solidarietà.
Ammetto subito, peraltro, che non scrivo frigido pacatoque animo. Dalle mie parti i deceduti sono stati migliaia e migliaia, i tassi di mortalità sono schizzati all’insù rispetto allo scorso anno in modo impressionante e moltissimi ora fanno i conti con danni collaterali pesanti. Lo dico perché una certa contiguità, non solo mediatica, con la tragedia incide su alcuni punti di vista. E può non essere un male. Di qui alcune valutazioni generali, necessarie rispetto ai temi sollevati.
In certe zone a rischio di contagio diffuso le limitazioni e, in particolare, il restare a casa (beninteso, con tutti i problemi connessi, dalle diversità delle situazioni abitative, alla deprivazione dell’accesso scolastico, all’incidenza sui rapporti parentali o amicali, e così via), sebbene imposte per il bene comune, hanno rappresentato nel concreto – in primo luogo – un privilegio: vale a dire l’autorizzazione, di cui molti non hanno potuto usufruire (personale sanitario, pubblici amministratori e lavoratori del settore pubblico, soggetti impegnati in attività economiche essenziali, ecc.), a non correre rischi derivanti dall’esercizio delle attività lavorative, o di frequenza scolastica, ordinarie. Personalmente, mi annovero tra i fortunati. Con una certa vergogna per non aver dovuto rischiare, come altri, di più. Piuttosto, il problema – vi ritorneremo – è stato quello delle persone confinate in casa, o nelle residenze assistenziali, perché malate – o con sintomi tali, per utilizzare ritornelli giuridici, da esservi motivi (più che) ragionevoli per sospettare l’avvenuto contagio – e rimaste di fatto senza supporto medico nella più disperante solitudine, in moltissimi casi fino alla morte (con la beffa, se può passarsi il termine, di nemmeno essere annoverati, a quel punto, come deceduti per la pandemia covid-19, vale a dire di esser spariti nel nulla).
Ventilare il pensiero secondo cui, per far salva la vita (di alcuni), nel suo bios, si cadrebbe nel pericolo di compromettere (in ognuno) «tutto il resto della vita» – nodo, questo, richiamato da Massimo Donini (incontro su Ritorno al futuro: risposte all’emergenza sanitaria o tappe verso una società autoritaria?, e-club dell’Università di Palermo, 9 maggio 2020), in riferimento ad Agamben – mi parrebbe a sua volta, nel caso di specie, un’esasperazione. Non potremo certo esigere che taluno doni un rene per salvare un altro, ma qualcosa potremo pure chiedere a rischianti minori per la tutela di rischianti maggiori, a meno che soggiaccia il retropensiero che questi ultimi contino davvero molto poco. È ben vero, come afferma il Comitato etico tedesco richiamato nell’intervista in die Zeit, che «un rischio generale di vita» dovrebbe «essere accettato da ciascuno», altrimenti bisognerebbe vivere come il Kaspar Hauser di Feuerbach (sempre che poi, però, non si desti, rispetto a chi quel rischio verso altri non l’abbia eliso, il sempre famelico circuito penalistico: qualcuno ricorderà le preoccupazioni riferite da Claus Roxin, argomentando sul dolo eventuale, in merito alla prima escursione su un sentiero di montagna cui aveva condotto suo figlio). Per cui, trattandosi di arginare, nella mia città, un numero di morti divenuto presto assai superiore alle vittime civili, nonostante i bombardamenti, di tutta la seconda guerra mondiale, forse qualche limitazione, in effetti, ci poteva ben stare, e qualche cautela per non rinnovare l’esperienza può ben permanere. Senza troppi patemi circa la stadera da utilizzarsi per il giudizio di proporzionalità: tanto più perché le limitazioni oggi necessarie non appaiono davvero così invasive. Nessuno infatti, pone in dubbio che le attività ordinarie debbano riprendere, come in effetti sono, per gran parte, riprese (ma nella mia provincia, non certo secondaria in quel settore, ben più della metà della produzione industriale non s’è mai interrotta). Esse, tuttavia, vanno gestite secondo certe modalità, che non pongono, mi pare, vincoli di molto superiori a quelli che si richiedono circa ordinarie attività pericolose. Certo, si tratta di modalità in qualche caso nuove, come quelle riferite, soprattutto, alla riorganizzazione della attività scolastiche: comunque, non certo tali da rendere invivibile la vita. Così che il pericolo vero dipende dalla demagogia, cioè dall’intento (politicamente allettante) di non esigere più nemmeno il facilmente tollerabile, perché esigere, tanto più in democrazia, implica un’assunzione di responsabilità maggiore di quella (tutta liberale?) del lasciar fare. Non è cosa ignota: dinnanzi a nuove fonti di possibile rischio, si danno nuove esigenze precauzionali, che costano sempre, a tutti, un maggior impegno; e se rispetto a specifiche attività non potesse, ancora, tornarsi a parlare di un rischio (a certi condizioni) consentito, si dovrebbe intervenire con forme solidali di sostegno sul piano economico. Senza dubbio c’è, in proposito, un margine di apprezzamento da parte della politica (cfr. F. Palazzo, Pandemia e responsabilità colposa, in Sistema penale, 26 aprile 2020; D. Pulitanò, Lezioni dell'emergenza e riflessioni sul dopo. Su diritto e giustizia penale, ivi, 28 aprile 2020): purché non asservita alla ricerca facile del consenso hic et nunc, ‘poi si vedrà’, o ai gruppi di interesse economici di cui si parla all’inizio dell’intervista. Francamente, dover riascoltare in nome del diritto fondamentale a una movida incontrollata o ai festeggiamenti calcistici, o in nome delle esigenze immediate di mercato erette a paradigma univoco, i racconti drammatici delle nostre terapie intensive, dove s’è fatto (letteralmente) l’incredibile per cercare, senza potervi riuscire sempre, di far respirare tutti i malati che riuscivano a giungere in ospedale, non mi alletta. Anche perché se la cosa sfugge di mano (e i dati internazionali lasciano molta inquietudine, in un mondo sempre meno blindabile per aree), allora sì che può determinarsi una catastrofe economica devastante, in linea con certe decimazioni medioevali della popolazione a seguito degli eventi epidemici: ben oltre cadute reversibili, ancorché non banalizzabili, di una decina di punti nel PIL.
È riscontrabile, peraltro, un’evidente schizofrenia. E il diritto (ma non solo) penale, in ciò, non aiuta. Da un lato ci si chiede, a ragione, perché non siano state adottate, ab initio, misure restrittive più rigorose, specie per certe aree. Dall’altro lato, si ipotizzano illegittimità, perfino di carattere costituzionale, rispetto a liberalizzazioni non (ancora) attivate. Col rischio della paralisi decisionale, posto che ogni soluzione, giuridicamente, è a rischio. Se si prende una misura, e gli eventi lesivi che essa mira a evitare non si verificano, si porrà subito in dubbio che quella misura abbia avuto effetto causale impeditivo e, dunque, che fosse necessaria: col possibile addebito dei danni, o dei costi economici, che essa abbia comportato per alcuni, se non dell’eccesso di potere o dell’abuso d’ufficio. Se non la si prende, o la si prende male, sono in agguato i delitti contro la salute pubblica, i delitti colposi contro la persona o l’ineffabile sfera applicativa del reato omissivo improprio. Da cui facili atteggiamenti difensivi, intesi, per esempio, a non assumere una responsabilità se non nel quadro di una parcellizzazione pressoché inestricabile delle competenze o assecondando il sentire sociale corrente, se non gli stakeholders dominanti. Ma anche con l’effetto dell’indisponibilità ex post a qualsivoglia trasparenza, cioè all’ammissione, giuridicamente rischiosissima, del fatto che, forse, si sarebbe potuto agire meglio, in modo da farne tesoro per l’avvenire. Il che impone di considerare se davvero il fine prioritario dei processi penali debba essere quello, riconosciute determinate responsabilità, di condannare, e non, invece, quello di fare verità per migliorare, rispetto al futuro, gli stili comportamentali individuali e pubblici (subordinando a quel fine i modi, e la necessità stessa, delle condanne). Così che per esempio, rispetto alla querelle in atto circa la concessione della semilibertà in Germania ai principali responsabili della tragedia ThyssenKrupp, sarebbe interessante, piuttosto, un impegno veemente inteso a verificare se, dopo quella vicenda, sia davvero cambiato qualcosa circa lo stato di inefficienza dei controlli sul rispetto delle norme antinfortunistiche nelle aziende: evitando che la condanna funga da alibi per far sì che tutto resti così com’era). In merito alle carenze nella gestione della vicenda covid-19 la realtà, del resto, è che essa lascia emergere una gigantesca ipotesi di colpa d’organizzazione, la quale impone inversioni di rotta da non eludere attraverso qualche condanna esemplare e qualche capro espiatorio. È facile richiamarne alcuni aspetti: l’incredibile constatazione della (letterale) mancanza a inizio pandemia, non risultandone remunerativa la produzione in Italia, di presidi banali (mascherine, guanti, camici et similia) per l’approccio in sicurezza ai malati contagiosi (il che ha prodotto un numero del tutto inaccettabile di vittime tra il personale sanitario e ha fatto sì che molti ospedali divenissero nel medesimo tempo luoghi di possibile salvezza e di diffusione del contagio); la carenza, molto a lungo, di un numero di tamponi corrispondente alle necessità; il non aggiornamento e la non implementazione dei piani di contrasto delle pandemie virali predisposti in corrispondenza di meno diffuse vicende epidemiche pregresse; la marginalizzazione, in non pochi contesti, della rete socio-sanitaria territoriale; la tendenza diffusa a collocare per motivazioni politiche in ruoli di responsabilità nell’ambito socio-sanitario, per esempio con riguardo alle residenze per anziani, soggetti carenti di competenze professionali adeguate in tale ambito; l’assenza di linee guida accreditate circa la protezione da epidemie delle comunità di persone vulnerabili; la già menzionata difficoltà (e sovente l’impossibilità) delle persone confinate in quarantena di poter ricevere assistenza sanitaria almeno da remoto o di usufruire a domicilio delle bombole d’ossigeno, pur quando indispensabili; in genere, la progressiva riduzione da anni, sottotraccia, dell’impegno economico nel settore sanitario, con le conseguenti carenze di organico negli ospedali e la contemporanea impossibilità d’accesso, per moltissimi laureati in medicina, alle scuole di specializzazione; la contrazione, che ne è derivata, dei tassi per abitante delle postazioni di terapia intensiva e subintensiva (e per fortuna che almeno un importante produttore nazionale di respiratori lo avevamo). Ma si potrebbe proseguire. Tutto questo incide nello stabilire che cosa debba valutarsi come (doverosamente) proporzionato a fini di tutela della vita. Troppo facile sarebbe considerare certe morti inevitabili, riguardando solo l’ultimo anello della filiera. «A seconda di quanto una società abbia ben costruito e mantenuto efficiente il suo sistema», così osserva opportunamente Klaus Günther», «varia il confine tra conseguenze mortali inevitabili ed evitabili dei ‘rischi generali per la vita’».
Proprio da quest’ultimo punto di vista, il concetto di bilanciamento in quanto criterio dei giudizi di proporzione – oggi tra i più gettonati perché consente scelte di campo ben precise, tuttavia evocando l’idea suadente del diritto mite – si è rivelato tra i più equivoci (o, se si vuole, tra i più fluidi). Lo dice bene Jürgen Habermas: «Nel corso del processo di bilanciamento […] i diritti fondamentali possono entrare in concorrenza tra loro. Ma, alla fine, la prevalenza resta di uno, il che significa che questo fa fuori tutti gli altri». Come altrettanto bene spiega Federico Consulich (Lo statuto penale delle scriminanti, Torino, 2018, pp. 41 ss.), a confutazione dell’autonomia di c.d. scriminanti (meramente) procedurali: esse sottendono, «dietro un’apparente neutralità, l’opzione pubblica per una delle due posizioni valoriali in campo», per cui «l’accento posto sul procedimento piuttosto che sul risultato autorizzatorio» «in realtà sancisce la prevalenza di un interesse o di un obiettivo di politica del diritto sull’altro». La logica del bilanciamento rimanda, in effetti (lo avevo sostenuto su Giustizia insieme, in un forum recente dal titolo Scelte tragiche e Covid-19), al criterio dell’aut-aut, che seleziona alcuni fattori rilevanti, considerandoli statici, nel contesto di un conflitto fra beni e, su tate base, decide che cosa tutelare e che cosa no. Mentre riterrei che la strada da percorrere debba essere, prioritariamente, quella dell’et-et, fin dove possibile. Com’è in larga misura avvenuto, nonostante i deficit iniziali sopra segnalati, nella gestione italiana della pandemia. Posto che da parte dei più, sul campo, non s’è affatto limitato a priori – tracciando sulla carta il limite del proporzionato rispetto alle criticità suddette – lo sforzo spendibile per la salvezza di altri, ma s’è cercato di dilatare enormemente quello sforzo, specie con riguardo agli strumenti sanitari disponibili ed anche con notevole rischio personale. Non escluso l’impegno posto in essere – altrimenti si sarebbe ingenerosi con chi s’è trovato a dover gestire responsabilità organizzative nei confronti dell’ignoto – pure nell’ambito politico-amministrativo. Così che, in particolare, il criterio di allocazione delle risorse sanitarie è potuto rimanere quello clinico, secondo l’indicazione dello stesso CNB: «ogni altro criterio di selezione, quale ad esempio l’età anagrafica, il sesso, la condizione e il ruolo sociale, l’appartenenza etnica, la disabilità, la responsabilità rispetto a comportamenti che hanno indotto la patologia, i costi, è ritenuto dal Comitato eticamente inaccettabile». Entro il quadro, ovviamente, di strategie complessive intese a garantire l’impiego proficuo più ampio possibile delle risorse sanitarie e sulla base di valutazioni, nel caso concreto, fondate sull’appropriatezza clinica, anche in rapporto alle esigenze di fruizione attuale delle risorse sanitarie: ma pur sempre escludendo «automatismi e scelte aprioristiche nell’accesso ai diversi percorsi di cura» (cfr. il parere Covid-19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del ‘triage in emergenza pandemica’, dell’8 aprile 2020, n. 3). Dovendosi evitare infingimenti, tuttavia, circa il fatto che l’obiettivo di assicurare tutela sanitaria adeguata a tutti i malati di covid-19 che ne avrebbero avuto bisogno, non è stato raggiunto, e non solo rispetto a un numero ridotto di casi sporadici: posto che, come s’è detto, molti di quei malati sono rimasti privi, addirittura, di qualsivoglia supporto sanitario, costituendo, quest’ultima, la sconfitta bioetica più cocente, finora, della vicenda covid-19 in Italia. Che del resto il rimando alla parola magica dei bilanciamenti non abbia consentito, in genere, una reale valorizzazione di tutti gli interessi comunque rilevanti in una data situazione concreta emerge in modo chiaro con riguardo alle normative, più volte evocate nell’intervista in die Zeit, sull’interruzione volontaria della gravidanza. S’è ben visto qual è stato, infatti, il livello reale dell’impegno di aiuto alla donna in termini di «rimozione delle cause» che la condurrebbero all’aborto, così come richiesto, in particolare, dall’art. 5 della l. n. 194/1978: vale a dire circa la prevenzione (primaria) di un fatto che, pure, recide una vita umana e incide pesantemente sul vissuto futuro di una donna. E ciò sebbene l’effettività di tale aiuto rappresenti un’esigenza basilare di valorizzazione della dignità stessa della donna, come efficacemente emerge nel parere su Aiuto alla donna in gravidanza e depressione post partum, approvato sulla base di un’amplissima convergenza pluralistica dal CNB nel dicembre 2005. Sei milioni di aborti legali, in Italia, nel quarantennio post 1978 non costituiscono un dato trascurabile. Né lo diventano in forza del ridursi, da tempo, dei tassi annuali, stante, fra l’altro, il minor numero delle donne in età fertile, ma altresì il diffondersi del ricorso alla pillola del giorno (o dei cinque giorni) dopo: che, a seconda del momento dell’assunzione durante il ciclo femminile, può agire anche impedendo l’annidamento in utero dell’embrione già formato, per cui quest’ultimo, con ciò, perde a priori ogni rilievo, nonostante il rango assegnatogli dalla Corte costituzionale ex art. 2 Cost. (è bastato, per rimuovere il problema, dilazionare la definizione di inizio della gestazione all’avvenuto annidamento). Come, del resto, quel rango si è rarefatto, con riguardo alle argomentazioni della medesima Corte sulla c.d. diagnosi preimpianto, nel mero diritto – davvero invidiabile – degli embrioni generati e poi scartati a essere posti in stato di congelamento, sine die né speranza. Trascurando, oltre a qualche norma non caducata della legge n. 40/2004, i rilievi dello stesso Habermas, che ravvisava già anni orsono nella generazione di embrioni «con riserva», essendosi già programmata la successiva selezione tra gli stessi, una logica di dominio radicale dell’esistenza altrui, antitetica rispetto al principio di uguaglianza (cfr. Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale [2001], trad. it. Torino, 2002).
Anche per quanto concerne le «insicurezze prognostiche» appare necessario distinguere: esse riguardano essenzialmente l’evolversi della patologia covid-19, le strategie mediche finalizzate a curarla e gli studi sperimentali in atto per addivenire a un vaccino efficace nei suoi confronti. Non riguardano invece, se non in modo secondario, le modalità necessarie per limitare il diffondersi del contagio, cioè i provvedimenti dei quali discutiamo in questa sede: posto che tali modalità sono largamente assodate e, laddove poste in essere, hanno dimostrato un’indubbia, ancorché non risolutiva, efficacia. Tanto che il dibattito ha avuto per oggetto, in merito, non l’utilità di quei provvedimenti, ma la loro estensione contenutistica e temporale in rapporto all’andamento della pandemia, vale a dire l’accettabilità di un certo livello del rischio (peraltro non facilmente identificabile) correlato a diverse graduazioni dell’intervento, col fine di non incidere troppo su esigenze di ordine esistenziale, economico e sociale. Quello che era da farsi, salvo deciderne il quantum, risultava piuttosto chiaro, una volta percepita la gamma degli effetti possibili del contagio in assenza di cure sicuramente efficaci e l’estensione del contagio a livello locale e nazionale. E lo stesso criterio cui ispirare gli interventi indiscutibilmente necessari era, e resta, piuttosto chiaro: far sì, cioè, che i tassi di rilevamento del virus indichino un trend di diminuzione del contagio, vale a dire, statisticamente, che il numero dei nuovi contagi non produca un numero eguale o maggiore di ulteriori nuovi contagi e si riduca, poi, in modo progressivo. Il che, inoltre, rende palese l’esigenza di un riferimento nazionale credibile sul piano scientifico, in grado di offrire alla responsabilità politica le informazioni sanitarie – in particolare, epidemiologiche – ineludibili onde operare scelte rispondenti ai criteri summenzionati.
L’informazione sulla pandemia è stata, riterrei, piuttosto capillare. Tanto da lasciar emergere chiaramente gli stessi limiti insiti nei dati disponibili e pubblicizzati: per esempio, con riguardo alla differenza, emersa rapidamente, tra l’aumento massiccio, in certe zone, dei tassi generali di mortalità e il numero, molto minore, dei deceduti dopo essere stati riconosciuti come affetti dal virus SARS-CoV-2. E di simile trasparenza è parte anche la non univocità dei pareri scientifici talora emersa su alcuni aspetti prognostici della pandemia e sulle prospettive del suo contrasto da parte della medicina: meglio un’informazione nitida circa la (riscoperta) non onnipotenza da ascriversi alle risorse scientifiche e circa la fatica dell’ottenere conoscenze affidabili, di un’informazione manipolata, che tolga paternalisticamente all’opinione pubblica, quale ne sia il fine, una percezione realistica e responsabilizzante dei problemi. Chi lo ha voluto, in effetti, un’idea circa lo status quaestionis la si è potuta fare. Piuttosto, ciò che può preoccupare è l’uso di una propria autorevolezza, sul piano politico, per formulare proposte o diffondere messaggi aventi fini (demagogici) diversi da quelli intesi a una gestione responsabile della pandemia, oppure, sul piano scientifico, per intenti di protagonismo suscettibili di minare la fiducia dell’opinione pubblica in una comunità dei competenti armonica, poiché impegnata, pur nel confronto delle opinioni e delle esperienze di ricerca, per il bene di tutti.
Desta, infine, non poca sorpresa la passione neo-garantista circa il ruolo del parlamento che in taluni sembra essersi risvegliata proprio nell’occasione dei provvedimenti adottati dal governo per il contrasto della pandemia: dopo che per anni il ruolo del potere legislativo è stato largamente delegittimato in più sedi, non senza ricorrenti giustificazioni di simile trend anche in quella accademica. Chi scrive ritiene di potersi trovare, in proposito, al di sopra di qualsiasi sospetto, avendo ribadito più volte e pure di recente (valga lo scritto Legalità, non oligarchie: profili penalistici, in disCrimen, 24 giugno 2020) il ruolo non surrogabile del parlamento, e dunque della divisione tra i poteri, nell’ambito dei sistemi democratici. Ma, francamente, quali provvedimenti diversi, nella sostanza, avrebbe dovuto prendere il parlamento rispetto a quelli, pressoché necessitati, adottati dal governo per arginare il diffondersi della pandemia? Si sarebbe dovuto, forse, perdere ancor più tempo a disquisire (visto che già alcuni ritardi iniziali hanno avuto conseguenze tragiche) prima di decidere? E se c’è un ruolo proprio del governo, dal punto di vista costituzionale, non è proprio quello di far fronte – fermo il rispetto della legislazione vigente e dei principi sanciti dalla Costituzione – a esigenze immediate di intervento? È proprio così deteriorato il sistema democratico italiano da non poter emergere, almeno in momenti particolari (come pure è avvenuto in certi momenti gravi della storia del nostro Paese), una solidarietà costituzionale di fondo fra le componenti politiche, pur nella strutturale articolazione delle medesime in forze di maggioranza e di minoranza? Vogliamo ricordare le parole – purché non le si legga a senso unico – rivolte in Portogallo dal capo dell’opposizione (Rui Rio) a quello del governo (Antonio Costa) quando andò inasprendosi la pandemia: «La minaccia che dobbiamo combattere esige unità, solidarietà, senso di responsabilità. Per me, in questo momento, il governo non è l’espressione di un partito avversario, ma la guida dell’intera nazione che tutti abbiamo il dovere di aiutare. Non parliamo più di opposizione, ma di collaborazione. Signor primo ministro, conti sul nostro aiuto. Le auguriamo coraggio, nervi d’acciaio e buona fortuna perché la sua fortuna è la nostra fortuna»? Un approccio che, pare, non sia rimasto affatto ininfluente sull’efficacia delle misure in quel Paese.
Venendo dunque specificamente, in breve, alle domande proposte:
1) In rapporto a quanto s’è detto, pare difficile stabilire parallelismi tra i giudizi di proporzionalità concernenti le misure di contrasto relative al diffondersi del virus SARS-CoV-2 e i giudizi inerenti alla proporzionalità dell’intervento penale in termini di extrema ratio, quale arma a doppio taglio, rispetto alle esigenze di prevenzione delle offese a determinati beni fondamentali.
Da un lato, infatti, l’ambito di efficacia preventiva connessa all’entità delle pene detentive tradizionalmente inflitte risulta assai più incerto rispetto all’ambito di efficacia delle misure anti pandemia covid-19 finora adottate.
Dall’altro lato, la limitazione nell’esercizio dei diritti fondamentali prodotta dalle suddette misure risulta, comunque, di molto inferiore a quella derivante dalla detenzione in carcere (e, per molti aspetti, anche dalla detenzione domiciliare), nonché assai meglio supportabile, per esempio con riguardo agli effetti sulle attività lavorative, attraverso provvedimenti di sostegno economico-sociale.
La gran parte dei diritti non sono stati cancellati, in realtà, dai provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria, ma hanno dovuto ricercare e sperimentare modalità nuove della loro espressione (sul piano del lavoro, dell’istruzione, dell’espressione del pensiero, e così via).
Il problema di fondo, peraltro, è che ci si dovrebbe affrancare dall’idea che la proporzionalità dell’intervento penale vada intesa come riferita a una sorta di rapporto equilibrato (secondo quali parametri?) e, tuttavia, intimidativo – una sorta di ossimoro – tra la gravità del reato e il danno minacciato nei confronti del colpevole: in base a criteri di ‘razionalità’ politico-criminale indimostrati e anzi, per lo più, contraddetti.
La proporzionalità della pena non è da concepirsi nei termini di una deprivazione ritenuta tollerabile (proporzionata) di chance esistenziali rispetto al condannato, bensì in rapporto alla capacità credibile della pena stessa di promuovere pur sempre, secondo le caratteristiche del reato commesso, un’inclusione sociale del colpevole. Così che la pena assuma, fin dal momento della comminazione, un orientamento motivazionale, piuttosto che intimidativo.
Ed è proprio in questo, semmai, che può recuperarsi una corrispondenza tra il concetto di proporzionalità nel contesto penale e in quello delle misure anti covid-19: nel cercare, cioè, di perseguire, insieme, esigenze plurime, non necessariamente antitetiche. Quelle di carattere sociale (contrastare il diffondersi della pandemia – fare verità sul reato, impedire che il medesimo produca profitti, creare condizioni antitetiche rispetto a una possibile recidiva), e quelle attinenti ai diritti individuali (salvaguardare anche in emergenza sanitaria, rimodulandone i modi, le attività in cui quei diritti si esprimono – promuovere l’inclusione sociale del condannato e, con ciò, una ri-valorizzazione nella legalità della sua persona). Entro il quadro, ancora una volta, dell’et-et, piuttosto che dell’aut-aut.
2) Ritengo che le misure anti covid-19 siano state seguite, dai più, perché considerate ragionevoli e necessarie. Del resto, la stessa forza preventiva del sistema penale dipende, già lo si diceva, dalla capacità di motivare a scelte personali. Se si fosse trattato solo di intimidazione, avrebbe inciso in senso antitetico l’estensione inevitabile, tanto più rispetto a quel tipo di misure, della cifra oscura, come pure l’incertezza sulla celebrazione dei processi e sulla stessa punibilità, in concreto, delle trasgressioni.
Certamente il rilievo penale di una certa condotta illecita segnala il particolare disvalore che essa assume in merito al bene tutelato e sul piano delle relazioni sociali, così che tale rilievo può avere, in effetti, una forza particolare di orientamento dei comportamenti. Ma ciò deriva essenzialmente dal rango assegnato, anche nel sentire comune, all’illecito penale, il quale implica – secondo l’indicazione dell’art. 27, co. 3, Cost. – l’appello a una più o meno marcata revisione, nel suo autore, dello stile di vita (aspetto, questo, mancante nell’illecito amministrativo). Così come deriva, altresì, dalla competenza assegnata, per gli illeciti penali, all’autorità giudiziaria.
Non si tratta dunque, anche sotto questo profilo, di entità delle pene: in quanto la funzione prioritaria dei procedimenti penali, lo si richiamava in precedenza, è quella di fare verità – circa i fatti illeciti accaduti – per migliorare, vale a dire per creare condizioni (non solo rispetto al soggetto agente, ma anche con riguardo, per esempio, alla prevenzione primaria) onde far sì che qualcosa di simile non torni a verificarsi nel futuro. Il processo penale, ribadirei, non serve per condannare: è la stessa condanna, piuttosto, che deve risultare funzionale all’intento migliorativo (laddove, invece, la condanna finisce sovente per costituire il pretesto simbolico – si pensi ancora, in genere, ai reati colposi di evento – per lasciare le cose come stanno).
Semmai, si tratterebbe di riflettere, con riguardo alla pandemia, circa l’esigenza di poter assumere provvedimenti immediati che incidano hic et nunc sulla libertà di movimento di chi, in modo irresponsabile, crei le condizioni, risultando malato, per il prodursi di nuovi focolai del contagio. Purché venga assicurata, in questi casi, una presa in carico non fittizia delle condizioni di salute del soggetto coinvolto: stante, lo ricordo nuovamente, il gran numero delle persone che nei mesi passati sono state confinate fiduciariamente in casa, o in determinate residenze comunitarie, e poi, di fatto, abbandonate a sé stesse.
3) Quanto è da ritenersi essenziale rispetto a fatti lesivi di beni fondamentali dovrebbe essere una reale volontà di prevenzione degli stessi, al di là degli strumenti utilizzati. Per cui, in effetti, non può muoversi dall’assunto che la minaccia edittale di una pena detentiva sortisca in modo automatico, e per qualsiasi forma di offesa verso un certo bene, i risultati migliori sul piano preventivo.
Si tratterà dunque di definire anzitutto, a tal proposito, una strategia politico-criminale complessiva, che deve muovere dalla prevenzione primaria. Tenendo presente, poi, che gli stessi strumenti sanzionatori utilizzabili nei confronti delle condotte offensive possono essere diversi dal ricorso al carcere, siano essi gestiti sul piano amministrativo o su quello penale: rilievo, quest’ultimo, il quale lascia emergere un limite storico, che prima o poi dovrà ben superarsi, del diritto penale italiano, ancor oggi carcerocentrico.
Tuttavia, deve realisticamente segnalarsi che, non di rado, la rinuncia all’uso pregresso del diritto penale quale strumento di prevenzione non si è accompagnata a una solida assunzione dell’impegno preventivo attraverso altri mezzi, come pure richiedeva, nel 1975, la richiamata sentenza del Bundesverfassungsgericht sull’aborto: così che simili evoluzioni normative, non solo in quel settore, hanno operato, o comunque sono state percepite, come passaggio di fatto legittimante, al di là delle affermazioni di principio, una rinuncia alla prevenzione tout court, o per lo meno uno scarso interesse rispetto alla medesima.
Ciò a parte, non riterrei che (nuovi) obblighi di penalizzazione fatti valere sul piano sovranazionale e sulla base di fonti normative, a loro volta, sovranazionali, possano essere intesi come obblighi indiscutibili di ricorso, nell’ordinamento italiano, al diritto penale, se non addirittura alla deterrenza detentiva, invece che come obblighi di protezione effettiva di determinati beni o diritti. Posto che il ruolo della libertà personale non può essere estromesso dal novero dei beni fondamentalissimi di rango costituzionale, rilevanti perfino sul piano dei c.d. contro-limiti. E che, secondo la Costituzione, l’intervento restrittivo, per ragioni penali, circa il rilievo di quei beni nei confronti del cittadino è affidato al legislatore, cioè a una fonte parlamentare la quale non informa, o lo fa solo parzialmente, le realtà sovranazionali.
Come non riterrei che delicatissime, e comunque sempre discutibili, ponderazioni che s’intendessero effettuare rispetto al bene stesso consistente nella vita umana siano da presidiarsi attraverso norme penali (si ricordi S. Canestrari, Principi di biodiritto penale, Bologna, 2015, sui temi del fine vita: «anche i giuristi dovrebbero avvertire la responsabilità di non alimentare una ‘contrapposizione agonistica’ – con le ‘armi pesanti’ del diritto penale – tra medico e paziente»).
Fuori dall’ambito di simili ponderazioni, deve semmai ammettersi che fin quando un diritto penale esista, a presidio di esigenze comportamentali valutate come irrinunciabili sul piano sociale, appare difficile escludere ex ante determinate condotte lesive di beni fondamentalissimi dalla sfera della rilevanza penalistica: sebbene non sia detto, come sopra si osservava, che ciò debba implicare il ricorso alla pena detentiva (l’extrema ratio non attiene tanto al diritto penale, ma all’utilizzo di tale forma sanzionatoria, che, comunque, non è da considerarsi automaticamente come la più efficace).
In questo quadro, peraltro, proprio il ruolo da riconoscersi alla tutela della vita umana manifesta un’insuperabile peculiarità. Quella tutela, infatti, costituisce presupposto cardine del principio di uguaglianza, vale a dire della democrazia. Poiché ogni flessibilizzazione di simile tutela finisce per implicare un giudizio sulle condizioni o sulle qualità di una data esistenza umana, fra l’altro recidendo la possibilità stessa di espressione dell’autonomia personale, di cui la vita costituisce presupposto. Con Habermas: «Il nucleo contenutistico della tutela della vita, sulla base del carattere individualistico del nostro ordinamento giuridico, non ha un effetto impeditivo di ogni arretramento, che gli altri diritti fondamentali non hanno?».
A conclusione. La pandemia, è probabile, ci accompagnerà per non poco tempo nel mondo, obbligando a riorganizzare secondo criteri di prudenza le modalità relazionali al pari delle attività economiche, e a provvedere affinché ci si trovi in grado di isolare, sul piano socio-sanitario, i focolai di contagio. Essa ha lasciato percepire a molti che la caducità della vita non è confinabile in una sua fase estrema, ma l’accompagna, con ciò segnalandone anche la preziosità. Una percezione, questa, familiare a molti poveri del mondo, e meno sperimentata dai benestanti. Ci si aspetta, dunque, il vaccino, perché tutto torni come prima. Così potrà dirsi che tutto è andato bene, dimenticando come la storia la scrivano sempre i sopravvissuti. No, non è andato tutto bene. E nel mondo non va tutto bene. Questa stessa pandemia sarebbe stata arginata meglio se il mondo non fosse dilaniato da contrapposizioni ormai sempre più estranee alla coscienza dei popoli, specie delle generazioni più giovani. Se le risorse per la vita non fossero dilapidate nella produzione delle armi. Se l’eguaglianza di principio dei diritti si fosse già trasformata nella cura del diritto di vivere, per tutti. Sarà benvenuto il vaccino. Ma sarebbe una sconfitta non cogliere il campanello d’allarme che questa pandemia ha suonato. Poiché quanto oggi, nel mondo, non va bene, può condurre, pur senza pandemie, alla distruzione dell’umanità: niente di meno. Il che impone anche ai giuristi di ergersi al di sopra della gestione tecnica, e remunerativa, dei contenziosi ordinari per tornare a svolgere una funzione culturale: quella di segnalare, essenzialmente, l’esigenza di voltare pagina, nel mondo e sul piano intersoggettivo, rispetto a logiche relazionali fondate sul conflitto. Ed è qui che si apre la vera sfida di una riprogettazione dei rapporti sociali e internazionali per gli stessi parlamenti, al di là delle disquisizioni minute sulle competenze circa l’adozione delle misure urgenti in tema di pandemia. Temo, infatti che l’alternativa sia severa: o si saprà urgentemente por mano a costruire una nozione globale della democrazia, o il futuro, alle generazioni che verranno, potrebbe essere sottratto.
7. Domenico Pulitanò. L’esperienza della pandemia e i problemi del penale
7.1 L’esperienza della pandemia e del lock down
La pandemia Covid-19, e le misure adottate in Italia e altrove per contrastarla, hanno posto problemi inquietanti, relativi al bilanciamento di beni fondamentali del singolo (vita, salute, libertà) e della comunità, con sacrificio di alcuni a favore di altri. Sono problemi che interpellano anche il diritto penale, arma a doppio taglio, finalizzata alla tutela di beni importanti e fattore di rischio per le libertà. Opportuna, dunque, la sollecitazione venuta da giustiziainsieme: ragionare sulle condizioni dell’osservanza di restrizioni pervasive, fino al lock down; su come il diritto possa e debba farsi carico dei problemi relativi al “generale rischio di vita”, nel bilanciamento con altri diritti (libertà e dignità), in condizioni di incertezza cognitiva o prognostica.
La pandemia è uno stato d’emergenza (purtroppo) reale, non uno stato d’eccezione stabilito dall’arbitrio soggettivo di un sovrano che proclama la sospensione della legge ordinaria. In tutto il mondo la pandemia di quest’anno 2020 ha distrutto vite, ha portato a restrizioni di libertà, ha messo in crisi l'economia. La potenza nascosta dell’invisibile virus ha sconvolto le cose umane, si è fatta gioco del potere dei reggitori delle società. “Usque adeo res humanas vis abdita quaedam / obterit, et pulchros fascis saevasquae secures / proculcare ac ludibrio sibi habere videtur” (Lucrezio, De rerum natura, V, v. 1233s).
Da metà marzo abbiamo vissuto per molte settimane in uno scenario di sospensione generalizzata e prolungata della normalità sociale, imposta da precetti che in situazioni non emergenziali rifiuteremmo come liberticidi. Restrizioni di diritti di libertà in senso forte: non solo la libertà di circolazione, direttamente bloccata, ma anche diritti e libertà che il blocco impedisce di esercitare. Le regole restrittive sono state via via attenuate, alcune restano ancora nei giorni in cui sto scrivendo (fine giugno).
7.2 La dimensione costituzionale
Sullo sfondo della vicenda Covid-19, la Presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, nella relazione sull’attività nel 2019 presentata il 28 aprile 2020, ha osservato che la Costituzione non prevede un diritto speciale dell’emergenza, non la sospensione di diritti fondamentali; è però non insensibile al variare delle contingenze, all’eventualità che dirompano situazioni di crisi o di straordinaria necessità e urgenza, per le quali è pensato come strumento il decreto legge (art. 77). “Necessità, proporzionalità, ragionevolezza, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui deve attuarsi la tutela sistemica e non frazionata dei principi e dei diritti fondamentali, ponderando la tutela di ciascuno con i relativi limiti, in base alle specifiche contingenze. È la Costituzione la bussola necessaria a navigare ‘per l’alto mare aperto” dell’emergenza e del dopo-emergenza che ci attende”.
L’emergenza sanitaria ha posto la politica di fronte alla responsabilità di scelte tragiche. Le necessità di contenimento del contagio (tutela della vita e della salute) sono state ritenute idonee a giustificare, nel bilanciamento con le libertà, restrizioni di libertà eccezionalmente spinte, ma razionali rispetto allo scopo di preminente importanza. Il principio di giustiziabilità esige la possibilità di un controllo giurisdizionale, in sede di giustizia ordinaria o costituzionale.
Più la compressione di diritti è severa, più è necessario che sia circoscritta nel tempo[2]: il criterio della temporaneità ci dice che la compressione emergenziale di diritti dovrebbe essere rivedibile in ogni momento alla luce dei fatti e di esigenze mutate. La responsabilità di valutazione e decisione, che è propria della politica in via normale, in situazioni non normali è più forte.
In questo contesto si pone il problema delle basi cognitive delle valutazioni e decisioni: incertezza e incompletezza delle conoscenze a disposizione, e conseguenti insicurezze prognostiche. Valutare e decidere in condizioni d’incertezza è condizione normale della politica. Le pretese e i principi giuridici che chiedono certezze in diritto e in fatto (legalità/determinatezza; accertamento al di là del ragionevole dubbio) debbono fare i conti con la realtà. Con i limiti delle nostre conoscenze, di ciò che sappiamo progettare, di ciò che sappiamo tradurre in norme e in concreti comportamenti.
7.3 Obblighi costituzionali di penalizzazione?
Nella discussione fra Habermas e Gunther, alla quale fa riferimento la sollecitazione venuta da Giustizia Insieme, è stata richiamata la storica sentenza del Bundesverfassungsgericht del 1975, che ha posto limiti alla depenalizzazione dell’aborto e ha suscitato il dibattito su obblighi giuridici di tutela anche penale della vita umana. Anche per la riflessione in Italia quella sentenza è stata un riferimento importante. La strada imboccata dalla nostra Corte costituzionale è stata diversa[3].
Quando in Italia, sul finire degli anni ’70, sono state introdotte riforme legislative orientate verso modelli di disciplina non più integralmente né principalmente penalistici, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale in malam partem, volte a riespandere l’area dell’illecito penale in nome della tutela di beni giuridici costituzionali. Le censure si sono appuntate sul ritrarsi dell’intervento penale: dalla rilevanza costituzionale di dati beni (la salute e l’ambiente, la vita del feto) è stato argomentato un obbligo di principio di tutela penale di quei beni, o quanto meno l’illegittimità del sopprimere una tutela penale già esistente.
La Corte costituzionale italiana, con giurisprudenza costante, ritiene inammissibili le questioni di legittimità costituzionale volte alla creazione o all’ampliamento di fattispecie di reato. Il principio di legalità dei reati e delle pene (art. 25 Cost.) comporta l’impossibilità per la Corte di “pronunciare alcuna decisione, dalla quale derivi la creazione – esclusivamente riservata al legislatore – di una nuova fattispecie penale”[4]. “Solo il legislatore può, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonché stabilire qualità e quantità delle relative pene edittali”[5].
Dietro la soluzione processuale dell’inammissibilità affiora una ragione più sostanziale: di fronte a problemi di tutela il penale non è una risposta obbligata[6]. È una risposta possibile, di fatto può essere necessaria, per esigenze di tutela di beni importanti.
Un obbligo di penalizzazione è espressamente previsto nella Costituzione italiana: “è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” (art. 13, 4° comma). Condizioni e limiti costituzionali sono posti alla previsione di cause di non punibilità (sentenza n. 148 del 1983). Nella giurisprudenza della nostra Corte costituzionale il rispetto per scelte legislative di tutela penale viene in rilievo anche in delimitazioni della portata della dichiarazione d’illegittimità costituzionale parziale di fattispecie di reato (vedi sentenza sull’aiuto al suicidio, n. 242 del 2019) o di istituti del sistema sanzionatorio (vedi sentenza n. 352 del 2019 sull’art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario). Non si tratta di confini rigidi: non sono precluse future scelte legislative meno penalizzanti.
Obblighi di penalizzazione sono previsti dalla normativa europea. Nella giurisprudenza della Corte EDU sono affermati a difesa di diritti della persona, contro usi arbitrari di poteri dell’autorità. In quest’ottica sono stati valutati come scommessa sulla funzione espressivo-simbolica del diritto penale”[7] messa in crisi da scelte arbitrarie di non punibilità o da carenze d’attivazione della giustizia penale.
Come risposta a problemi di sicurezza del convivere e dei diritti delle persone, il diritto criminale/penale è un’opzione possibile, talora necessaria, sempre problematica nei modi. Un azzeramento non è pensabile. La tutela della vita da aggressioni dolose (non uccidere) è un nucleo irriducibile.
Ai suoi compiti di tutela, il Leviatano in versione liberaldemocratica può provvedere, ed è bene che provveda, innanzi tutto con altri mezzi, meno invasivi del penale. Diritto penale minimo è un’idea regolativa, non un principio in senso forte. Per le democrazie liberali, un’idea regolativa importante per le politiche del diritto penale.
7.4 Limiti del penale e rapporto giustizia/politica
Nelle riflessioni sulla ripresa dopo l’emergenza acuta, è stato segnalato da un autorevole politologo il problema del panpenalismo, “la debordante e soffocante presenza del diritto penale in tutti gli ambiti della vita sociale ed economica, a sua volta riflesso della peculiare posizione di forza assunta dalla magistratura inquirente in Italia”[8].
È una presa di posizione politica, ovviamente discutibile, da me condivisa: alla politica deve essere riconosciuto uno spazio non sottoposto a scrutinio diverso da quello culturale e politico, nella sfera pubblica (luogo centrale nella filosofia politica di Habermas). La macchina del law enforcemewnt penalistico non dovrebbe diventare un fattore di rischio e di turbamento per l’esercizio dei diritti dei consociati o di funzioni di governo politico.
Per una riflessione su diritto penale e situazioni d’emergenza è di particolare interesse l’indagine aperta dalla Procura di Bergamo sul ritardo nella costituzione di una zona rossa nei comuni della Val Seriana. “Il governo si difende davanti al pm”, è il titolo di prima pagina del Corriere della sera, 13 giugno 2020. Sono stati sentiti, come persone informate sui fatti, il Presidente del Consiglio e alcuni ministri. Nella discussione mediatica è stato sollevato il problema, se l’indagine giudiziaria penale possa avere ad oggetto valutazioni e decisioni di tale rilevanza politica. È stato inquadrato in un’ottica politica, senza andare a fondo dei problemi giuridici.
Sul piano penalistico, al confine con la politica si colloca la disciplina dei reati ministeriali, agganciata ai criteri della legge costituzionale n. 1 del 1989. Compete all’organo politico (Camera o Senato) debitamente investito dall’autorità giudiziaria, l’eventuale diniego dell’autorizzazione a procedere, con valutazione insindacabile, “ove reputi che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nella funzione di governo” (art. 9).
Il confine della legalità penale è tracciato in via generale dai normali criteri di attribuzione/delimitazione di responsabilità. Di particolare rilievo il tema della colpa, un tipo di responsabilità che nel campo del diritto penale hard (responsabilità per delitto) dovrebbe essere un’eccezione rigorosamente delimitata. La tutela della vita e dell’integrità fisica è il campo principale di applicazione. L’esperienza della pandemia ha mostrato la centralità del problema della colpa, quando si è posto il problema delle eventuali responsabilità e dei limiti di responsabilità di operatori chiamati ad agire in situazioni particolarmente esposte, nelle quali sono morte molte persone. Si sono contrapposte esigenze di responsabilizzazione ed esigenze che sono state formulate come richieste di scudo. La conciliazione dovrebbe essere cercata in criteri di ragionevole delimitazione di principio della responsabilità, avendo riguardo a condizioni di fatto che restringono il campo di ciò che è esigibile.
La penalizzazione della colpa mette in campo logiche difensive che portano al non riconoscimento di errori compiuti, dell’aver sbagliato che “comunque accompagna, in modo più o meno rilevante, l’esistenza di ciascuno”[9]. Anche l’incidenza deformante sul discorso pubblico è una ragione che invita alla massima cautela nell’imboccare la strada del penale.
Problemi non solo di garanzia, ma anche di opportunità, riguardano non solo la giustizia degli esiti, ma l’attivarsi della macchina fin dall’inizio: i presupposti dell’apertura di indagini, e l’esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà non è un via libera per iniziative ad explorandum. Di fatto, i presupposti dell’obbligo sono affidati alla valutazione del PM (alla posizione di forza delle Procure) in assenza di controlli sulla sussistenza di una notizia di reato che fondi in concreto l’obbligo di verifica. La messa in moto della macchina giudiziaria, in condizioni d’incertezza, comporta costi e rischi certi; l’esito di giustizia è incerto.
La questione dei filtri processuali è presente nel disegno di legge delega n. 2435, presentata alla Camera il 13 marzo 2020. Per la tenuta dei diritti, tutti i problemi di filtro e di controllo sulla macchina investigativa e processuale meritano la massima attenzione. Indipendentemente dal merito delle singole iniziative, il trasferimento in sede giudiziaria di problemi di portata generale comporta il rischio di espansioni panpenalistiche sul terreno delle responsabilità politiche, o semplicemente su quello delle libertà delle persone coinvolte. Nel contesto difficile della post emergenza, un problema che sarebbe bene prevenire.
Sul piano della responsabilità politica, il problema si presenta in termini più generali, rispetto a una pluralità di interessi da soddisfare e da bilanciare, in situazioni d’incertezza fattuale e prognostica: scelte tragiche, nel senso letterale del termine, che comportano comunque il sacrificio di interessi importanti, anzi di diritti fondamentali. È in gioco la salute pubblica, la vita delle persone. Ha avuto eco anche in Italia l’intervista di Wolfgang Schauble, Presidente del Bundestag, che ha affermato la priorità della intoccabile (unantastbar: §. 1 della Costituzione tedesca) dignità della persona: sarebbe sbagliato subordinare tutto alla salvaguardia della vita umana.
In un editoriale ne Il foglio, 29 aprile, Giuliano Ferrara ha contrapposto a questa “sortita di un grande tedesco in vene di verità difficile” la scelta italiana: “abbiamo scelto per ora, con tentennamenti, retropensieri luterani, remore da etica capitalistica dispiegata, di non osare la grande scrematura di vecchi e malati, pagando un prezzo notevole per esclusive ragioni di pietà, di grazia e di amore che sono superiori a quelle della dignità”.
Vita, libertà, dignità, sono diritti delle persone. La critica politica (da me condivisa) alla posizione espressa da Schauble non può disconoscere le ragioni di chi ponga l’accento sulla dignità e sulle libertà.
Le scelte su ambiti, modi, tempi di restrizioni emergenziali di libertà (fino alla costituzione di zone rosse) sono scelte politiche particolarmente delicate. Abbisognano di solidi presupposti cognitivi, ma che spesso debbono essere prese in condizioni d’incertezza cognitiva e/o prognostica. Comportano valutazioni discrezionali, in ragione degli interessi coinvolti e di previsioni sui diversi possibili scenari.
Il carattere spiccatamente problematico delle scelte, sia con riguardo alle premesse cognitive sia con riguardo ai bilanciamenti d’interessi, è (mi pare) un argomento contro la trasposizione del problema sul terreno del diritto penale, e conseguentemente della giustizia penale. L’idea che restrizioni spinte delle normali libertà, sia pure a protezione dal contagio, possano essere valutate sul piano penalistico come un dovere imposto ai governanti da regole cautelari, mi sembra pericolosa per gli equilibri di una società aperta. Di fatto, le democrazie liberali della nostra Europa hanno dato, di fronte alla pandemia, risposte diverse.
7.5 Condizioni dell’osservanza. Doveri di solidarietà.
L’esperienza del lock down ha mostrato un soddisfacente livello di osservanza di precetti che in situazioni non emergenziali rifiuteremmo come liberticidi; decisamente contenuti i tassi di disobbedienza. Segno di efficacia generalpreventiva delle normative d’emergenza? Di paure legate alla presa di coscienza del rischio pandemico? O di altre ragioni, o di un mix di ragioni diverse? Sulle ragioni dell’ampia osservanza di restrizioni pesanti torneranno a indagare e a ragionare gli storici.
Una valutazione radicalmente negativa sull’acquiescenza a misure straordinariamente restrittive è stata formulata da un noto filosofo: “Com’è potuto avvenire che un intero paese sia senza accorgersene eticamente e politicamente crollato di fronte a una malattia? ……. Abbiamo accettato senza farci troppi problemi, soltanto in nome di un rischio che non era possibile precisare, di limitare in misura che non era mai avvenuta prima nella storia del paese, nemmeno durante le due guerre mondiali, la nostra libertà di movimento …. i nostri rapporti di amicizia e di amore, perché il nostro prossimo era diventato una possibile fonte di contagio” (G. Agamben, Una domanda, in Quodlibet, 14 aprile 2020).
La domanda di Agamben merita considerazione, come provocazione a riflettere sul senso morale e politico dell’osservanza che ci è stata chiesta e che abbiamo accettato, sulla sospensione di libertà fondamentali.
La valutazione prevalente, da me condivisa, è del tutto opposta alla censura di crollo morale. Nell’osservanza delle restrizioni è leggibile la moralità di un sacrificio molto pesante, nell’interesse proprio e degli altri con cui conviviamo.
Nella duplice emergenza della pandemia e del lock down è apparso evidente che il contenimento del contagio e la tenuta della società (della convivenza) sono legati al positivo adempimento di doveri. Assunzioni di responsabilità delle istituzioni politiche, e osservanza dei doveri da parte di tutti: doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.)[10]. Per l’esercizio dei nostri diritti – inviolabili in via di principio, ma fragili di fronte a forze di varia natura – abbiamo bisogno della solidarietà, dell’osservanza di doveri reciproci.
Vengono in rilievo doveri generali gravanti su tutti, e doveri di adempimento di funzioni e di compiti di varia natura, da posizioni di garanzia di livello elevato (dirigenti ed operatori amministrativi, medici, infermieri) fino a compiti umili ma necessari. Nell’emergenza sanitaria possono avere una contingente ragion d’essere anche doveri che comportano restrizioni di normali libertà.
Per quanto concerne i problemi del penale, l’indicazione che può essere letta nell’esperienza della crisi è la preminente importanza della dimensione precettiva e dell’osservanza. Le parole d’ordine del garantismo liberale, così gratificanti per la nostra cultura, presuppongono un sistema precettivo che comporta limitazioni di libertà. Condizione minima della con-vivenza (il minimo etico) è l’osservanza dei divieti che costituiscono il nucleo duro del diritto criminale (articolazioni del decalogo biblico: non uccidere, non rubare, non ingannare).
Situazioni di crisi richiedono adempimenti più impegnativi, adempimenti di doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Nella gestione dell’emergenza, sanzionare i trasgressori delle normative speciali dell’emergenza è questione sostanzialmente irrilevante; può essere rimandata a tempi futuri, nei quali forse ci apparirà di scarso interesse.
Quando il lock down è stato allentato, la discussione in Italia si è appuntata su punti specifici della normativa sulla fase 2, criticati, talora irrisi per scarsa chiarezza (difetto di tassatività, nel gergo penalistico) o dubbia ragionevolezza del confine fra ciò che viene permesso e ciò che resta vietato. Chi sono i congiunti con cui si può incontrare? Perché non gli amici? La perdurante esigenza di cautele sanitarie può giustificare una delimitazione quantitativa dei contatti e degli spostamenti, ma non legittima l’autorità pubblica a decidere, sostituendosi alla libertà di ciascuno di noi, quali contatti personali siano preferibili.
Differenziare fra i possibili contatti personali, secondo criteri che non hanno alcun legame con questioni di sanità, ha mostrato un difetto grave di sensibilità liberale, un’impostazione non rispettosa della libertà e dignità personale, censurabile sul piano della legittimità costituzionale alla luce dei principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza.
La custodia dei principi liberali, cui ci siamo impegnati contro politiche centrate sul più penale, richiede la massima attenzione contro rischi di ‘normalizzazione’ di soluzioni emergenziali di compressione di diritti. Anche di questo ci ammonisce l’esperienza della pandemia e del lock down. “Un punto ci inquieta per il futuro. L’ideologia del controllo totale. L’allegra facilità nel rinunciare ad importanti libertà come prezzo da pagare al nuovo feticismo della sicurezza”[11]. La questione su cui continuare a interrogarci riguarda l’insieme dei diritti fondamentali, vita, libertà, dignità.
[1] C. Roxin, L. Greco, Strafrecht, AT, Bd. I, München, Beck, 2020, § 15/91 e amplius 15/84 ss., con tutti i riferimenti essenziali. I filosofi tedeschi che ragionano in astratto di diritti e valori dovrebbero confrontarsi con tali problemi concreti del loro ordinamento.
[2] Intervista alla Presidente Cartabia, Corriere della sera, 29 aprile.
[3] Anche in materia d’interruzione della gravidanza, cfr. Corte cost. n. 27/1975, che ha inciso sulla penalizzazione a tutto campo, aprendo la possibilità di aborto terapeutico. Cfr. anche Corte cost. n. 35 del 1997.
[4] Corte cost. n. 108 del 1981, con nota di M. Branca, Norme penali di favore: dall’irrilevanza al rifiuto della sentenza-legge in Giur. cost., 1981, I, p. 913 s.
[5] Così Corte cost. n. 447 del 1998, sulla riforma del 1997 dell’abuso d’ufficio, dove si ritrova una più ampia motivazione di un indirizzo consolidato e stabile. In epoca più recente Corte cost. n. 161 del 2005 (sulla riforma del reato di false comunicazioni sociali).
[6] È la tesi che ho sostenuto in D. Pulitanò, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 484 s.
[7] F. Viganò, L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, in Studi Romano, p. 2643 s. (citazione da p. 2688).
[8] Angelo Panebianco, La ripresa e i suoi avversari”, in Corriere della sera, 15 aprile 2020 .
[9] L. Eusebi, Legalità, non oligarchie: profili penalistici, in DisCrimen, in corso di pubblicazione in Jus n. 1/2020.
[10] Ha sottolineato questo aspetto G. De Francesco, Dimensione giuridica ed implicazioni sociali nel quadro della vicenda epidemia, in Legislazione penale, 23 aprile 2020.
[11] P. Borgna, 25 aprile e stato d’eccezione, in Questione giustizia, 24 aprile 2020.

Per installare questa Web App sul tuo iPhone/iPad premi l'icona.
