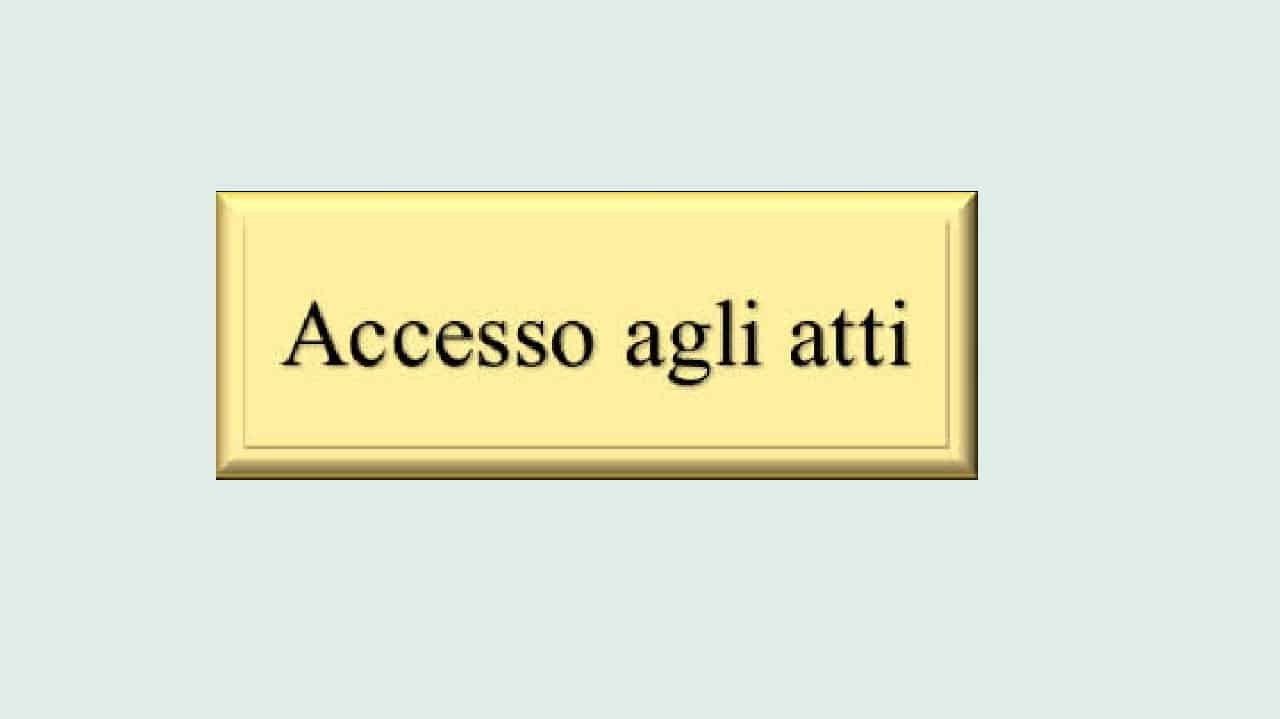I nominativi dei sottoscrittori di una petizione (nota a TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 11 ottobre 2024, n. 329).
di Ippolito Piazza
Sommario: 1. Una sentenza «inquietante»? – 2. Le ragioni favorevoli all’accesso nella pronuncia del TAR. – 3. I nominativi dei firmatari tra pubblicità e tutela dei dati personali. – 4. Strumentalità e limiti dell’accesso difensivo.
1. Una sentenza «inquietante»?
È possibile conoscere i nomi dei firmatari di una petizione rivolta a un consiglio regionale? La risposta sembrerebbe scontata, dal momento che chi firma una petizione si espone personalmente a sostegno di una causa, che proprio dalla somma delle sottoscrizioni individuali trae la propria forza. Quando però a chiedere la lista dei sottoscrittori è un’impresa che prospetta azioni legali nei loro confronti può sorgere qualche dubbio.
Ha destato infatti un certo clamore la decisione del TAR Friuli che ha concesso a un’impresa l’accesso ai nominativi dei firmatari di una petizione indirizzata al Consiglio regionale e rivolta a contestare la costruzione di un nuovo stabilimento siderurgico. È facile intuire quanto sia rischiosa, per il funzionamento di questo istituto di partecipazione popolare, la consapevolezza che la sottoscrizione possa esporre il cittadino firmatario a future azioni giudiziarie.
Un’analisi distaccata della sentenza richiede, però, di guardare alle norme e alle posizioni soggettive fatte valere in giudizio, per inquadrare correttamente la pronuncia e capire se davvero la si possa definire “inquietante”[1]. L’occasione è certamente utile perché un caso tanto singolare permette di riflettere sui limiti del diritto di accesso e, in particolare, del c.d. accesso difensivo.
Per maggiore chiarezza, occorre prima di tutto riassumere la vicenda, che ruota attorno alla ipotesi di costruzione di una acciaieria in una zona industriale che si affaccia sulla laguna di Grado. A fronte di una iniziale apertura alla realizzazione del progetto, la Giunta regionale friulana aveva ritenuto a settembre del 2023 di non darvi più corso, volendo prediligere altri tipi di investimento nell’area. Il progetto di acciaieria era stato nel frattempo avversato da alcuni Comuni del territorio e da comitati di cittadini contrari alla costruzione. Nell’ambito di queste proteste si era inserita anche una petizione (“Petizione contro l’acciaieria”), presentata nel luglio del 2023 al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e sottoscritta da più di ventimila cittadini.
L’impresa che in qualità di appaltatrice avrebbe dovuto realizzare l’impianto ha proposto quindi istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, allo stesso Consiglio regionale per conoscere la lista dei sottoscrittori della petizione, ritenendo di aver subìto un danno dalla stessa, non solo perché alla petizione è almeno in parte imputata l’interruzione del progetto ma anche per il suo contenuto potenzialmente diffamatorio. L’istanza è stata respinta dal segretario regionale del Consiglio sulla base di due ragioni: in primo luogo, i documenti richiesti rientrano in un procedimento (l’iter delle petizioni presentate al Consiglio regionale) che non è destinato a concludersi con un provvedimento amministrativo e dunque esulerebbero dall’ambito applicativo del diritto di accesso; in secondo luogo, ragioni di riservatezza impedirebbero di rivelare i dati personali dei sottoscrittori della petizione.
La motivazione della sentenza è incentrata su due punti: il regime di pubblicità dei dati di chi sottoscriva una petizione e la strumentalità di questi dati rispetto alla tutela degli interessi giuridici dell’impresa che richiede l’accesso. Si tratta di aspetti logicamente consequenziali: se infatti i nominativi richiesti fossero di per sé pubblici, non ci sarebbe bisogno di sindacare la legittimazione dell’impresa a domandarli. Nel commento ci soffermeremo su entrambi, per capire quanto sia condivisibile la soluzione data dal TAR e, più in generale, per capire se possa trovarsi un equilibrio ragionevole tra l’esigenza di conoscenza e quella di riservatezza.
2. Le ragioni favorevoli all’accesso nella pronuncia del TAR.
Come detto, il Consiglio regionale ha fondato il diniego all’accesso anzitutto sulla natura non amministrativa del documento richiesto. Si tratta tuttavia di un argomento debole, che comprensibilmente il TAR non condivide. La legge n. 241 del 1990 dà infatti una definizione molto ampia di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, comprendendovi «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale» (art. 22, c. 1, lett. d)[2].
Per essere accessibile, dunque, il documento non deve necessariamente rientrare in un procedimento amministrativo: ciò che conta è invece che esso sia “detenuto” da una pubblica amministrazione, quale certamente è il Consiglio regionale, e che concerna attività di pubblico interesse. Non sembra quindi rilevante, per escludere le petizioni dall’ambito dell’accesso, che il procedimento non sia destinato a concludersi con un provvedimento amministrativo ma con l’esame della petizione da parte del Consiglio regionale. Da questo punto di vista, è istruttiva l’esperienza dell’ordinamento dell’Unione europea, nel quale – anche in ragione della distinzione non sempre netta tra funzioni esecutive e legislative[3] – il diritto di accesso è esercitato sia nei confronti dei documenti amministrativi, sia nei confronti di quelli in senso lato “legislativi”[4], che sono addirittura sottoposti a un regime di pubblicità rafforzato[5].
Stabilito che le petizioni rivolte al Consiglio regionale sono soggette alla normativa sul diritto di accesso, diviene allora decisivo capire se siano conoscibili i nomi dei sottoscrittori e, pertanto, quale sia il regime di pubblicità di questi dati. Qui sta uno dei profili di interesse della pronuncia.
Ad avviso del TAR l’elenco dei sottoscrittori è un documento pubblico «per la sua intrinseca natura». Ciò per due motivi: il primo riguarda il fatto che le petizioni, essendo dirette a «promuovere o sollecitare interventi “concernenti comuni necessità” o per la “soluzione di problemi di interesse della collettività regionale”», attengono alle funzioni di indirizzo e controllo politico del Consiglio regionale e «all’attività e ai processi decisionali dell’amministrazione», che sono «in toto governati dai principi di pubblicità e trasparenza dei relativi atti».
Vi è poi un motivo sostanziale che spinge verso la pubblicità dei nomi dei sottoscrittori: secondo il TAR, l’obiettivo delle petizioni è quello di «influenzare e arricchire il processo decisionale pubblico attraverso richieste e proposte che traggono la loro legittimazione proprio dai soggetti che le supportano». Prosegue il TAR affermando che è «la stessa indicazione dei sottoscrittori, non solo nel loro numero, ma anche nella loro precisa individualità – quali soggetti portatori di specifici interessi, conoscenze responsabilità – che conferisce “forza” persuasiva alla petizione e, in definitiva, ne connota i tratti». Dal punto di vista dei sottoscrittori, la firma della petizione comporterebbe dunque l’accettazione, «seppur implicitamente e in ragione della natura dell’atto che controfirmano», della pubblicazione del proprio nominativo.
I sottoscrittori rinuncerebbero cioè alla protezione dei dati personali rendendoli «manifestamente pubblici», circostanza che determina la liceità del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. e) del GDPR[6].
Nella tesi del TAR, i sottoscrittori della petizione si troverebbero in una situazione analoga a quella degli autori di un esposto alla pubblica amministrazione[7], per i quali non esisterebbe un diritto all’anonimato: il principio di trasparenza consente infatti all’interessato di conoscere l’intero contenuto delle segnalazioni di cui è stato oggetto, inclusi i nomi dei segnalanti e fatta eccezione per le sole ipotesi in cui da tale conoscenza possano sorgere «azioni discriminatorie o indebite pressioni»[8].
In effetti, si riscontravano in passato due orientamenti nella giurisprudenza amministrativa: l’uno, favorevole alle ragioni della trasparenza, riteneva accessibile il nome del segnalante, che si “espone” nei confronti della pubblica amministrazione[9]; l’altro, favorevole alla riservatezza, negava invece l’accessibilità del nominativo, dal momento che l’esposto è solo un atto di impulso che resta formalmente estraneo all’attività amministrativa[10]. Sembra prevalere oggi un orientamento mediano[11], lo stesso cui aderisce il TAR nella sentenza in commento, in base al quale l’accesso al nominativo non è si per sé escluso né consentito: occorre, per poter concedere l’accesso, che il richiedente dimostri che la conoscenza del nominativo è necessaria e strumentale rispetto a una propria esigenza difensiva. Quest’ultimo orientamento fa corretta applicazione delle indicazioni offerte dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di diritto di accesso c.d. difensivo: in base all’art. 24, c. 7, legge n. 241 del 1990, che garantisce «comunque» l’accesso ai documenti «la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici», l’amministrazione deve compiere un «rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità» tra documento e interesse che si intende tutelare ma, allo stesso tempo, le è preclusa ogni «ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto» nell’eventuale successivo giudizio instaurato dal richiedente[12]. L’accesso difensivo è pertanto precluso solo nei casi di «evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990».
In sintesi, il richiedente è tenuto a dimostrare che il documento gli è necessario per tutelare i propri interessi, cioè che sussiste un nesso di strumentalità tra il documento e la sua esigenza difensiva; l’amministrazione può (e deve) sindacare soltanto in astratto simile strumentalità, senza spingersi a giudicare la rilevanza del documento rispetto alla ammissibilità o alla fondatezza di una successiva iniziativa giurisdizionale[13].
Ecco quindi che, in materia di esposti, la giurisprudenza più recente tende a concedere l’accesso al nominativo di chi ha presentato un esposto all’amministrazione qualora il richiedente riesca a dimostrare che il nominativo è necessario per intraprendere un’azione giudiziaria, per esempio per presentare una querela o per domandare il risarcimento del danno prodotto dall’esposto. In assenza del nesso di strumentalità, l’accesso deve invece essere negato, rischiandosi altrimenti di dar tutela a una pura curiosità o, peggio, a un intento ritorsivo[14].
La stessa ricostruzione viene trasposta dal TAR Friuli al caso in questione: i «principi di trasparenza e responsabilità non possono quindi ammettere la preclusione all’accesso alle petizioni e ai relativi documenti accompagnatori, salvo che, in particolari situazioni, i sottoscrittori documentino, quale conseguenza della pubblicazione della loro sottoscrizione, possibili azioni discriminatorie o indebite pressioni a loro danno».
Nel caso di specie, ad avviso del TAR, le potenziali azioni giudiziarie prospettate dalla ricorrente costituiscono il «legittimo esercizio di un diritto» e non invece «pretestuose intimidazioni» o «minaccia di un male ingiusto». Il TAR riconosce, invece, che l’impresa ha dimostrato il proprio interesse specifico e attuale rispetto al documento e ai nominativi dei firmatari «in connessione con l’impatto che la stessa può aver avuto sugli esiti dei procedimenti amministrativi relativi all’acciaieria»; inoltre, la stessa impresa ha pure «connotato […] il proprio interesse ostensivo anche in chiave difensiva, ai sensi dell’art. 24, c. 7, della l. n. 241/1990 […]: la conoscenza dei nominativi dei soggetti da convenire in giudizio è infatti indispensabile quale che sia l’azione da instaurare».
L’idea che i nominativi dei sottoscrittori debbano essere resi noti è, poi, rafforzata dall’analisi delle norme riguardanti la pubblicità degli atti del Consiglio regionale, che si rinvengono nel Regolamento interno del Consiglio regionale friulano. In particolare, l’art. 179 bis, c. 1 bis, di tale regolamento dispone che alcuni atti, tra i quali quelli che il Presidente del Consiglio riceve per sottoporli all’esame degli organi consiliari, devono essere direttamente e integralmente pubblicati sul sito internet istituzionale. Vero è che lo stesso comma stabilisce anche delle ipotesi di deroga all’obbligo di pubblicazione: in particolare, il Presidente del Consiglio può disporre la non pubblicazione totale o parziale di atti «contenenti dati personali non divulgabili a norma della disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali»; la disposizione aggiunge inoltre che «gli atti prodotti da soggetti esterni nell’ambito delle procedure di consultazione delle Commissioni sono pubblicati con le modalità di cui al primo periodo, salvo che l’interessato non comunichi il proprio diniego alla pubblicazione». Tuttavia, rileva il TAR, nel caso in questione nessuna di queste deroghe è stata attivata e, in particolare, nessuno dei sottoscrittori ha manifestato il proprio dissenso rispetto alla pubblicazione.
Nella circostanza l’elenco dei sottoscrittori non era stato allegato al documento sottoposto all’esame della commissione consiliare: per il TAR si tratta comunque di una «evenienza di mero fatto» che non altera la natura pubblica del documento (e del resto è lo stesso art. 134, c. 2, del citato regolamento a stabilire che le petizioni siano accompagnate dalle autocertificazioni di nascita, residenza e cittadinanza italiana dei firmatari).
Dalla ricostruzione della motivazione emerge come la sentenza sia ampiamente argomentata e ragionevole e, a prima vista, anche condivisibile. A un più attento esame, però, sembrano esservi ragioni per discostarsi dalla ricostruzione del TAR, sia con riguardo al regime di pubblicità dei nominativi dei sottoscrittori di una petizione, sia con riguardo all’applicazione, nel caso di specie, dell’art. 24, c. 7, della legge n. 241 del 1990. Proveremo a indicare queste ragioni nei prossimi paragrafi.
3. I nominativi dei firmatari tra pubblicità e tutela dei dati personali.
La prima questione da affrontare riguarda il regime di pubblicità dei nominativi dei sottoscrittori della petizione: come infatti accennato in premessa, se la lista dei firmatari fosse di per sé pubblica avrebbe poco senso guardare all’applicazione del diritto di accesso difensivo (sarebbe del resto esercitabile, senza bisogno di motivare l’istanza, il diritto di accesso civico)[15]. Come detto, i giudici friulani ritengono che la lista dei firmatari sia pubblica e non sia stata allegata alla petizione soltanto per una «evenienza di mero fatto». La mancata allegazione può invece fondarsi su argomenti giuridicamente rilevanti, collegati alla tutela dei dati personali.
In primo luogo, s’è visto come lo stesso regolamento interno del Consiglio regionale contempli ipotesi di non pubblicazione, totale o parziale, di documenti consiliari, quando questi contengano dati personali non divulgabili. È vero, come affermato dal TAR, che il Consiglio o il Presidente non hanno formalmente “attivato” una delle ipotesi di deroga alla pubblicazione, tuttavia l’attivazione potrebbe ritenersi implicita nella mancata allegazione dell’elenco dei sottoscrittori alla petizione. Così pure il fatto che i sottoscrittori non abbiano manifestato il loro dissenso rispetto alla pubblicazione (ma, ci si potrebbe domandare, ne erano consapevoli?) non comporta con certezza che essi li abbiano resi «manifestamente pubblici». In altre parole, sicuramente la sottoscrizione di una petizione comporta il sostegno personale e non anonimo di una causa; ma la sottoscrizione non implica anche il consenso alla pubblicazione dei dati personali da parte dell’istituzione a cui la petizione è diretta[16].
Con ciò si intende dire che sono possibili petizioni anonime? Tutt’altro: si è da sempre sostenuto che una petizione deve essere firmata, «apparendo evidente l’assurdità di una istanza coperta dall’anonimato»[17]. D’altronde è sufficiente cercare sui siti istituzionali le petizioni presentate alle Camere ai sensi dell’art. 50 Cost. per rendersi conto che esse sono sempre accompagnate dai nomi dei proponenti. Bisogna semmai domandarsi quale sia il senso della sottoscrizione della petizione: proseguiva l’autore poc’anzi citato dicendo che la firma serve «anche perché occorre accertare la titolarità di esercizio di tale diritto»[18]. Ebbene, così come accade per le formalità stabilite dalla legge per la raccolta delle firme a sostegno dei referendum previsti dalla Costituzione[19], il fatto che le sottoscrizioni delle petizioni in oggetto debbano essere accompagnate dalla autocertificazione dei firmatari non ha tanto il senso di rendere pubbliche le loro generalità, bensì di renderle verificabili. L’autocertificazione non è rivolta a tutti gli altri cittadini ma è rivolta all’istituzione (nel nostro caso il Consiglio regionale) che potrà valutarne l’autenticità, così da esser sicura della genuinità del sostegno popolare a una certa causa. Per tornare al parallelo con l’esperienza europea, si consideri che nel caso delle petizioni presentate al Parlamento europeo ai sensi degli artt. 227 del TFUE e 44 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, è espressamente prevista la possibilità di renderle anonime[20].
Vi è poi un altro elemento di cui tener conto: almeno una delle firme che accompagnano la petizione al Consiglio regionale friulano dev’essere autenticata[21], il che sembra costituire una garanzia minima sulla sicura provenienza dell’atto da (almeno) un titolare del diritto di petizione. Se, come sostiene in maniera condivisibile il TAR, la legittimazione delle petizioni è tratta dalla «precisa individualità» dei sottoscrittori, tale individualità deve essere presente alla istituzione e non, qualora si oppongano ragioni di tutela dei dati personali, anche all’esterno di essa. Del resto, la petizione in oggetto è un atto di mero impulso, rivolto proprio e solo al Consiglio regionale, che rimane del tutto libero riguardo al seguito da dare (o non dare) alla stessa.
A dispetto, quindi, di una immediata percezione che spinge a ritenere di per sé pubbliche le firme in calce a una petizione, emerge un quadro più complesso che sembra andare nella direzione opposta.
4. Strumentalità e limiti dell’accesso difensivo.
Veniamo allora alla seconda questione: posto che i nomi dei sottoscrittori non sono per loro natura pubblici, occorre capire se siano accessibili ai sensi dell’art. 24, c. 7 della legge n. 241 del 1990. S’è detto che il diritto di accesso difensivo consente «comunque» al richiedente di ottenere i documenti che siano necessari al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici. È quindi direttamente il legislatore a stabilire – qualora ricorra tale strumentalità difensiva del documento – la prevalenza dell’accesso sulle contrapposte esigenze di riservatezza, così che all’amministrazione è preclusa ogni attività di bilanciamento[22]. Nel caso di specie, ad avviso del TAR, la dimostrazione della strumentalità dei dati richiesti è stata fornita dalla società ricorrente («sebbene soltanto nel presente giudizio in termini chiari e precisi») e a nulla varrebbe, per negare l’accesso, l’eventuale dissenso dei sottoscrittori[23].
Eppure, a fronte di elementi all’apparenza univoci, esistono ragioni che inducono a ritenere recessivo il diritto di accesso difensivo.
Anzitutto, il fatto che il legislatore abbia stabilito la prevalenza di quest’ultimo rispetto a eventuali interessi contrari[24] non significa che si tratti di un diritto privo di limitazioni[25]: anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 21 del 2020), pur riconoscendo che la fattispecie dell’accesso difensivo possa operare «quale eccezione al catalogo di esclusioni» previste per il “normale” accesso documentale, ha parlato di «opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi»[26]. E occorre altresì notare come lo stesso comma 7 prosegua stabilendo che «nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». Tra i dati sensibili, rispetto ai quali l’accesso è possibile solo in casi di “stretta indispensabilità”, rientrano anche quelli idonei a rivelare le opinioni politiche[27]: forse non è il caso della petizione in questione, tuttavia il diritto di petizione è inquadrato da tempo come diritto politico[28]. Da un lato, una simile connotazione dovrebbe indurre a garantire al diritto di petizione una tutela forte (considerato peraltro il legame che sussiste con la libertà di manifestazione del pensiero[29]), anche nei confronti del diritto di accesso[30]. Dall’altro, la natura politica del diritto sembra allontanare il caso delle petizioni da quello degli esposti alle pubbliche amministrazioni: questi ultimi sono, infatti, rivolti a organi amministrativi, generalmente sottoscritti da un singolo privato e indirizzati nei confronti di altri privati precisamente individuati.
In secondo luogo, per quanto riguarda la strumentalità dell’accesso difensivo, si è già detto che il sindacato dell’amministrazione (e del giudice) non possa attenere alla fondatezza delle iniziative che il richiedente voglia intraprendere, cionondimeno deve trattarsi di un sindacato rigoroso. E allora, come già avvenuto nella giurisprudenza amministrativa, il giudice può valutare l’astratta connessione dei documenti richiesti rispetto alla proponibilità di un’azione giudiziaria. In questo caso, la società ritiene di essere diffamata dal contenuto della petizione e deve quindi esserle concesso di attivare la tutela giurisdizionale, ai sensi dell’art. 24 Cost., sia in sede penale che in sede civile.
La mancata conoscenza dei nomi dei sottoscrittori non appare, però, un ostacolo insormontabile per l’accertamento della responsabilità penale. È ben possibile, infatti, sporgere comunque querela e qualora «l’Autorità Giudiziaria dovesse riscontrare fattispecie penalmente perseguibili attribuibili a soggetti individuati, sarebbe doveroso all’esito del procedimento formulare un’imputazione dandone avviso alla parte offesa»[31].
Per quanto riguarda la responsabilità civile, questa sembra doversi escludere per ciò che riguarda la mancata realizzazione dell’impianto (il TAR parla invece dell’«impatto che la stessa [petizione] può aver avuto sugli esiti dei procedimenti amministrativi relativi all’acciaieria»): essa sembra infatti esser dipesa dalla volontà politica espressa dagli organi della Regione, che può essere stata condizionata solo in via di fatto dal contenuto della petizione[32]. Analogamente, la giurisprudenza ha escluso l’accessibilità del nome dell’autore di un esposto quando i danni che il richiedente riteneva di aver subìto non discendevano dall’esposto ma dalla successiva attività posta in essere dall’amministrazione[33].
Resta, però, che i nominativi dei sottoscrittori sono necessari per poter intraprendere un’azione civile per i danni eventualmente patiti in conseguenza del contenuto diffamatorio della petizione[34]: per quanto complessa possa apparire un’azione nei confronti di tanti soggetti, essa è certamente astrattamente proponibile e ciò dovrebbe essere sufficiente ai fini del rilascio dei documenti richiesti. Tuttavia, è da dire che una simile azione non è di per sé esclusa, perché la società ricorrente conosce i nomi di alcuni almeno dei sottoscrittori della petizione (i nomi dei proponenti sono pubblici e comunque vi sono dei controinteressati costituiti nel giudizio di fronte al TAR): dunque, il fatto che l’azione non sia in radice negata pare escludere una lesione del diritto di difesa dell’art. 24 della Costituzione, che può essere soddisfatto bilanciandolo con gli altri diritti rilevanti che emergono nella vicenda (e senza considerare che il processo civile conosce forme di integrazione del contraddittorio). Come detto, il diritto di accesso non è privo di limiti e richiede presupposti – la cui esistenza deve essere rigorosamente vagliata – che nel caso di specie non sembrano sussistere.
[1] https://verdisinistra.it/gruppo-danieli-zanella-inquietante-sentenza-tar-fvg-contro-regione-spero-consiglio-di-stato-ripari-vulnus/.
[2] Sul tema si può rinviare, in generale, a A. Corrado, Il principio di trasparenza e i suoi strumenti di attuazione, in M.A. Sandulli (a cura di), Princìpi e regole dell’azione amministrativa, IV ed., Milano, 2023, 192 ss.
[3] Proprio con riferimento alla trasparenza, v. P. Leino, Secrecy, Efficiency, Transparency in EU Negotiations: Conflicting Paradigms?, in Politics and Governance, 3/ 2017, 9.
[4] Si tratta dei documenti formati o ricevuti dalle istituzioni europee nel corso di una procedura legislativa, i quali dovrebbero essere resi direttamente accessibili in forma elettronica o attraverso un registro (art. 2, par. 6, Reg. (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001; si veda anche il considerando n. 6 dello stesso regolamento, secondo cui «Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore […]»).
[5] In proposito, e per ulteriori riferimenti, sia consentito rinviare a I. Piazza, Un altro passo verso la trasparenza del processo legislativo europeo, in Giorn. dir. amm., 2023, 499 ss.
[6] Reg. UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
[7] Sul tema sia consentito rinviare a I. Piazza, Accesso difensivo e tutela dei dati personali: il caso dei nominativi nelle segnalazioni alla p.a., in questa Rivista, 2022. Il richiamo alla giurisprudenza su segnalazioni ed esposti è effettivamente necessario, data la difficoltà di rinvenire precedenti sullo specifico tema delle petizioni: per un accenno, si può vedere TAR Lombardia – Brescia, 7 marzo 2005, n. 128, che riguardava comunque la peculiare ipotesi di diritto di accesso dei consiglieri comunali rispetto agli atti detenuti dal Comune.
[8] Il TAR cita in proposito la recente pronuncia del Cons. St., IV, 1 marzo 2022, n.1450.
[9] Tra altre, v. Cons. St., sez. V, 28 settembre 2012, n. 5132, TAR Toscana, sez. I, 3 luglio 2017, n. 898, TAR Emilia Romagna - Bologna, sez. I, 3 agosto 2017, n. 584.
[10] Si vedano, per esempio, TAR Emilia Romagna - Bologna, sez. II, 17 ottobre 2018, n. 772 e TAR Veneto, sez. III, 20 marzo 2015, n. 321.
[11] Si veda Cons. St., IV, 1 marzo 2022, n. 1450 e, in precedenza, Cons. St., sez. III, 1 marzo 2021, n. 1717.
[12] Cons. St., Ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4, sulla quale si vedano V. Mirra, Accesso difensivo e riservatezza: due diritti in conflitto, in Foro it., 10/2021, 550 ss., M. Sica, Diritto di accesso ai documenti amministrativi e processo civile. Una nuova sentenza dell’adunanza plenaria, in Riv. dir. proc., 2021, 1412 ss. e G. Delle Cave, L’accesso difensivo post Adunanza Plenaria n. 4/2021 tra potere valutativo della P.A. e apprezzamento del giudice, in questa Rivista, 2022.
[13] Da ultimo, v. Cons. St., VI, 6 dicembre 2024, n. 9780. Lo stesso TAR Friuli, nella parte conclusiva della sentenza, sottolinea che «la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione della fondatezza o ammissibilità delle prospettate azioni giudiziarie o delle iniziative che l’istante intende percorrere, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso». Sul tema, v. F. Francario, Il diritto di accesso deve essere una garanzia effettiva e non una mera declamazione retorica, in Federalismi.it, n. 10/2019, spec. 23.
[14] In tal senso, Cons. St., n. 1717/2021; TAR Emilia Romagna – Bologna, II, 8 febbraio 2022, n. 136.
[15] Che, come noto, spetta a «chiunque» (art. 5, c. 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Sul diritto di accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) la letteratura è vasta: qui si rinvia unicamente ai volumi di A. Corrado (a cura di), Conoscere per partecipare: la strada tracciata dalla trasparenza amministrativa, Napoli, 2018, G. Gardini, M. Magri (a cura di), Il FOIA italiano: vincitori e vinti. Bilancio a tre anni dall’introduzione, Sant’Arcangelo di Romagna, 2019, e, per una prospettiva comparata, di B.G. Mattarella, M. Savino (a cura di), L’accesso dei cittadini. Esperienze di informazione amministrativa a confronto, Napoli, 2018.
[16] Sul trattamento dei dati personali in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, inclusi i dati raccolti in occasione di iniziative come petizioni e richieste di referendum, si veda il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 aprile 2019.
[17] G.P. Meucci, Petizione (Diritto di), in Noviss. Dig. It., vol. XIII, Torino, 1966, 6.
[18] G.P. Meucci, Petizione (Diritto di), cit., 6.
[19] Legge 25 maggio 1970, n. 352.
[20] https://www.europarl.europa.eu/petitions/it/faq/pdf. Sulle petizioni al Parlamento europeo, v. G.E. Vigevani, Art. 50, in S. Bartole, R. Bin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 514 s.
[21] Art. 134, c. 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale.
[22] Sul punto, v. F. Francario, Il diritto di accesso deve essere una garanzia effettiva, cit., 18 s.: «Nell’ipotesi dell’accesso gergalmente detto defensionale, la regola di composizione di un ipotetico conflitto è dunque fissata direttamente dal legislatore e non è pertanto più rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione; con la conseguenza che l’Amministrazione non ha più il potere di stabilire essa quale sia l’interesse prevalente nel caso concreto. […] La regola è quindi che l’accesso, strumentale – si ripete – al soddisfacimento di un bisogno di tutela proprio di una situazione giuridica soggettiva, prevalga. L’eccezione è che rimanga insoddisfatto. Perché venga impedito è necessario che si contrapponga un interesse di “pari rango”, che vi sia cioè una eccezione espressamente contemplata sul piano normativo; e non già una semplice esigenza discrezionalmente apprezzabile da parte della pubblica amministrazione». Di «obbligo» per l’amministrazione parla espressamente M. Sinisi, I diritti di accesso e la discrezionalità amministrativa, Bari, 2020, 102 s.: «Il comma 7 dell’art. 24, l. n. 241/90 introduce dunque una norma di chiusura del sistema: esso pone un preciso limite alla discrezionalità della pubblica amministrazione obbligando la stessa ad accordare l’accesso pur a fronte di esigenze di riservatezza che si opporrebbero all’ostensione dei documenti richiesti. A fronte della pretesa conoscitiva del richiedente (in presenza delle dimostrate necessità defensionali o, nel caso di interessi sensibili e giudiziari, in presenza di “stretta indispensabilità”) si configura dunque un obbligo in capo alla pubblica amministrazione di provvedere in senso favorevole all’istante (consentendo allo stesso il più ampio “accesso” a fronte della mera “visione” dei documenti, contemplata nella formulazione previgente della disposizione normativa) senza che possa essere operato alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che l’interessato potrebbe eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso procedimentale e pur a fronte di eventuali indicazioni contrarie provenienti dal controinteressato che abbia segnalato la sussistenza di eventuali profili ostativi all’accesso».
[23] Sui rapporti tra disciplina dell’accesso e tutela dei dati personali nell’attività dell’amministrazione, v. F. Francario, Protezione dei dati personali e pubblica amministrazione, in questa Rivista, 2021; Id., Disposizioni “urgenti” in materia di protezione dei dati personali. Brevi note sul trattamento dati per finalità di pubblico interesse, sempre in questa Rivista, 2021; F. Cardarelli, Commento all’art. 2-ter, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in R. D’Orazio, G. Finocchiaro, O. Pollicino, G. Resta (a cura di), Codice della privacy e data protection, Milano, 2021, 1012 ss.
[24] Circostanza che ha indotto la giurisprudenza a interpretare in modo particolarmente serio l’accertamento dei requisiti che legittimano l’esercizio del diritto e, in particolare, del nesso di strumentalità tra documento richiesto ed esigenza difensiva: si rinvia sul punto a I. Piazza, Accesso difensivo e tutela dei dati personali, cit., § 4.
[25] E. Carloni, Il paradigma trasparenza. Amministrazioni, informazioni, democrazia, Bologna, 2022, 173: «È una formulazione, quella dell’art. 24, c. 7, che va letta in rapporto con i limiti previsti dallo stesso articolo, anche se sul punto la giurisprudenza ha assunto posizioni prevalentemente più restrittive: sicuramente riferibile al limite «relativo» della protezione dei dati personali, questo contro-limite è talvolta inteso come applicabile a tutti i limiti relativi, ma pare più persuasivo in un’ottica sistematica ritenerlo altresì applicabile a tutti i limiti, sia «relativi» che non, sempre però in un’ottica di bilanciamento e proporzionalità». Lo stesso A. aggiunge (ivi, nota 96): «Affermare la forza dell’accesso documentale non significa, in ogni caso, sancirne la prevalenza assoluta e indiscriminata, rispetto a qualsivoglia limite».
[26] Si rimanda ancora a E. Carloni, Il paradigma trasparenza, cit., 173, che ricorda come il problema dei limiti dell’accesso difensivo si sia posto anche in un caso particolarmente delicato, nel quale veniva in questione la riservatezza delle fonti giornalistiche: il riferimento è alla pronuncia del TAR Lazio, III, 18 giugno 2021, n. 7333 (sulla quale v. M. Sinisi, L’accesso defensionale a materiali e contenuti informativi in possesso della RAI (il caso Report), in questa Rivista, 2021) e alla successiva sentenza del Cons. St., VI, 11 aprile 2022, n. 2655.
[27] Art. 9, Reg. UE 2016/679.
[28] In tal senso, tra altri, G.P. Meucci, Petizione (Diritto di), cit., 8: «È con l’invio e con la presa in esame della petizione che il cittadino si inserisce, partecipandovi, alla funzione di indirizzo politico in quanto viene a far presenti istanze di carattere generale che le Camere sono tenute ad esaminare dopo che le Commissioni hanno riferito». Sulla natura del diritto di petizione, oltre che per un inquadramento in chiave comparata dell’istituto, v. R. Orrù, La petizione al pubblico potere tra diritto e libertà. Evoluzione storica e profili comparatistici, Torino, 1996, spec. 216 ss.
[29] P. Stancati, Petizione (dir. cost.), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 599. Si veda anche A. Coccia, Art. 50, in Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Rapporti politici, Tomo I, art. 48-52, Bologna-Roma, 1992, 53: «[…] anche la petizione rivolta alle Camere rientra, in quanto tale, nelle libere espressioni del pensiero individuale o collettivo e, per questo aspetto, si trova accomunata nella medesima disciplina di carattere costituzionale e legislativo». Sul diritto alla segretezza delle proprie opinioni e, in generale, sul tema della libertà di manifestazione del pensiero ci si limita al rinvio a P. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, spec. 435 ss.
[30] Sul rapporto tra petizioni e privacy, v. già P. Stancati, Petizione (dir. cost.), cit., 605.
[31] In questi termini, nel caso di un esposto alla pubblica amministrazione, la già citata sentenza del TAR Emilia Romagna – Bologna, II, 8 febbraio 2022, n. 136.
[32] Con riferimento alle petizioni ex art. 50 Cost., ma con ragionamento valido anche per il nostro caso, v. P. Stancati, Petizione (dir. cost.), cit., 601 s.: «Se si esclude, infatti, che la stessa iniziativa legislativa produca un vincolo nei confronti del Parlamento, deve, a maggior ragione, escludersi che lo produca la petizione. Pertanto l’iter procedimentale suscitato dalla petizione trova in questa solo una causa «occasionale» non giuridica, ed è direttamente e formalmente imputabile alle Camere e non al titolare del diritto in esame. Solo in senso latissimo potrebbe dunque l’attività delle commissioni dirsi provocata dalla petizione». Allo stesso modo, v. P. Caretti, De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, V ed., Torino, 2023, 151 s., che parlano, anche riguardo all’esperienza regionale, di «scarsissima utilità» rivelata dall’istituto delle petizioni.
[33] Si veda ancora TAR Emilia Romagna – Bologna, II, 8 febbraio 2022, n. 136.
[34] La relativa azione potrebbe anche essere esercitata in sede penale: varrebbe allora il discorso fatto poco sopra circa la possibilità di arrivare a conoscere gli autori della diffamazione attraverso l’autorità giudiziaria.