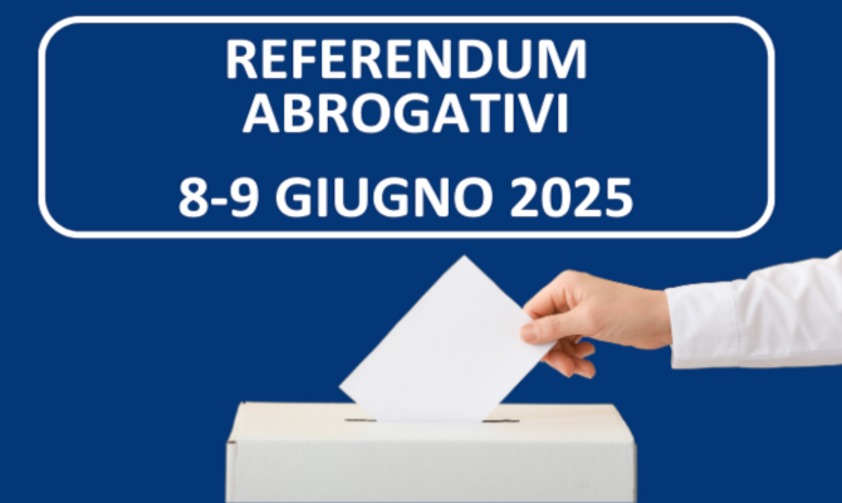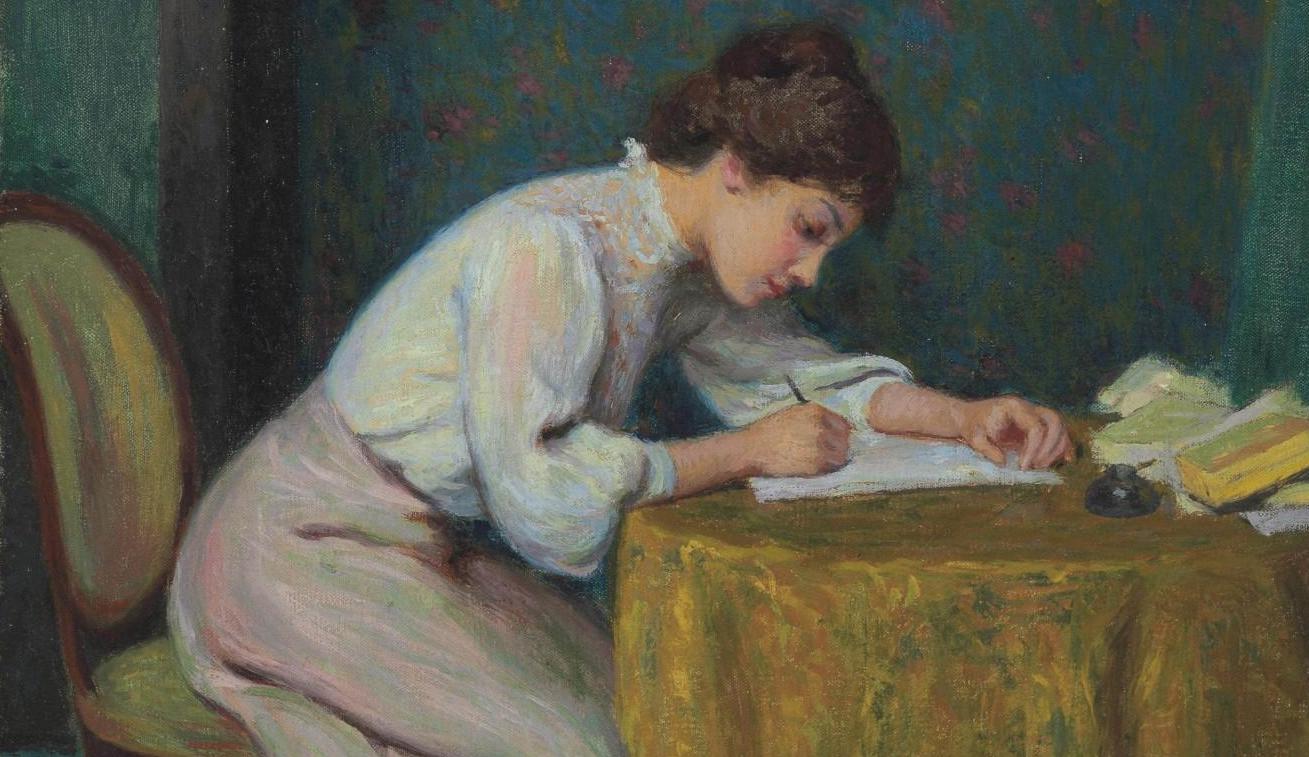
È dall’8 marzo 1946 che il rametto di mimosa è stato associato, per iniziativa delle parlamentari comuniste Teresa Mattei e Rita Montagnana, alla Giornata Internazionale della Donna.
La scelta cadde sulla mimosa perché fiorisce nei primi giorni del mese di marzo e, secondo i nativi americani, i fiori della mimosa significano forza e femminilità.
L’Unione delle Donne Italiane scartò prima le anemoni e poi i garofani, perché la mimosa, con i suoi fiori gialli luminosi e profumati, era anche un fiore molto economico e rappresentava la speranza e la vitalità in un momento di rinascita e cambiamento.
Ed è proprio un cambiamento che vogliamo annunciare.
Oggi, in occasione della Giornata internazionale in cui si celebra la forza delle donne, Giustizia Insieme vuole omaggiare tutte le donne protagoniste della Rivista non con un ramoscello di mimosa, ma con una riscrittura al femminile di tutte le biografie delle autrici e delle componenti del comitato scientifico e di redazione
A pensarci bene non si tratta di un regalo o di un omaggio, ma di un dovere culturale, perché non è mai solo una questione di parole: nominare le donne, soprattutto le donne professioniste, può contribuire anche a cambiare la percezione nei loro confronti.
Non si può negare che sia pervasiva e trasversale, anche nel mondo delle donne, una certa resistenza e ritrosia all’uso del femminile.
Lo spiega bene Cecilia Robustelli nel Tema di discussione dal titolo “Infermiera sì, Ingegnera no”, pubblicato nel 2021 sul sito dell’Accademia della Crusca.
«Qual è la ragione di questo atteggiamento linguistico? Le risposte più frequenti adducono all’incertezza di fronte all’uso di forme femminili nuove rispetto a quelle tradizionali maschili (è il caso di ingegnera), la presunta bruttezza delle nuove forme (ministra proprio non piace!), o la convinzione che la forma maschile possa essere usata tranquillamente anche in riferimento alle donne. Ma non è vero perché maestra, infermiera, modella, cuoca, nuotatrice ecc. non suscitano alcuna obiezione: anzi, nessuno definirebbe mai Federica Pellegrini nuotatore.
Le resistenze all’uso del genere grammaticale femminile per molti titoli professionali o ruoli istituzionali ricoperti da donne sembrano poggiare su ragioni di tipo linguistico, ma in realtà sono celatamente, di tipo culturale; mentre le ragioni di chi lo sostiene sono apertamente culturali e, al tempo stesso, fortemente linguistiche.»
L’attenzione alle discriminazioni linguistiche e al coretto uso dei femminili professionali è solo il primo passo verso un diverso approccio culturale al tema; il linguaggio è lo specchio del pensiero e tradisce pregiudizi, paure e anche convinzioni spesso nascoste nei meandri del nostro conformismo culturale.
E allora smettiamo di nasconderci dietro al dito della cacofonia, evitiamo la ricerca spasmodica del neutro impossibile e non esaltiamo la polisemia dei termini.
Care lettrici, cari lettori sappiamo bene che qualcuno di voi storcerà il naso quando leggerà le nostre biografie, ma crediamo che abbia ragione Vera Gheno, in Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole, quando ci invita a riflettere in questo senso: «succede che ciò che non viene nominato tende ad essere meno visibile agli occhi delle persone. In questo senso chiamare le donne che fanno un certo lavoro con un sostantivo femminile non è un semplice capriccio, ma il riconoscimento della loro esistenza: dalla camionista alla minatrice, dalla commessa alla direttrice di filiale, dalla revisora dei conti alla giudice, dalla giardiniera alla sindaca. E pazienza se ad alcuni le parole suonano male: ci si può abituare.»
Immagine: Federico Zandomeneghi (1841-1917), Ragazza che scrive, s.d., olio su tela, cm 46×38, collezione privata.






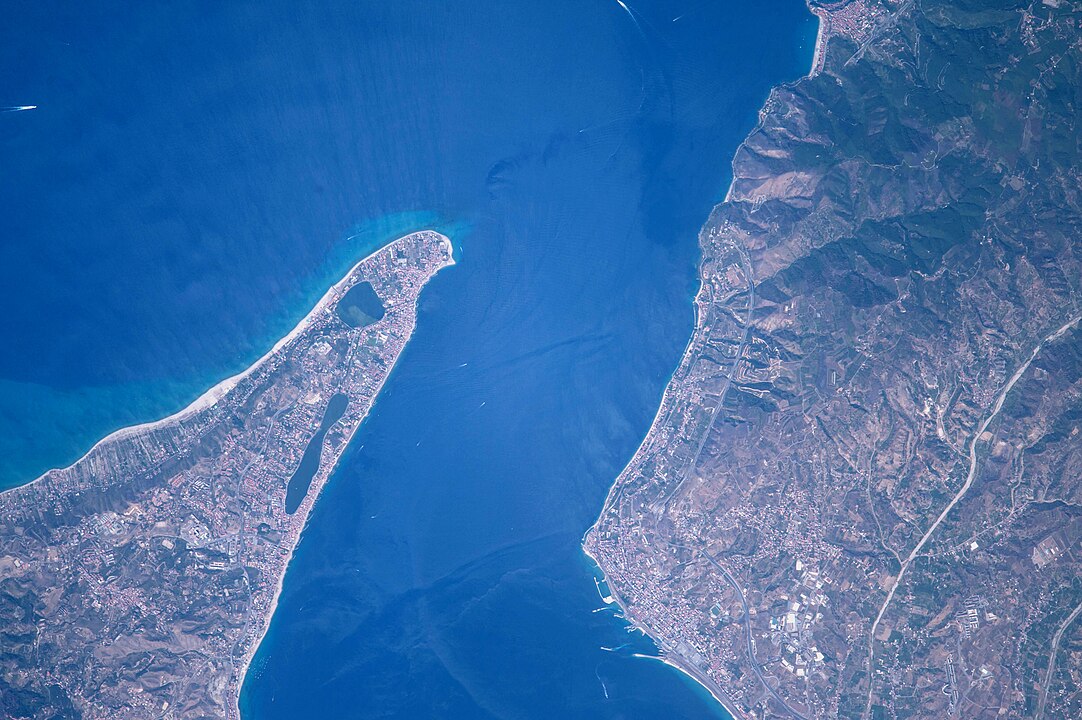
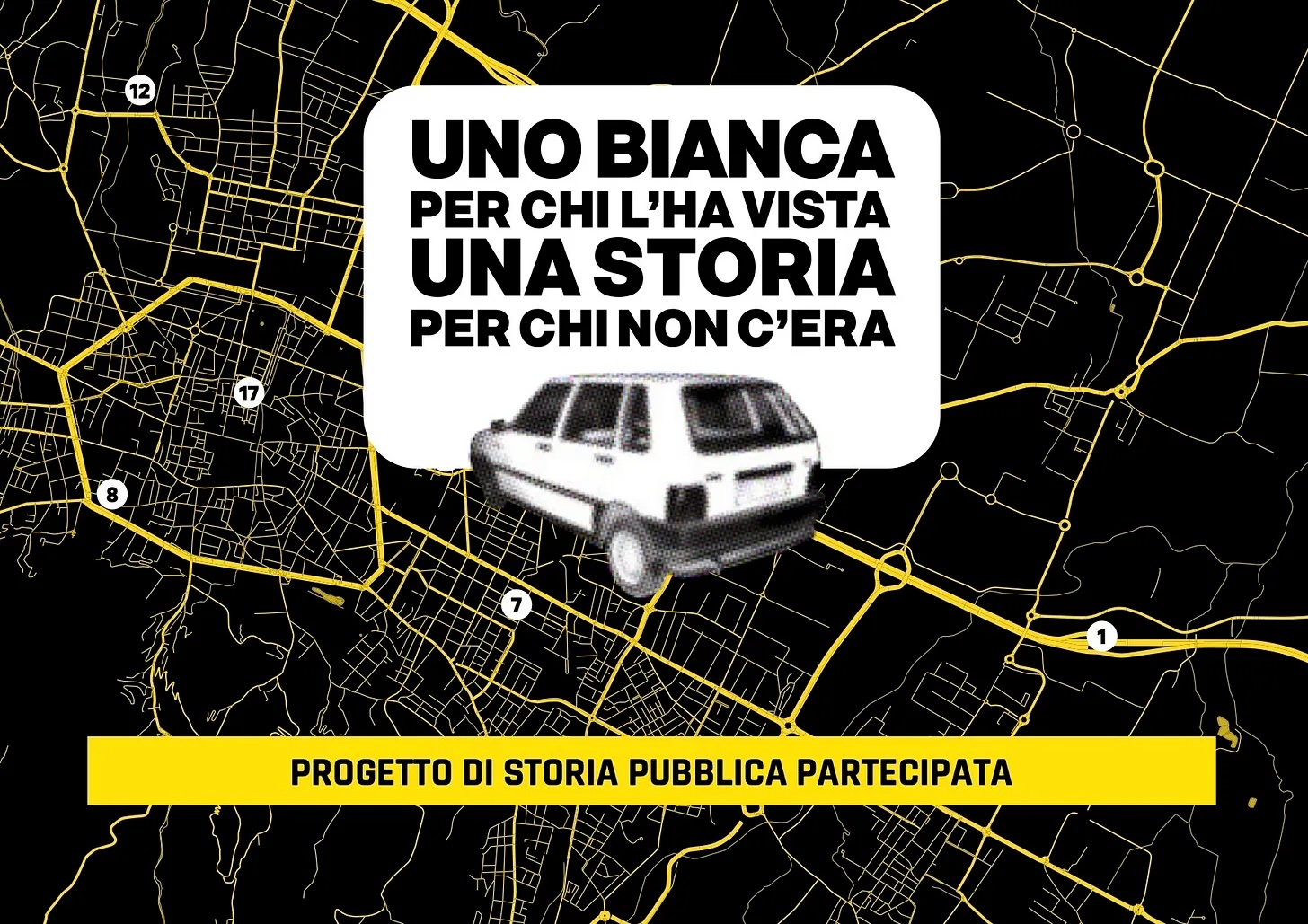


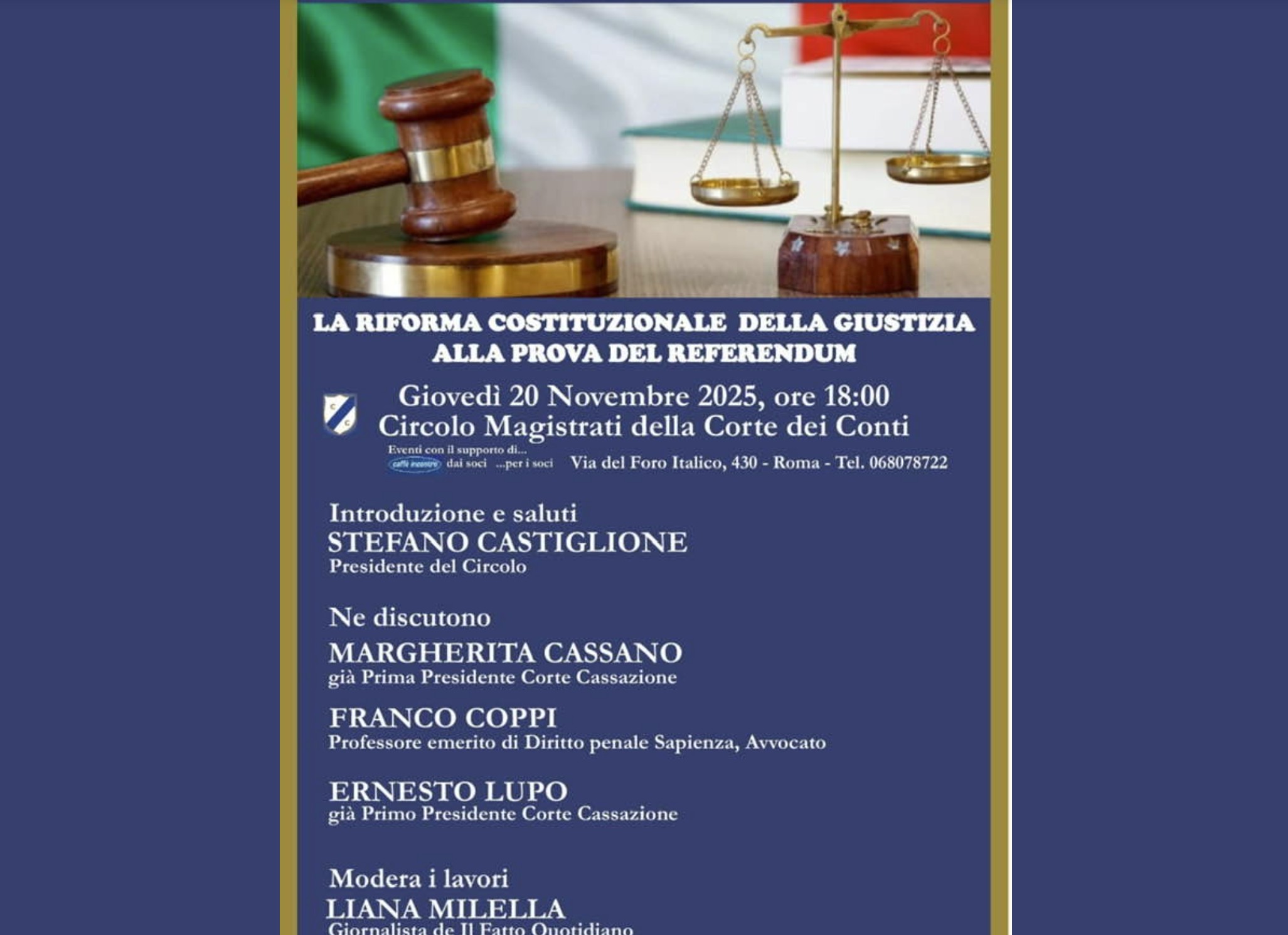





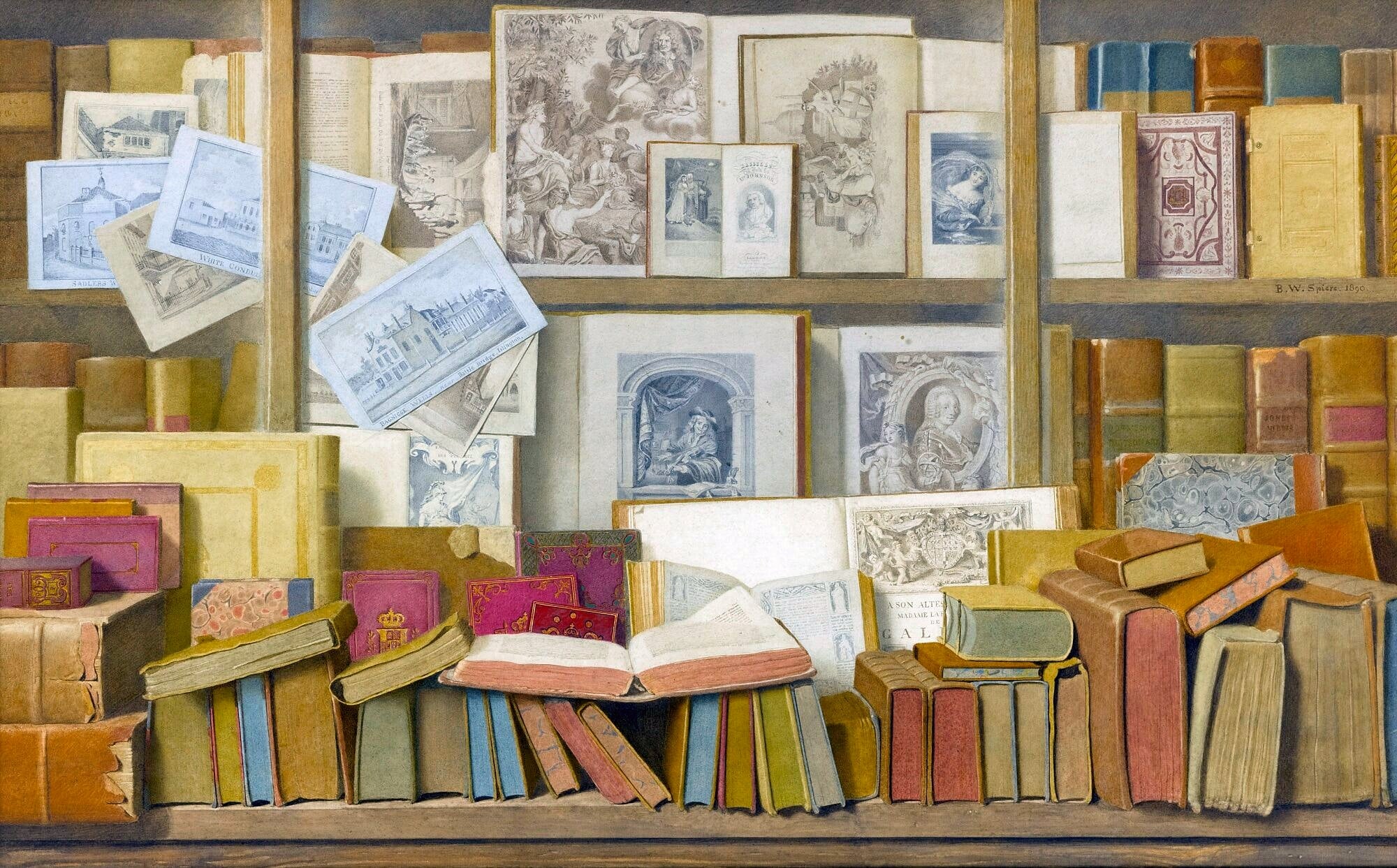



![La Corte di giustizia sulla nozione di “paese sicuro” e l’esclusione di particolari categorie soggettive- Corte giust, 1 agosto 2025, Cause riunite C‑758/24 [Alace] e C‑759/24 [Canpelli]](/foto/3586.jpeg)