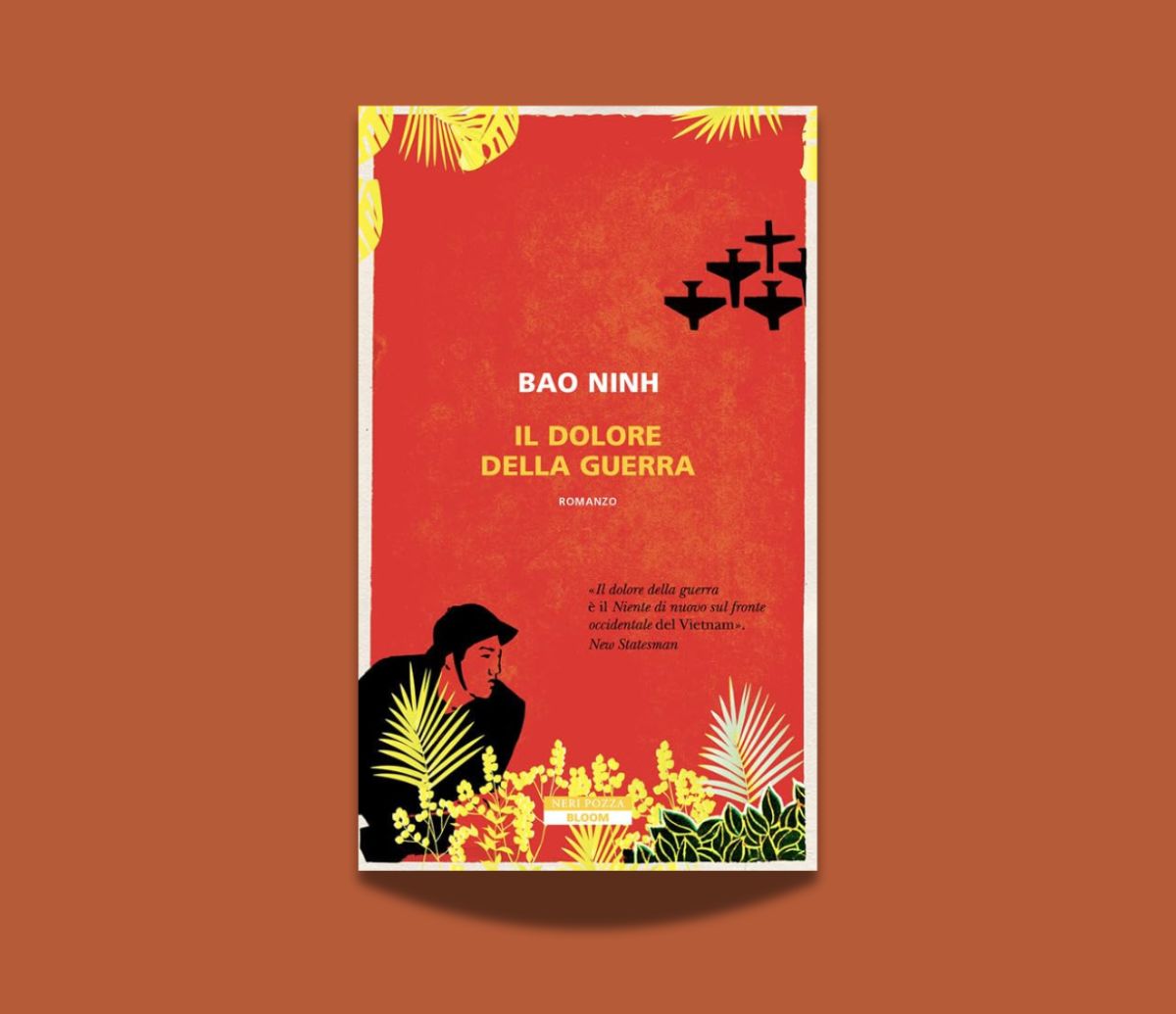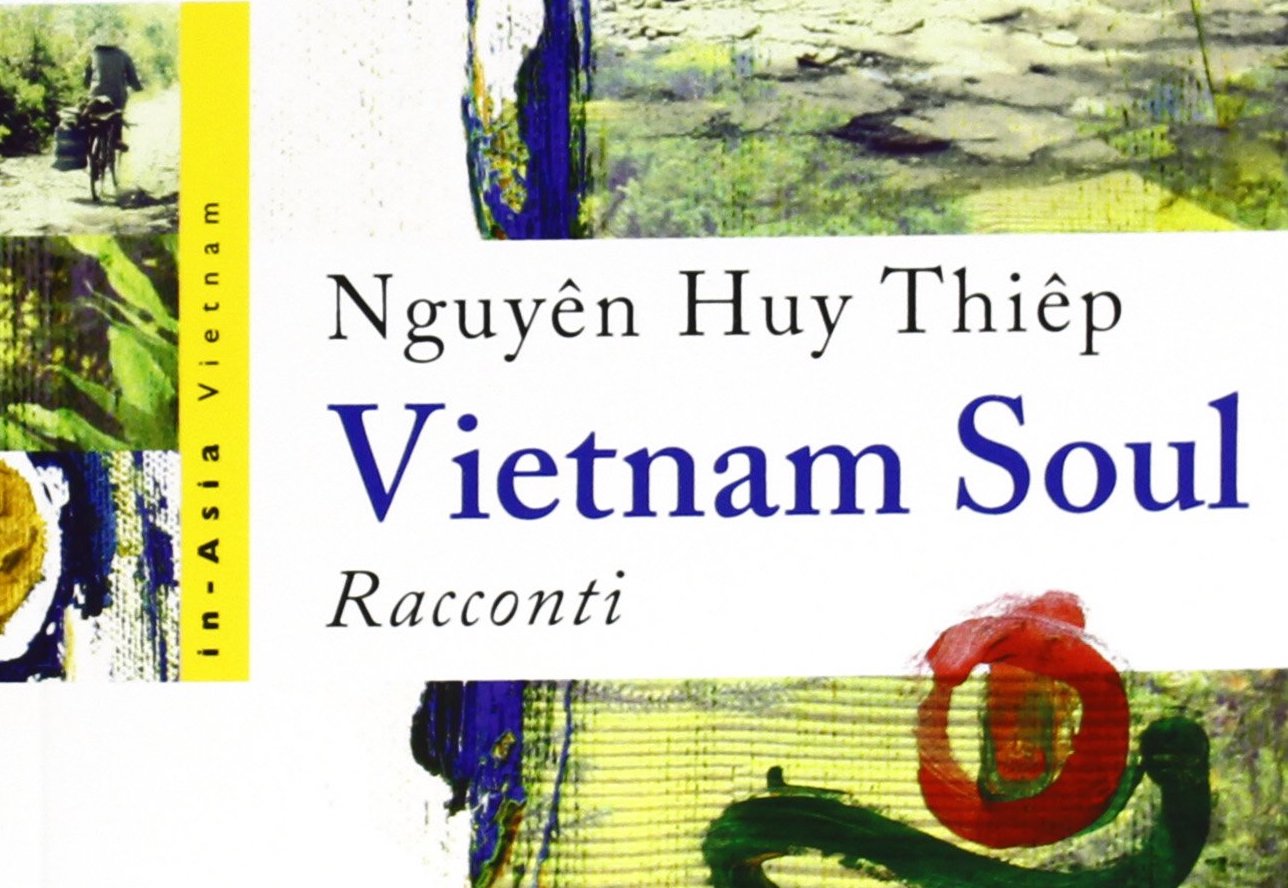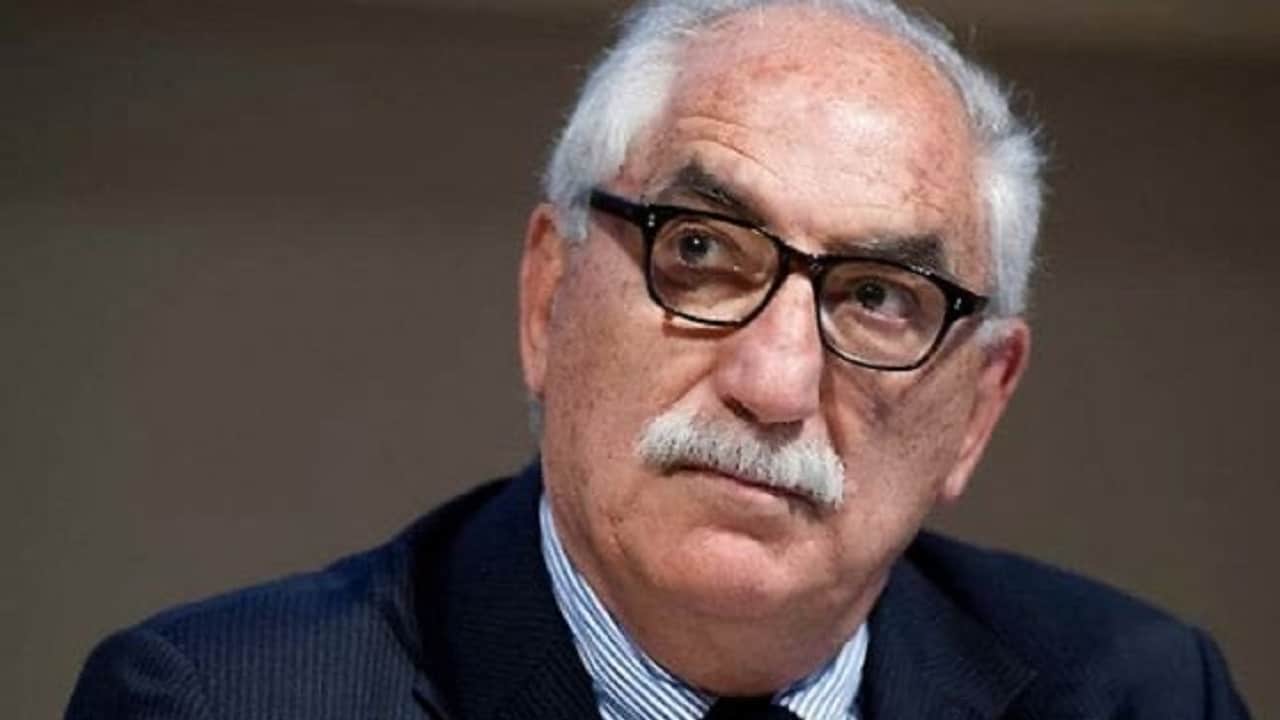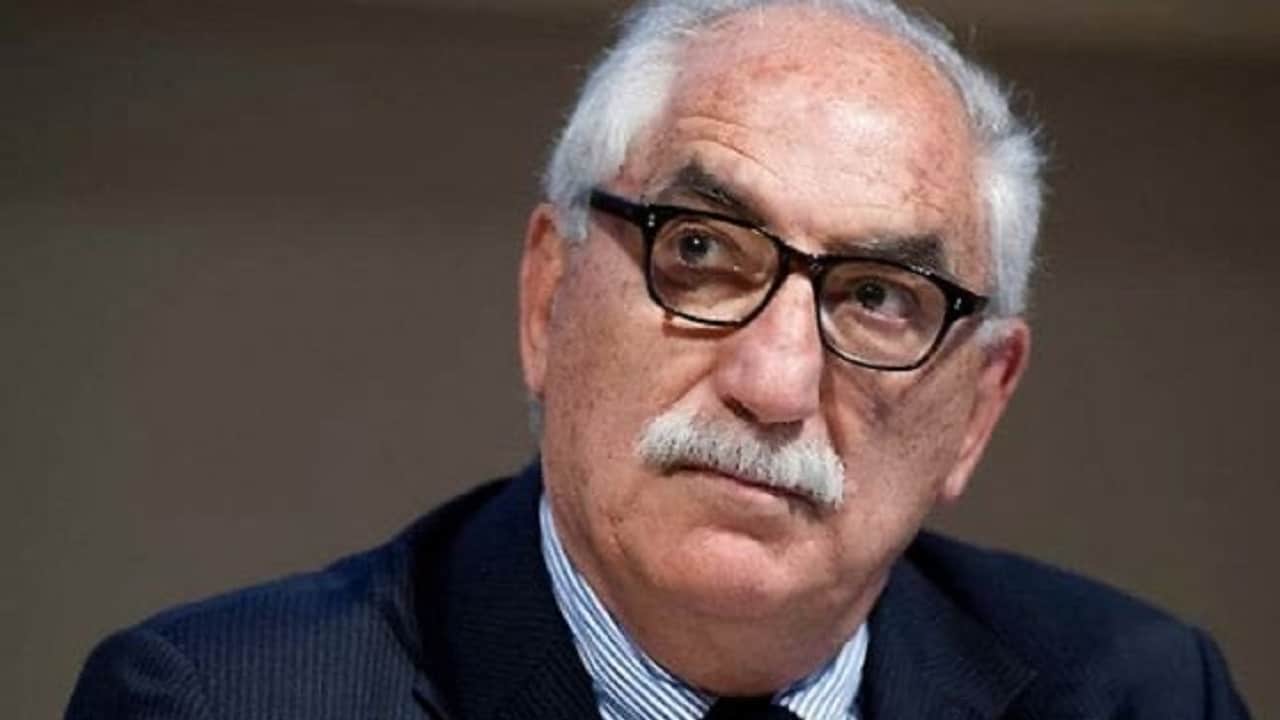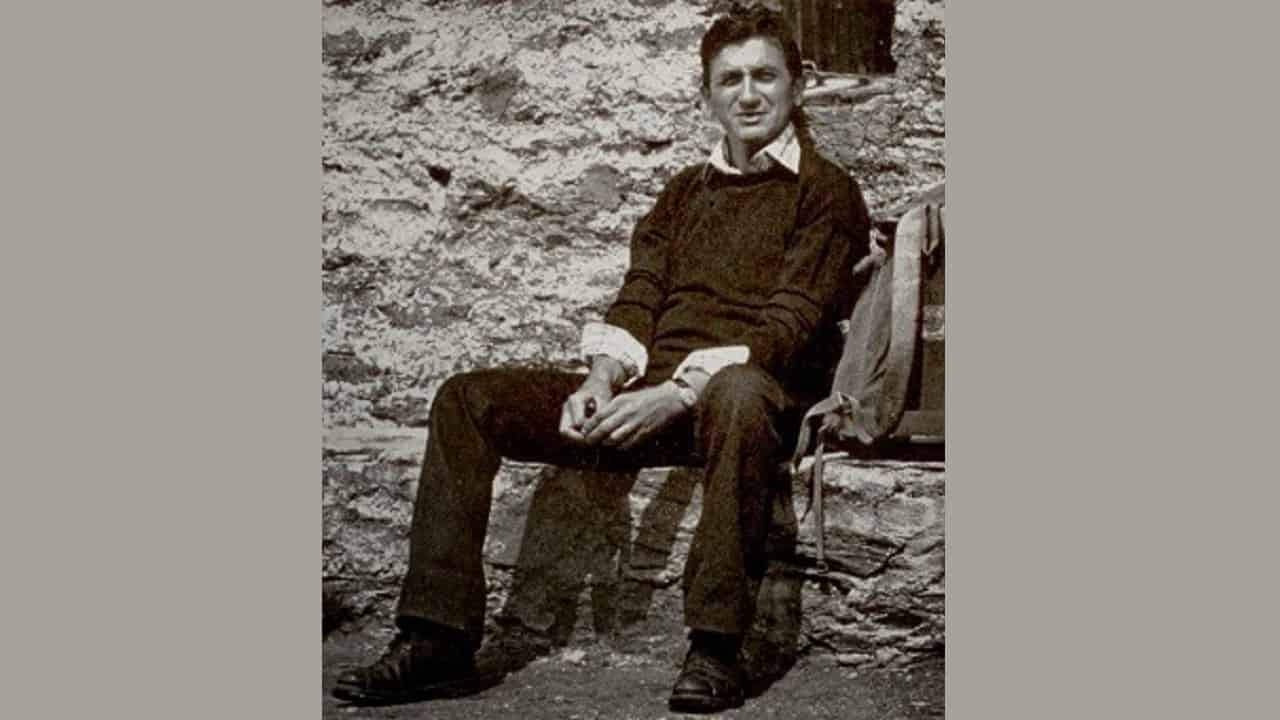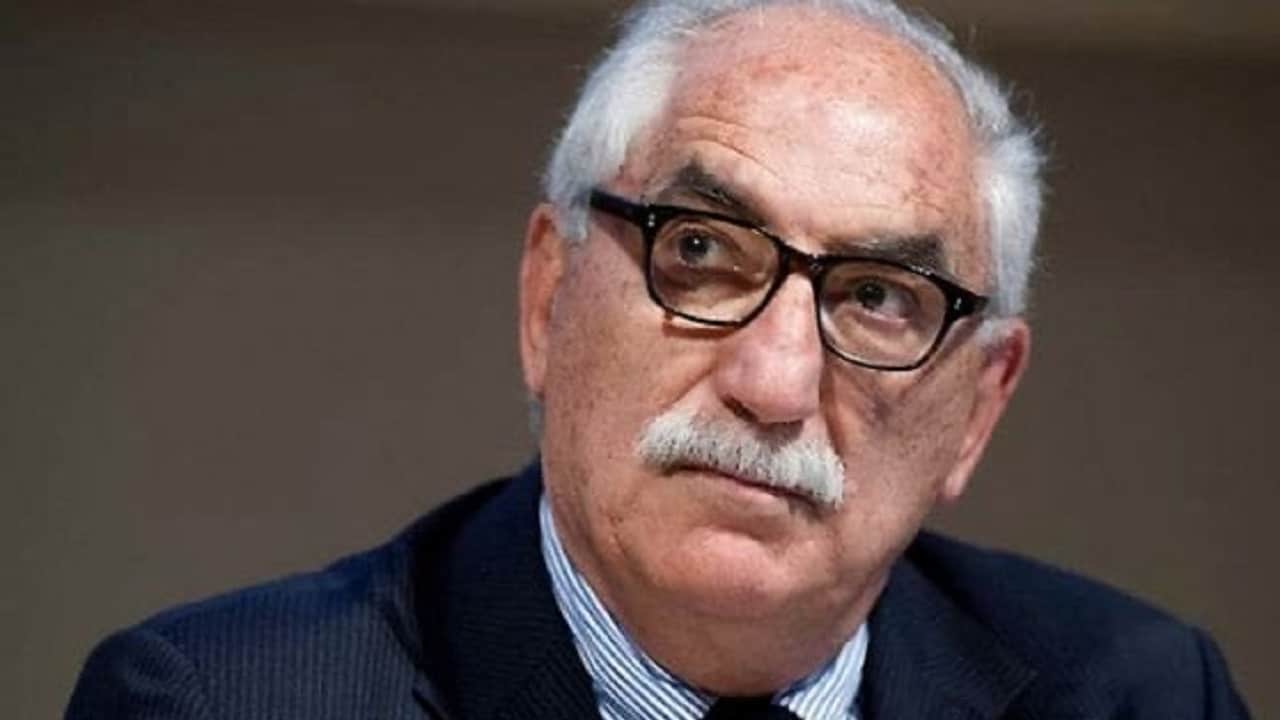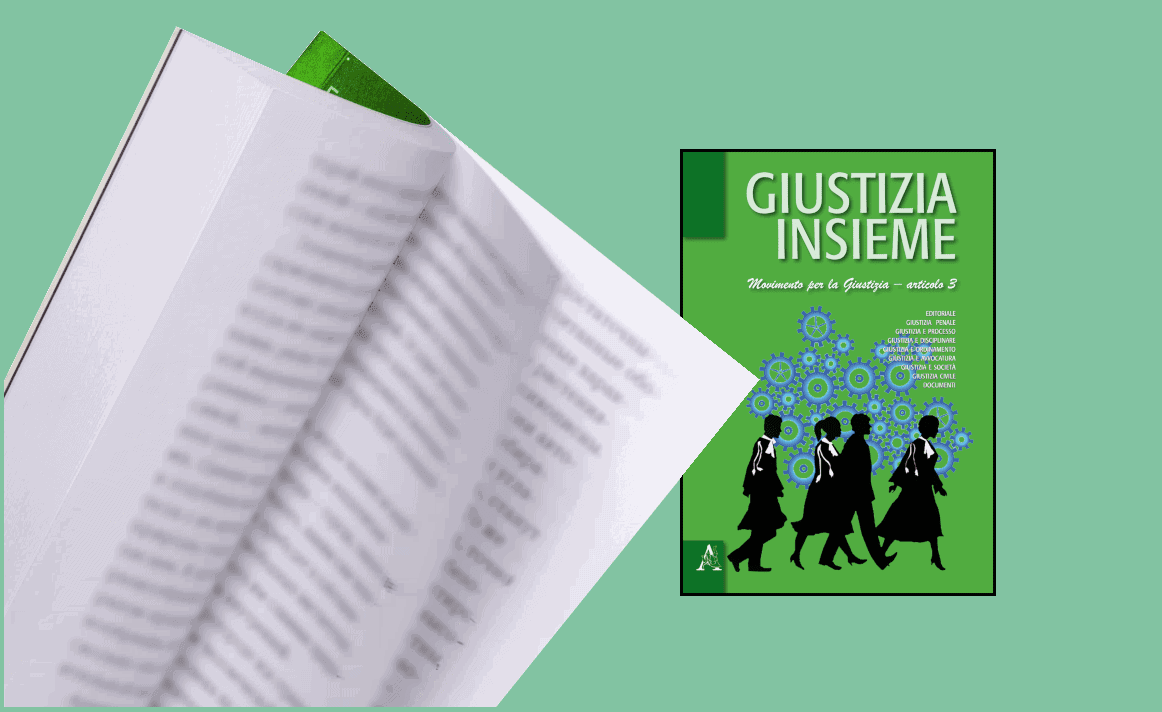A complete Unknown [1]
Da convinto dylaniano, appena ho letto sui giornali che stava per essere proiettato anche in Italia “A complete unknown”, il film di James Mangold (regista americano nato il 16 dicembre, come me, ma nel 1963), mi sono informato sul primo giorno di proiezione previsto a Milano: il 23 gennaio, peraltro in un cinema molto vicino alla mia abitazione. Ma, ahimè, proprio quel giorno era previsto un mio intervento a Bologna in un convegno sulla “controriforma” della separazione delle carriere: impossibile mancare. Il 22 ho dunque acquistato via web il biglietto per il primo spettacolo del 24 gennaio, alle ore 14,30. Mi sono recato al cinema mezz’ora prima per evitare la prevedibile lunga fila. Ma – mostrato il biglietto alla persona addetta ai controlli – è esploso il dramma: non potevo entrare perché, causa un mio errore, il biglietto era per il giorno 25…inutile implorare comprensione!
Ed eccoci allora al pomeriggio successivo, primo spettacolo, posto centrale in terza fila, finalmente ci sono. L’ho visto poi una seconda volta, tre giorni dopo, ma in quarta fila e lo vedrò ancora una terza volta. Perché? Perché questo film è un capolavoro ed è comunque particolarissimo rispetto ai tanti che riguardano Dylan o che lo vedono protagonista principale o secondario. Penso subito a Pat Garrett e Billy the Kid”, di Sam Peckinpah (1973), interpretato da Kris Kristofferson, James Coburn, Rita Coolidge e Bob Dylan, nella parte del giornalista Alias (una figura inventata): la sua colonna sonora, ed in particolare il famoso brano Knockin’ on heaven’s door (di cui posseggo oltre 300 versioni di cantanti e gruppi di ogni Paese del mondo) ebbero un successo maggiore del film, il che non fu gradito a S. Packinpah. In Masked and Anonymous (2003), il menestrello di Duluth interpreta la rockstar Jack Fate, liberato di prigione apposta per tenere un concerto di beneficenza nel bel mezzo di un Nordamerica molto autoritario. Ma non si può dimenticare un capolavoro come Io non sono qui del 2007 (I’m not there) di Todd Haynes con sei diversi attori (Christian Bale, Cate Blanchett, Ben Whishaw, Marcus Carl Franklin, Richard Gere ed Heath Ledger), ognuno dei quali interpreta le parti in cui il regista divide la vita da artista e l’anima cangiante di Dylan, grazie a sotto-trame diverse che il film presenta con grande maestria.
Tra i docufilm su Bob Dylan, mi limito qui a citare i due di Martin Scorsese: No Direction Home: Bob Dylan (2005) e Rolling Thunder Revue (2019) che si concentrano sugli aspetti multiformi della vita e dell’arte del cantautore, mescolando realtà e fantasia. Martin Scorsese e Bob Dylan sono riusciti a regalare al pubblico una satira affascinante di tutti quei miti che le rockstar finiscono per trovarsi addosso.
Ritorniamo ora a “A complete unknown”. Bob Dylan è nato a Duluth (Minnesota) il 24 maggio 1941 ma il film, che nulla ci dice sulla sua famiglia e su come è nato il suo amore per la musica, si apre con il suo arrivo a New York nel 1961 (con il nome vero di Robert Zimmerman) e finisce dopo il Newport Folk Festival del 1965, ove il 27 luglio il menestrello impugna per la prima volta in un importante concerto la chitarra elettrica confondendo molti suoi fans ma sorprendendone altri positivamente.
Ma sia l’inizio che la fine del film hanno un altro protagonista: Woody Guthrie (interpretato da Scoot McNairy), gravemente malato per un morbo neurogenerativo, eroe di Dylan che lo va a trovare in un ospedale del New Jersey: nella stanza dov’è ricoverato canta per lui e conosce Pete Seeger che assiste il malato. Entrambi (Woody e Pete) riconoscono subito il suo talento – come avverrà poco dopo per Joan Baez - e Seeger lo aiuterà a diventare un fenomeno nei club del Greenwich Village e del centro di New York, quando Dylan “pratica” ancora la musica folk, pur interessandosi ad ogni diverso genere e studiando i diversi modi di suonare e cantare che man mano conosce.
“A complete unknown” non è dunque un film sulla vita intera di Dylan, perché ne narra poco meno di cinque anni, anni importanti per lui e per noi-
Tra le protagoniste, due bellissime attrici: Elle Fanning (che interpreta Sylvie Russo, il cui vero nome – Suze Rotolo – Dylan non ha voluto che si usasse nel film) e Monica Barbaro (che interpreta Joan Baez). È di gran classe il modo in cui il regista descrive il doppio amore di Bob per le due ragazze, la gelosia della prima e la fermezza della seconda, fino alla fine di quegli amori: il film evita qualsiasi scivolata voyeuristica, non c’è una scena di sesso ed i baci sono pochi ed immacolati. Anzi emergono evidenti i tratti duri di Dylan con le sue donne: a Joan Baez, che gli chiede un giudizio su un suo pezzo, risponde, lasciandola senza parole, che “le sue canzoni assomigliano ai quadri nello studio di un dentista”!
Ma anche la narrazione di soli 4/5 anni di vita può essere sufficiente – come in questo caso - a farci comprendere chi era e chi è Bob Dylan... questo film è infatti un inno alla sua libertà ed indipendenza, alla sua indifferenza rispetto agli interessi ed alle aspettative della società che lo circonda.
I film in cui si rievocano biografie di persone realmente esistite vengono chiamati anche biopic. Può essere tale un film che racconta solo cinque anni della vita del protagonista, peraltro famoso anche per la “scorbutica riservatezza” [2]?
Molti grandi artisti ne hanno scritto recensioni entusiaste, come Neil Young, il cui storico brano “Harvest”, costituiva la sigla della trasmissione sulla West Coast Music che ho condotto a Radio Taranto per alcuni anni. Neil Young – che ha un lungo passato di stima reciproca e di collaborazioni con Dylan con cui ha partecipato al celebre film - concerto "The Last Waltz" di Martin Scorsese nel 1978, eseguendo con lui il brano "I Shall Be Released"- ha detto: “Amo da sempre Bob Dylan e la sua musica. Questo film è un tributo meraviglioso alla sua vita e alla sua musica”.
Anche Bob Dylan ha espresso un giudizio positivo sul film, con particolare riferimento a Timothée Chalamet, il protagonista (che ha anche coprodotto il film). “Timmy è un attore brillante, quindi sono sicuro che sarà completamente credibile nei panni di me. O di un me più giovane. O di un altro me”. E secondo un importante critico del New Yorker” è stato capace di “indovinare in modo incredibile la voce e il modo di cantare di Dylan”.
Timothée Chalamet, che ha ringraziato il cantautore americano per le parole di apprezzamento nei suoi confronti, non solo si è calato nei panni del musicista, ma ha anche affrontato il ruolo dal vivo: le sue performance nel film includono decine di brani cantati e suonati in presa diretta, un’impresa che si preannunciava tanto ambiziosa quanto rischiosa.
Del resto, non c’è una sola canzone nel film che sia interpretata da Dylan o Joan Baez o da Pete Seeger in playback: tutto è cantato in modo perfetto dagli attori che, a partire da Chalamet, ne interpretano il ruolo.
A fare da contraltare alla giovane star, un cast di attori cantanti di alto livello: Edward Norton (proposto al golden globe quale migliore attore non protagonista) nei panni di Pete Seeger, figura chiave del movimento folk e testimone dell’impegno e delle tensioni sociali dell’epoca; Monica Barbaro nei panni di Joan Baez ed inoltre Scoot McNairy e Body Holbrook rispettivamente nei panni di Woody Guthrie e Johnny Cash.
Ottima la scelta di far scorrere i testi in italiano di tutti i brani che gli attori cantano. Tra l’altro, leggendo i testi dei brani di Bob Dylan, anche di quelli meno famosi, si può ben comprendere quanto meritata sia stata l’attribuzione a lui del Premio Nobel per la letteratura nel 2016.
Prima o (forse meglio) dopo aver visto il film, è da leggere il libro “Dylan Goes Electric !”, di Elijah Wald del 2015 da cui il film prende ispirazione. Il libro ricostruisce gli anni cruciali in cui il menestrello abbracciò l’elettricità, dividendo pubblico e critica e segnando uno dei punti di svolta più controversi nella storia della musica popolare.
“A Complete Unknown” si inserisce nella lunga tradizione di opere che rileggono la figura di Dylan, ma lo fa con un taglio particolare: unendo fedeltà storica e qualche licenza narrativa, ma il film mira a catturare l’essenza mutevole di un artista che ha fatto della reinvenzione di se stesso il suo manifesto[3].
Questo biopic è molto più di un semplice omaggio all’artista: un viaggio tra i miti del passato e le complessità del presente, con la musica come protagonista assoluta che rende il cinema capace di raccontare storie che risuonano oltre lo schermo.
Mangold ha dichiarato [4] che Dylan ha voluto incontrarlo dopo che la sceneggiatura era ormai conclusa. Dopo averla letta gli ha detto “mi piace”, dandogli anche qualche suggerimento. Mangold è riuscito a far emergere – come lui stesso dice – “l’atemporalità delle sue opere, ancora oggi parte integrante del tessuto americano”. Timothée Chalamet, invece, pur sperando che ciò avvenga, non lo ha mai incontrato: aveva quattro mesi per studiare e prepararsi ad interpretarlo, ma a causa della pandemia, quel periodo si è allargato fino a cinque anni così da permettergli di studiare l’uso della chitarra ed il canto. “Sapevo chi era Bob Dylan, ovvio, avevo sentito le canzoni più famose, ma conoscendolo di più mi sono innamorato profondamente della sua musica, poetica, emotiva fino a diventare devoto discepolo della Chiesa di Bob”.
È verissimo, tanto che, dopo avere visto il film ed al di là di quanto già sapevo, ho condiviso un altro giudizio di Chalamet quando ha affermato che ciò che lo affascina del giovane Dylan è “il fatto che abbia sempre creato arte senza compromessi, facendo quello che voleva..Pur essendo così giovane sapeva esattamente quello che voleva ottenere…si è fidato dell’istinto”. Chalamet ha cioè riproposto sullo schermo un artista già leggendario e ancora mitico perché la forza delle sue liriche hanno oggi la stessa attualità di 50/60 anni fa.
Chalamet ha saputo mostrare anche certi aspetti apparentemente negativi della personalità di Dylan (arroganza, troppo eccentrico, poco conciliante)?
Alla domanda Chalamet risponde che a lui invece “è parso soprattutto stimolante, provocatorio, liberatorio. Un eroe che dà vigore”[5].
Ecco perché ho già definito questo film un inno a quella libertà che ha caratterizzato la vita da artista (e immagino non solo quella) di Bob Dylan: rinunciando agli enormi guadagni che i produttori discografici gli proponevano, Dylan sceglieva da sé cosa e come suonare, i componenti dei gruppi che lo avrebbero accompagnato in concerti e registrazioni, sceglieva quando staccare la spina. E la vicenda del Newport Folk Festival di Newport del luglio del 1965 è emblematica: i produttori e musicisti storici (Pete Seeger incluso) che da anni organizzavano l’evento, lo supplicano – alla fine anche con rabbia - di suonare il folk cui il festival è da sempre dedicato, rinviando l’avventura lungo la strada del rock elettrico. Ma lui non molla di un metro: aveva già selezionato i componenti del gruppo che sarebbe salito sul palco lui e predisposto gli impianti che avrebbero amplificato il volume. Solo Johnny Cash lo sostiene e lo incoraggia.
Partono i suoi pezzi “rock-elettrici”: il pubblico, che lo ha accolto con entusiasmo ed applausi quando è salito sul palco, si divide sorpreso e ad uno spettatore che gli grida “traditore”, Dylan risponde “Non ti credo”.
Seeger tenta anche di tagliare i fili dell’amplificatore ma ad un certo punto i critici come lui iniziano a manifestare curiosità per quella storica svolta.
Dylan interrompe per poco ma ritorna sul palco ed “offre” a tutti “Like a rolling stone”, la canzone più importante nella storia del rock. Alla fine gli applausi superano fischi e proteste e Joan Baez, che ha assistito defilata alle sue performances, si avvicina a Bob Dylan, con cui da tempo ha rotto ogni rapporto sentimentale, lo guarda e gli dice, prima di girarsi ed andarsene via, che ha dimostrato di essere un uomo libero.
Ho visto due volte il film e per due volte mi sono emozionato sentendo T. Chalamet cantare “Like a rolling stone”.
Ho già comprato le versione in vinile rosso della colonna sonora del film (16 brani).

Ed ho già ordinato il relativo CD (23 brani): ci sono i pezzi che dimostrano l’amore di Dylan per il folk, per il blues, per il rock, per la musica popolare degli stati del Sud ed altro, ma anche quelli che rimandano al suo impegno sociale di quegli anni (anni in cui J. Kennedy era morto, Nixon avanzava e la guerra nel Vietnam si espandeva).
Nella colonna sonora c’è anche MASTERS OF WAR, con le cui parole Dylan auspica esplicitamente la morte dei fabbricanti d’armi.
E spero che moriate,
e la morte vi colga ben presto.
Seguirò la vostra bara
in un pallido meriggio,
resterò a vedervi calare
nel vostro letto di morte,
e rimarrò sul bordo della fossa
finché sarò sicuro che sarete proprio morti.
Pare che Joan Baez non abbia mai avuto il coraggio di eseguire l’ultima strofa di Masters of War, non se l’è mai sentita di cantare: “E spero che moriate”.
Comunque, occorre provare e riprovare a sentire quella musica e quelle parole cantate con la voce di Timothée… diventa per tutti una sfida specie guardando il volto di quel giovane che, come un moto perpetuo, canta nel Village cercando di capire gli altri e se stesso.
Ma il film sta ormai per finire: il giovane Dylan va ancora a trovare Woody Guthrie in ospedale ed ancora canta per lui, nonostante il divieto dell’infermiere. Woody se ne andrà il 3 ottobre del 1967.
Ultima scena del film: Dylan, in motocicletta, lascia l’ospedale ed esce dal campo visivo. Dove starà andando? Già verso il futuro che lo porterà fino al Nobel?
Non si può dire! Anni dopo, Joan Baez racconta che provò a parlare con lui della interpretazione che lei dava delle sue canzoni, ma Dylan le disse: “Sai, quando creperò, la gente darà sicuramente un’interpretazione di merda delle mie canzoni. Interpreteranno ogni fottuta virgola. Ma loro non sanno cosa vogliono dire le mie canzoni. Merda, non lo so neanche io”.
Difficile uscire dalla sala cinematografica mentre scorrono i titoli di coda accompagnati da tre pezzi storici.
Quali? Non ve lo dico.
---===oOo===---
Postfazione:
Non ho mai nascosto di essere un appassionato amante di tutto ciò che Bob Dylan canta, suona, scrive e forse pensa. Spesso ho scritto su di lui, anche presentando suoi concerti o con recensioni successive. La mia passione per Dylan si è però arricchita nel tempo grazie ai racconti della sua amica Fernanda Pivano, nonché partecipando a vari eventi dedicati al “menestrello di Duluth”: ad es., nel cortile del carcere di Lodi (2009), quando parlai a detenuti e cittadini del mitico Billy the Kid e di “Knockin’ on heaven’s doors”; nell’università Cattolica di Milano (2011), nella storico Liceo O. Flacco di Bari (2011), nel festival della letteratura a Bologna (2019), e nell’aula magna del Palazzo di Giustizia di Torino (nel corso di un convegno di formazione organizzato dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati su “L’ingiustizia nella parole di Bob Dylan”). Sempre a Torino, nel marzo del 2017, ho presentato il film “I’m not there” di Todd Haynes. Ho visto moltissimi concerti di Bob Dylan in tante parti del mondo (in Italia non credo di averne perso alcuno) e ammirato raccolte di sue opere visive (disegni, dipinti sculture), studiando decine di libri che riguardano lui e la sua musica. Soprattutto, ho più volte trattato il tema della giustizia e quello della ingiustizia nelle canzoni di Bob Dylan, anche con un contributo al volume “Giustizia e letteratura I”, a cura di Gabrio Forti, Claudia Mazzuccato, Arianna Visconti, con il Gruppo di Ricerca del Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale (Vita&Pensiero, 2012). Proprio il prof. Gabrio Forti spiegò le ragioni del convegno nella Cattolica di Milano del 14 gennaio 2011: “Sono i testi che devono essere studiati e che devono parlare. Essi fanno venire alla luce i fermenti elettivi”. “E quindi – aggiungeva – non chiudiamoci nei recinti del tecnicismo giudiziario”. Ecco perché raccomando a coloro che si avvicinano a Dylan di riuscire ad essere visionari come lui e di usare soprattutto anima e cuore per “tentare di capire” le sue parole e la sua musica. La mente serve meno e lo stesso Dylan non direbbe a nessuno qual era il senso vero dei suoi brani, anzi negherebbe che ve ne sia alcuno. Come Magritte ha fatto con le sue immagini. Il modo di pensare di Dylan, comunque, alla fine influenza i suoi fedeli: nel New Mexico, più di trent’anni fa, avevo cercato la tomba di Billy The Kid nella zona indicata nelle guide, ma pare fosse stata nel frattempo spazzata via dal fiume. In fondo meglio così: nei miei ricordi lo avrei collocato in un posto preciso, mentre lui è dovunque, in ogni parte del mondo e la gente conosce il suo nome, meno quello dello sceriffo suo assassino.
Ciò che di Bob Dylan mi ha sempre affascinato sono stati la sua spasmodica attenzione per l’umanità negletta, il suo inno alla solidarietà tra e verso i deboli; l’esaltazione delle regole che, come le sue parole ci ricordano, sembrano rispettate più dai disperati che da coloro che normalmente definiamo “onesti”. Si tratta, in fondo, di un modo originale di parlare di giustizia. Se Dylan urla che “non c’è un solo uomo giusto” (Ain’t no man righteous, no not one, 1979) è perché ci sogna tutti giusti; se denuncia la giustizia forte coi deboli e debole con i potenti (The lonesome death of Hattie Carroll, 1963) è perché la vorrebbe eguale per tutti. E così ogni sua parola, alla fine, rimanda alla giustizia. La giustizia sociale che invoca chi è respinto dalla metropoli in cui si era trasferito carico di sogni e speranze (Talking New York, 1961) o la giustizia dei Tribunali che spetta a coloro che sono uccisi e torturati per il colore della pelle (The death of Emmett Till,1962) o perché semplici immigrati clandestini. Ma Bob Dylan non si limitò a cantare la giustizia: la praticò con impegno. Fu parte del movimento che, sull’onda della sua Hurricane (1975), ottenne la revisione della condanna per triplice omicidio del pugile nero Rubin Carter e la sua scarcerazione dopo 22 anni di ingiusta detenzione. Dylan lo andò a trovare in carcere, volle conoscere e capire con ostinazione e poi battersi per lui. Non dovrebbero farlo oggi, a difesa della giustizia, tutti gli italiani di buona volontà? Se avessero dubbi, consiglio loro di meditare su queste parole: “E un uomo quante volte può voltarsi e far finta di non avere visto?” (Blowin’ in the wind, 1962). Ed a quanti preferiscono il comodo quietismo per sé anzichè l’impegno per tutti domando, sempre con Dylan, “Cosa mai ci vuole per trovare dignità”? (Dignity, 1994)
E, per finire con questa postfazione, oltre che per giustificare il mio interesse da magistrato per Bob Dylan, mi piace ricordare che Robert Siegel (giornalista e regista newyorkese), in una intervista chiese a Dylan, partendo dalle numerose citazioni di sue parole che figurano in sentenze della Corte Suprema americana, “quante volte può un giudice citare una canzone di Dylan per illustrare qualche punto oscuro di diritto? E quante volte può farlo un avvocato nell’interesse del suo cliente? ” La risposta di Dylan fu “186 volte !”.
[1] Al termine di questo articolo sono leggibili alcune notizie che servono a spiegare la mia “insana ed acritica passione” (come l’ho sempre definita) per Bob Dylan.
[2] Parole di Paolo Mereghetti (Il Corriere della Sera, 18.1.25).
[3] Parole di Claudio Fabretti (Onda Rock, 13.1.2025).
[4] “Il Venerdì” di Repubblica del 10.1.2025.
[5] Intervista ad Alesasandria Venezia su “Io donna”.