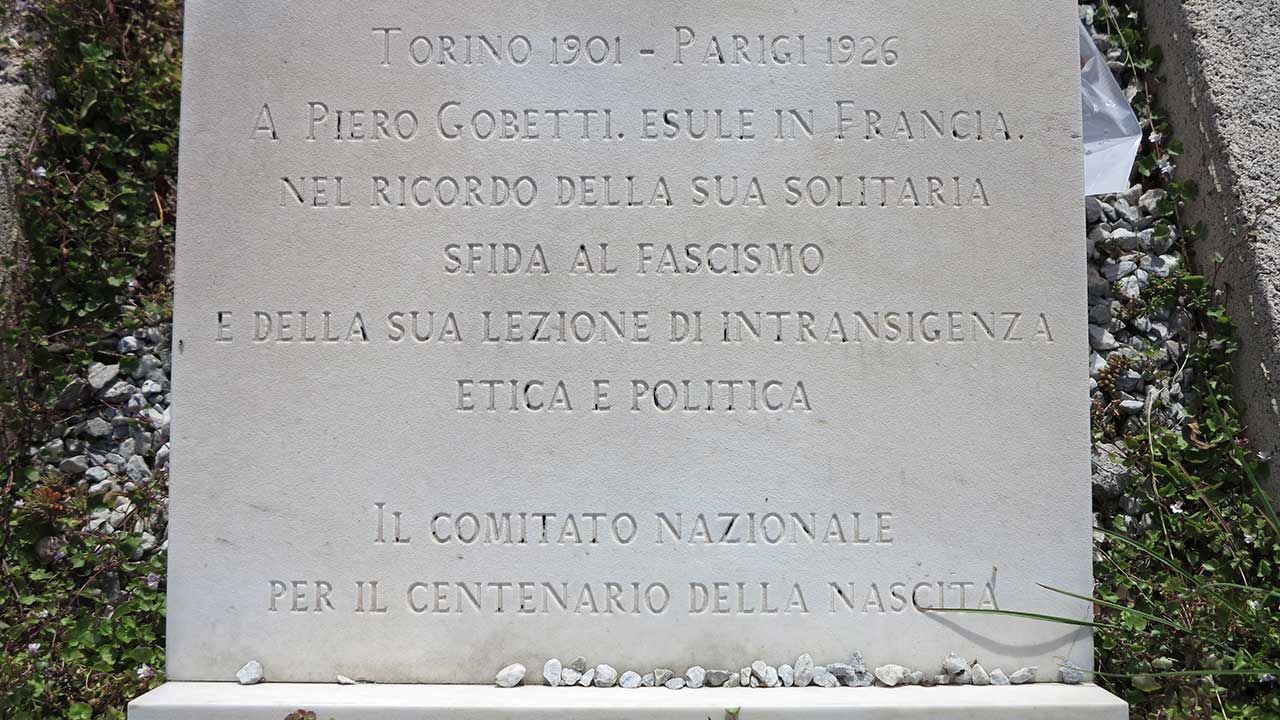È un bel dire che gli uomini si differenziano dagli altri animali per le capacità logiche.
Molti e importanti studiosi attribuiscono anche ai nostri parenti stretti la facoltà di apprendere e generalizzare sulla base dell’esperienza. Il fatto è che l’uomo intanto è tale in quanto non solo apprende, codifica ed elabora, ma anche conserva, modifica ed è in grado di recuperare pure quello che pensava di aver dimenticato.
Grande miracolo la memoria! Se uno riflette, si rende conto che l’uomo è l’unico essere a potersi definire historicus, proprio perché solo lui, e non gli altri animali, è in grado di recuperare il suo passato, di attingerlo, aprendo quello scrigno con chiavi del tutto originali che ne rendono possibile la lettura.
È necessario, infatti, distinguere la memoria individuale da quella collettiva.
Sul piano soggettivo essa è alimentata da esperienze e stati d’animo, da rappresentazioni acquisite o in via di acquisizione; sul piano sociale la memoria collettiva diventa necessariamente storia.
Il pestaggio e la morte di G. Matteotti sono storia dolorosa e presente come non mai nel vissuto del nostro Paese.
Fin da giovane egli aveva aderito al socialismo e nel 1922, espulso dal partito socialista italiano, con i riformisti ancora vicini al pensiero di Filippo Turati, contribuì alla fondazione del partito socialista unitario e ne divenne segretario. Nel periodo della sua formazione culturale e politica aveva sicuramente individuato i limiti delle costruzioni teoriche del socialismo ottocentesco e condiviso la critica marxiana alle astrattezze ideologiche di quei socialisti utopisti del tutto incapaci di un’analisi scientifica delle condizioni reali delle società esistenti e perciò incapaci di individuare gli strumenti idonei a modificarle.
Già nel 1921 Matteotti aveva pubblicato una “Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia” pienamente consapevole che l’ordine e la ripresa economica e sociale dell’Italia dopo la guerra non potevano realizzarsi con l’arma dello squadrismo e della repressione di ogni forma di dissenso. Sicuramente una risposta a tutti coloro che giustificavano squadrismo e repressione dopo il biennio rosso che tra il 1919 e il 1920 aveva coinvolto nella lotta politica masse di operai e contadini fino all’occupazione delle fabbriche dall’agosto al settembre del 1920 che ne segnò, insieme, l’apice e la fallimentare conclusione. Tanto che Giorgio Amendola nella sua Intervista sull’antifascismo comparsa nel 1976 definisce biennio rosso-nero quel periodo perché in esso si ebbe un processo di radicalizzazione a sinistra e di corrispondente reazione a destra.
Certo, è ormai opinione quasi del tutto condivisa che non vi era mai stato il pericolo reale di una rivoluzione proletaria: nessuno l’aveva promessa e nessun partito avrebbe potuto guidarla.
La classe operaia ne uscì sconfitta e le classi padronali avevano ricevuto “la scossa di chi è stato rasentato dalla morte”.
Così il fascismo diventò un partito e il partito dell’ordine che, per dirla con Benedetto Croce, una volta “normalizzato” avrebbe garantito il ritorno ad un forte e rinnovato stato liberale. Il grande filosofo dei “distinti” mantenne una posizione di attesa e di fiducia anche quando nel 1923 fu votata la legge Acerbo che attribuiva i due terzi dei seggi alla lista di maggioranza relativa e in vista delle elezioni del maggio 1924 nacque il Listone, ovvero un’alleanza larga che si poneva al di sopra dei partiti: ne fecero parte liberali come Salandra, nazionalisti, monarchici, ex popolari.
I fascisti ottennero il 65% dei voti e tra le opposizioni solo i popolari ebbero una tenuta elettorale.
Il 30 maggio G. Matteotti denuncia i brogli elettorali e nel suo famoso discorso (che i giovani dovrebbero leggere e commentare a scuola e in famiglia), chiede formalmente alla Camera di non convalidare le elezioni avvenute.
Il 10 giugno viene rapito, pestato a sangue e ucciso da cinque squadristi al comando di Amerigo Dumini.
Sepolto in un bosco a pochi chilometri da Roma, il corpo fu ritrovato circa due mesi dopo il 16 agosto 1924.
La risposta delle opposizioni all’assassinio di Matteotti fu l’abbandono dei lavori parlamentari, la cosiddetta secessione dell’Aventino, con la speranza che la protesta potesse suscitare la reazione morale del Paese. Gramsci e i comunisti ritennero del tutto improbabile sul piano politico una protesta morale senza la mobilitazione delle masse.
Non ci fu né l’una né l’altra e col discorso del 3 gennaio del 1925 il fascismo, per dirla con Renzo de Felice, diventò un vero e proprio regime.
Tutto il percorso verso il consolidamento del regime con le leggi fascistissime, parte da quel pestaggio, da quel supplizio, da quel corpo sfigurato e restituito ormai decomposto come un Cristo privo di sudario.
Nell’attuale temperie storica è possibile che si instaurino sistemi autoritari attraverso il pestaggio, la repressione violenta del dissenso, perfino l’assassinio politico?
È davvero morta la bella utopia, quella che ogni cittadino della polis deve coltivare per trasformare e migliorare il mondo in cui vive?
I sistemi democratici sono in grado di arginare la spinta delle destre autoritarie?
Ritorna la lezione di K. Popper contenuta ne “La società aperta e i suoi nemici”, un testo scritto tra il 1944/ 45 mai come oggi tanto attuale proprio perché l’autore rifiutava gli schemi rigidi, i sistemi pre-costruiti, in una parola gli archetipi. Quelli che si sono nutriti di tali pensieri guardano con dolore alla società contemporanea aperta solo in apparenza, un mondo in cui si afferma la legge del più forte come se fosse la più naturale delle soluzioni, in cui la sopraffazione e l’ingiustizia producono guerre e lutti senza fine. H. Marcuse negli anni ’60 rifletteva sulla “fine dell’utopia”. Si trattava. allora, per il filosofo francofortese di dare forza e concretezza ai movimenti giovanili.
Oggi, forse, si tratta di trasformare in azione politica concreta le istanze che provengono non solo dai giovani consapevoli, ma da tutti quei movimenti che pongono al centro delle rivendicazioni i problemi reali del sottosviluppo, delle emarginazioni, delle ingiustizie sociali.
I sistemi democratici non nascono una volta e per sempre, vanno costruiti e ricostruiti ogni giorno.
E ciò vale ancor più quando assistiamo a manifestazioni di intolleranza e di conflittualità tra istituzioni e società civile.
M. Weber ne “La politica come professione” scrive che c’è una differenza assoluta tra l’agire secondo convinzione e l’agire secondo responsabilità. Nel primo caso chi opera si preoccupa appunto dei principi in base ai quali agisce e non si cura allo stesso modo delle conseguenze del suo agire; nel secondo caso chi agisce guarda contemporaneamente agli effetti prevedibili dell’azione e se ne assume la responsabilità. Dunque i politici in modo particolare dovrebbero informare le proprie scelte e le azioni conseguenti ai principi costituzionali e all’etica della responsabilità. Non che sia pacifica e semplice questa sintesi.
S. Hampshire in “Non c’è giustizia senza conflitto” partendo dall’assunto di Eraclito: "[…] occorre sapere che la giustizia è conflitto[…]” sostiene che la conflittualità, cioè l’ambivalenza è propria dell’anima umana ed è propria della città. Posto che la giustizia è l’armonia delle parti e degli elementi ed essa è imposta dalla ragione, si tratta di vedere come operativamente si possa superare il conflitto. Il filosofo invoca per il superamento di ogni controversia procedure concordate e istituzionalizzate che sostituiscano la forza bruta, il dominio, la tirannia. Secondo il filosofo analitico inglese il problema irrisolto del nostro tempo è la relazione tra due tipi di società: da un lato la società e i governi consapevolmente tradizionali in cui preti, rabbini, imam o mullah ed altri esperti del volere divino mantengono e impongono un unico pensiero e le società e i governi democratici che permettono la pluralità dei pensieri e dei punti di vista.
Ora proprio i paesi democratici possono pretendere che debba esistere un’unica concezione “buona” dei valori, cioè la propria?
L’articolo 17 della nostra Costituzione recita che i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi; l’articolo 21 aggiunge che tutti i cittadini hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
In una democrazia matura non sarebbe dovuto accadere quello che è accaduto ultimamente nelle strade di Pisa e Firenze dove giovani liceali a volto scoperto, con lo zaino in spalla e le belle utopie nel cuore manifestavano liberamente, sicuri di essere protetti e non barbaramente manganellati. È intervenuto, sdegnato, il Presidente della Repubblica rivolgendosi al Ministro degli Interni: "con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”. E il Ministro: "cortei non autorizzati. Abbiamo difeso il Consolato Usa e la Sinagoga".
Da chi? Si domanda il cittadino italiano, da chi dobbiamo difenderci?
Dalla partecipazione alla vita pubblica, dall’entusiasmo in parte ritrovato dei nostri giovani, dobbiamo forse difenderci dal dissenso?
Il pestaggio e il sangue sul viso di quei ragazzi sono il vecchio-nuovo segno del nostro tempo?