
GIUSTIZIA INSIEME
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2974-9999
Registrazione: 5 maggio 2023 n. 68 presso il Tribunale di Roma
Note minime sulla questione del travisamento della prova nel ricorso per cassazione*
di Marco Dell’Utri
È a me affidato il compito di presentare o illustrare, in termini sintetici, il tessuto o le linee di ragionamento che possono riconoscersi nelle diverse pronunce della Corte di cassazione civile che hanno ammesso la rilevabilità, come vizio di legittimità, del travisamento della prova.
Cercherò di assolvervi sottraendo solo pochi minuti della vostra attenzione.
È stato rappresentato, in modo che a me pare molto brillante ed efficace, il perimetro entro il quale si muovono le questioni su cui siamo chiamati a riflettere.
Si tratta, dunque, di esaminare, dalla prospettiva del giudice di legittimità, il rapporto tra il giudice di merito e la prova e, in modo più specifico, quel particolare impegno, cui il giudice di merito è chiamato, di ricavare, dai mezzi di prova acquisiti al processo, le informazioni probatorie destinate a sostenere la decisione che verrà assunta.
La regola sulla quale il giudice di legittimità misura il senso della propria diversità, rispetto al giudice di merito – ed è una regola sulla quale non mette conto più di discutere, a scanso di ogni possibile equivoco – è quella per cui deve escludersi alcuna possibilità, per il giudice di legittimità, di porre a oggetto del proprio esame il modo attraverso il quale il giudice di merito ha discrezionalmente operato le proprie scelte sul significato da attribuire ai mezzi di prova esaminati: si tratta di una prerogativa propria del giudice di merito, rispetto alla quale la Corte di cassazione, quale giudice di legittimità, difetta di alcuna attribuzione.
Il tema della denunciabilità, in sede di legittimità, del travisamento della prova, nella misura in cui si situa all'interno di questo rapporto tra il giudice di merito e il mezzo di prova, è propriamente chiamato a dirimere questa apparente aporia: se al giudice di legittimità è inibita la possibilità di sindacare il modo attraverso il quale il giudice di merito ha valutato la prova; e se il travisamento della prova è propriamente un giudizio sul modo in cui il giudice di merito ha assunto le sue determinazioni sul significato da attribuire alla prova, come sarà mai possibile, per il giudice di legittimità riconosce rilevanza a detto travisamento?
Nel porre questa domanda, non a caso ho inteso contrapporre all'impossibilità, per il giudice di legittimità, di sindacare la valutazione della prova fatta propria dal giudice di merito, l'eventuale rilevanza, come vizio di legittimità, del travisamento come giudizio sul modo in cui il giudice di merito ha assunto le sue determinazioni sul significato da attribuire alla prova.
Lo spazio che si apre al tema del travisamento della prova in sede di legittimità sta proprio qui: ossia, nell'assumere, da parte del giudice di merito, talune determinazioni sul significato di una prova che non sono una valutazione della prova.
Credo che questo punto costituisca propriamente il cuore della divisione su cui le diverse sensibilità o attitudini della Corte di cassazione civile faticano a incontrarsi.
Per comprendere questo aspetto (ossia la domanda se “ci sono attribuzioni di significato a una prova, che non sono una sua valutazione?”) credo che occorra porsi la seguente domanda: può il giudice di merito legittimamente attribuire, a un mezzo di prova, qualunque significato? Può il giudice di merito, ad esempio, pretendendo con ciò di operare una valutazione discrezionale legittima, affermare che una fotografia che riproduce un'automobile fornisca (non già l’immagine di un trattore, di un quad, di un trabiccolo a quattro ruote, etc., dunque di qualcosa che mantiene un legame razionalmente spiegabile con la figura di partenza, bensì) la riproduzione di un fiume?
Il carattere banale o paradossale dell’esempio – per cui occorre che mi scusi, per quanto la stilizzazione aiuti a semplificare o schematizzare il ragionamento – varrà ad evidenziare (come sotto la lente di un microscopio) uno spazio che, seppur minimo, purtuttavia si apre, tra la valutazione discrezionale del significato di un testo (genericamente inteso) e ciò che, di quello stesso testo, non può più costituire, giuridicamente, una valutazione.
Si sostiene: si tratterebbe di una ricostruzione dei fatti incontrastabilmente contraddetta da quanto risultante dagli atti e, dunque, suscettibile di essere censurata in sede di revocazione (art. 395 n. 4 c.p.c.); a patto, tuttavia, (lo afferma lo stesso art. 395 n. 4 c.p.c.) che il giudice non abbia espressamente giudicato sul contrasto eventualmente insorto tra le parti circa il significato di quella fotografia automobile/fiume.
Se, infatti – si osserva – il giudice di merito avesse espresso la propria valutazione su tale contrasto, decidendo sul rapporto automobile/fiume, (verosimilmente, il 999 per mille delle volte riconoscendo l'automobile, l'1 per mille delle volte continuando imperterrito a riconoscere il fiume) avrebbe comunque valutato la prova e, dunque, tale valutazione sarebbe in ogni caso non più censurabile, in sede di legittimità, sulla base della regola che abbiamo inizialmente posto come indiscutibile; e ciò, soprattutto, a seguito della soppressione del vizio di motivazione (se non nel caso-limite della motivazione non costituzionalmente giustificabile).
Dobbiamo, dunque, affermare che la parte che si sia vista dar torto dal giudice di merito che avesse riconosciuto espressamente, nella fotografia dell'automobile (e nel contrasto sul punto intervenuto tra le parti), la riproduzione fotografica di un fiume, non possa più contestare questa decisione, poiché in sede di legittimità la valutazione della prova fatta propria dal giudice di merito non è consentita; quella decisione, quindi, non sarebbe affatto illegittima (la motivazione infatti, avrebbe una sua logica interna, non denunciabile ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c.), dovendo ritenersi, semmai, o al più, una decisione ingiusta.
Ma siamo proprio sicuri di dover riconoscere come legittima l'assoluta e piena libertà del giudice di merito di attribuire a una prova tutti i significati che ritiene arbitrariamente di potergli attribuire? Il potere di valutazione del giudice di merito è una libertà assoluta o è, invece, un potere discrezionale? (non dimentichiamoci che l’art. 116 c.p.c., proprio con riguardo alla valutazione delle prove, parla di ‘prudente apprezzamento’).
Esiste una distinzione tra la libertà interpretativa che riconosciamo, ad esempio, all’interprete di un'opera d'arte, rispetto al potere (discrezionale) interpretativo che il giudice di merito ha nell'attribuire un significato a un mezzo di prova?
Il riferimento al tema dell’interpretazione artistica non deve suonare eccentrico, o dominato da intenti d’indole puramente retorica, rispetto al discorso che si viene svolgendo, se solo si pensi alla ricchezza e alla fecondità delle pagine dedicate da Emilio Betti al tema dell’ermeneutica artistica nei passaggi che si ascrivono alla sua teoria generale dell’interpretazione, sovente proprio nel contrasto con Hans Georg Gadamer proprio a proposito dell’interpretazione artistica come ‘modello’ di approccio conoscitivo.
L’interprete di un'opera d'arte avrebbe buon gioco, ad esempio, dinanzi alla nostra fotografia dell'automobile, a vedere rappresentata mirabilmente, attraverso il mezzo inventato dalla scienza e dalla tecnologia contemporanee, l'idea (magari di stampo futurista) del ‘movimento’, del fluire dello spirito delle cose, di quell'antico ‘tutto scorre’ (proprio come un fiume) che il presocratico Eraclito aveva intuito quale essenza profonda delle cose, e che aveva esemplificato nell'impossibilità di bagnarsi due volte nella stessa acqua di uno stesso fiume.
Dunque, la rappresentazione di quell’automobile null’altro sarebbe se non la (simbolica) rappresentazione del ‘fiume eracliteo’.
E, tuttavia, per arrivare a questa conclusione, l’interprete dell'opera d'arte deve necessariamente avvalersi dell'uso della metafora, della libertà dell’associazione simbolica; deve introdurre, nel rapporto con il testo artistico (o, meglio, interpretato in chiave artistica), il libero gioco (necessariamente ‘arbitrario’) del proprio mondo interiore e delle proprie esperienze intellettuali.
Ma il giudice di merito alle prese con un testo probatorio dispone della medesima libertà? Potrebbe davvero usare liberamente la metafora, l'associazione simbolica, arricchire la lettura del testo con l’introduzione arbitraria del proprio mondo interiore e di proprie particolari esperienze intellettuali?
La risposta negativa a questo interrogativo (di per sé evidente, per la radicale diversità di prospettive e di finalità dei due approcci ermeneutici) ci riporta a voci di un vocabolario o a nozioni elementari più consuete del linguaggio giuridico: la discrezionalità, che è il tratto di ogni ‘funzione’ regolata da norme giuridiche, non è (e non può essere) la libertà dell’arbitrio; e dunque, la valutazione discrezionale di un testo probatorio ha dei confini, che sono propriamente identificabili con il perimetro di tutti i significati possibili di un testo che rispondano a una logica spiegabile (meglio sarebbe dire ad una logica ‘aperta alla condivisione collettiva’), ossia (per tornare al nostro testo probatorio), con il perimetro all’interno del quale trovano posto tutte le informazioni probatorie della cui congruità, rispetto al mezzo di prova esaminato, è possibile rendere conto in termini logico-razionali (naturalmente, di una logica e di una razionalità aperte alla condivisione collettiva e orientate in termini argomentativi).
Al di fuori di quel perimetro (disegnato, occorre ripetere, dagli imperativi della logica e del ragionamento argomentativo), le scelte del giudice (nell’attribuzione di significati al testo) non costituiscono più l’esercizio di una valutazione discrezionale, ma sono solo l’esplicazione di un imprevedibile e incontrollabile arbitrio (ossia di un arbitrio destinato a seguire una logica del tutto interna e autoreferenziale); un arbitrio in forza del quale sarebbe possibile inventare qualunque significato dei testi probatori disponibili; testi che, da ‘base’ di un ragionamento logico, diverrebbero mero ‘pretesto’ di un sogno intellettuale: si tratterebbe, né più né meno, di ‘inventare prove’.
E quando il giudice ‘inventa’ una prova, non sta più valutando il mezzo probatorio sottoposto al suo esame: lo sta ‘creando’ (si vorrebbe dire d'ufficio), non avvedendosi dell’evidente errore che stravolge completamente, travisandola, la ricognizione del contenuto (che ambisce a porsi come) oggettivo del mezzo di prova esaminato.
E quando il giudice ‘crea’ una prova (d'ufficio) contro la legge sembrerebbe proprio porsi in contrasto con la regola per cui: "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”: si tratta della regola (giuridica) contenuta nell’art. 115 c.p.c.
Si tratterebbe, dunque, di una decisione radicalmente e irriducibilmente infedele al processo per effetto della violazione di una norma giuridica.
La decisione del giudice di merito fondata sul presupposto che la fotografia di un'automobile ritragga un fiume, dunque, non è (solo) una decisione ingiusta: è propriamente una decisione illegittima, ossia resa in violazione di una specifica norma processuale; e al giudice di legittimità deve riconoscersi il potere di rilevarlo.
Le sentenze della Corte di cassazione che hanno ragionato secondo questo schema, credo si siano limitate al rilievo di questo vizio elementare (per quanto verosimilmente molto raro), aggiungendo unicamente, ai fini della rilevanza della censura, la necessità che l’istante che denunci tale vizio, oltre a dimostrare l’impossibilità di ricondurre al testo probatorio (neppure in modo indiretto) l’informazione che il giudice di merito ha ritenuto di trarne (secondo i termini di quella logica argomentativa prima descritta), dimostri altresì che l'errore denunciato, ove corretto, valga a condurre a una decisione certamente allo stesso favorevole: si tratta, in tal senso, di conferire rilievo a quel carattere di decisività della censura di legittimità, più volte richiamato anche a proposito di temi processuali di diversa natura.
Le massime che l’analisi critica dei colleghi dell’ufficio del Massimario hanno tratto, dalle nostre sentenze che si sono diffuse secondo il paradigma che ho cercato rapidamente di sintetizzare, mi pare restituiscano fedelmente il senso di quanto sin qui riportato.
Il timore – del tutto ragionevole e realistico – che l’adozione di tale prospettiva possa generare un uso strumentale del vizio del travisamento della prova, con il malizioso obiettivo di condurre il giudice di legittimità a tornare indebitamente sulla valutazione nel merito dei fatti di causa – e, dunque, la conseguente legittima preoccupazione di una moltiplicazione artificiosa dei ricorsi in sede di legittimità, non devono (né possono) indurci a legittimare un’obiettiva (ulteriore) limitazione del diritto delle persone di difendere le proprie ragioni nel processo, al solo scopo di sopperire alle sperimentate difficoltà del legislatore di governare e proporzionare, in modo più ragionevole, i flussi abnormi delle controversie condotte all’esame di una Corte Suprema.
Converrà peraltro considerare come, attraverso una severa vigilanza sui ricorsi e, soprattutto, attraverso un accurato self-restraint delle proprie asserzioni, il giudice di legittimità potrà incidere in modo significativo sul costume del foro, opponendosi con rigore ad ogni pretesa delle parti di indulgere ancora, in sede di legittimità, su temi di merito; ma senza tuttavia perdere, tra le maglie del controllo, forme palesi e inaccettabili di ingiustizia non adeguatamente sorvegliate in sede territoriale.
Si tratterebbe – per richiamare la fortunata formula – di non buttare via il bambino (dell’ingiustizia inaccettabile) assieme all’acqua ‘sporca’ (delle valutazioni di fatto).
Credo che questo specifico atteggiamento di fermezza sul senso di giustizia sia una conclusione da esaminare, non tanto (o non solo) alla stregua degli impulsi della propria coscienza civile (di cittadini, prima ancora che di giuristi), quanto piuttosto in forza di un più misurato equilibrio, se non proprio di una più meditata saggezza, nell’affrontare il senso elementare delle cose.
*Il testo riproduce l’intervento svolto, il 14 marzo 2023, nell’Incontro di studi organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione, dal titolo “Errare Humanum…Travisare Diabolicum. La questione del travisamento nel ricorso per cassazione”, tenutosi a Roma, nell’Aula Magna della Corte di cassazione.
Sommario: I. Introduzione - 1. Le riforme del 1997 e 2012 dell’amministrazione del sistema giudiziario e i tribunali ungheresi - 2. L’amministrazione degli organi giudiziari ungheresi - II. Percorso di accesso alla magistratura - 1. I requisiti prescritti dalla legge per l’ammissione al concorso - 2. Il procedimento del concorso per magistrato ordinario.
I. Introduzione
1. Le riforme del 1997 e 2012 dell’amministrazione del sistema giudiziario e i tribunali ungheresi
Negli anni ’90 per la riforma dei sistemi giudiziari nei paesi post-comunisti le circostanze erano favorevoli: con l’esperienza della dittatura appena passata e le intenzioni verso l'integrazione europea, tutti i legislatori dei paesi dell’Est Europa cercavano di creare un'organizzazione giudiziaria indipendente e istituire consigli giudiziari indipendenti, ponendo così la selezione dei giudici nelle mani dei giudici stessi.
L’Ungheria con la riforma del 1989 ha compiuto una transizione verso un regime democratico, tale riforma ha consentito al sistema ungherese di passare da un modello di amministrazione della giustizia di tipo ministeriale ad uno compiutamente consiliare. L’articolo 50 della Costituzione del 1989 ha previsto l’istituzione del Consiglio Giudiziario Nazionale[1], effettivamente introdotto dalla legge sull’Organizzazione e l’amministrazione delle corti del 1997[2]. Con la transizione ad un sistema democratico la titolarità delle competenze che hanno ad oggetto lo status dei giudici, ad. es. reclutamento, promozioni, retribuzione, responsabilità, sono state trasferite dall’esecutivo ad un organo indipendente a composizione mista di membri togati e laici. L’adesione al modello consiliare ha consentito al sistema ungherese di soddisfare gli standard internazionali ed europei relativi all’indipendenza della magistratura[3].
La seconda riforma generale della magistratura é avvenuta con l’entrata in vigore della nuova Costituzione, la Legge Fondamentale, nel 2012[4]. La riforma della magistratura ha rappresentato un elemento centrale del processo di mutamento con il quale é stato introdotto un sistema ’ibrido’[5]. Si prevede l’istituzione di un Ufficio Nazionale per la Magistratura[6], presieduto da un giudice nominato a maggioranza assoluta dal Parlamento, al quale la nuova Costituzione attribuisce 'le responsabilità fondamentali dell’amministrazione delle corti ordinarie’, limitando il ruolo del Consiglio Giudiziario Nazionale[7] ad una funzione di mero controllo dell’amministrazione centrale, di cui risulta titolare il Presidente dell’Ufficio Nazionale. Tale assetto costituzionale rivela la volontà politica di introdurre un sistema organizzativo ’ibrido’, caratterizzato dalla coesistenza tra un organo di nomina parlamentare e un rappresentante della magistratura, all’interno del quale le funzioni che più incidono sullo status dei giudici, e.g. decisioni su carriere, trasferimenti, nomine, giudizi disciplinari dei magistrati, siano attribuite in via esclusiva al primo, relegando il secondo a funzioni meramente consultive e di controllo[8].
La ridefinizione dell’assetto istituzionale avvenuta a livello costituzionale trova conferma anche a livello legislativo, al quale la ‘Costituzione nuova’[9] rinvia per la concreta attribuzione ai due organi citati delle funzioni in materia. Dalla legge organica n. 61 del 2011 è stata realizzata un’assoluta concentrazione in un organo monocratico – il Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura – di tutte le competenze relative allo status dei giudici, alla organizzazione e al budget degli uffici giudiziari. Allo stesso tempo, la legge declina la partecipazione all’amministrazione della giustizia da parte del Consiglio Giudiziario Nazionale in termini esclusivamente accessori rispetto alle funzioni attribuite al Presidente.
Rispetto a questa ultima riforma complessa del sistema giudiziario ungherese la Commissione di Venezia ha espresso valutazioni fortemente critiche[10]. In particolare, la Commissione ha affermato che la concentrazione di poteri in un organo monocratico e la contestuale compressione del ruolo del Consiglio non solo finiscono con il contraddire gli standard europei in materia di organizzazione della giustizia, relativi al rispetto dell’indipendenza dei giudici, ma risultano difficilmente compatibili anche con la tutela effettiva del diritto a un processo giusto garantito dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo[11]. L’indipendenza del sistema giudiziario e dei giudici ungheresi é ancora un oggetto molto importante del dialogo in corso relativo allo stato di diritto tra la Commissione Europea e il Governo ungherese.
2. L’amministrazione degli organi giudiziari ungheresi
L’amministrazione centrale dei tribunali è di competenza del Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura, coadiuvato dai vicepresidenti. L’operato amministrativo del Presidente è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale Giudiziario. Il Presidente dell’Ufficio è responsabile del funzionamento e dell’efficienza dell’amministrazione centrale, deve assicurare che quest’ultima, come previsto dalla legge, svolga le proprie mansioni nell’osservanza del principio costituzionale dell’indipendenza giudiziaria. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente adotta decisioni, regolamenti e raccomandazioni. Il Presidente dell’Ufficio è eletto dal parlamento nazionale – a maggioranza dei due terzi dei deputati – su proposta del Presidente della Repubblica e la carica può essere rivestita soltanto da un giudice.
Il Consiglio Nazionale esercita la vigilanza sull'amministrazione centrale dei tribunali ed è composto da 15 membri. Ne fa parte d’ufficio il Presidente della Corte suprema mentre gli altri 14 giudici sono eletti da e tra i membri dell’assemblea dei giudici delegati.
In Ungheria la giustizia è amministrata dai seguenti organi giudiziari:
- la Corte suprema (Kúria),
- le corti d’appello regionali (5),
- i tribunali regionali (20),
- i tribunali locali (107) e distrettuali (secondo i distretti di Budapest (6))
La competenza giurisdizionale dei tribunali corrisponde in generale alle suddivisioni amministrativo-territoriali del paese. I tribunali locali in campagna e distrettuali a Budapest esercitano la loro giurisdizione in primo grado per i casi civili e penali, e giudicano in composizione monocratica. I tribunali regionali si occupano dei casi civili, penali, amministrativi e del lavoro in primo grado, ove previsto in tal senso dalla legge, e decidono sui ricorsi in appello presentati contro le sentenze dei tribunali locali e distrettuali. I tribunali regionali in primo grado giudicano in composizione monocratico e in secondo grado in composizione collegiale di tre giudici.
Le Corti d’appello regionali si occupano dei ricorsi in appello presentati contro le decisioni dei tribunali regionali, sono composte dalle divisioni penale, civile, amministrativo, lavoro e giudicano in composizione collegiale di tre giudici.
Il titolare dell’amministrazione dei tribunali e delle corti è sempre il presidente, e ogni tribunale regionale e corte d’appello ha il suo consiglio giudiziario e la seduta plenaria.
La Corte suprema, con sede a Budapest, è la massima autorità giudiziaria in Ungheria, che garantisce l’uniformità di applicazione del diritto da parte dei tribunali e, a tal fine, adotta decisioni di armonizzazione del diritto che sono vincolanti per tutti i tribunali. Il presidente della Corte suprema è eletto dal parlamento nazionale – a maggioranza dei due terzi dei deputati – su proposta del Presidente della Repubblica. La carica di presidente della Corte Suprema può essere rivestita soltanto da un giudice. La Corte Suprema esamina (nei casi previsti dalla legge) i ricorsi presentati contro le decisioni dei tribunali e delle corti di appello regionali, esamina le istanze di revisione, adotta decisioni di uniformità vincolanti, esamina la giurisprudenza che emerge dalle cause definitivamente chiuse, analizza e riesamina la prassi giurisprudenziale dei tribunali, pubblica decisioni e risoluzioni in materia di principi giuridici. É composta da collegi giudicanti e collegi preposti all’armonizzazione del diritto e da sezioni penale, civile e amministrativo.
La Corte Suprema è indipendente dall’amministrazione del Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura, la sua amministrazione compete al Presidente della Corte Suprema, nominato a maggioranza assoluta dal Parlamento.
II. Percorso di accesso alla magistratura
1. I requisiti prescritti dalla legge per l’ammissione al concorso
La garanzia della qualità e dell'efficacia del sistema giudiziario si ritrova, da un lato, nelle condizioni strutturali e, dall'altro, nelle caratteristiche del personale. Come condizioni strutturali si considerano la produzione legislativa (e.g. le procedure giudiziare, la situazione costituzionale dei tribunali, la gestione dei tribunali, la distribuzione dei poteri di controllo) e le condizioni di lavoro (e.g. la gestione del personale degli uffici giudiziari, il carico di lavoro del personale, le infrastrutture personali e materiali). Un fattore chiave nel funzionamento del sistema giudiziario é il fattore “umano", che significa il sistema di selezione, nomina e promozione dei giudici. Evidentemente il modo in cui si accede alla magistratura e il potere di decidere sulla carriera di un giudice possono avere un impatto fondamentale sulla qualità del giudizio[12].
Una parte importante della riforma giudiziaria menzionata precedentemente è stata la modifica sostanziale della procedura di selezione dei giudici introdotta dalla legge n. 162 del 2011[13]. Alla magistratura professionale si accede per concorso pubblico, che assicura un procedimento trasparente, sulla base di soli requisiti di capacità e merito. Per diventare giudice di livello superiore (corti d’appello e Corte Suprema) non esiste una procedura diversa, i giudici dei livelli inferiori della magistratura (tribunali distrettuali o tribunali regionali) accedono ai tribunali superiori mediante il concorso pubblico, secondo le regole generali applicati per tutti.
I requisiti previsti dalla legge e verificati insieme con la domanda per essere nominato magistrato sono i seguenti: il candidato (i) ha più di 30 anni; ii) ha la cittadinanza ungherese, iii) possiede la piena capacità giuridica e la capacità di agire definita dal codice civile, iv) é in possesso di una laurea in giurisprudenza; v) ha espletato il periodo di 3 anni di tirocinio forense vi) ha superato l’esame di specializzazione (in materia di diritto penale e procedura penale, diritto civile e procedura civile, diritto amministrativo, diritto del lavoro e della previdenza sociale e diritto comunitario), (vii) dopo l’esame di specializzazione ha svolto almeno 1 anno di esperienza lavorativa forense e.g. segretario di tribunale o avvocato, notaio, pubblico ministero o pubblico ufficiale, viii) ha presentato la dichiarazione sul proprio patrimonio richiesta dalla legge, ed (ix) risulta idoneo ad agire come giudice sulla base del risultato ‘dell’esame d’idoneità’.
ad v) Il periodo di tirocinio
Il percorso classico per diventare magistrato inizia con lo svolgimento di un tirocinio giudiziario, che al quale si accede tramite un altro concorso pubblico[14], diverso dal concorso in relazione a un posto vacante di magistrato ordinario. La selezione è attuata mediante esame scritto e orale in materie giuridiche. Il concorso é bandito periodicamente dal Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura nella Gazzetta Ufficiale. Il contenuto e la valutazione dell’esame spettano al Presidente[15], ma il candidato viene nominato tirocinante dal Presidente del tribunale nel cui territorio è stata presentata la domanda dell’applicazione.
I vincitori del concorso assumono la qualifica di ’tirocinante di tribunale’ e svolgono il periodo di tirocinio, della durata complessiva di 3 anni, articolato in corsi di approfondimento teorico-pratico e sessioni presso uffici giudiziari. I tirocinanti frequentano tutti gli uffici giudiziari, affiancando i magistrati tutor già in servizio nello svolgimento delle funzioni giudiziarie. I corsi teorici si tengono presso il tribunale regionale, nel cui territorio il tirocinante é stato nominato e la materia della formazione professionale dei tirocinanti é disciplinata dal decreto del Ministro della Giustizia. L’attività svolta durante il periodo di tirocinio é valutata dai tutor nominati dal Presidente del tribunale regionale. Il tirocinante di tribunale non esercita funzioni giudiziarie.
Si nota che sono ammessi a partecipare al concorso per un posto vacante di magistrato ordinario anche quelli che hanno espletato il loro tirocinio in un altro campo legale, e.g. studio legale di avvocati o notarile, ma durante la loro valutazione professionale dal consiglio giudiziario questo possa essere uno svantaggio.
ad vi) L’esame di specializzazione
Concluso il periodo del tirocinio e se la valutazione del tirocinante è positiva, il candidato puó presentare la domanda per l’esame di specializzazione organizzato dal Ministero della Giustizia[16]. L’esame si divide in tre parti secondo le materie dell’esame, che materie sono: 1. diritto penale, procedura penale, diritto penitenziario, diritto delle contravvenzioni, 2. diritto civile e di famiglia, diritto commerciale e fallimentare, procedura civile 3. diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto comunitario, diritto del lavoro e della previdenza sociale.
L'esame di specializzazione è uniforme per tutti i laureati in giurisprudenza che hanno completato i 3 anni di pratica forense (magistrati, avvocati, pubblici ministeri, notai, etc.). La commissione esaminatrice è composta da professionisti provenienti da tutti i campi legali (e.g. giudici, avvocati, professori universitari, pubblici ministeri, pubblici ufficiali) che hanno almeno dieci anni di esperienza professionale legale e hanno superato l’esame di specializzazione. I membri della commissione sono nominati dal Ministro della Giustizia per un periodo di cinque anni.
ad vii) Segretario di tribunale
Dopo il superamento dell’esame di specializzazione il percorso classico per diventare magistrato continua con la nomina del candidato a ‘segretario di tribunale’. Il segretario esercita certe funzioni giudiziarie previste dalla legge nel settore penale (e.g. nei casi delle contravvenzioni e, nel settore civile, nei casi relativi al registro delle imprese o degli enti civili9 in un modo autonomo, e aiuta anche il collabora anche al lavoro dei magistrati in tutti i settori. Il segretario di tribunale é nominato dal presidente del tribunale regionale nel cui territorio svolge la sua attività.
ad ix) L’esame d’idoneità
L’esame d’idoneità é un esame fisico e psicologico. Sono autorizzati a gestirlo solo gli esperti professionisti (medici, psicologi e psichiatri) affiliati agli Istituti di ricerca per gli affari giudiziari e il procedimento dell’esame è stabilito da un decreto[17] comune del Ministero della Giustizia e del Ministero della Sanità Pubblica. Le parti principali dell'esame sono: l’esame fisico, l’esame psicologico e l’esame neuropsichiatrico. In ogni caso la commissione composta da tre esperti decide all’unanimità in merito all'ammissibilità, deve elaborare un parere professionale motivato e la decisione della commissione è impugnabile.
2. Il procedimento del concorso per magistrato ordinario
Il concorso in relazione a un posto vacante di magistrato ordinario si apre con la pubblicazione del bando. In ogni caso compete al Presidente dell’Ufficio Nazionale di bandire un concorso per un posto vacante e la legge prescrive che il processo di nomina sia aperto, non discriminatorio, trasparente e deve fornire pari opportunità a ciascun candidato. Il bando del concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Magistratura e sul sito web centrale dell'amministrazione della giustizia. Il candidato deve inviare la domanda e tutti i documenti di verifica dei criteri prescritti dalla legge direttamente al presidente del tribunale regionale, nel cui circondario il posto vacante si trova, indicato nel decreto di indizione. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande ogni candidato è ascoltato dal consiglio giudiziario del tribunale regionale o della corte di livello superiore.
Dopo aver ascoltato i candidati, il consiglio giudiziario valuta i documenti presentati e la capacità professionale del candidato assegnando punti e, secondo il numero totale dei punti in classifica, indica il miglior candidato. Nella valutazione dei candidati sono presi in considerazione i criteri determinati dal decreto ministeriale[18] in cui sono determinati anche i punti di valutazione assegnati ai singoli criteri:
- la durata dell’esperienza lavorativa in un campo legale (max. 26 punti),
- la valutazione del tirocinio e la valutazione del lavoro di segretario di tribunale (max. 20 punti) o per un posto di magistratura superiore la valutazione di professionalità (max. 24 punti),
- il risultato dell'esame di specializzazione (max.10 punti),
- il titolo scientifico (max. 20 punti),
- il risultato di una formazione post-laurea relativamente alla materia in cui il candidato svolgerà la sua funzione come giudice (max. 15 punti),
- i viaggi di studio all'estero (max. 5 punti),
- le competenze linguistiche (max. 10 punti),
- le pubblicazioni su argomenti giuridici (max. 5 punti) e altre attività professionali (max. 20 punti) che possono essere prese in considerazione sempre relativamente alla materia in cui il candidato svolgerá la sua funzione come giudice.
Nel caso di un concorso per la nomina a magistrato superiore, un ulteriore criterio di valutazione è il parere della divisione o sezione del tribunale o di corte d’appello o della Corte Suprema di cui diventerà giudice il candidato vincitore del concorso (max.20 punti). Dopo aver ascoltato il candidato anche il consiglio giudiziario del tribunale lo valuta (max. 10 punti).
Al consiglio giudiziario del tribunale non é consentito di discostarsi dalla graduatoria dei candidati, ma se due o più candidati raggiungono la stessa quantità di punti, il consiglio giudiziario stabilisce l’ordine tra i candidati con una decisione motivata. Il consiglio manda le domande e l’ordine dei candidati al presidente del tribunale regionale. Se il presidente del tribunale è d'accordo con la graduatoria dei candidati, trasmette le domande e la graduatoria al Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura. Nel caso in cui il presidente del tribunale non sia d'accordo con la graduatoria dei candidati, deve motivare la sua decisione di proporre un candidato diverso dal candidato arrivato al primo posto.
Il risultato del concorso alla fine è deciso dal Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura o, nel caso di un concorso per la Corte Suprema, dal Presidente della Kúria. Se il Presidente dell'Ufficio Nazionale per la Magistratura accetta il candidato arrivato al primo posto della graduatoria, presenta la domanda di nomina al Presidente della Repubblica. Il Presidente dell'Ufficio Nazionale per la Magistratura può discostarsi dalla graduatoria e proporre il secondo o il terzo classificato per la nomina al posto vacante, ma in questo caso deve motivare la decisione e inviare la sua proposta prima al Consiglio Giudiziario Nazionale per il suo accordo.
I candidati per la prima volta sono nominati magistrati dal Presidente della Repubblica. Nel caso di una domanda per un tribunale o corte superiore il vincitore del concorso è trasferito dal Presidente dell’Ufficio Nazionale per la Magistratura e nel caso di un concorso per la Corte Suprema il vincitore é nominato dal Presidente della Corte Suprema. La decisione sulla nomina del candidato è sempre pubblicata nella Gazzetta Ungherese e il candidato deve prestare giuramento prima di iniziare l'attività giudiziaria. Per la prima volta il giudice è nominato per un periodo determinato di tre anni e dopo la prima valutazione positiva sarà nominato per un periodo indeterminato.
Nel 2019 è entrata in vigore una modifica[19] della legge n. 162 del 2011 sullo ‘Status e retribuzione dei giudici’ che prevede un’eccezione per i giudici della Corte Costituzionale, eletti a maggioranza assoluta del Parlamento, che sono nominati magistrati della Corte Suprema dalla Presidente senza partecipare al concorso generale. Questa recente modifica è stata fortemente criticata dalla Commissione Europea nelle Relazioni sullo Stato di diritto degli ultimi anni.
Infine, viene si evidenzia che la legge ungherese prevede seri requisiti per quanto riguarda la condotta sociale dei giudici. Secondo le esperienze relativamente recenti del passato socialista, l'attività politica dei giudici è generalmente proibita, ciò significa che la partecipazione ad attività politiche e l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni politici sono vietati dalla legge. Oltre al loro lavoro professionale, i giudici sono autorizzati ad impegnarsi solo con le attività scientifiche, educative, di coaching, arbitraggio, artistiche, editoriali e tecnologiche, o altre attività protette dalla legge sulla proprietà intellettuale. La legge specifica che i giudici sono autorizzati a svolgere le attività sopramenzionate solo se tale attività non mette in pericolo la loro indipendenza e imparzialità e non ostacola l'adempimento dei loro obblighi giudiziari.
Un'altra caratteristica particolare del sistema giudiziario ungherese, che ha anche le sue origini nel passato socialista è, che diversamente che in molte altre parti del mondo, nei tribunali ungheresi tra i giudici le donne sono in maggioranza rispetto agli uomini. Poi secondo il rapporto annuale 2017 della Commissione Europea in Ungheria ci sono circa 30 giudici per ogni 100 mila ungheresi. La relazione annuale della Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) ha valutato i sistemi giuridici nel 2022 e ha comunicato una relazione rispetto a tutti i paesi europei sulla base dei dati del 2012 e del 2020.
In Ungheria la ripartizione dei posti tra i giudici donne e uomini secondo CEPEJ:
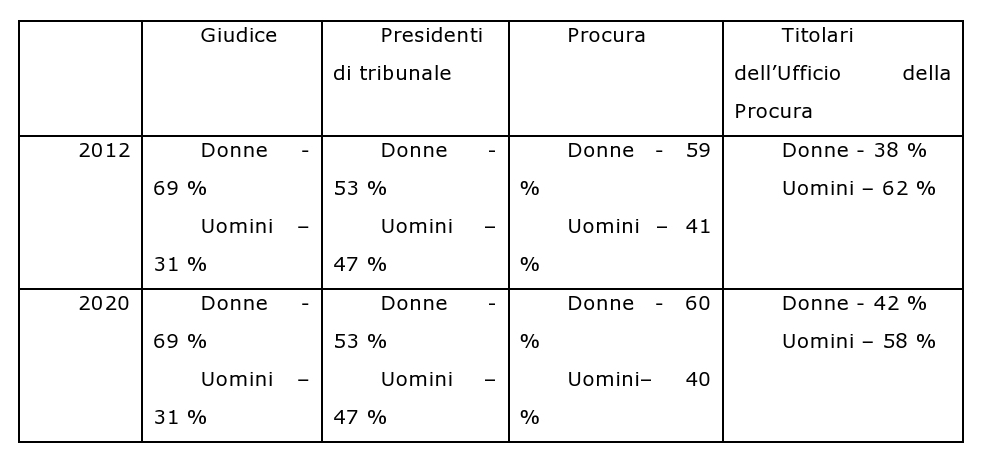
Source: European judicial systems CEPEJ Evaluation Report (2022: 65)
Per quanto riguarda i motivi storici e sociologici bisogna ricordare che prima della seconda guerra mondiale le donne non avevano la possibilità di studiare e laurearsi alle università. Dopo la guerra è diventata più comune che le donne studiassero e avessero più possibilità di fare carriera, ma in Ungheria per circa 40 anni la filosofia comunista determinava e limitava la libertà del pensiero, il che valeva anche per il sistema giudiziario. Nell’ambiente comunista i giudici tradizionalmente lavoravano più come pubblici ufficiali che come giudici indipendenti, e la formazione dei magistrati ovviamente non sosteneva l’approfondimento del principio dell'indipendenza della magistratura. Tradizionalmente sembra che le donne si adattino meglio a lavorare in un modo burocratico e, secondo alcuni autori[20] ungheresi, per le donne laureate è sempre stato più facile fare carriere nei campi in cui si guadagna meno, perché gli uomini semplicemente si ritirano dalle carriere mal pagate. Tra i laureati in giurisprudenza, la maggior parte delle donne lavora in campo giudiziario. Come sopra menzionato i giudici ungheresi hanno possibilità molto limitate di impegnarsi con altre attività e i loro stipendi tradizionalmente sono molto bassi rispetto alle altre carriere legali.
La situazione è migliorata dalla metà degli anni 90, e nel 2019 il Ministro della Giustizia ungherese ha annunciato l’aumento degli stipendi dei magistrati di oltre il 60%. Negli ultimi anni il numero di uomini è aumentato nel sistema giudiziario, ma rimane ancora inferiore rispetto al numero delle donne. Dobbiamo ancora aggiungere il vantaggio dell'orario flessibile del lavoro, la possibilità di 'home office’ che in Ungheria esisteva nel sistema giudiziario già in un'epoca in cui per altri campi di lavoro ancora non era assolutamente riconosciuta questo modo di lavoro, la chiusura estiva e invernale dei tribunali, e si capisce facilmente perché la carriera giudiziario fosse più attraente per le donne che per gli uomini.
Infine, si nota che diversamente dal sistema italiano in Ungheria il pubblico ministero non è un organo della magistratura ordinaria, non è un giudice. La Procura della Repubblica ungherese è un’autorità indipendente prevista dalla Costituzione, soggetta soltanto alla legge. È presieduta e amministrata dal Procuratore generale, nominato a maggioranza assoluta dal Parlamento. I procuratori sono nominati dal Procuratore Generale, ma i percorsi di accesso alla procura sono molto simili all’accesso alla magistratura[21].
*Giudice della sezione fallimentare della Corte Capitale di Budapest. Il suo contributo si inserisce nell'approfondimento del tema Accesso in magistratura, precedenti contributi Accesso alla magistratura - 1. Pensieri sparsi sul concorso in magistratura di Giacomo Fumu, Riflessioni sul concorso in magistratura di Mario Cigna Il tirocinio formativo ex art. 73 d.l. n. 69/2013 di Ernesto Aghina, Il procedimento per la nomina e selezione dei giudici e pubblici ministeri nella Repubblica Federale Tedesca di Cristiano Valle, sotto la voce della rivista Ordinamento giudiziario.
[1]Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT)
[2]Legge n. 87 del 1997 sulla Organizzazione e l’amministrazione delle corti (artt. 34-59)
[3]S. Penasa: L’amministrazione della giustizia in Ungheria:un sistema istituzionale ’bicefalo’ di derivazione ’democratico-illiberale’, Gli organi di governo autonomo della magistratura:un’analisi comparativa, Saggi-DPCE online, 2020/4, ISSN:2037-6677
[4] La Legge Fondamentela di Ungheria (25 Aprile 2011)
[5]Ibid. S. Penasa
[6]Országos Bírósági Hivatal (OBH)
[7]Országos Bírói Tanács (OBT)
[8]I. Vörös, The Constitutional Landscape after the Fourth and Fifth Amendment of Hungarian Fundamental Law, cit. 2 ss, Commissione di Venezia, Parere sul Quarto emendamento della Legge Fondamentale, 14-15 giugno 2013, 16 ss.
[9]La Legge Fondamentela di Ungheria (25 Aprile 2011) Articolo 25
[10]Commisione di Venezia Parere n. 663/2012, Opinion on Act CLXII of 2011 on the Legal Status and Renumeration of Judges and Act CLXI of 2011 on the Organisation and Administration of Courts of Hungary
[11]Rule of Law Report 2020 capitolo dedicato all’Ungheria.
[12]Bencze M. – Badó A. (2016): A magyar bírósági rendszer hatékonyságát és az ítélkezés színvonalát befolyásoló strukturális és személyi feltételek, in: A magyar jogrendszer állapota, MTA-TKJTI, 2016, 14_Bencze_Matyas_Bado_Attila.pdf (tk.hu), 14_Bencze_Matyas_Bado_Attila.pdf (tk.hu)
[13]Legge organica n. 161 del 2011 in materia di ’Organizzazione e amministrazione delle corti’ e la legge organica n. 162 del 2011 in materia di ’Status e retribuzione dei giudici’
[14]Decreto del Ministro della Giustizia n.11 del 1999.
[15]3/2016. (II.29.) OBH utasítás
[16]Decreto del Ministro della Giustizia n. 5 del 1991
[17]Decreto comune del Ministero della Giustizia e del Ministero della Sanità Pubblica n. 1 del 1999.
[18]Decreto del Ministro della Giustizia (KIM) n.7 del 2011.
[19]Legge no.127 del 2019
[20] A.Laczó-A.Madarasi, Dominance of female judges in the courts of Hungary – A different path to the development of women’s equality, 2022.
[21] Legge no. 164 del 2011.
Sull’appellabilità dell’ordinanza pronunciata sulla richiesta di accesso documentale ex art. 116, co. 2, c.p.a. (nota a Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2023, n. 4)
di Clara Napolitano
Sommario: 1. I fatti processuali e il principio espresso dalla Plenaria. – 2. Fondamento del principio: la natura decisoria dell’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. – 3. Questioni collaterali: la «connessione» dei documenti oggetto della richiesta al giudizio in corso. – 4. Effettività della tutela, doppio grado di giudizio e principio di legalità processuale.
1. I fatti processuali e il principio espresso dalla Plenaria.
Il Supremo Consesso del Consiglio di Stato si esprime sull’appellabilità dell’ordinanza che si pronuncia in merito alla richiesta di accesso documentale inoltrata nel corso del giudizio ex art. 116, co. 2, c.p.a.
Qui di seguito i fatti della controversia che ha sollecitato l’intervento della Plenaria.
Nel 2020 la Consob[1] approva il regolamento del personale; la relativa delibera è quindi impugnata innanzi al Tar Lazio da alcuni avvocati appartenenti all’ufficio “consulenza legale” della Commissione, nella parte relativa al mancato adeguamento del trattamento giuridico ed economico, nonché dell’ordinamento delle carriere degli avvocati interni rispetto a quanto previsto dalla l. 31 dicembre 2012, n. 247[2] sull’ordinamento professionale forense e dall’ordinamento delle carriere degli avvocati della Banca d’Italia.
Nell’ambito del giudizio di annullamento, i ricorrenti propongono richiesta di accesso documentale ex art. 116, co. 2, c.p.a., finalizzata alla ostensione di tutti i documenti amministrativi afferenti al regolamento del personale e concernenti il profilo del trattamento economico, ivi compresi verbali delle riunioni di Commissione nei quali il tema è trattato; corrispondenza interna intercorsa tra le Unità organizzative della Consob; corrispondenza intercorsa tra la Consob e gli Ordini professionali. L’esibizione documentale – tematicamente limitata all’adeguamento del trattamento economico – è dichiaratamente funzionale alla difesa nel giudizio principale già incardinato.
A questa richiesta la Consob risponde con parziale reiezione, limitando l’ostensione alla sola corrispondenza intercorsa con gli Ordini professionali e negando, viceversa, l’accesso alla restante documentazione richiesta, ritenuta «connessa all’esercizio di potestà normativa» – tale intendendosi l’adozione del regolamento del personale – e, pertanto, non accessibile in forza dell’art. 24, co. 1, lett. c), l. n. 241/1990[3].
È qui che s’instaura una sub-fase processuale avverso quel diniego d’accesso, conclusasi con ordinanza[4] nella quale, rilevata la fondatezza dell’istanza e accertato il conseguente diritto dei ricorrenti di accedere alla documentazione richiesta[5], il Tar ordina alla Consob di consentire l’accesso entro i trenta giorni successivi dalla comunicazione del provvedimento giurisdizionale.
L’Amministrazione resistente appella l’ordinanza, chiedendo altresì la sospensione cautelare dei suoi effetti: la VI Sezione del Consiglio di Stato, investita del ricorso, accoglie (solo parzialmente) la sospensiva[6] e, con altro provvedimento[7], rimette all’Adunanza plenaria la questione circa l’ammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza del Giudice che si pronuncia sull’accesso documentale in giudizio ex art. 116, co. 2, c.p.a.
Questione alla quale – lo si dichiara sin d’ora – il plenum del Consiglio di Stato risponde in senso affermativo, così ponendo fine a un serrato contrasto giurisprudenziale: «l’ordinanza resa nel corso del processo di primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. amm., è appellabile innanzi al Consiglio di Stato».
2. Fondamento del principio: la natura decisoria dell’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.
Ora, il principio ha un fondamento logico-concettuale ben preciso: l’ordinanza di cui all’art. 116, co. 2, c.p.a. ha natura decisoria[8]; come tale, dev’esserne assicurata l’appellabilità in ossequio ai principi costituzionali di difesa (art. 24 Cost.) e del doppio grado di giudizio (art. 125 Cost.).
Non v’è dubbio che il decisum del Consiglio di Stato abbia consentito una maggiore effettività della tutela dei richiedenti l’accesso, nonché degli eventuali controinteressati, mediante l’attribuzione di autonoma valenza decisoria all’ordinanza; questo esito, peraltro, passa per una attività interpretativa delle disposizioni che, probabilmente, esula dallo stretto perimetro del principio di legalità processuale.
Ma andiamo per gradi.
La natura decisoria dell’ordinanza che si pronuncia sull’istanza di accesso in corso di giudizio, si diceva.
Per rifletterci bisogna guardare alla vicenda da un angolo visuale più ampio, che procede più addietro nel tempo, e che si affaccia anche al diritto procedimentale sostanziale.
Invero, quello dell’accesso, disciplinato dall’art. 116 c.p.a., è un rito speciale, più celere di quello ordinario: esso consente d’impugnare il diniego (espresso o tacito) di accesso entro trenta giorni dalla sua conoscenza (o dalla formazione del silenzio rifiuto) e si conclude con una sentenza in forma semplificata, nella quale il Giudice, accertata la fondatezza della domanda[9], ordina all’Amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti[10]. La sentenza, ovviamente, è appellabile.
Il comma 2 della medesima disposizione[11] ha poi una funzione di economia processuale[12]: esso consente – nell’ambito di un giudizio pendente – d’inoltrare istanza di accesso ai documenti “connessi” al giudizio medesimo. Su quell’istanza, depositata presso la segreteria del Tar e notificata all’Amministrazione e alle altre parti processuali, il Giudice può pronunciarsi con apposita ordinanza oppure direttamente nella sentenza che decide il giudizio principale.
La strutturazione della norma nulla dice circa la natura dell’ordinanza, dunque il tenore letterale non suggerisce alcuno specifico orientamento sul punto.
Ciò contrariamente a quanto, invece, accadeva prima del 2010, dunque prima della codificazione, laddove il diritto procedimentale amministrativo[13] e le disposizioni organizzative e di rito processuali[14] attribuivano espressamente la natura «istruttoria» a quell’ordinanza.
L’eliminazione dell’attributo «istruttoria» nella disposizione codicistica induce a ritenere che il legislatore quod voluit dixit, quod non dixit noluit: sicché il dato normativo di cui all’art. 116, co. 2, c.p.a. – o meglio, il silenzio di quel dato – sarebbe il primo indizio – a livello interpretativo – della mutata natura dell’ordinanza sull’istanza di accesso.
E però è altresì vero che già prima del codice del processo amministrativo era emerso un contrasto giurisprudenziale, interno persino alle medesime sezioni, sul modo di concepire questo tipo di ordinanze e i relativi procedimenti: tanto che – a fronte di sentenze del Consiglio di Stato che sancivano l’inappellabilità dell’ordinanza, stante la sua natura istruttoria[15] – si è gradualmente manifestato un orientamento meno rigido – a dir così, casistico – per il quale la natura dell’ordinanza (e dunque la sua appellabilità) muterebbe a seconda del suo concreto contenuto[16], in particolare a seconda che il Giudice operi (o meno) un vaglio sull’effettiva rilevanza dei documenti per il giudizio in corso.
L’Adunanza plenaria sceglie di scartare quest’ultimo indirizzo, fonte di eccessive incertezze («la natura decisoria o meno di un provvedimento giudiziale va stabilita sulla base di criteri normativi», si legge nella sentenza in commento). E, come anticipato, di attribuire all’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., natura decisoria.
Oltre al dato storico di cui s’è appena dato conto, che considera tanto il diritto processuale quanto quello sostanziale, la Plenaria si avvale di ragioni interpretative della disposizione codicistica per giungere alle sue conclusioni.
Anzitutto, la richiesta di accesso è collocata nell’alveo dell’art. 116 c.p.a. che, come detto, concerne il giudizio a fronte del diniego d’accesso: se avverso il diniego (espresso o tacito) può esser proposto ricorso, da decidersi con sentenza; e se quello stesso ricorso («il ricorso di cui al comma 1», sancisce la disposizione) può essere presentato in forma di richiesta nell’ambito di un giudizio già instaurato per ragioni di economia processuale; allora – anche quando presentato in forma di richiesta – esso dev’essere deciso con provvedimento impugnabile analogo alla sentenza.
A ciò si aggiunga che la richiesta non dev’essere solo depositata nella segreteria del Tar – come le altre richieste istruttorie – ma dev’essere anche notificata all’Amministrazione e agli eventuali controinteressati (non necessariamente coincidenti con le parti già evocate in giudizio), esattamente come un ricorso. Dato essenziale: l’istanza è rivolta non al Giudice, bensì all’Amministrazione. Ciò la rende intrinsecamente differente dalle altre richieste presentate in giudizio (da ritenersi effettivamente istruttorie) e la avvicina di molto a un’istanza procedimentale, della quale è data notizia in giudizio, e il cui esito è giustiziabile.
Questo crinale della distinzione tra piano sostanziale e processuale separa, dunque, l’accesso ai documenti amministrativi dall’acquisizione probatoria al giudizio. È qui che la Plenaria fa ricorso a un suo precedente – la sentenza n. 19/2020 – nel quale i due istituti sono nettamente separati.
Per il Giudice amministrativo del 2020, a differenza dell’accesso difensivo ai documenti, «gli strumenti di acquisizione probatoria […] si muovono esclusivamente sul piano e all’interno del processo; sono assoggettati alla prudente valutazione del giudice; eventuali rigetti non sono autonomamente impugnabili o ricorribili, potendo gli eventuali vizi dell’istruttoria rilevare come motivi di impugnazione della sentenza. Di conseguenza, il naturale corollario è che l’eventuale rigetto dell’istanza di esibizione di un documento della pubblica amministrazione […] non si pone in contrasto, né elude la ratio legis contenuta negli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990, poiché le due disposizioni operano su un piano diverso, avendo la legge n. 241/1990 assunto l’interesse del privato all’accesso ai documenti come interesse sostanziale, mentre l’acquisizione documentale […] costituisce esercizio di un potere processuale e l’acquisizione del documento resta pur sempre subordinata alla valutazione della rilevanza dello stesso, ai fini della decisione, da parte del giudice al quale spetta di pronunciarsi sulla richiesta istruttoria […]»[17].
Se allora la richiesta di accesso ex art. 116, co. 2, c.p.a. è – di fatto – rispondente ai criteri di cui agli artt. 22 ss., l. n. 241/1990 e non può qualificarsi come mezzo istruttorio, in merito alla stessa il Giudice deve potersi pronunciare con provvedimento impugnabile.
Ciò anche per il più ampio principio costituzionale che assicura il diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost. non soltanto del richiedente, ma anche dei controinteressati e della stessa p.A., qualora nel corso del processo sia emessa una ordinanza che accolga il ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e consenta l’ostensione dei documenti richiesti. Rispetto a quel provvedimento dev’esser garantita reazione sia da parte della p.A., sia dei controinteressati.
Il richiamo costituzionale della Plenaria si estende, infine, all’art. 125 Cost., ritenuto espressivo del principio del doppio grado di giudizio, come risultante dalla storica interpretazione offertane della stessa Plenaria nel 1978[18]: vero è che i provvedimenti espressamente appellabili sono le sentenze adottate dai Tribunali amministrativi regionali (artt. 91 e 100 c.p.a.) e le ordinanze cautelari adottate dai medesimi Tribunali (art. 62 c.p.a.); tuttavia, accanto a questi devono considerarsi le decisioni implicitamente appellabili, ovvero quelle che, a prescindere dalla forma e dal nomen, hanno un contenuto decisorio idoneo a incidere su situazioni giuridiche e suscettibili di passare in giudicato ovvero di risolvere «in contraddittorio tra le parti una specifica controversia»[19].
3. Questioni collaterali: la «connessione» dei documenti oggetto della richiesta al giudizio in corso.
Ora, l’impianto decisorio della Plenaria è indubbiamente chiaro e approda a una soluzione condivisibile perché ampliativa della tutela delle parti nel processo, così costituendo ancora attuazione del principio di effettività della tutela, garantito dall’art. 113 Cost. e dall’art. 1 c.p.a.
Le ragioni che inducono a preferire la natura decisoria dell’ordinanza sull’accesso rispetto a quella istruttoria sono tuttavia le medesime sulle quali è opportuno riflettere.
Si è detto che – sia in ragione di un criterio interpretativo storico, sia sistematico, sia puramente letterale dell’art. 116, co. 2, c.p.a. – quell’ordinanza contiene sempre determinazioni decisorie, come tali appellabili.
Ciò implica che il Giudice, quando decide sull’istanza di accesso formulata in giudizio, debba applicare il diritto sostanziale, e dunque debba verificare (soltanto) se sussistono i presupposti di cui agli artt. 22 ss., l. n. 241/1990: all’istanza si applica il diritto procedimentale in materia di accesso.
Affinché questo assunto sia sostenibile, deve venire in ombra il requisito della rilevanza della documentazione richiesta ai fini del giudizio: invero, per il diritto sostanziale, l’accesso documentale difensivo si sottrae a una previa «ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990»[20].
Il dato testuale dev’essere dunque interpretato. L’art. 116, co. 2, c.p.a. parla di richiesta di accesso «connessa» al giudizio in corso; questo requisito della connessione – e dunque del vaglio sulla rilevanza dei documenti per il giudizio instaurato – è stato valorizzato dall’orientamento che ha ritenuto la natura puramente istruttoria dell’ordinanza: secondo il quale, poiché il Giudice non deve guardare alla disciplina procedimentale dell’accesso, bensì alla rilevanza dei documenti ai fini della risoluzione della controversia, la richiesta ex art. 116, co. 2, c.p.a. sarebbe assimilabile a un mezzo istruttorio (una sorta di acquisizione probatoria, quindi).
Il Consesso in plenum diluisce, invece, il concetto di «connessione», riferendolo a una «strumentalità in senso ampio, in quanto la valutazione che deve essere effettuata dal giudice non è soltanto vòlta a verificare la possibile rilevanza del documento per la definizione del giudizio, ma può servire anche per risolvere in via stragiudiziale la controversia, per proporre una nuova impugnazione ovvero ancora una diversa domanda di tutela innanzi ad altra autorità giudiziaria»[21].
Come a dire: anche nella richiesta ex art. 116, co. 2, c.p.a. si deve guardare non alla stretta strumentalità alla conclusione del giudizio, bensì a una “più ampia” strumentalità che guarda – però – più che al processo, alla situazione sostanziale del richiedente. Così rischiando, però, di confondere il piano delle situazioni sostanziali con quello del processo.
Secondo la Plenaria, questa idea più ampia di «connessione» giustifica anche il fatto che l’art. 116, co. 2, c.p.a. consente al Giudice di non decidere in ordine all’istanza di accesso con ordinanza, ma di deciderla con la sentenza che definisce il giudizio: come statuito dal Consesso, il Giudice potrebbe infatti non ritenere necessaria la documentazione ai fini della definizione del giudizio e dunque rinviare la decisione incidentale sull’accesso al momento di adozione della sentenza.
Questa lettura non sembrerebbe scevra da contraddizioni: se la richiesta d’accesso è sottoposta alla disciplina sostanziale (e dunque non va considerata come acquisizione probatoria nel processo); se la valutazione sulla connessione è talmente ampia da escludere soltanto i documenti che – marcatamente – nulla hanno a che vedere col giudizio in corso; allora diventa meno agevole qualificare il potere del Giudice di differire l’accesso al momento della sentenza che conclude il giudizio, perché il suo esercizio implica una valutazione – più puntuale – circa la necessarietà della documentazione ai fini proprio di quella definizione del giudizio.
La costruzione, dunque, parrebbe restituire un potere – quello valutativo del Giudice circa la «connessione» dei documenti al giudizio – dai confini piuttosto incerti: che può giocarsi sul crinale oppositivo “inclusione/esclusione”.
Vale a dire che potrebbero avverarsi con la medesima plausibilità due scenari opposti.
Il primo, includente: se i documenti richiesti non devono essere necessariamente pregiudiziali per la decisione finale (ma, appunto, basta che siano «connessi» alla controversia per cui è causa), il Giudice ne ingiunge l’ostensione già in ordinanza, applica la l. n. 241/1990 e quindi estende la tutela del richiedente.
Il secondo, escludente: dato lo stesso presupposto, la semplice «connessione» al giudizio e la non stretta strumentalità alla decisione, il Giudice può anche differire la decisione rinviandola alla sentenza, così però non garantendo la tutela del diritto d’accesso del richiedente.
Potrebbe essere opportuno, pertanto, che il potere valutativo del Giudice circa la «connessione» della documentazione al giudizio in corso – mantenendosi sulla sua strumentalità in senso ampio – sia esercitato già nell’ordinanza sulla richiesta exart. 116, co. 2, c.p.a., in modo da differire il meno possibile la tutela del richiedente, rendendola effettiva.
4. Effettività della tutela, doppio grado di giudizio e principio di legalità processuale.
La sentenza dell’Adunanza plenaria in commento si presta a qualche riflessione, in cenno conclusivo, di più ampio respiro.
L’impressione che se ne trae leggendola è che la base fondativa su cui essa poggia, ovvero la dicotomia tra natura istruttoria e decisoria dell’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., sia in realtà un – efficace – espediente argomentativo per ampliare la tutela giurisdizionale e consentire l’appellabilità di un provvedimento la cui impugnativa non è espressamente contemplata dalle disposizioni codicistiche.
Ciò è vieppiù evidente laddove si legga l’ordinanza di rimessione, la quale – nel tratteggiare il quadro giurisprudenziale e nell’aderire espressamente all’indirizzo che esclude l’appellabilità dell’ordinanza[22] – tocca temi processuali più generali.
Anzitutto, il rapporto tra la richiesta ex art. 116, co. 2, c.p.a. e le istanze istruttorie – in particolare e la richiesta di documenti che la parte può rivolgere direttamente al giudice (art. 64, co. 3)[23] – che confluiscono nel processo e che sono decise (anch’esse) con ordinanza, la quale però non è impugnabile bensì revocabile o modificabile dallo stesso Giudice che l’ha pronunciata.
La questione emerge perché – al di là della qualificazione formale come “istruttoria” – la richiesta ex art. 116, co. 2, al pari della richiesta ex art. 64, co. 3, comporta l’esibizione di atti e documenti che sono correlati al processo in corso e che contengono dati: probabilmente nel primo caso vi dev’essere solo la «connessione» al giudizio, mentre nel secondo vi dev’essere uno stretto rapporto di strumentalità alla decisione, ma – poiché la scelta del mezzo è operata dalla parte che lo richiede – ciò comporterebbe che sia la stessa parte richiedente, a qualificare il grado di connessione con il giudizio.
Secondo tema generale: il rapporto tra giudice di primo grado e giudice d’appello. Ammettere l’appellabilità dell’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., non soltanto limita l’autonomia del primo, nella sua istruttoria processuale e nella conduzione del giudizio, ma rischia soprattutto di creare rallentamenti nella macchina giurisdizionale: sia perché una impugnazione potrebbe rivelarsi superflua, laddove superata da una sentenza comunque favorevole; sia perché l’ordinanza, sebbene non impugnabile, non solo è – come detto – modificabile e revocabile ma consente comunque un contraddittorio, pur differito alla impugnazione della eventuale sentenza da parte del soccombente nel merito.
Infine, il tema della esecuzione coattiva dell’ordinanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.: laddove considerata provvedimento decisorio, la sua attuazione dovrebbe esser garantita anche tramite il rimedio dell’ottemperanza; viceversa, la sua mancata esecuzione da parte della p.A. dovrebbe esser valutata dal Giudice come argomento di prova (art. 64, co. 4, c.p.a.)[24].
L’Adunanza plenaria tace sulle questioni prospettate dalla Sezione rimettente, focalizzandosi strettamente sul tema della natura dell’ordinanza e offrendo una triplice – storica, letterale, sistematica – interpretazione dell’art. 116, co. 2, alla luce del principio costituzionale del doppio grado di giudizio di cui all’art. 125 Cost.
Il principio – che ha avuto un non univoco riconoscimento dalla dottrina[25] e dalla giurisprudenza costituzionale[26] – è apparso in particolare poco afferente alla funzione giurisdizionale, essendo riferibile, specialmente per la sua collocazione sistematica in Costituzione, più alla costruzione amministrativa del sistema ordinamentale italiano, implicando un riequilibrio tra centro e periferia tramite l’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali[27].
Esso è comunque utile, nella lettura fornitane dalla Plenaria[28], all’ampliamento della tutela, sebbene questo esito non si confronti con un altro principio costituzionale: quello della legalità processuale di cui all’art. 111 Cost., per il quale il giusto processo è «regolato dalla legge».
Siamo, cioè, di fronte alla introduzione per via pretoria di una nuova regola processuale – ovvero l’appellabilità di una ordinanza non tipizzata dalla disposizione quale provvedimento autonomamente impugnabile – e dunque all’ampliamento dello strumento dell’appello. L’ordinanza rientrerebbe tra i provvedimenti «implicitamente» impugnabili perché avente contenuto decisorio: sebbene anche la decisorietà del contenuto sia stata determinata per via pretoria.
La chiave di lettura sta, forse più fermamente, nell’art. 24 Cost., giustamente richiamato dalla Plenaria: «è necessario assicurare il diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.; art. 1 cod. proc. amm.) dei controinteressati e della stessa pubblica amministrazione, qualora nel corso del processo sia emessa una ordinanza che accolga il ricorso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. e consenta l’ostensione dei documenti richiesti. Se non si permettesse, infatti, l’immediata appellabilità si potrebbe determinare, a seguito dell’ordine di esibizione e del conseguente obbligo della sua esecuzione, un pregiudizio irreversibile per il diritto alla riservatezza privata dei controinteressati e per le prerogative pubbliche dell’autorità che detiene i documenti. Si tenga conto, inoltre, che, potendo la pubblica amministrazione e i controinteressati non coincidere con le parti del processo principale, se non si assegnasse valenza decisoria all’ordinanza le suddette parti oltre a subire il pregiudizio sopra indicato potrebbero anche non essere legittimate a proporre impugnazione autonoma avverso la sentenza che definisce la controversia».
Il riferimento al principio costituzionale della difesa in giudizio fornisce, a parer di chi scrive, la più condivisibile lettura costituzionalmente orientata per garantire un ampliamento della tutela: ciò non tanto per la necessità di applicare meccanicamente il doppio grado di giudizio – stante il fatto che, lo si ripete, anche l’ostensione dei documenti oggetto di richiesta probatoria può comportare un potenziale pregiudizio, pertanto qualunque atto di primo grado dovrebbe così esser soggetto a una impugnativa autonoma in secondo grado – bensì per assicurare la difesa non soltanto del richiedente che si veda negare l’accesso; ma anche del controinteressato laddove l’accesso sia consentito, il quale soprattutto – in difetto d’autonoma impugnabilità – resterebbe sguarnito di protezione dinanzi al Giudice.
E questo risultato è raggiunto dalla Plenaria tramite un’attività interpretativa che va oltre il dettato normativo[29], arricchendolo guardando alla effettività della tutela: si conferma, insomma, la forza del formante pretorio amministrativo, che dice lo jus integrando le disposizioni, stavolta quelle regolatrici del processo.
[1] Delib. Consob 10 dicembre 2020, n. 21621, resa esecutiva con D.P.C.M. del 18 marzo 2021, a sua volta modificato con delibera n. 22313 del 27 aprile 2022, resa esecutiva con D.P.C.M. del 18 maggio 2022, in https://www.consob.it/documents/1912911/1950567/reg_consob_2020_21621.pdf/c94d5a3e-435a-a516-f8ca-8da8571d8840.
[2] In particolare dall’art. 23 della medesima legge, rubricato «Avvocati degli enti pubblici», il quale prevede che agli avvocati degli enti pubblici debba essere assicurato «un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta».
[3] Secondo il quale il diritto di accesso è escluso «nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione».
[4] Tar Lazio, II-quater, ord. 15 luglio 2022, n. 10022.
[5] Nel merito, il Tar rileva che il diniego d’accesso difetta di legittima motivazione: quand’anche si volesse attribuire natura normativa alla delibera di approvazione del regolamento del personale, bisognerebbe comunque riconoscere la prevalenza dell’interesse sotteso all’accesso difensivo rispetto agli interessi posti a base di quella esclusione, fondandosi detta prevalenza sul comma 7 dell’art. 24, in ossequio al quale «[d]eve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici» (corsivo nostro).
Sul punto, peraltro, v. Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020, n. 19: «L’utilizzo dell’avverbio “comunque” denota la volontà del legislatore di non ‘appiattire’ l’istituto dell’accesso amministrativo sulla sola prospettiva della partecipazione, dell’imparzialità e della trasparenza, e corrobora la tesi che esistano, all’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso, due anime che vi convivono, dando luogo a due fattispecie particolari, di cui una (e cioè quella relativa all’accesso cd. difensivo) può addirittura operare quale eccezione al catalogo di esclusioni previste per l’altra (e cioè, l’accesso partecipativo), salvi gli opportuni temperamenti in sede di bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi (v. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 7 febbraio 2014, n. 600).
[…] La logica difensiva è costruita intorno al principio dell’accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi.
La tecnica legislativa utilizzata nel comma 7, rispetto ai precedenti commi del medesimo art. 24, avvalora la tesi che questo aggravamento probatorio in tanto si giustifica, proprio in quanto si fuoriesce dalla stretta logica partecipativa e di trasparenza, per entrare in quella, diversa, difensiva» (pt. 9.1).
[6] Cons. Stato, VI, ord. 9 settembre 2022, n. 4444: «il principale motivo opposto dalla Consob alla richiesta di accesso, incentrato sulla natura normativa, ovvero regolamentare, dell’attività posta in essere, e quindi sulla previsione (in tesi escludente) di cui all’art. 24, comma 1, lett. c, della l. 241/1990, appare revocabile in dubbio, per (almeno) due ragioni:
- sia perché nel riferirsi all’attività “diretta all’emanazione di atti normativi”, la disposizione di legge parrebbe prevedere piuttosto un differimento dell’accesso, ovvero una causa di esclusione temporanea, destinata a venire meno una volta che tale attività sia conclusa e l’atto sia stato formato;
- sia perché la tesi seguita dal Giudice di primo grado, nel senso che l’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, avrebbe carattere “comunque” preminente, appare persuasiva».
Ciò nondimeno, secondo la Sezione, «in questa sede, valutati anche comparativamente i contrapposti interessi, per quanto sinora osservato la domanda cautelare dell’Avvocatura è fondata e può essere accolta solo limitatamente alla richiesta di accesso al parere dell’Avvocatura stessa, il cui documento non può quindi essere osteso ai ricorrenti in primo grado».
[7] Stante il fatto che, come anche riferito nell’ordinanza cautelare già citata, «è controversa tra le parti, in rito, la questione dell’appellabilità dell’ordinanza del Tar, anche al cospetto di indirizzi giurisprudenziali al riguardo (da sempre) divergenti, questione che giustifica la sua rimessione dell’Adunanza plenaria, come da separata ordinanza», la VI Sezione fa rinvio alla Plenaria con ordinanza n. 8367 del 28 settembre 2022.
[8] La stessa ordinanza di rimessione – Cons. Stato, VI, n. 8367/2022, cit. – lega la natura dell’ordinanza alla sua sorte processuale: «Tale questione [la natura decisoria o istruttoria dell’ordinanza, n.d.r.], sulla quale la giurisprudenza diverge, si riflette peraltro non solo sull’appellabilità o meno dell’ordinanza ma, anche, conseguentemente, sulle modalità della sua esecuzione e, in particolare, nell’ipotesi in cui l’amministrazione non si conformi spontaneamente, sulla possibilità, per gli interessati, di attivare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza» (pt. 5).
[9] L. Iannotta, I rapporti tra accesso tradizionale ed accesso civico generalizzato: la riqualificazione dell'istanza di accesso in corso di giudizio, in Foro amm., n. 7-8/2020, pp. 1373 ss.: «Tale rito presenta i caratteri di un giudizio di accertamento, come si evince dallo stesso art. 116 c.p.a. nella parte in cui afferma che il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti. Il rito ha ad oggetto il rapporto amministrativo, disponendo il giudice di ampi e penetranti poteri di cognizione ed essendo direttamente chiamato a valutare, alla luce dei parametri normativi, se sussistono i presupposti per l’ostensione degli atti richiesti».
[10] Ripercorrendo sinteticamente l’art. 116, c.p.a., «1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi […] il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio […]. 4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione».
[11] Art. 116, co. 2, c.p.a.: «In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio».
[12] A. Travi, Manuale di giustizia amministrativa, Torino, 2023, p. 364.
[13] L’art. 25, co. 5, l. n. 241/1990, nella versione risultante dopo la riforma attuata con l. n. 15/2005, prevedeva: «Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini» (corsivo nostro).
[14] L’art. 21, co. 1, l. n. 1034/1971 (l. Tar), per effetto delle modifiche apportate dalla l. 205/2000, qualificava espressamente tale ordinanza come istruttoria, stabilendo che «il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio».
[15] Cons. Stato, VI, n. 403/2002, citata da Tar Lazio, ord. n. 8367/2022, cit.
[16] Cons. Stato, VI, n. 1629/2004: «se è vero che la impugnativa avverso le determinazioni concernenti il diritto di accesso, proposta con istanza al Presidente del TAR ai sensi dell’art. 1 L. n. 205 dovrebbe essere decisa con “ordinanza” come testualmente previsto dal citato art. 1, nondimeno si deve convenire che ogni qualvolta la pronuncia del Tribunale, senza nemmeno passare all’esame della pertinenza della documentazione richiesta (in relazione all’oggetto del giudizio pendente), ne escluda la accessibilità sulla sola base della ritenuta carenza dei presupposti stabiliti dalla disciplina generale ex artt. 22 e segg. L. n. 241/1990, allora la pronuncia stessa assume una connotazione decisoria e come tale è suscettibile di essere appellata (in tal senso cfr. la decisione della Sezione 10 febbraio 2002, n. 5450)». Indirizzo peraltro anche recentemente ripreso da Cons. Stato, VI, 14 agosto 2020, n. 5036; Cons. Stato, III, 7 ottobre 2020, n. 5944; Cons. Stato, IV, 27 ottobre 2011, n. 5765; Cons. Stato, III, 25 giugno 2010, n. 4068.
[17] Cons. Stato, Ad. plen., n. 19/2020, cit., pt. 9.3.1, che così prosegue: «Occorre in altri termini tenere distinti, da un lato, la pretesa all’ostensione del documento nei confronti della pubblica amministrazione, intesa quale protezione accordata all’interesse sostanziale alla conoscenza e, dall’altro lato, il diritto alla prova, inteso come protezione dell’interesse processuale della parte alla rappresentazione in giudizio, attraverso un determinato documento, dei fatti costitutivi della domanda, subordinato alla duplice valutazione giudiziale della concludenza e della rilevanza dello specifico mezzo di prova (v. Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 158)».
[18] Ci si riferisce alla sentenza Cons. Stato, Ad. plen., 20 gennaio 1978, n. 1, nella quale si sancì l’appellabilità delle ordinanze cautelari, con commento di F. Satta in Foro It., vol. 101, 1978, pp. 1/2 - 7/8.
[19] Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/1978, cit.
[20] Così il Tar Lazio nella sua ordinanza sull’accesso, la n. 10022/2022 già citata. L’assenza di valutazioni circa l’afferenza dei documenti al giudizio instaurato parrebbe condivisa anche dal Consiglio di Stato, il quale, in sede di appello della Consob con domanda cautelare, lo accoglie solo in parte, escludendo il parere dell’Avvocatura per ragioni normative (d.p.c.m. 26 gennaio 1996, n. 200, il cui art. 2 prescrive il segreto per determinati atti dell’Avvocatura, tra cui anche i «pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza»).
[21] Cons. Stato, Ad. plen., n. 4/2023 in commento.
[22] Così la VI Sezione motiva il suo orientamento: «Sebbene le particolari modalità di presentazione dell’istanza, che come visto va notificata alle altre parti (e che peraltro potrebbero anche non coincidere del tutto con quelle del giudizio principale), possano indurre a ritenere che con essa si apra una fase autonoma del giudizio suscettibile di concludersi con una pronuncia avente carattere decisorio, preminenti appaiono sul piano sistematico le considerazioni già ricordate. In particolare la richiesta connessione tra l’istanza di accesso e il giudizio già in corso, che ne suggerisce pur sempre la strumentalità, e, più in generale, anche per ragioni di economia, l’esigenza di non differenziare troppo, nel trattamento processuale, questo tipo di istanza da quelle altre istanze o domande, pacificamente di carattere istruttorio, con le quali è richiesta nel giudizio l’ammissione di mezzi di prova o di ricerca della prova e il cui esito, per quanto spesso potenzialmente in grado di ipotecare la sorte del giudizio persino in misura maggiore, non è autonomamente ed immediatamente appellabile» (pt. 8).
[23] Che recita: «Il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione».
[24] Secondo il quale «Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo».
[25] Cfr. l’accurata ricostruzione di G. Serges, Doppio grado di giurisdizione (diritto costituzionale), in Dig. Disc. Pubbl., Agg., 2017, Torino, pp. 297 ss.
[26] Corte Cost., 22 giugno 1963, n. 110 e poi 15 aprile 1981, n. 62, nelle quali si afferma che l’art. 125 Cost. assicura la tutela in ogni stato e grado del processo ma «non garantisce la parte contro la soppressione di un grado»; v. inoltre Corte Cost., 31 marzo 1998, n. 395, nella quale il principio del doppio grado di giudizio è costruito nel senso che impedisce che il Tar sia giudice di unico grado.
[27] In questo senso, U. Pototschnig, A. Travi, Appello (diritto amministrativo), in Enc. dir., Agg. III, 1999, Milano, pp. 151 ss.
[28] In linea con Ad. plen., n. 1/1978, cit., in tema di ordinanze cautelari. Per una efficace ricostruzione del principio del doppio grado di giudizio, in senso critico, v. A. De Siano, Tutela cautelare monocratica e doppio grado di giudizio, in Federalismi.it, n. 1/2020. Dello stesso A., sul tema del potere giurisdizionale che muta sotto il medesimo formante giurisprudenziale, v. Dall’atipicità delle azioni all’atipicità dei poteri del G.A. Torsioni del processo amministrativo in nome della giustizia, in Dir. proc. amm., n. 1/2020, pp. 59 ss.
[29] Sulla pervasività del potere giurisdizionale rispetto alla norma di legge, in chiave metodologica, v. da ultimo P.L. Portaluri, Di poeti, giudici e sirene. Cantiunculae supra methodum, in Dir. amm., n. 4/2022, pp. 915 ss.; il tema è oggetto anche del recentissimo volume di F. Saitta, Interprete senza spartito? Saggio critico sulla discrezionalità del giudice amministrativo, Napoli, 2023.
Il lavoro di pubblica utilità: quel che il reo toglie, il reo restituisce
di Fabrizio Guercio
Sommario: 1. Introduzione - 2. L’evoluzione normativa dell’istituto - 3. Gli ambiti di operatività del L.P.U. - 3.1 Sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi (post ‘‘Riforma Cartabia’’) - 3.2 Sospensione del procedimento con messa alla prova (M.A.P.) – 3.3 Sospensione condizionale della pena – 3.4 Istituto trattamentale dei detenuti e degli internati – 3.5 Reati di competenza del Giudice di Pace – 3.6 Violazione del Codice della Strada – 3.7 Violazione della disciplina normativa in materia di stupefacenti – 3.8 Altri ambiti settoriali – 4. Le ragioni sottese all’estensione della portata applicativa dell’istituto.
1. Introduzione
Il lavoro di pubblica utilità (d’ora in avanti indicato con l’acronimo L.P.U.) consiste nello svolgimento di un’attività non retribuita in favore della collettività, da effettuarsi presso lo Stato o gli altri territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) ovvero presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
A norma dell’art. 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, il L.P.U. può consistere in prestazioni di opera intellettuale o manuale, profondamente diverse per tipologia: dalla manutenzione del verde urbano all’assistenza di persone vulnerabili. Nello specifico:
1. «prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato».
Ai sensi del comma 2 del medesimo testo normativo, le attività di pubblica utilità sono prestate sulla base di apposite convenzioni stipulate dall’Ente ospitante con il Ministero della Giustizia o, su delega dello stesso, con il Presidente del Tribunale competente per territorio.
Tanto premesso, appare opportuna una breve ricostruzione dell’evoluzione storica del L.P.U.[1], prima di effettuare una compiuta ricognizione dei suoi ambiti di operatività e di esaminarne la cangiante natura giuridica: pena principale, pena sostitutiva, sanzione accessoria, obbligo del condannato, istituto trattamentale, condizione di estinzione del reato, condotta riparatoria o riabilitativa.
Infine, verranno analizzate le ragioni che – a parere dello scrivente – hanno indotto il Legislatore ad ampliare sempre più la portata applicativa del L.P.U., nelle sue molteplici sfaccettature.
2. L’evoluzione normativa dell’istituto
Dopo una prima, timida, apparizione nel nostro ordinamento con la Legge n. 689/1981, che ha previsto (agli articoli 102 e 103) la possibilità di convertire le pene pecuniarie in L.P.U., quest’istituto – ancora considerato come un ‘‘oggetto misterioso’’, cui guardare con diffidenza – è stato riproposto, a distanza di oltre un decennio, dalla Legge n. 122/1993, come sanzione accessoria facoltativa per le ipotesi di condanna per uno dei reati di cui all’art. 3 della Legge n. 654/1975 («Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale») ovvero per uno dei delitti previsti dalla Legge n. 962/1967, in materia di «Prevenzione e repressione del delitto di genocidio».
Soltanto col primo rintocco del terzo millennio il L.P.U. ha trovato una vera e propria consacrazione nel nostro ordinamento giuridico, seppur limitatamente ai reati di competenza del Giudice di Pace.
Il suo ambito di operatività, quindi, è stato progressivamente esteso: dapprima, ad alcune specifiche ipotesi delittuose e, successivamente, come obbligo dell’imputato o del condannato, per qualunque tipologia di reato, nelle ipotesi di «sospensione del procedimento con messa alla prova» e sospensione condizionale della pena.
Questo lento processo legislativo di valorizzazione dell’istituto in commento ha recentemente raggiunto il suo culmine con l’entrata in vigore della Legge n. 150/2022 (c.d. ‘‘Riforma Cartabia’’), che ha elevato il L.P.U. a sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi.
3. Gli ambiti di operatività del L.P.U.
Terminato questo breve excursus normativo (in chiave diacronica), è possibile focalizzare l’attenzione sugli ambiti applicativi del L.P.U. e sulla sua eterogenea natura giuridica.
3.1. Sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi (post ‘‘Riforma Cartabia’’)
L’art. 545 bis c.p.p., inserito dal D.Lgs. n. 150/2022 e rubricato «condanna a pena sostitutiva», stabilisce che «quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti».
La disposizione normativa da ultimo citata, radicalmente riscritta dal summenzionato D.Lgs. n. 150/2022, annovera tra le ‘‘pene sostitutive’’ anche il lavoro di pubblica utilità, prevedendo in particolare che, «Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di» tre anni, tenuto conto dell’eventuale aumento di pena di cui all’art. 81 c.p., può sostituirla con il L.P.U.
Tanto premesso, ai sensi della seconda parte dell’art. 545 bis co. 1 c.p., «Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria (...) il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso».
In base al comma secondo della disposizione normativa in commento «Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato» e può richiedere all’U.E.P.E., altresì, «il programma di trattamento (...) del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente».
Quindi, una volta «acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti (…) In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo».
Infine, a mente del succitato art. 53 L. 689/1981, «con il decreto penale di condanna, il Giudice, su richiesta dell’imputato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità».
3.2. Sospensione del procedimento con messa alla prova (M.A.P.)
L’art. 168 bis c.p., introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3 co. 11 Legge n. 67/2014, prevede che «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».
La ‘‘probation’’, che può essere concessa una sola volta, è necessariamente subordinata – ai sensi del comma 3 della succitata disposizione normativa – al L.P.U. e, in particolare, ad «una prestazione non retribuita (...) di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi», per un massimo di otto ore al giorno.
Inoltre, il L.P.U. deve svolgersi, ove possibile, tenendo conto delle «specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato» e, comunque, «con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute».
L’esito positivo della messa alla prova estingue il reato (art. 168 ter c.p.).
3.3. Sospensione condizionale della pena
Ai sensi dell’art. 165 co. 1 c.p., così come modificato dalla Legge. n. 145/2004, se il condannato non si oppone, il Giudice può (discrezionalmente) subordinare la sospensione condizionale della pena – quale causa di estinzione del reato – alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, secondo le modalità indicate nella sentenza e per un tempo comunque non superiore alla durata della pena sospesa.
Il successivo comma 2, inoltre, prevede che, se il beneficio de quo è concesso a chi ne abbia già usufruito in passato, la sospensione condizionale dev’essere necessariamente subordinata all’adempimento di uno degli obblighi indicati al comma precedente, tra cui – come anzidetto – il L.P.U.
Ne consegue che:
- nell’ipotesi in cui il condannato non abbia già beneficiato in passato del beneficio in commento, il Giudice può subordinare la pena al L.P.U. solo nel caso in cui il reo, espressamente interpellato sul punto, non abbia manifestato la propria opposizione;
- ove invece il condannato abbia già beneficiato della sospensione condizionale della pena, non occorre un suo espresso atto di assenso o dissenso, in quanto – per pacifica giurisprudenza – «la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione di quest'ultimo alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata» (cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. VI, n. 12079/2020).
3.4. Istituto trattamentale dei detenuti e degli internati
Ai sensi dell’art. 20 ter della Legge sull’ordinamento penitenziario (la n. 354/1975), inserito dall’art. 2 co. 1 lett. c) D.lgs. n. 124/2018, «1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative. 2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto (...) 4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati». Il comma 6 della disposizione in commento, inoltre, prevede delle apposite ‘‘cautele’’, in modo da contemperare lo svolgimento di tale attività risocializzante con le esigenze di pubblica sicurezza (ad esempio, «I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all'esterno dell'istituto»).
3.5. Reati di competenza del Giudice di Pace
Come sopra accennato, il L.P.U. irrompe nel nostro ordinamento – ancorché limitatamente ai reati di competenza del giudice di Pace – con il D.Lgs. n. 274/2000, i cui articoli 54 e 55 lo configurano, rispettivamente, come pena principale (alternativa a quella detentiva) e come pena sostitutiva.
A norma dell’art. 54, il Giudice di Pace può applicare – per i reati di sua competenza rationae materiae – la sanzione del L.P.U., purché l’imputato ne faccia espressa richiesta.
La prestazione dell’attività di pubblica utilità – da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, ma comunque nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato – «non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi» e non può eccedere le sei ore settimanali (salvo che il condannato richieda diversamente) e le ore otto ore giornaliere. Il L.P.U., inoltre, deve aver luogo «con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato».
Stando al disposto del comma 5, «ai fini del computato della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro».
Le modalità di svolgimento del L.P.U. – la cui definizione è demandata dal successivo comma 6 al Ministro della giustizia, con decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 281/1997 – sono state concretamente determinate con il D.M. 26.3.2001 di cui al paragrafo 1).
La verifica periodica sull’osservanza degli obblighi connessi al L.P.U. spetta – in base a quanto disposto dal successivo art. 59 – all’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente per territorio o, in mancanza, al comando territoriale dell’Arma dei Carabinieri.
La mancata presentazione nel luogo in cui il L.P.U. dev’essere svolto o l’abbandono dell’attività integra, in assenza di un «giusto motivo», un’autonoma fattispecie delittuosa, punita «con la reclusione fino a un anno» (art. 56 co. 1); alla stessa pena soggiace chi violi reiteratamente e senza giustificato motivo gli obblighi o i divieti inerenti al L.P.U. (ad esempio, presentandosi in ritardo o non osservando le direttive impartitegli, per almeno due volte).
***
L’art. 55 del testo normativo de quo, invece, configura il L.P.U. come una pena sostitutiva di carattere doppiamente residuale, in quanto richiede che la pena pecuniaria – per uno dei reati di competenza del Giudice di Pace – non sia stata eseguita, per insolvibilità del condannato, entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione (ex art. 660 c.p.p.), e che lo stesso condannato vi faccia richiesta: in tale ipotesi, la pena pecuniaria si converte «in lavoro di pubblica utilità da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54». Per espressa previsione normativa, inoltre, «Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a 250 euro di pena pecuniaria» e, in caso di violazione del L.P.U. ‘‘sostituito’’, «la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5».
Il condannato, tuttavia, può far cessare in qualunque momento la pena sostitutiva del L.P.U. pagando la pena pecuniaria, «dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata» (art. 55 ult. co.).
3.6 Violazione del Codice della Strada
A mente dell’art. 224 bis del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992), introdotto dall’art. 6 della L. n. 102/2006, nelle ipotesi di delitti colposi commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale (segnatamente, nei casi di cui agli artt. 589 bis, 590 e 590 bis c.p.), nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva, il Giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria del L.P.U., la cui durata non può essere inferiore a un mese (tre, in caso di recidiva) né superiore a sei mesi. Per espressa previsione di legge, inoltre, «L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato», il quale, tuttavia, può richiedere di svolgere il L.P.U. per più di sei ore settimanali. In ogni caso, la durata della prestazione lavorativa giornaliera non può superare le otto ore.
Ove il condannato violi gli obblighi connessi a tale sanzione, si configura– per effetto dell’espresso richiamato normativo – la summenzionata fattispecie delittuosa di cui all’art. 56 D.lgs n. 274/2000, che è punita «con la reclusione fino a un anno».
***
Ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada (introdotto dalla Legge n. 120/2010), fuori dall’ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, se non vi è opposizione dell’imputato, la pena detentiva e pecuniaria (ammenda e arresto) irrogata per uno dei reati previsti dal medesimo articolo («guida in stato di ebbrezza», nelle sue diverse ‘‘declinazioni’’, e «rifiuto di sottoporsi ad accertamenti») può essere sostituita, una sola volta, anche col decreto penale di condanna, con quella del L.P.U., «da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze».
In queste ipotesi, «In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità».
Inoltre, con la sentenza o col decreto penale di condanna, il Giudice incarica l’U.E.P.E. o l’Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o il comando territoriale dell’Arma dei Carabinieri, di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Se il L.P.U. ha esito positivo, il Giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, disponendo altresì «la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato»; per contro, «In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio (...) tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca».
***
Un’analoga previsione normativa è dettata dall’art. 187 comma 8 bis C.d.S., introdotto dalla Legge n. 120/2010, a tenore del quale, fatta salva l’ipotesi in cui il conducente in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia provocato un incidente stradale, se non vi è opposizione dell’imputato, la pena detentiva e pecuniaria (ammenda e arresto) irrogata per i reati di cui ai commi 1 («guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope») e 8 (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti») può essere sostituita, una sola volta, anche col decreto penale di condanna, con quella del L.P.U., «da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato», congiuntamente alla «partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente».
Anche in questi casi:
- «In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità»;
- con la sentenza o col decreto penale di condanna, il Giudice incarica l’U.E.P.E. o l’Ufficio di P.S. del luogo di esecuzione della pena o il Comando territoriale dell’Arma dei Carabinieri, di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- se il L.P.U. ha esito positivo, il Giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, disponendo altresì «la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato»;
- «In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio (...) tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca».
3.7. Violazione della disciplina normativa in materia di stupefacenti
A mente dell’art. 73 co. 5 bis del D.P.R. n. 309/1990 (così come modificato, da ultimo, dalla L. n. 79/2014), nel caso in cui una persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope riporti una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per fatti di lieve entità (ai sensi del comma 5 del medesimo testo normativo), qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, il Giudice, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., può applicare – in luogo delle pene detentive e pecuniarie – il L.P.U., secondo le modalità previste dall’art. 54 D.lgs. n. 274/2000, per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Sennonché, «In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione (...) tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita».
Ai sensi del successivo comma 5 ter (aggiunto dal D.L. n. 78/2013), poi, «La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona».
3.8. Altri ambiti settoriali
Oltre che nelle ipotesi sopra citate di cui alla Legge n. 689/1981 (come sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, su richiesta del condannato[2]) e al D.L. n. 122/1993 (come sanzione accessoria irrogabile con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 3 Legge n. 654/1975, con cui è stata ratificata ed eseguita la «convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale», o dalla Legge n. 962/1967, in materia di «Prevenzione e repressione del delitto di genocidio»)[3], il L.P.U. trova applicazione nei seguenti ambiti:
- come ‘‘condotta riabilitativa’’ in materia di «divieto di accedere a manifestazioni sportive» (D.A.SPO.), ai sensi del comma 8 bis dell’art. 6 L. n. 401/1989, come modificato dal D.L. n. 53/2019[4];
- come obbligo cui subordinare, in caso di mancata opposizione del condannato e in alternativa all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di «danneggiamento» di cui all’art. 635 c.p., così come modificato dall’art. 3 co. 2, lett. b), della L. n. 94/2009 e dall'art. 7 co. 1, lett. d), D.L. n. 53/2019;
- come obbligo cui il Giudice può subordinare, in caso di mancata opposizione del condannato e in alternativa al ripristino o alla ripulitura dei luoghi (ovvero, quando ciò non sia possibile, al pagamento delle spese necessarie in tal senso o al rimborso di quelle sostenute a tal fine), la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di «deturpamento e imbrattamento di cose altrui» commesso su «beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati» o nei casi di recidiva, ex art. 639 commi 2, 3 e 5 c.p.;
come obbligo cui subordinare, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la sospensione condizionale della pena inflitta per il delitto di «Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici», disciplinato dall’art. 518 duodecies, recentemente introdotto dalla L. n. 22/2022 (unitamente agli altri articolo di cui si compone il titolo VIII bis del codice penale, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale»).
4. Le ragioni sottese all’estensione della portata applicativa dell’istituto
Come sopra esposto, dopo un esordio un po’ stentato, l’istituto del L.P.U. ha progressivamente trovato un ambito applicativo sempre più ampio all’interno del nostro ordinamento giuridico, pur mantenendo la sua natura proteiforme.
E le ragioni di fondo di questa scelta legislativa possono rinvenirsi:
1. in un’ottica deflattiva della popolazione carceraria;
2. nella funzione rieducativa della pena;
3. nella spiccata funzione retributiva del L.P.U.
Sul primo versante, è innegabile lo sforzo profuso dal Legislatore, già da diversi decenni, per ridurre il numero di detenuti, anche in un’ottica di contrazione delle spese penitenziarie: dapprima attraverso istituti come l’indulto e l’amnistia e, da ultimo, mediante interventi normativi finalizzati a promuovere la natura ‘‘residuale’’ della detenzione inframuraria e della custodia cautelare in carcere, inibendone il ricorso nelle ipotesi di condotte di reato non particolarmente gravi e, comunque, tali da non generare un significativo ‘‘allarme sociale’’.
È del pari innegabile, poi, che il L.P.U. svolga (o, comunque, ambisca a svolgere) una fondamentale funzione risocializzante del reo, in armonia col dettato di cui all’art. 27 comma 3 della Carta costituzionale, secondo cui le «pene devono tendere alla rieducazione del condannato», da intendersi – in un’accezione laica e non moraleggiante – come il positivo (ancorché graduale) reinserimento del reo all’interno della propria comunità di appartenenza, per effetto della ‘‘correzione’’ di quei comportamenti antisociali che l’hanno indotto a delinquere: in tal senso, l’imposizione di una prestazione non retribuita in favore della collettività, oltre a sortire sul reo un effetto special-preventivo, lo ‘‘responsabilizza’’, nella misura in cui lo costringe a confrontarsi col ‘‘danno criminale’’ arrecato alla collettività con la propria condotta penalmente rilevante.
E proprio a questo profilo è legato a filo doppio quello che – a parere dello scrivente – costituisce l’elemento caratterizzante il L.P.U.: la funzione retributiva.
Orbene, secondo i sostenitori della ‘‘teoria retributiva della pena’’, nella sua accezione classica, la sanzione penale costituisce il ‘‘corrispettivo’’ del male arrecato dal reo alla società, come magistralmente compendiato nel brocardo «malum passionis quod infligitur ob malum actionis» («il male della sofferenza che è inflitto a causa del male dell’azione»)[5]: in termini più esplicativi, poiché ha arrecato un vulnus all’‘‘ordine costituito’’, il reo deve ricevere una punizione che gli provochi pari sofferenza (donde la natura afflittiva e, al contempo, proporzionale della risposta punitiva dello Stato).
Intesa in questi termini, la teoria della pena come ‘‘retribuzione’’ appare obsoleta e in aperto contrasto con il succitato art. 27 co. 3 Cost., a tenore del quale, inoltre, «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità», quale che sia l’entità del «malum actionis».
Cionondimeno, una lettura ‘‘costituzionalmente orientata’’ della teoria retributiva della pena, alla luce di quella funzione rieducativa scolpita nella Carta fondamentale, non solo è possibile, ma è addirittura auspicabile.
E invero, guardando al condannato come a un «animale sociale»[6] (piuttosto che come a un ‘‘relitto della società’’), appare di gran lunga preferibile che – a titolo meramente esemplificativo – l’autore di un efferato delitto di tipo ‘‘predatorio’’, invece di scontare i propri ‘‘debiti con la Giustizia’’ in carcere o in regime di detenzione domiciliare, si rimbocchi le maniche e, inforcando il rastrello in luogo di un grimaldello, pulisca le aiuole della città in cui, con la propria condotta antigiuridica, qualche tempo prima aveva infranto la ‘‘pace sociale’’.
Ma soprattutto, l’idea di contemperare la funzione rieducativa della pena e quella retributiva non è un’utopia, atteso che l’istituto in commento risponde perfettamente a questa finalità: rieducare il reo attraverso l’imposizione di un’attività non retribuita, di tipo morale o materiale, preordinata a ‘‘ristorare’’ la sua comunità di appartenenza.
In altri termini, attraverso il lavoro di pubblica utilità, ciò che il reo toglie, il reo dà, sia pure sotto altra forma: manutenzione del verde pubblico o di beni demaniali, assistenza in favore dei tossicodipendenti, etc…
E così quel «malum passionis» di cui parlavano gli antichi si converte in «bonum actionis»: il bene dell’attività di pubblica utilità per il male dell’azione criminosa.
[1] Cfr., sul punto, il fondamento contributo dell’Avv. Fabio Piccioni, dal titolo ‘‘Il lavoro di pubblica utilità’’, pubblicato sul sito ‘‘Altalex’’ e reperibile al seguente link: https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2020/01/15/lavoro-pubblica-utilita#_Toc29978221
[2] Ex art. 102 co. 2, «Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo» (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, 14-21 giugno 1996, n. 206, nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione).
[3] Merita di essere segnalato che, ai sensi dell’art. 1 co. 1-quinquies della disposizione normativa in commento, «Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654».
[4] «Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1 [ossia «il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime»], l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del medesimo divieto (…) La cessazione è (…) concessa se il soggetto ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali (…) lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (…) e ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive».
[5] Cfr. Grozio, De iure belli ac pacis, lib. II, cap. XX, § 1,1.
[6] Secondo la celeberrima definizione di ‘‘uomo’’ di Aristotele («O ἄνθρωπος φύσει πολιτικoν ζῷον», «O anthropos physei politikon zoòn»).
Sommario: 1. Il diritto e il fine vita pensando ad Arturo Carlo Jemolo - 2. Il cammino della giurisprudenza e del legislatore sul fine vita - 3. Perché serve la legge. Il diritto di amarsi con dignità fino alla fine della vita.
1. Il diritto e il fine vita pensando ad Arturo Carlo Jemolo
Vorrei cominciare la mia riflessione partendo da un incipit che più volte è stato richiamato nel corso dei lavori rappresentato dalla oramai storica espressione di Arturo Carlo Jemolo a proposito dei rapporti fra famiglia e diritto – un’isola che il diritto può solo lambire, ma lambire soltanto – dalla stessa prospettiva prudenziale mutuando un’idea di sostanziale sfavore per un intervento del diritto sulla materia del fine vita. Disfavore che si esprime, oggi, rispetto ad un intervento regolativo da parte del legislatore ma che, implicitamente, direi soffusamente, si rivolge a tutti quegli operatori del diritto che hanno con le loro condotte imposto all’attenzione della società e del mondo politico il tema del fine vita. E sì, perché, affermare che l’intervento del legislatore, oggi, andrebbe a “lambire” qualcosa che non appartiene al diritto ma semmai all’etica ed agli ambiti filosofici, altro non vuol dire che se ci si fosse attenuti alla regola del Prof. Jemolo non si sarebbe nemmeno dovuti giungere alle “risposte” che la giustizia comune - ordinaria ed amministrativa- e quella costituzionale hanno nel tempo offerto sul tema del fine vita. E risalendo ancor di più a ritroso il pensiero che si aggancia all’isola non v’è che chi non veda la nemmeno malcelata insoddisfazione per le risposte rese dalla giurisdizione sul tema, insoddisfazione questa volta di sostanza, che si appuntano contro la “direzione” intrapresa, considerandola a sua volta espressiva di un fare giurisprudenza creativa, scollato dalla tradizione giuridica ma, ancor più gravemente dalle coordinate costituzionali intessute attorno alla netta separazione fra ambito legislativo e giurisdizionale.
Le riflessioni che seguono, tutto al contrario, cercheranno di mettere in luce gli aspetti positivi che il “cammino” intrapreso dalla giurisprudenza sul tema del fine vita ha prodotto rispetto alla tutela della persona, per giungere ad alcune conclusioni di sistema su alcuni dei nodi scoperti che ruotano attorno al ruolo del giudice, ad i suoi rapporti con il legislatore ed alla funzione che il sistema costituzionale gli attribuisce.
2. Il cammino della giurisprudenza e del legislatore sul fine vita
Chi scrive ha già provato a misurarsi sul tema del fine vita.
Sono quindi allora qui sufficienti poche battute sul cammino della giurisprudenza e del legislatore sul tema del fine vita, per il resto rinviandosi alle riflessioni in passato esposte, per quel nulla che possano ancora valere[1].
Cass. n.21748/2007, nel decidere il caso Englaro e nel riconoscere il diritto della persona non più capace di interrompere, attraverso l’ufficio del tutore chiamato ad operare nel suo interesse, le cure che in situazione di coscienza aveva espresso di non voler ricevere se fosse caduta in uno stato di incoscienza, ha rappresentato il punto di svolta del sistema di protezione giurisdizionale del diritto all’autodeterminazione del malato, realizzato attraverso la valorizzazione di principi di valore costituzionale[2]. Pronunzia che rappresenta un vero e proprio paradigma di un modo di argomentare del giudice che guarda al diritto, anche in chiave comparatistica, come espressione dell’uomo nella sua complessità e che riempie i vuoti e le lacune mettendo al centro della decisione la persona umana e la sua dignità.
La sentenza n.21748/2007 è stata da una parte della dottrina – ed in verità non solo dalla dottrina – additata, probabilmente per le implicazioni umane vissute con sofferenza – ed in modo diametralmente opposto –, come esempio di travalicamento, attraverso il canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, dei compiti del giudice interno e dell’obbligo sullo stesso ricadente di applicare e non “creare” la legge.
Il giudice comune avrebbe dato vita, attraverso il caso concreto, ad una vera e propria manipolazione, con l’arma dell’interpretazione, dei valori e dell’ordine di priorità in cui sono disposti saccheggiando orientamenti giurisprudenziali “altri” che poco o nulla avrebbero rilievo nell’ordinamento interno e giungendo a risultati frutto di preferenze soggettive e di intuizioni emozionali capaci, addirittura, di aggirare il comando legislativo ed il vincolo di soggezione alla legge, fino al punto di mortificare il significato proprio del controllo incidentale di legittimità costituzionale. Secondo questa prospettiva il valore della dignità umana sarebbe diventato una sorta di artificio, in assenza di una posizione espressa dal legislatore in ordine alla possibilità di intervento sulla vita altrui da parte di soggetti pur legati da vincoli di parentela, oltre che sulla natura stessa dello stato vegetativo permanente e dell'alimentazione forzata. Sotto tale profilo la decisione dei giudici (di legittimità e di quelli di merito in sede di rinvio), conclamava un vero e proprio (grave) straripamento del (potere) giudiziario, mistificando le regole della "scienza", proiettate nel senso di riconoscere una pur limitata attività cerebrale anche nei soggetti che si trovano in tale sventurata condizione.
Ciò renderebbe l'attuale sistema antidemocratico, in balia della “tirannia dei valori”[3] e della giurisdizione allorché il giudice offre, spogliando i cittadini e chi li rappresenta, del potere di decidere ciò che è giusto e ciò che non è giusto o degno per un essere umano, modificando il modello costituzionale della tutela dei diritti, che riconosce al legislatore il compito di confezionare i diritti ed al giudice soltanto di applicarli e tutelarli.
Su altro versante si è cercato di mostrare, al contrario, le virtù della sentenza Englaro, stigmatizzando le critiche, a volte con toni peraltro inaccettabili, espresse contro i contenuti della decisione ed il modo di giudicare che essa rappresenta[4].
Qui è sufficiente ribadire che Cass. n. 21748/2007 si inscrive in quel movimento giurisprudenziale secondo il quale il giudice, di fronte al "silenzio" del legislatore, non può rimanere inerte rispetto ad una domanda di giustizia, ove questa sia giustificata e tutelata dal quadro dei principî scolpiti all'interno del sistema – integrato nel senso appena descritto – non essendogli consentito un non liquet. Rispetto all'assenza di un humus comune e condiviso, il giudice non deve né può indietreggiare o deflettere dal ruolo e dalla funzione che questi svolge allorché emergano, in termini sufficientemente chiari e prevedibili, dei principî di base che trovano la loro naturale collocazione all'interno delle Carte dei diritti fondamentali, per come vivificate dai rispettivi diritti viventi.
Comunque la si pensi rispetto alla sentenza Englaro, non si può negare che la legge n.219/2017, dedicata al tema della relazione di cura fra medico e paziente e alle dichiarazioni anticipate di trattamento, si muova sul binario tracciato dalla stessa pronunzia Englaro, ponendo al centro proprio quelle coordinate di base fondate sui canoni della dignità, dell’autodeterminazione e del consenso che la sentenza già evocata aveva valorizzato, diffondendosi con una disciplina, questa volta destinata ad operare in via generale e che si basa sull’alleanza del medico con il paziente, finalmente valorizzando anche sfere di interessi rimaste spesso poco considerate in passato (parenti, minori). Il tutto in una prospettiva tesa a salvaguardare la dignità del malato – e di chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità - secondo canoni di efficienza ed effettività sempre perfettibili e magari passibili di ulteriori e più ampie forme di tutela allorché il contesto sociale e le sensibilità che in esso maturano ne richiedano ulteriori approfondimenti.
La legge n.219/2017 appena ricordata aveva tuttavia un limite intrinseco, rappresentato dal combinato disposto dell’art. 1, c.5, e del comma uno dell’art. 2, laddove prende in considerazione la posizione del malato che decide di rinunziare o rifiutare i trattamenti sanitari necessari per la propria sopravvivenza e che, per tale scelta, si trova esposto alle sofferenze fisiche e psicologiche che si presenteranno in esito a tale scelta. Il legislatore ha previsto, anche in questi casi, un intervento attivo del medico, questa volta non orientato a salvaguardare il prolungamento della vita del malato, ma a garantire l’apprestamento di condotte di sostegno anche sanitario - legge 15 marzo 2010 n.38 - a beneficio del medesimo.
Ci si chiedeva, dunque, fino a che punto si potesse spingere l’attività di sostegno in favore di chi decide, in fase terminale, di non volere più vivere, ritenendo che un’esistenza martoriata dal dolore e dalla sofferenza equivalga ad una ‘non vita’ e sia contraria alla propria dignità. Poteva il malato chiedere l’aiuto a porre fine alla propria esistenza quando non è in condizioni di autonomamente realizzare il proprio proposito? Quali conseguenze derivavano a carico di chi, esercente o meno la professione medica, offriva il proprio contributo attivo al fine di realizzare siffatto proposito? Il sistema sanitario doveva farsi carico di venire incontro a tale esigenza e fino a che punto poteva essere preteso un intervento in tale direzione da parte del medico?
A questi e ad altri interrogativi non forniva risposte complete la legge n.219/2017, essa limitandosi ad escludere che il paziente non potesse pretendere dal sanitario trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Rispetto a tali richieste, dunque, il medico, afferma il comma 6 dell’art. 1 della l. n.219/2017, “non ha obblighi professionali”.
Non si dubitava, peraltro, che la legislazione in vigore non consentisse al medico che ne fosse richiesto, di mettere a disposizione del paziente che versi nelle condizioni sopra descritte, trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte. – cfr. Corte cost. n.207/2018[5] e Corte cost.n.242/2019[6] –.
È dunque questo il contesto nel quale intervengono le due pronunzie della Corte costituzionale sulla triste vicenda del dj Fabo, che sono state scandagliate dagli altri relatori e, per parte di chi scrive, già oggetto di separata riflessione, mostrando apertis verbis il vuoto di tutela in atto esistente nell’ordinamento.
E ciò perchè è proprio l’esame congiunto delle due pronunzie a confermare come le stesse, nate in un ambito prettamente penalistico, nel quale dunque i giudici costituzionali erano stati chiamati a verificare gli effetti di una condotta agevolativa dell’accelerazione al fine vita del dj Fabo, hanno poi visto i giudici costituzionali offrire una risposta, o se si vuole un progetto di risposta, che ha ampliato enormemente il tema di indagine e non ha guardato soltanto al problema dei riflessi penalistici della condotta, ma ha tentato di scrutare il tema generale. Una risposta che ha coinvolto il diritto, si è detto prospettato prima ed accertato con l’ultima pronunzia, di ogni persona in condizioni di malattia irreversibile ad accelerare la fine della vita nella ricorrenza di determinati – e, per i più, tassativi – presupposti fissati dalla stessa Corte costituzionale.
I seguiti che la giurisprudenza costituzionale ha prodotto nella giurisprudenza comune, dopo avere certificato l’impossibilità di ovviare alla lacuna normativa esistente, con il proposto referendum, rendono plasticamente urgente ed ineludibile un intervento “di cornice” del legislatore.
Le poche riflessioni che seguono saranno dunque orientate a rendere palese le ragioni di tale duplice esigenza.
3. Perché serve la legge. Il diritto di amarsi con dignità fino alla fine della vita
Stefano Rodotà ci ha consegnato un testo molto interessante e delicato, dedicato al tema “amore e diritto”.
In esso non manca, ancora una volta, un attento richiamo alla frase di Jemolo già ricordata. Richiamo che, per l’un verso, è riconoscimento tangibile della centralità, nel pensiero di Jemolo, del tema degli affetti e (ma) per altro verso, si presta ad un’analisi in qualche modo critica sull’idea che il ritirarsi del diritto di fronte a ciò che è amore ed a lasciare che esso sia "isola" non lasci davvero irrisolti alcuni nodi che riguardano, appunto, il tema del rapporto fra amore e diritto[7]. Si trattava, allora, di un’analisi incentrata su tratti apparentemente diversi da quelli che qui oggi esaminiamo, destinati ad incollarsi con una scelta (tragica) di morte che sembra istintivamente collocarsi in un campo “altro” rispetto a quello dell’amore. Ambiti nei quali, al momento in cui il libro venne alla luce (2015, ma in realtà pensato ancor prima come l’Autore attesta nel ringraziamento finale) non solo non vi era una legislazione interna sulle unioni civili ma nemmeno era stata emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo la sentenza Oleari c. Italia.
Insomma, un’epoca nella quale l’assenza di una legislazione sul tema delle unioni omosessuali era avvertita da Rodotà come lesiva del diritto d’amare e, dunque, della dignità dell’uomo. L’assenza di legislazione nella materia anzidetta aveva il senso di una privazione di garanzia all’amore nella sua pienezza (p.19).
Ed è qui che l’analisi di Rodotà intercetta il tema dell’autodeterminazione, ragionando attorno alla tutela del diritto alla salute. Un principio fondativo, scolpito da Corte cost. n.438/2008 prima e dalla giurisprudenza della Corte edu – in particolare (Corte edu, Pretty c. Regno Unito) e di legittimità, poi[8].
È proprio questa analisi a tornare utile quando ci si interroga sull’opportunità o meno di una legislazione in materia di fine vita.
A sommesso avviso di chi scrive, vi è la necessità di offrire una tutela effettiva al diritto di ogni persona di liberamente autodeterminarsi rispetto alla propria esistenza, purché questo si concili con altre imperiose esigenze correlate alla fragilità delle persone coinvolte, alla piena libertà e capacità di esprimere validamente il consenso verso una scelta irrimediabile, dopo che essa si manifesta ed è posta in esecuzione.
Il che conferma che in materia esistono diritti fondamentali da tutelare e, fra questi, quello di amarsi fino alla fine con dignità del malato terminale che decide, secondo il proprio convincimento, di volere cessare di vivere. Senza tuttavia dimenticare che questo diritto fondamentale non può essere considerato assoluto e tiranno, ma deve convivere con altre esigenze parimenti fondamentali che attengono alla stessa persona ed al suo essere parte di una comunità.
Questo sembra essere, in definitiva l’insegnamento da trarre dal composito esame delle giurisprudenze delle Corti nazionali e sovranazionali che si sono espresse sul tema.
Se il diritto alla cura e al rifiuto alle cure è già oggi da considerare meritevole di piena tutela, ove espresso e procedimentalizzato secondo i canoni fissati dalla l. n.219/2017, è proprio la necessità di offrire parimenti tutela, nelle forme che il legislatore intenderà fissare sulla base della griglia di indicazioni offerte dalla Corte costituzionale, al diritto a porre fine alla propria esistenza con dignità, a reclamare con forza una disciplina normativa che consenta a quel diritto fondamentale, scolpito attorno ai canoni di dignità-autodeterminazione-fragilità, di realizzarsi pienamente ed in modo effettivo.
Ed infatti, il varco aperto nella legislazione penale dalla Corte costituzionale ma, ancora di più, l’avere concretizzato - o inventato, per usare la felice (ed al tempo stesso solo apparentemente provocatoria) espressione dell’indimenticato Paolo Grossi – il diritto al suicidio assistito, secondo paradigmi e contenuti che il giudice delle leggi ha fissato, per giungere alla caducazione parziale dell’art. 580 c.p., ha inevitabilmente calamitato nel sistema in una situazione di incertezza sul quomodo con il quale questo diritto a por fine alla propria esistenza debba essere declinato, su quale debba essere il ruolo del servizio sanitario nazionale e dei comitati etici nell’attuazione dello stesso, sulle modalità operative, sull’obiezione di coscienza da eventualmente riconoscere al sanitario.
Insomma, un fascio di questioni alle quali non possono non aggiungersi quelle imposte dall’interpretazione che le Corti di merito hanno offerto delle condizioni legittimanti il c.d. suicidio assistito, confrontandosi con “casi della vita” in parte diversi da quello preso in esame dal giudice costituzionale.
Ora, chi scrive è dell’avviso che l’attuale situazione sia al tempo stesso fisiologica e patologica. Lo è nel primo senso laddove si considera che il giudice nazionale al quale sono posti casi della vita da risolvere originati dalle sentenze della Corte costituzionale già ricordate è responsabile delle decisioni che gli sono sollecitate, alle stesse non potendo opporsi con una semplice presa d’atto che manca una legge. Posizione che non lo renderebbe fedele alla Costituzione (art.54) ed agli obblighi che nascono dalla funzione giurisdizionale che lo stesso esercita. E nella stessa prospettiva non si può nascondere l’utilità della formazione progressiva di un diritto vivente che, proprio in relazione alla mutevolazza dei casi della vita, offra soluzioni concrete nello stigma fissato dalla Corte costituzionale[9].
Come ci è capitato altre volte di osservare, gli operatori di giustizia non possono nascondersi dietro un dito e non considerare che le coordinate di un sistema nel quale la produzione del diritto è sempre più plurale, promanando da centri di imputazione che la democrazia, le sue regole, e in particolare quelle che la Costituzione ha fissato, individuano come “motori propulsori” dei diritti al servizio della società. E tra questi sono proprio i casi della vita a dimostrarsi spesso difficili, onerosi, complessi per chi è chiamato a giudicare, esponendolo a ruoli e modi di essere che non gli sono congeniali, egli essendo ontologicamente chiamato a condannare o assolvere, più che ad essere arbitro delle esistenze altrui.
Ma è pure vero che la funzione giurisdizionale è essa stessa figlia del suo tempo, della coscienza sociale, della cultura di un popolo, anche quando è chiamata a verificare la coerenza, attualità e capacità del sistema normativo vigente di rispondere alle esigenze avvertite da chi è parte della società[10].
Detto questo non si può non convenire con chi – R. Bin[11] e da ultimo, G.Luccioli, nel suo saggio, intenso, dedicato al tema del fine vita[12] – auspica un intervento del legislatore in materia. Non vi è alcuna contraddizione, almeno agli occhi di chi scrive, fra quanto fin qui detto e l’esigenza di un intervento normativo che “universalizzi” le indicazioni offerte dalla Corte costituzionale, affidando al legislatore il bilanciamento fra i valori che si fronteggiano in materia e dia veste normativa agli auspici espressi dalla Corte costituzionale a proposito della creazione di un processo medicalizzato, prevedendo eventualmente la riserva esclusiva al servizio sanitario nazionale, in uno all’obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto – p.10 Cons.in diritto sent.n242/2019 –.
Ora, sembra evidente che porsi dal lato di chi evoca, ancora una volta, per rispettabilissime ragioni di natura etica, l’idea dell’isola per rappresentare l’intendimento sfavorevole ad una regolamentazione in via normativa del fine vita avrebbe il senso di una regressione verso posizioni di “non diritto” che, per converso, contrastano con le indicazioni della Corte costituzionale.
Ovvia l’obiezione ad una simile conclusione di chi ha stigmatizzato il “suprematismo giudiziario” della Corte costituzionale proprio in questo ambito – Bin[13] per tutti – e contesta l’ortodossia costituzionale della posizione espressa in tema di suicidio c.d. assistito.
Ma a tale obiezione si può agevolmente opporre il solido aggancio del diritto al suicidio assistito ai valori costituzionali e, soprattutto, alla dignità della persona. Dacché la mancata regolamentazione dell’attuale assetto desumibile dal diritto vivente non può che generare una situazione di caos alla quale il legislatore può porre rimedio per offrire una cornice di principi che siano poi attuati in relazione ai singoli casi della vita dal giudice. E ciò anche in modo da offrire una regolamentazione essenziale sul ruolo dell’autodeterminazione, in relazione alla situazione di fragilità nella quale si trova coinvolto il paziente che decide di porre fine alla propria esistenza. Tema, quest’ultimo che richiede particolare attenzione quando sono coinvolti minori di età[14].
Quanto al quomodo dell’intervento normativo[15], altre volte abbiamo provato a rappresentare l’idea che la materia di cui si discute si presta ad una disciplina mite, nella quale la cornice dei principi che il legislatore deve fissare offra poi all’interprete la possibilità di attuarla in relazione alla molteplicità e diversità dei casi della vita, in modo da offrire una risposta alla domanda di giustizia, quanto più rispondente ai canoni ed ai valori che qui si è provato a sunteggiare.
Chi scrive crede davvero nel canone della fiducia che deve animare gli operatori che compongono il frastagliato pianeta giustizia. Una fiducia che, come ha di recente scritto Tommaso Greco[16] deve tendere a creare una stabile rete di collegamento fra i diversi protagonisti del diritto, animandoli a cooperare in vista di un diritto più flessibile, più mite o più duttile[17].
Occorre dunque adoperarsi, ad ogni livello, in una prospettiva di ricercata alleanza fra mondo politico ed operatori del diritto. Alleanza che consenta al legislatore di esaminare il diritto giurisprudenziale fin qui emerso per valutarne la congruenza rispetto agli obiettivi che esso intende perseguire, ma anche agli altri operatori del diritto di offrire indicazioni che potrebbero tornare utili allo stesso legislatore, senza con questo invadere competenze altrui, ma appunto mettendo a disposizione dell’organo legittimato a provvedere, la propria esperienza da giudice e da giurista al servizio delle istituzioni. Tutto ciò in vista di un obiettivo comune che vede nella “rete” l’idea migliore per cooperare insieme agli altri costruttori del diritto e che viene ormai indicato come paradigma sul quale il diritto non può che fondarsi a fronte della sua pluralità[18]. Il che, in definitiva, sembra essere una prospettiva sulla quale potere e dovere investire fruttuosamente.
Non resta, a questo punto, che dedicare a chi è giunto fino a questo punto della lettura le parole di Guido Calabresi sul tema del dialogo[19], nella speranza che esse possano essere fatte proprie da tutti gli operatori del diritto con coscienza, coraggio e responsabilità emarginando suggestioni pericolose che ventilano più o meno apertamente lo spettro di omicidi per sentenza.
Ora, in questo stato di cose, che cosa tiene legati i giudici al rispetto dei limiti? Che cosa impedisce loro di arrogarsi un potere eccessivo? Che cosa li aiuta a conservare qualcosa della metodicità e cautela dei loro omologhi del passato in un mondo tanto accelerato e proteiforme? Il metodo dialogico è la soluzione moderna affinché il giudice sia inserito in un contesto di costante confronto, conforto, ispirazione, influenza, scambio e limite con altre Corti, altre giurisdizioni, altri Stati, altri interlocutori istituzionali. Il dialogo attenua la ferocia repentina e drastica con cui il giudice assolverebbe il suo ruolo nel contesto giuridico moderno, raccostandolo alla prudenza mite, incessante ma graduale, che apparteneva ai suoi predecessori della common law al fine di aggiornare e migliorare il diritto.
[1] Sia consentito il rinvio a R.G.Conti, Scelte di vita e di morte. Il giudice è garante della dignità? Roma, Aracne, 2019.
[2] N. Lipari, Il diritto civile tra legge e giudizio, Milano, 2019., 91.
[3] Cfr., S. Staiano, Legiferare per dilemmi sulla fine della vita: funzione del diritto e moralità del legislatore, in il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi, a cura di A. D’Aloia, Napoli 2012, 391, che ricorda la lezione schmittiana sull’assolutezza della legge accompagnata da una Costituzione priva di norme di garanzia a presidio della persona.
[4] G. Ferrando, Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo e Costituzione, in Pol. Dir., 2012,1, 3 ss.
[5] A. Ruggeri, Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord.n.207 del 2018), in Consultaonline, n.1/2019.
[6] A. Ruggeri, La disciplina del suicidio assistito è “legge” (o, meglio, “sentenza legge”), frutto di libera invenzione della Consulta (a margine di Corte cost., n.242 del 2019), in Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti XXIV. Studi dell’anno 2020, Torino, 2021, 47 ss.
[7] S. Rodotà, Diritto d’amore, Roma-Bari, 2015, in particolare, 11,12 e 18.
[8] V. volendo, senza pretesa alcuna di esaustività per solo per comodità di chi scrive e vantaggio di sintesi in questa sede, R. Conti, I giudici e il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della Cassazione e delle Corti europee, Roma, 2015, 122 ss.
[9] Sia consentito il rinvio a R. G. Conti, La giurisdizione del giudice ordinario e il diritto UE, in Le trasformazioni istituzionali a sessant’anni dai trattati di Roma, a cura di A. Ciancio, Torino, 2017, 99.
[10] Tornano alla mente le parole del Professore e Presidente emerito della Corte costituzionale Paolo Grossi che in questi giorni è mancato ai vivi, ormai da lustri orientate a descrivere il mondo del diritto sempre più votato e indirizzato verso la postmodernità proprio per il caos normativo che costituisce la regola dell’essere giuristi del nostro tempo. Ed è stato proprio Grossi che "...La Costituzione è còlta - ripetiamolo, perché sta qui una soluzione davvero appagante - come testo e come sostrato valoriale, quasi un continente che affiora solo parzialmente alla superficie, ma la cui consistenza maggiore è sommersa (anche se perfettamente vitale). Realtà, dunque, di radici, di valori che non si irrigidiscono nella secchezza di comandi, ma divengono plastici principii con la immediata concretizzazione in diritti fondamentali del cittadino. Radici, sì, ma già ad origine giuridiche, basamento del complesso diritto positivo della Repubblica…”. Ed aggiungeva, ancora, che “…Il vecchio giudice, condannato ad essere 'bocca della legge' dai riduzionismi strategici degli illuministi (dapprima) e dei giacobini (successivamente), non può che togliersi volentieri di dosso la veste opprimente dell'esegeta, ormai del tutto inadeguata, e indossare quella dell'interprete, dell'inventore, intendendo la sua operazione intellettuale irriducibile in deduzioni di semplice natura logica (come in una celebre pagina di Beccaria) e concretizzabile piuttosto in una ricerca, in un reperimento, con le conseguenti decifrazione e registrazione…”- P. Grossi, Il mestiere del giudice, Prefazione, in Il mestiere del giudice, a cura di R.G. Conti, Padova, 2020.-
[11] R. Bin, Il giudice tra Costituzione e biodiritto, in Scritti in onore di Antonio Ruggeri, Napoli, 2021, Vol.I, 460.
[12] Sul quale v., volendo, la recensione al volume di chi scrive R. Conti, Dignità della persona e fine della vita, Bari, 2022, in Giustiziainsieme, 4 settembre 2022.
[13] R. Bin, Cose e idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti, in Diritto costituzionale, Rivista quadrimestrale, 2019, 20 ss.
[14] Tema sul quale in passato si è provato a riflettere in R.G.Conti, Il giudice e il biodiritto, in Trattato di diritto e bioetica, a cura di A. Cagnazzo, Napoli, 2017, 62.
[15] A. Ruggeri, Ancora su Cappato e la progettazione legislativa volta a dare seguito alle indicazioni della Consulta, in Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti XXIV. Studi dell’anno 2020, cit., 590, da tempo suggerisce l’utilizzazione di una legge costituzionale, in ragione della materia che si situa nel cuore della Costituzione, attenendo a vicende relative al fine della vita che coinvolgono beni di primario rilievo.
[16] T. Greco, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Roma, 2021.
[17] T. Greco, op.cit., 120.
[18]Cfr., ancora, B. Pastore, Interpreti e fonti, cit., 28 ss.
[19] G. Calabresi, Il mestiere del giudice. Pensieri di un accademico americano, Bologna, 2013, 76.

To install this Web App in your iPhone/iPad press icon.
