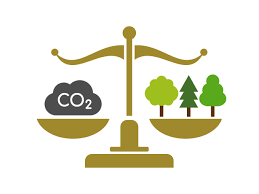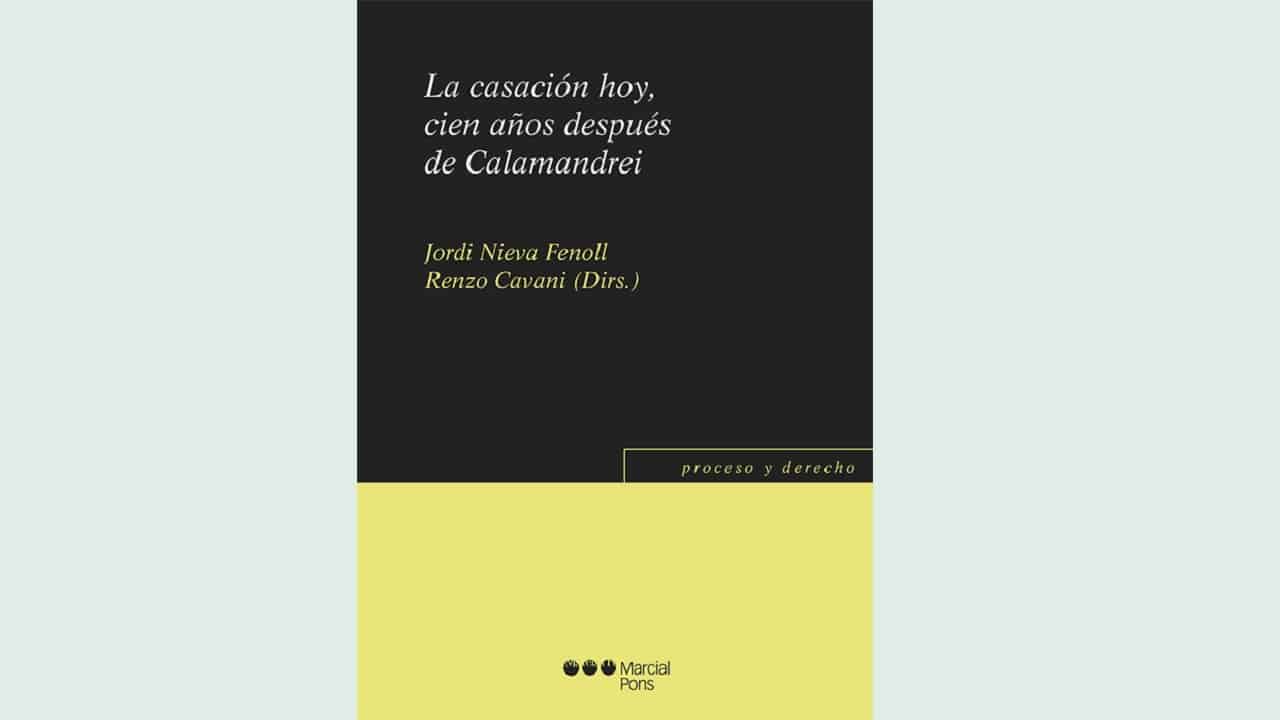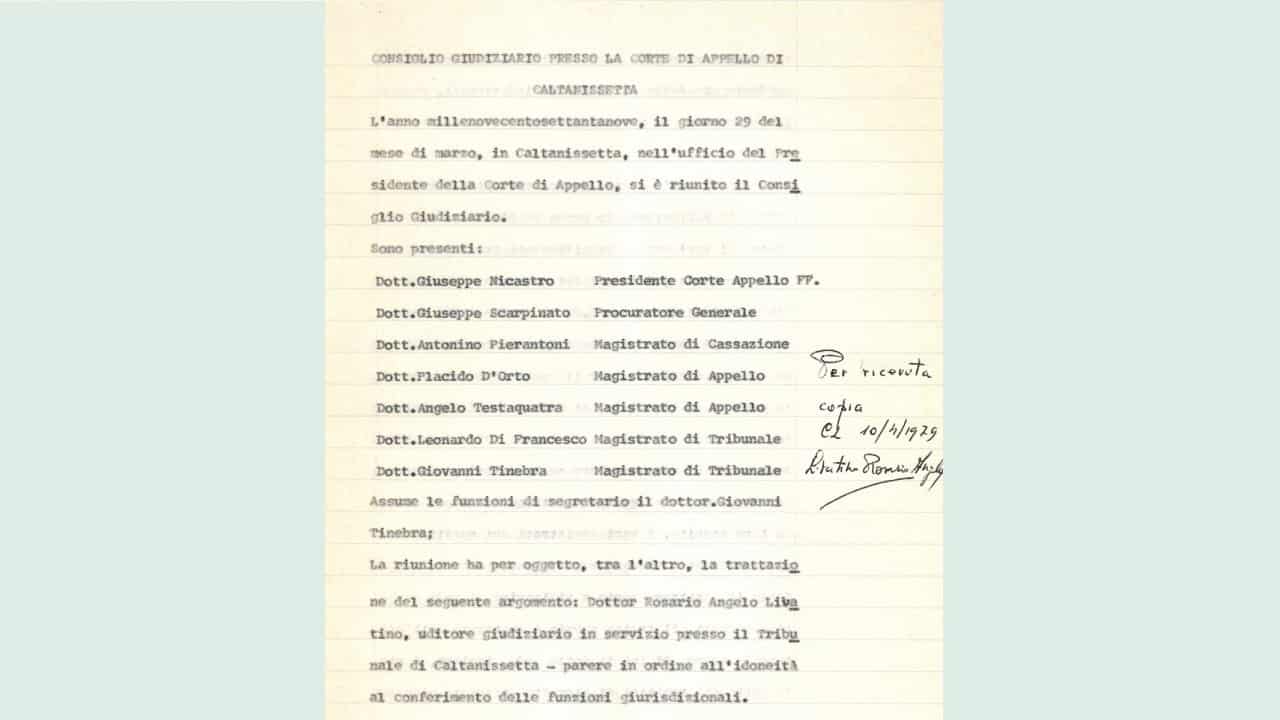Il giudice e l’algoritmo (in difesa dell’umanità del giudicare)
Sommario: 1. Diritto immune e governo della calcolabilità. – 2. Legal tech and co. e giustizia predittiva (il sogno proibito del positivista). – 3. L’eterno enigma del diritto. – 4. Gli usi processuali delle emozioni. – 5. Conclusioni. «Un algoritmo non si può convincere» (in difesa dell’umanità del giudicare).
1. Diritto immune e governo della calcolabilità
La storia del diritto può essere letta come il perenne (e mai compiuto davvero fino in fondo) sforzo di rendere irrilevanti le emozioni, di cautelarsi contro di esse, di renderle inoperanti, innocue, inoffensive; un tentativo di immunizzare lo scorrere dei traffici giuridici e le prassi dalla imprevedibile e irragionevole mutevolezza del sentire emotivo e quindi della volontà che ne è, spesso, espressione. Dominare l’imprevedibile: questa la immane pretesa del diritto[1].
A questo fine – si dice - non può essere in nessun caso emotivo colui che è chiamato ad applicare quelle “direttive di ragione” che sono le norme giuridiche, ossia il giudice. Il suo operato si vuole quanto più possibile meccanico, puramente sillogistico, depurato (immunizzato appunto) e non viziato da disposizioni, stati, intenzioni e da tutto ciò che si potrebbe definire un personale “senso di giustizia”. Il suo ragionamento deve essere dimostrabile, logico, e quindi esatto, controllabile oggettivamente, fondato e giustificato esclusivamente sulla ragione, che procede da premesse a conclusioni. Bruno Celano ha parlato recentemente di “anti-psicologismo” delle teorie del ragionamento giuridico, prodotto diretto dell’insegnamento kelseniano per il quale il diritto è (deve essere) «un che di impersonale, anonimo, de-psicologizzato», che gode (deve godere) «di una relativa indipendenza, o autonomia (sia concettuale, sia normativa), rispetto alle preferenze, alle intenzioni, alla volontà, alle decisioni, alle credenze (…) di coloro che vi sono soggetti; e in ciò risiede il suo carattere di oggettività»[2]
Diritto funzionale al vivere civile e ai traffici economico-sociali, razionale quindi, calcolabile, geometrico, matematico, scientifico, prevedibile, oggettivo, certo, a cui Natalino Irti ha dedicato, negli ultimi anni, importanti studi[3].
La calcolabilità (del diritto, delle decisioni) sembra essere divenuta la nuova parola chiave per capire il presente giuridico; è onnipresente, pervasiva[4]. L’uso così enfatico di questo vocabolo, come mai prima nella storia del diritto era accaduto, porta a prefigurare anche nell’universo giuridico una dittatura del calcolo, per usare la felice espressione che dà il titolo al bel libro del matematico Paolo Zellini[5].
Facendo ciò, il diritto ha quindi espunto consapevolmente dal proprio ambito “la soggettività dei soggetti”, il nostro essere uomini in carne e ossa; ha dettato regole oggettive (immuni da elementi psicologici) come se gli esseri umani non fossero, prima di tutto, esseri emotivi, o forse proprio per questa ragione; proprio per la consapevolezza, cioè, che l’uomo è un essere emotivo e che in quanto tale deve ricevere la guida del proprio agire al di fuori di sé medesimo.
Ma – parafrasando Pascal – si può ben dire che la “realtà vivente” della giustizia ha le sue ragioni, che la ragione non conosce…[6]
Infatti noi sentiamo in qualche modo vago, spesso non detto, sottaciuto, che la giustizia è una esperienza profondamente umana, e che è anzi giusto e bene che sia così. Qualsiasi cosa si intenda con queste espressioni, nella pluralità dei significati che ognuno di noi attribuisce a queste parole così vaghe (quali “umanità”, “umana”, “giustizia”), vediamo comunque essere radicata l’idea per la quale la razionalità meccanica non deve mai essere dis-umana, il dominio delle regole oggettive non deve significare insensibilità per le concrete conseguenze.
Ciò, peraltro, non sembra valere allo stesso modo per ogni ambito dell’esperienza. Possiamo discutere sul significato e l’opportunità di un giudice emotivo e del ruolo (positivo o negativo) che i processi emotivi giocano nel ragionamento giudiziale. Ma già il fatto che si avverte il senso e l’esigenza di questo dibattito è rivelatore di qualcosa di molto significativo. Ciò ci dice qualcosa. Avrebbe infatti senso chiederci se vogliamo un ingegnere emotivo? Credo di no. E, per esempio, un farmacologo emotivo? Nemmeno. Già, forse, più centrato sembrerebbe chiederci se è bene, oppure no, che un medico sia emotivo – salvo poi, molto probabilmente, convenire con una risposta tendenzialmente negativa. Perché questa differenza? Perché vediamo che l’ingegnere o il farmacologo non hanno a che fare, nel loro mestiere, con esseri umani, né governano o maneggiano, nella loro attività, esistenze e dolori, ma si occupano di costruzioni e osservazioni della realtà, e quindi delle leggi del calcolo e della natura, che prescindono dall’uomo. Il medico, invece, interagisce primariamente con esseri umani che si trovano nel momento della loro massima sofferenza e che in quanto tali sono inoggettivabili – anche se, alla fine, ci arrendiamo al fatto che la soluzione alla malattia prescinde, almeno in larga parte, dai vari atteggiamenti umani impiegati. Vorremmo quindi un ingegnere perfetto calcolatore, un farmacologo impassibile, un medico, forse, imperturbabile. Ma nulla di tutto ciò lo ritroviamo nel campo del diritto, che vede coinvolta la persona in quanto soggetto, nel momento del conflitto, che porta con sé il proprio perenne anelito trascendentale verso la giustizia – la trascendenza della giustizia, ossia la perenne possibilità per l’uomo di contestare la giustizia attuale nel nome della giustizia stessa[7]. Vorremmo, quindi, un giudice incapace di provare la minima emozione? Un giudice a-patico, nel senso deteriore del termine, svuotato della umana capacità di leggere, interpretare e tradurre la gamma delle emozioni, e però, magari, dotato di abilità eccezionali, sopra la media, nel ricordare articoli di codice, eccezioni all’operare di regole e le pronunce per intero della Cassazione su un dato argomento?
2. Legal tech and co., e giustizia predittiva (il sogno proibito del positivista)
Antoine Garapon – magistrato francese nonché uno dei più lucidi studiosi della teoria del processo - in un recente saggio dedicato alle sfide della giustizia digitale ha messo in luce come sia stato proprio questo diffuso sentire la giustizia come una impresa umana, “artigianale” quasi, a rendere più difficoltoso l’ingresso delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale nel mondo del diritto rispetto ad altri ambiti della vita sociale (salute, benessere, educazione, ambiente, politica)[8]. Vi sarebbe stata, insomma, una certa resistenza culturale (qualcosa più di un generico sospetto) verso procedure automatizzate che mirino a sostituire l’attività del giurista, ai più diversi livelli, con il funzionamento impersonale di software e algoritmi, proprio in virtù di quella in-oggettivabilità e irriducibilità dell’esperienza umana e dei casi della vita in formule preconfezionate. Oggettivabilità e riducibilità, invece, che - va osservato - non sono altro che il “sogno proibito” del positivista radicale, il tentativo di portare alle estreme conseguenze il mito di una entità che possa davvero definirsi bouche de la loi, cioè un qualcuno o un qualcosa (giudice o software) capace di rendere una decisione-output a seguito dell’inserimento di un fatto della vita-input.
Nonostante il ritardo, concetti come legal tech, smart, digital, cyber justice sono ora espressioni consolidate. Il filo conduttore di questo vasto universo tecno-giuridico è costituito dalla “giustizia predittiva”, ossia l’esigenza che le conseguenze del nostro agire giuridico siano quanto più possibile prevedibili, pre-dicibili, e che il margine di alea sia ridotto al minimo, fino a potenzialmente scomparire – una esigenza, di nuovo, che ha radici antiche e che risale, quantomeno in questa versione, all’ideologia mitica del codice (e del codice civile in particolare) secondo la quale un libro rilegato e ordinato secondo articoli in ordine numerico avrebbe dovuto contenere la regolamentazione intera ed esaustiva, totale, completa dell’esperienza giuridica tra privati[9].
Più nello specifico, lo scopo della giustizia predittiva è quello di rendere le conseguenze delle azioni umani (per quanto qui ci riguarda, in caso di conflitto) trasparenti in anticipo attraverso l’uso dei big data, immense raccolte di informazioni non elaborabili da una mente umana per quantità e qualità del dettaglio, la cui analisi e combinazione permette di scoprire strutture e patterns di regolarità laddove prima si scorgeva solo caos, disordine e casualità. La potenza dell’algoritmo è infatti in grado di digerire e metabolizzare i dettagli e gli elementi fattuali, contestuali, e giuridici di milioni di casi già decisi in precedenza, prevedendo l’outcome della controversia con un altissimo grado di accuratezza. La creazione di modelli predittivi complessi su questa base rende così accessibile e conoscibile qualcosa che prima non lo era con mezzi umani, un nuovo livello di realtà. Dati, dati, e ancora dati. Attraverso le loro combinazioni è possibile una conoscenza sovrumana condotta scientificamente; da cui l’accusa, spesso mossa, e con buone ragioni, di “anti-umanesimo” del mondo legal tech[10].
L’uso di questi strumenti è stato confinato il più delle volte fuori dal processo vero e proprio, in chiave preventiva dello stesso, cioè per prevederne l’esito possibile. Una sorta di do-it-yourself justice[11], una “giustizia fai da te” messa in atto consultando il responso di software decisionali che anticipano i probabili (o probabilissimi) orientamenti giurisprudenziali sulla base delle precedenti statuizioni. Gli esempi sono ben noti. Si riporta che alcuni ricercatori dell’University College di Londra e dell’University of Sheffield nel 2016 hanno creato un algoritmo in grado di prevedere in anticipo l’esito di alcune controversie riguardanti i diritti umani in decisione alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in particolare, sulla base degli artt. 3, 6, e 8 della relativa Convenzione) a partire dalla struttura morfologica, e quindi dall’analisi semantica, delle precedenti sentenze in casi simili; ebbene, l’algoritmo ha previsto le conclusioni dei giudici nel 79 per cento dei casi[12]. E inoltre apprendiamo di un software, Case Cruncher Alfa (il nome dice molto: in italiano suonerebbe qualcosa come “il masticatore di casi”), elaborato da alcuni studenti di giurisprudenza dell’Università di Cambridge, il quale è risultato vincitore, gareggiando contro un pool di avvocati specializzati provenienti dai migliori studi legali inglesi, nel predire le soluzioni di 750 casi riguardanti controversie in materia di assicurazioni decise dal Financial Ombudsman: mentre la percentuale “indovinata” dal software è del 88, 6 per cento, quella della squadra composta da uomini si assesta al 62,3 per cento[13]. In Francia, poi, è operativa la piattaforma Predictice, già testata presso due corti di appello e ora ampiamente utilizzata da colossi assicurativi per testare la probabilità di successo caso per caso nell’eventualità di contenzioso e di valutare conseguentemente la strategia processuale più adatta. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.
Nulla esclude, però, che l’uso di questi strumenti possa avvenire anche dentro al giudizio, e cioè o in funzione decisionale vera e propria o quantomeno per orientare, con varia forza, la decisione umana. In un mondo fatto così, il giudice, ove presente, sarà sempre più spinto a conformarsi passivamente alla decisione che gli viene proposta dall’algoritmo e solo se vorrà discostarsene sarà sottoposto a più intensi doveri di motivazione. Ma quanto vorrà? Già Francesco Carnelutti, sul finire degli anni ’40, si preoccupava di questo, rilevando come l’uso (acritico) da parte dei giudici delle massime giurisprudenziali li dispensasse dalla «fatica del pensare»[14].
È senza dubbio vero che, ora, paventare lo scenario del giudice-robot è nella migliore delle ipotesi prematuro, se non proprio un esercizio di fantascienza giuridica. Ciò non toglie che, filosoficamente, valga la pena vagliare l’ideologia sottostante la giustizia algoritmica, e cioè quella di ridurre, assottigliare la discrezionalità del giudice in tutte le sue ramificazioni, fino all’ideale regolatore della sua eliminazione completa – e non mi pare certo un caso che questa esigenza sia così potente e insistente proprio in questa epoca, la nostra, che ha visto il ruolo del giudice assumere un’importanza cruciale nella governance delle nostre società ai più vari livelli.
3. L’eterno enigma del diritto
La realtà è che fare giustizia è molto più difficile che applicare la legge.
Il diritto vive in bilico tra la certezza (che presuppone l’immutabilità) e il bisogno di adattamento (che comporta, per definizione, evoluzione e quindi incertezza). È questo uno dei molteplici paradossi del diritto, uno degli enigmi che ne caratterizzano il funzionamento. Questo eterno problema può anche essere declinato come dilemma tra l’esigenza di certezza e quella di giustizia[15]. Infatti, le regole che compongono il diritto richiedono adattamento al caso concreto, o richiedono una loro evoluzione e cambiamento quando la loro interpretazione o applicazione appare (è) ingiusta. Tutto si regge, si appoggia quindi sul giudizio.
Il diritto esige quindi questa contraddizione.
Nel mondo degli algoritmi, invece, un diritto troppo calcolabile è un diritto cristallizzato e cementificato. Un diritto assolutamente calcolabile è un diritto nel quale il giudice è incoraggiato a conformarsi, omologandosi, al flusso di decisioni passate, producendo automaticamente risultati sempre identici a sé stessi (effetto “performativo”). Nei casi in cui il giudice si conformi – e l’argomentazione non deve sorprendere – egli sarebbe premiato con la possibilità di motivare succintamente, o non motivare affatto, bastando il richiamo a quanto “deciso” dall’algoritmo.
Gli effetti del conformismo giudiziale non vanno affatto sottovalutati; quest’ultimo - come rileva molto opportunamente e molto criticamente ancora Antoine Garapon – «renforce la culture, l’idéologie dans le sens de Ricoeur, au détriment de l’utopie»[16]. Portare a compimento totale il miraggio positivista del giudice-robot significa null’altro che rinforzare le soluzioni dominanti, lo stato dell’arte, il “come stanno le cose” (l’“ideologia”) a scapito, ricoeurianamente, del pensiero utopico.
Non era così che dovevano andare le cose, verrebbe da dire… Il giudice, storicamente, ha sempre svolto - negli interstizi interpretativi più o meno ampi lasciati dal legislatore, nelle fessure che le parole lasciano aperte e nella misura del consentito – una attività interpretativa volta a garantire una decisione giusta, ma giusta nel senso di giusta nel caso concreto, cioè in questa ipotesi qui, irrepetibile nella sua singolarità, hic et nunc, davanti a queste, e non altre, persone. Come già rilevava sempre Carnelutti, la giustizia – se è veramente tale – è sempre giustizia del caso singolo[17].
Prendere sul serio il giudizio significa quindi destreggiarsi tra la complessa dialettica tra regole e principi, tenere conto delle esigenze e degli interessi in evoluzione e financo – di fronte a casi nuovi – il dovere di inventare (nel senso latino di invenire, cioè “trovare dopo aver cercato”, a partire dal materiale dato) una soluzione, e giustificarla[18]. Tutte esigenze che si pongono in contrasto con gli obiettivi della giustizia algoritmica. I giuristi sanno bene che gran parte dell’evoluzione del diritto avviene nel (e tramite il) giudizio, cioè attraverso l’attività interpretativa, o interpretativo-creativa, del giudice; e ciò sconfessa, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la presunta “immunità” del diritto da quel senso di giustizia che guida l’interprete, il quale, avendo di fronte a sé questo specifico caso di specie, è chiamato a decidere. E – si badi bene – questa non è solo una innegabile affermazione descrittiva di uno stato di cose, ma una affermazione normativa, nel senso che è giusto e bene che sia così.
Mi sia consentito riportare a questo proposito un bel passo di Luciana Breggia (magistrato oltre che studiosa di diritto) in un recente articolo dedicato alla prevedibilità delle decisioni e all’umanità nel diritto:
Il giudizio umano è l’unico che può valutare quel singolo fatto per dargli valore anche al di là della fattispecie espressa e, attraverso i criteri ermeneutici, può dare rilevanza ad interessi materiali non espressamente o non completamente formalizzati nella fattispecie, ma degni di tutela alla luce del complessivo sistema delle fonti e dei principi costituzionali, eurounitari e internazionali[19]. (enfasi nostra).
Torniamo al punto di partenza, e cioè che fare giustizia è cosa ben più complessa che applicare il diritto. Fare giustizia, tra le molte altre cose, significa – come recita il passo - valutare singoli fatti per attribuire loro valore anche al di là della fattispecie espressa, e dare rilevanza a interessi materiali non espressamente o completamente esplicitati nella singola disposizione normativa. Sono affermazioni importanti, che devono essere meditate[20]. Certo, tutto ciò non significa potersi muovere al di fuori dei confini del diritto. Il giudice, dando spazio ai valori di giustizia, deve operare pur sempre dentro la legalità; anzi, possiamo dire che solo così facendo la attua appieno e nella maniera più genuina possibile. Una legalità che va oltre il legalismo formalista. Dal costituzionalismo dei principi, dalla sua portata sovversiva - come ben rileva Paolo Grossi - non si torna indietro. Da qui il capovolgimento: il “vero diritto” è incerto, e non può che esserlo[21].
Senza avallare un tanto inammissibile quanto pericolo soggettivismo del giudice, ognuno vede con chiarezza la porosità dei concetti riportati nel passo citato, quali “complessivo sistema delle fonti”, “principi costituzionali” ecc. e come questi abbiano il grande pregio di saper recepire, entro i confini della legalità costituzionale, quell’in-determinabile senso di giustizia che alla fine di ogni discorso non può che ricadere sul singolo giudicante.
Senza dimenticare infine che questo benefico margine di discrezionalità non è limitato al diritto ma si esprime anche nel momento della ricostruzione delle questioni di fatto. Queste – come giustamente sottolinea ancora Luciana Breggia – devono essere ricostruite «anche in base alle narrazioni processuali dei soggetti coinvolti, cariche di percezioni, emozioni, punti di vista»[22]. Infatti, solo «l’ascolto empatico» che è «proprio dell’umano» è in grado di dare corpo e consistenza alle istante di giustizia che devono essere riempite di senso, laddove invece una macchina «riduce la discrezionalità a un calcolo probabilistico».[23]
Ecco quindi riemergere la funzione inventiva del giudizio.
Va da sé che il tema cruciale è quello dell’educazione del giudice e della formazione della sua sensibilità. Non giudici purchessia, quindi, ma giudici attenti, consapevoli, sensibili, empatici; qualità irrinunciabili per svolgere una funzione tanto terribile come quella del giudicare (cfr. già, a questo proposito, le severe parole di Salvatore Satta: «Che una persona, un uomo, possa giudicare di un altro uomo è cosa che a noi sembra naturale (…): ma se ci si pensa un momento si vede subito che questo è uno dei misteri, forse il più grande, che stanno alla base della vita sociale. (…) Ciò significa che la forza su cui il giudice si regge, la fonte della sua autorità, non è umana, ma divina, è il charisma…»[24]). La bontà e la tenuta di un sistema si regge su queste qualità che si ottengono – certo nel lungo periodo – con una preparazione universitaria eccellente, una conoscenza teorica unita da uno spiccato senso pratico e una visione quanto più possibile consapevole delle infinite complessità della realtà e di ciò che è relazione, e cioè con un pensiero critico affinato, che rifugge il semplicismo, i giudizi taglienti, l’ottusità.
Anzi, la filosofa del diritto americana Martha Nussbaum – che più di tutti ha studiato a fondo l’importanza delle emozioni nella giustizia e nella vita politica[25] – consiglia come parte integrante dell’educazione e dell’attività dei giudici la lettura delle grandi opere letterarie e dei classici senza tempo, che parlano di uomini e vicende, dolori e complessità dell’anima. Solo in questo modo sarebbe possibile fare autentica giustizia. Nonostante questo consiglio possa sembrare, a prima vista, ingenuo o suscitare un sorriso, esso rivela in realtà una grande verità. E cioè che il desiderio, che si traduce in sforzo (per certi versi lodevole), di ottenere buone sentenze a prescindere dalle qualità umane di chi giudica è una impresa votata allo scacco, al fallimento. Siamo consapevoli, infatti, che il diritto, per quanto lo si intenda in senso ampio, non è tutto, ma che, più ancora in generale, ciò che conta è la qualità del sistema civile di riferimento, del quale il diritto è solo una parte, e forse nemmeno la più importante.
4. Gli usi processuali delle emozioni
Giudicare significa quindi non essere impermeabili, ma in ascolto. Colui che giudica, anzi, deve lasciarsi muovere dalla viva esperienza nella quale è processualmente immerso. Il processo è un contesto pervaso da emozioni fortissime; il tribunale è il luogo delle emozioni forse come pochi altri della vita sociale e tutti gli attori processuali sono anche attori emotivi. Ma il punto che vorrei enfatizzare è che non solo l’emotività del giudice è un dato innegabile, ma anche che è un qualcosa che può e deve essere incanalato positivamente.
Certo, se la domanda fosse se è bene che il giudice decida secondo i propri sentimenti e le proprie emozioni, e cioè sulla base di giudizi più o meno coscienti di antipatia e simpatia, o di rabbia, ira, collera, irritazione, tristezza, affetto, turbamento, e così via, essa non avrebbe nemmeno senso di esser posta. A ciò osta l’elaborazione plurisecolare del concetto di stato di diritto e del principio di legalità. I codici processuali, poi, si premurano di garantire che un giudice, in quelle ipotesi in cui sia coinvolto emotivamente, sia privato del potere di decidere. A salvaguardia del principio di imparzialità, la disciplina dell’astensione e della ricusazione, nel processo civile (artt. 51 e 52 c.p.c.), prevede che il giudice debba astenersi (e correlativamente possa essere ricusato) in caso di «grave inimicizia», sua o del coniuge, con una delle parti o con i difensori, o in altre ipotesi tipizzate in cui il suo “portato emotivo” potrebbe condurlo a favorire l’una o l’altra parte (come nel caso di vincoli di parentela, o di particolare frequenza di contatti con le parti).
Il codice, quindi, vuole serenità di giudizio; quella serenità che deriva dal disinteresse. Ma ciò non significa affatto che il giudice non sia chiamato, nel corso del giudizio, a fare uso di quella qualità eminentemente umana che è la comprensione delle proprie e altrui emozioni, e a servirsene. Si è già fatto cenno al delicato giudizio di diritto, che chiama il giudice a prendere in considerazione e valorizzare interessi ed esigenze anche non formalizzate nelle singole disposizioni ma desumibili dai principi generali, e come questa valorizzazione coinvolga necessariamente il senso di giustizia di un buon giudice.
Questo uso intelligente della soggettività lo si ritrova anche a proposito della valutazione degli elementi fattuali. È qui che un approccio puramente calcolatore mostra, forse, il suo volto più debole.
Solo a guisa di esempio: ai sensi dell’art. 116 del c.p.c. il giudice deve valutare la prova secondo il proprio «prudente apprezzamento», espressione che codifica il principio del “libero convincimento” (il «contenitore di emozioni» del giudicante[26]), mentre l’art. 533 c.p.p. afferma il canone dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» nel riconoscimento della colpevolezza dell’imputato. Certo, saremo gli ultimi a disconoscere la essenziale necessità di criteri razionali e obiettivi nel percorso di valutazione probatoria che rendano la decisione del giudice quanto più controllabile intersoggettivamente[27]; ma di certo è difficile spingersi fino al punto di voler negare la presenza e l’importanza di un nucleo infrangibile, un segmento ultimo e insopprimibile di soggettività insito nel convincimento personale e nella valutazione della ragionevolezza o meno del dubbio circa la colpevolezza. Potremmo davvero immaginare un giudice che si trovi a condannare un imputato, in ipotesi a una pena detentiva altissima, perché “dalle carte” oggettivamente, matematicamente, emerge che non vi sono dubbi ragionevoli circa la colpevolezza, pur non credendo egli, dentro di sé, a quella ricostruzione?
5. Conclusione. «Un algoritmo non si può convincere» (in difesa dell’umanità del giudicare)
Che ne è quindi della immacolata, pura logicità controllabile, verificabile del giudizio, inteso come dover essere regolativo?
Sul carattere puramente logico del giudizio rileggiamo Carnelutti il quale - in un dimenticato e visionario saggio[28] – scrisse che credere che il giudizio dimostri qualcosa significa commettere «l’errore di confondere la sentenza con la sua motivazione» sicché bisogna invece tenere a mente che «la motivazione giustifica, non scopre la disposizione»[29]. La distinzione alla quale Carnelutti fa riferimento è quella, ben nota, tra “contesto di scoperta” e “contesto di giustificazione”, ossia tra ragioni che spiegano e ragioni che giustificano (i “buoni argomenti” veri e propri) e in definitiva tra nozione psicologica e nozione logica del ragionamento. Prima il giudizio si forma, nasce internamente in noi e poi ne vengono esplicitate le ragioni. Naturalmente – ma non c’è, forse, nemmeno necessità di ribadirlo - tutto ciò non toglie che «vi è bisogno non solo di scoprire ma di giustificare la scoperta» e che quindi «nessuno di noi giuristi è disposto ad ammettere una sentenza non motivata». Piuttosto ciò porta ad avere consapevolezza che – nel giudizio – «la logica sillogistica… era parziale» e che non è possibile scorgere nel sillogismo «l’atto logico originale»[30].
Dove risiede quindi questo atto logico originale che dà vita e corpo al giudizio?
«Il diritto (c’è ancora bisogno di dirlo?) – afferma e si chiede ancora Carnelutti - è un fatto essenzialmente spirituale». Esso, in quanto tale, non è riducibile all’insieme delle sue parti: «la norma giuridica in sé, o un complesso di norme, un codice per esempio, è un pezzo del diritto, non tutto il diritto, cioè il diritto vivo nella pienezza della sua vita» la quale «si accende (…) quando le norme sono applicate o anche siano violate». Il diritto è viva esperienza umana: «un contratto, un delitto, un processo sono degli uomini uno di fronte all’altro», e perciò «bisogna capire quegli uomini per capire il diritto». Ecco l’umanità del giudizio. Il diritto inteso nella sua umanità non solo «è materia ribelle ai numeri» ma anche – aggiunge qui Carnelutti, toccando vette inarrivabili del pensiero giuridico – «alle parole»[31]. Ma in che senso l’esperienza giuridica sarebbe ribelle alle parole? Egli intende – se ben interpreto il suo pensiero - la parola logica, escludente, categorica, che de-termina e de-finisce (cioè che stabilisce il termine e la fine, che fissa i significati), che pretende di tagliare, e quindi recintare le intere sfumature in-dicibili e inarticolabili delle esperienze umane dentro argini concettuali. Egli, invece, non si riferisce certo alla parola parlata, recitata, narrata, raccontata, viva e vissuta; quella che si manifesta nel dialogo processuale, la “oralità” intesa non solo in chiave semplificatoria (come spesso, riduttivamente, si intende oggi) ma soprattutto come veicolo per l’approdo a una soluzione giusta.
Ecco quindi la accentuata enfasi di Carnelutti sulla dimensione dialogica della giustizia. Il parlare processuale è, sotto questo aspetto, espressamente poetico, nel senso che non vede le parole nell’univocità del loro significato. «La parola – egli prosegue con un linguaggio evocativo che ci indica la giusta strada da seguire – ha da essere parlata affinché se ne esprima la musicalità. E con l’oralità affiora la eloquenza. (…) Ma l’eloquenza combina la musica con la poesia. E il segreto della musica è la pausa; mediante i suona essa riesce a far gustare il silenzio. Non basta scrivere, bisogna parlare col giudice; e non basta spesso il discorso, se non è un’orazione perché a lui s’ha da fare intendere ciò che non si può dire»[32].
Dire l’indicibile, quindi: questo il fondamento e la funzione allo stesso tempo paradossale e necessaria del giudizio.
[1] N. Irti, La crisi della fattispecie, in Riv. Dir. Proc., 2014, 44 e seg.
[2] B. Celano, Ragionamento giuridico, particolarismo. In difesa di un approccio psicologistico, in Riv. Fil. Dir., 2017, 315 e seg.
[3] N. Irti, Nomos e lex (Stato di diritto come Stato della legge), in Riv. Dir. Civ., 2016, 590; Id., Un diritto incalcolabile, ivi, 2015, I, 1; Id., Capitalismo e calcolabilità giuridica (letture e riflessioni), in Riv. Soc., 2015, 801; Id., Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie, in Riv. Dir. Civ., 2014, 687. V. poi la raccolta di questi studi in Id., Un diritto incalcolabile, Torino, 2016.
[4] Oltre agli studi sulla (in)calcolabilità del diritto citati alla nota precedente, adde A. Carleo (a cura di), Calcolabilità giuridica, Bologna, 2017, volume nel quale la studiosa ha raccolto alcune delle riflessioni svolte durante i “Seminari Leibniz per la teoria e la logica del diritto” svoltisi presso l’Accademia Nazionale dei Lincei (Roma, ottobre 2019).
[5] P. Zellini, La dittatura del calcolo, Milano, 2018.
[6] Il riferimento è, ovviamente, al celebre Pensiero «Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce» (B. Pascal, Pensieri (1670), in B. Pascal, Pensieri, opuscoli lettere, a cura di A. Bausola, R. Tapella, Milano, 1997, 585).
[7] Questa trascendenza della giustizia è resa con viva materialità dalle parole del Calamandrei, Fede nel diritto (a cura di S. Calamandrei, con saggi di G. Alpa, P. Rescigno, G. Zagrebelsky), Roma – Bari, 2008, 64: «Giustizia? (…) Due litiganti vanno dinanzi al giudice e tutt’e due, per soverchiare l’avversario, invocano la giustizia; la parola è la stessa, ma per ciascuno di essi vuol dire l’opposto, vuol dire la propria vittoria e la rovina del suo contraddittore. Due popoli si scannano per la conquista di un regno: tutt’e due hanno scritto la parola diritto sulla propria bandiera; ma il diritto qual è, quello del vincitore o quello del vinto, quello di chi vuol mantenere le proprie leggi, o quello di chi vuole instaurare un ordine nuovo in luogo delle leggi abbattute?».
[8] A. Garapon, Les enjeux de la justice prèdictive, in La semaine juridique (éd. gén.), 9 gennaio 2017, n. 1-2.
[9] Sull’ideologia “mitica” del codice (nel senso di credenza mitologica), si vedano le notazioni di P. Grossi, Ritorno al diritto, Roma – Bari, 2015 (cap. significativamente intitolato “Sulla odierna ‘incertezza’ del diritto”), 51 e seg., spec. 58.; nonché nella raccolta Id., Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2007.
[10] A. Garapon, op. cit., 49
[11] A. Garapon, op. cit., 51.
[12] Lo riporta E. Gabellini, La «comodità del giudicare»: la decisione robotica, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2019, 1309.
[13] E. Gabellini, op. cit., 1310.
[14] F. Carnelutti, Giurisprudenza consolidata (ovvero della comodità del giudicare), in Riv. Dir. Proc., 1949, 41 e seg.
[15] Lucidamente, F. Carnelutti, La certezza del diritto, in Riv. Dir. Proc., 1943, 81 e seg. (a margine, criticamente, del volume di F. López de Oñate, La certezza del diritto, Roma, 1942).
[16] Garapon, op. cit., 52 (che cita, in nota 11, P. Ricoeur, L’idéologie et l’utopie).
[17] Così, incisivamente, F. Carnelutti, Diritto e processo, Napoli, 1958, 138.
[18] Sul carattere radicalmente inventivo del diritto (carattere tanto spesso quanto infruttuosamente messo in ombra nella storia), nel quadro della fine delle “grandi narrazioni della modernità” e dell’avvento del costituzionalismo, P. Grossi, L’invenzione del diritto, Roma – Bari, 2017. Più di recente, cfr. anche Id., Prefazione, in R. G. Conti (a cura di), Il mestiere del giudice, Milano, 2020 e Id.,
[19] L. Breggia, Prevedibilità, predittività e umanità nella soluzione dei conflitti, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2019, 395 e seg.
[20] Ricca di significato, a questo proposito, l’intervista ai Professori Gaetano Silvestri, Vincenzo Militello, e Davide Galliani, sulla dinamica tra regole e principi sopranazionali, a cura di R. G. Conti, Il giudice disobbediente nel terzo millennio, in https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/669-il-giudice-disobbediente-nel-terzo-millennio , e quella ai Professori Antonio Ruggieri e Roberto Bin, a cura di R. G. Conti, Giudice o giudici nell’Italia postmoderna? Le risposte, in https://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme/620-2.
[21] P. Grossi, Ritorno al diritto, cit., 66: «la cosiddetta incertezza del diritto, che non si può non cogliere quale fattore negativo se si assume un angolo di osservazione prettamente legalistico, merita un capovolgimento valutativo, se la si vede come il prezzo naturale da pagare per il recupero di una dimensione giuridica che sia veramente diritto».
[22] L. Breggia, op. cit.
[23] L. Breggia, op. cit.
[24] S. Satta, La tutela del diritto nel processo (1950), ora in Il mistero del processo, Milano, 1994, 65. Sulla complessità umana del giudizio, v. anche le recenti e profonde riflessioni di un altro grande processualcivilista, V. Colesanti, Sulla legittimazione a giudicare (meditazioni su un alto pensiero «chi sono io per giudicare?»), in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 2019, 1081 e seg.
[25] M. Nussbaum, Poetic Justice: The Literary Imagination and the Public Life, Beacon Press, 1995; Id., Upheavals of Thoughts: The Intelligence of Emotions, Cambridge University Press, 2001; Id., Political Emotions. Why Love Matters for Justice, Harvard University Press, 2013.
[26] L. Lanza, Emozione e libero convincimento nella decisione del giudice penale, in Criminalia. Annuario di scienze penalistiche, 2011 (online)
[27] J. Ferrer Beltran, Prova e verità nel diritto, Bologna, 2004; Id., La valutazione razionale della prova, Milano, 2007.
[28] F. Carnelutti, Matematica e diritto, in Riv. Dir. Proc., 1951, 201 e seg.
[29] F. Carnelutti, ult. op. cit., 202, 203.
[30] F. Carnelutti, ibid.
[31] F. Carnelutti, ult. op. cit., 211 – 212.
[32] F. Carnelutti, ult. op. cit., 212.