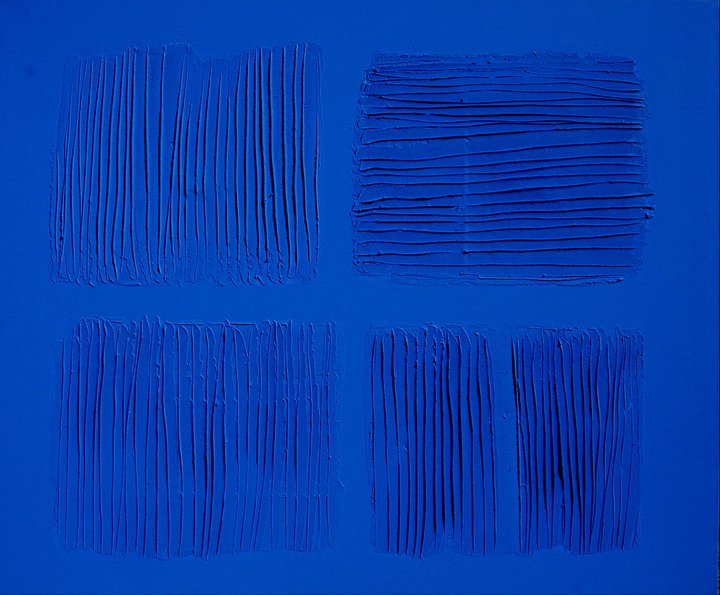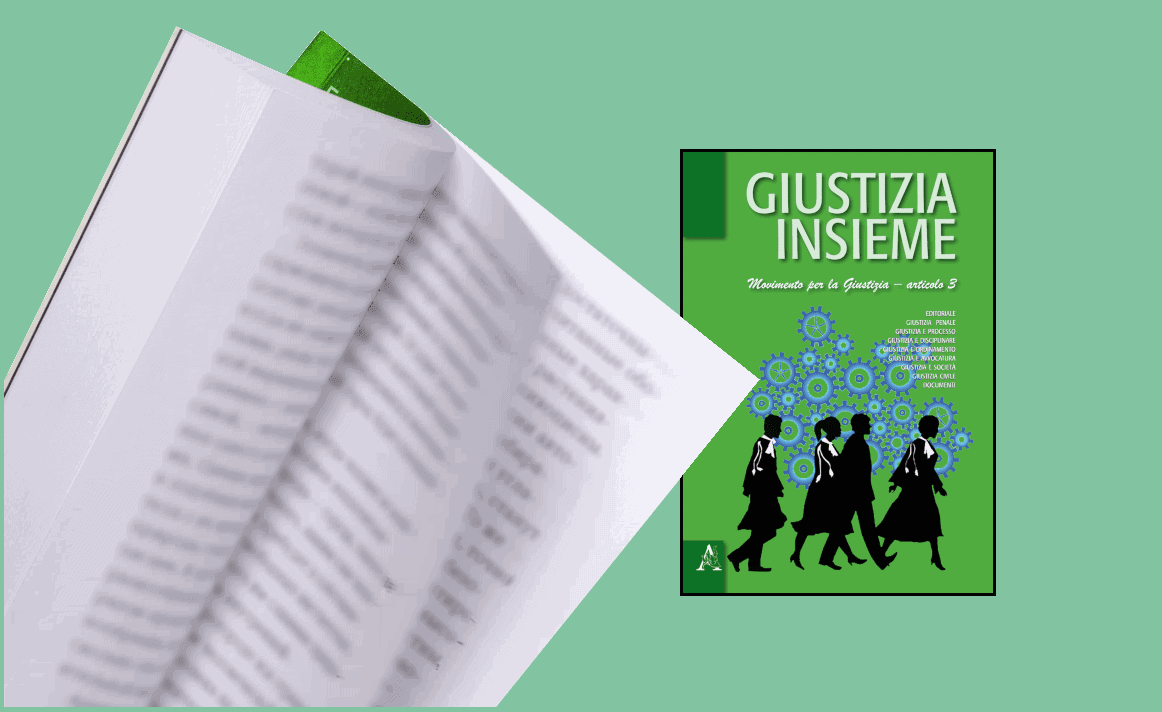1. Non gode di buona stampa la riforma Cartabia del processo penale.
Tra i magistrati c’è chi ne aveva proposto l’immediata abrogazione già prima dell’entrata in vigore. Ma la sua demolizione è diventata ormai un luogo comune, una moda.
Dall’accademia vengono persino interpretazioni complottistiche delle effettive finalità della riforma.
A proposito della disciplina dei collegamenti a distanza si è sostenuto che la previsione del previo consenso delle parti quale condizione ordinaria di ammissibilità, sia solo una strategica e temporanea astuzia del legislatore, intenzionato in realtà a porre le premesse di una graduale evoluzione verso una giustizia stabilmente amministrata a mezzo di interfacce elettroniche, fino alla riduzione del contraddittorio a un confronto tra avatar.
Quanto alla previsione della videoregistrazione come modalità privilegiata di documentazione, si è sostenuto che gli obiettivi «malcelati o forse fin troppo palesi» del legislatore siano quelli di annientare la centralità del dibattimento come sede per la formazione della prova, quando si tratti di documentare atti delle indagini preliminari, o di attentare al principio di immediatezza, quando si tratti di acquisire prove formate in altro dibattimento o prima del mutamento della composizione del collegio giudicante. Sicché il rafforzamento delle garanzie sarebbe soltanto apparente; e si ipotizza addirittura un dolo del legislatore.
Anche prescindendo da questi eccessi, comunque, è generalizzata l’accusa di tradimento dei principi in nome del «pragmatismo efficientista» imposto dal PNRR: come se non fosse possibile, e dunque necessario, distinguere tra l’etica della giurisdizione e l’economia dell’organizzazione giudiziaria.
2. Questa ostilità spesso preconcetta verso la riforma si può spiegare solo movendo dalla distinzione tra politica e propaganda, che sono senza dubbio attivate entrambe da problemi reali: con la determinante differenza, però, che la politica propone soluzioni, la propaganda usa i problemi senza nemmeno affrontarli.
Un esempio può rendere icasticamente chiara questa distinzione.
L’immigrazione è ovviamente un problema grave e complesso. Ma allontanare le ONG dal canale di Sicilia significa usare il problema senza nemmeno affrontarlo.
Come ha scritto Massimo Donini, la riforma Cartabia propone appunto soluzioni, non si limita a usare i problemi, a differenza di quanto troppo spesso è accaduto in passato. E qualunque critica si possa muovere al disegno riformatore, l’interprete dovrebbe farsi carico della tenuta del sistema.
Il giurista non è un legislatore mancato; e non può rimanere intrappolato nel cantiere sempre aperto della propaganda. Anche quando non sia stato chiamato a far parte delle commissioni istituite per le riforme, ha il compito istituzionale di ricondurre a sistema persino norme discutibili.
Chi deve scrivere una sentenza o un ricorso, chi deve difendersi in un processo penale, attende da dottrina e giurisprudenza risposte sul significato delle norme, non rimpianti per ciò che non è stato, e sarebbe potuto essere, né immagini dal metaverso.
Occorrerebbe dunque ricostruire il sistema della riforma Cartabia per chiarire quali problemi ha inteso risolvere e in quale prospettiva, in modo da disporre di un’attendibile chiave di lettura delle diverse disposizioni.
3. Non v’è dubbio che seri problemi della nostra giustizia penale nascano in particolare da una crescente autoreferenzialità dei magistrati del pubblico ministero.
E’ l’obbligatorietà dell’azione penale che viene frequentemente esibita a giustificazione del plateale fallimento di alcune iniziative processuali, benché l’art. 112 cost. non imponga certo di prescindere da una valutazione del fondamento delle notizie di reato. Tuttavia questo approccio, inteso a giustificare iniziative inutili (se non dannose) in quanto “dovute”, trovava una sua legittimazione nell’art. 125 disp. att., che qualificava come non infondata la notizia di reato quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari fossero idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Abolito ora l’art. 125 disp. att., il nuovo testo dell’art. 408 comma 1 prevede che «quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione». Sicché la nuova formulazione non è più unilaterale, non è più attenta alla sola prospettiva del pubblico ministero; assume dichiaratamente la prospettiva del giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione secondo una regola di giudizio inevitabilmente orientata alla fase processuale, che presuppone invece l’esercizio dell’azione penale.
Il pubblico ministero è tenuto a chiedere l’archiviazione quando la condanna non sia il prevedibile esito del giudizio, esattamente come è tenuto a esercitare l’azione penale quando una condanna sia prevedibile. Sarebbe un azzardo l’esercizio dell’azione penale senza ragionevole prevedibilità della condanna; e un’identica regola di giudizio è dettata anche per il giudice dell’udienza preliminare, appunto perché questa udienza è destinata a fungere da «filtro delle imputazioni azzardate».
Vero è che secondo C. cost. n. 88/1991, richiamata poi anche da C. cost. n. 478/1993, «il principio di obbligatorietà dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità effettuato dal giudice: ed in esso è insito, perciò, quello che in dottrina viene definito favor actionis»; con la conseguenza che nei casi dubbi l'azione andrebbe esercitata e non omessa. Ma la finalità di evitare un processo superfluo, riconosciuta in entrambe le sentenze, presuppone che sia il legislatore ordinario a definire le condizioni dell’archiviazione, salva l’esclusione «dell’opposto principio di opportunità che consente alla pubblica accusa di agire o meno anche in base a valutazioni estranee alla fondatezza della 'notitia criminis'». E il legislatore impone oggi come criterio di giudizio la prevedibilità della condanna. Sicché occorre fare riferimento all’articolo 533 c.p.p., che della condanna definisce i presupposti, esigendo che venga pronunciata solo se «l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio». Il dubbio dunque, come non può giustificare la condanna, così non può giustificare né l’esercizio dell’azione penale né il decreto che dispone il giudizio, perché legittimamente il legislatore ordinario ha ora riposto in soffitta il favor actionis. Se ne facciano una ragione coloro che ancora lo considerano implicito nel principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale.
L'art. 112 Cost. non esige affatto che il pubblico ministero si determini in base a una regola di decisione diversa da quella prevista per il giudice. Al contrario, estende all'azione penale lo schema argomentativo che la tradizione liberale prescrive per la giurisdizione, escludendo così che le determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale possano essere giustificate in ragione della funzionalità al perseguimento di risultati di controllo sociale. Infatti la giurisdizione è un sistema di giustizia legale, le cui decisioni devono essere giustificate sempre e soltanto in ragione della loro conformità a un sistema di norme e di valori, che si assume precostituito all'intervento del giudice.
Contrariamente a quanto si sostiene, dunque, l’art. 112 Cost. esclude che l’etica del pubblico ministero possa essere diversa dall’etica del giudice. Il principio di legalità vale per il pubblico ministero come vale per il giudice.
Nella giurisdizione l’argomentazione utilitaristica può giustificare solo la definizione della norma cui la decisione si proponga di essere conforme (utilitarismo della norma), non la singola decisione (utilitarismo dell’atto); e l’art. 112 Cost. estende questa logica anche alle determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale.
Nel momento in cui assume le proprie determinazioni sull’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero deve “mettersi nei panni del giudice” che pronuncerebbe la sentenza: come qualsiasi attore, che promuova il giudizio, deve assumere la prospettiva del giudice per poter preconizzare l’accoglimento della sua domanda.
L’orizzonte del pubblico ministero non è più quello di una dignitosa partecipazione al giudizio, ma quello di una piena assunzione di responsabilità per il suo esito. E questo è certamente un formidabile contributo a superare la cultura autoreferenziale dell’accusa, benché la soluzione sembri contraddire la logica della separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, che pure la stessa riforma Cartabia dell'ordinamento giudiziario ha in qualche misura avallato, riducendo fino ai limiti della compatibilità costituzionale il possibile passaggio dall’una all’altra funzione.
Si è sostenuto, sulla base anche di un risalente parere del CSM, che questa nuova regola di giudizio sia incompatibile con i principi del processo accusatorio e con la centralità del dibattimento. Ma il principio del contraddittorio esige una centralità non statistica bensì metodologica del dibattimento. L’accusatorietà del sistema non dipende dal numero dei dibattimenti. Né l’immotivato decreto che dispone il giudizio potrebbe pesare in senso sfavorevole all’imputato sul convincimento di un giudice del dibattimento che partecipa direttamente alla formazione della prova. Mentre è ragionevole che non debba essere l’accusa a confidare su sviluppi dibattimentali eventualmente favorevoli.
Del resto anche nel processo nordamericano l'organo dell'accusa deve dimostrare nell'udienza preliminare che sussiste «una prova sufficiente a far sì che una persona "media" concluda che l'imputato sia colpevole del reato addebitatogli». E nel processo inglese il giudice, per disporre il rinvio a giudizio, deve accertare che vi sono «prove tali che, se non fossero inficiate o contraddette in dibattimento, una giuria potrebbe ragionevolmente condannare su di esse». Ma nessuno ne ha mai posto in discussione la compatibilità con i principi del processo accusatorio.
Certo, se si celebrassero moltissimi giudizi con metodo inquisitorio indipendentemente dalle scelte dell’imputato, si potrebbe a ragione parlare di tradimento dei principi del processo accusatorio. Ma se le indagini preliminari valgono a escludere che un qualsiasi giudizio sia aperto, significa solo che il pubblico ministero ha fatto bene il suo mestiere.
Com’è noto, l'art. 358 prevede che nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero deve compiere tutti gli atti necessari ai fini delle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale (art. 326) e deve svolgere «altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini».
Questa norma, che attua una specifica direttiva della legge delega, aveva suscitato qualche riserva da parte di coloro che vi avevano visto il residuo di una concezione inquisitoria e paternalistica del ruolo del pubblico ministero. Altri la interpreta invece come un segno dell'esigenza di obbiettività e di imparzialità del pubblico ministero, ricollegabile all'art. 97 comma 1 della Costituzione.
Ma è sufficiente considerare come il dovere del pubblico ministero di acquisire tutti gli elementi necessari all'accertamento dei fatti, e quindi anche dell'eventuale innocenza della persona sottoposta alle indagini, derivi già autonomamente dalla prima parte dello stesso art. 358, laddove richiama l'art. 326. Se infatti lo scopo delle indagini preliminari è di consentire le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale (art. 326), ne consegue che il pubblico ministero dovrà, comunque, accertare tutti i fatti necessari a verificare se la notizia di reato è «infondata», essendo noto che la conferma di un'ipotesi di accusa dipende principalmente dal fallimento dei tentativi di dimostrarne l'inattendibilità.
Sicché è del tutto ragionevole che la notizia di reato sia qualificata infondata quando non sia prevedibile una condanna.
4. In questa prospettiva sistematica si può comprendere perché la riforma ha introdotto controlli giurisdizionali sia sull’effettiva decorrenza dei termini delle indagini preliminari sia sulla tempestività della loro conclusione. Infatti, se il rispetto del termine di deposito degli atti delle indagini è garantito dal procuratore generale, vale a dire da un organo della stessa accusa, il rispetto del termine per le determinazioni del pubblico ministero è garantito dal giudice su eventuale iniziativa della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa. Sicché, fin dalla fase procedimentale, i parametri di riferimento del pubblico ministero dovranno essere quelli del giudice chiamato a valutarne l’azione, perché è stata finalmente eliminata quella sorta di extrafunzionalità ritagliata per il pubblico ministero dalla giurisprudenza sulla sindacabilità solo disciplinare delle scelte circa i tempi delle indagini preliminari.
Gli interventi del giudice nel corso delle indagini preliminari rimangono solo incidentali, ma il controllo sul rispetto dei tempi del procedimento è costante ed è aperto alle istanze degli interessati. È un controllo ab estrinseco, che non attiene ovviamente al merito delle strategie investigative del pubblico ministero, ma è destinato a garantirne la legalità attraverso un possibile sindacato sui tempi imposti dal legislatore.
5. Peraltro a una analoga finalità di responsabile esercizio delle funzioni di accusa può essere ricondotta anche la nuova disciplina dei criteri di priorità.
L’art. 3 bis disp. att. prevede che, «nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio».
Si tende così a rendere in qualche misura prevedibile e trasparente l’inevitabile discrezionalità di molte scelte del pubblico ministero, perché, nel predisporre il progetto organizzativo dell'ufficio in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore della Repubblica è tenuto a determinare «i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili» (art. 1 comma 6, d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106). È ragionevole dubitare tuttavia che le indicazioni di carattere generali provenienti dal legislatore e dal C.S.M., come le stesse direttive del progetto organizzativo dell’ufficio, possano esprimere più che generici criteri di ragionevolezza, la cui applicazione concreta sarà comunque condizionata dai connotati della singola specifica notizia di reato. Sarebbe comunque auspicabile tuttavia che questa selezione non lasciasse nondimeno pendenti in un limbo indefinito le notizie di reato non prioritarie, in attesa della prescrizione dei reati ipotizzabili, ma comportasse più seriamente l’archiviazione delle notizie che non si prevede possano essere trattate in tempi ragionevoli, in modo da rendere possibile il sindacato del giudice sulle scelte pur sempre discrezionali del pubblico ministero e in eventuale via incidentale anche il sindacato della Corte costituzionale sulla legge che definisce i criteri generali di priorità.
È infatti ragionevole sostenere che, scaduti i termini prescritti per le indagini, il pubblico ministero debba tempestivamente chiedere l’archiviazione, perché da un canto «gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca» (art. 408 comma 1), dall’altro canto i criteri di priorità precludono ulteriori indagini. E questa conclusione non contrasterebbe affatto con l’art. 112 Cost. (obbligatorietà dell’azione penale), perché a determinare l’archiviazione non sarebbe una valutazione di opportunità di quello specifico provvedimento, bensì l’applicazione della norma che preclude l’espletamento di indagini in difformità dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio. La decisione risponde dunque a un utilitarismo della norma non del singolo atto. E il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione sarà legittimato a due verifiche: che allo stato degli atti non sia davvero prevedibile una condanna; che i criteri di priorità precludano effettivamente l’espletamento di ulteriori indagini.
Questa ricostruzione del funzionamento dei criteri di priorità può così raccordarsi alla improcedibilità dell’azione penale per eccessiva durata dei giudizi di impugnazione, benché in questa sopravviva l’impropria sovrapposizione tra i temi della prescrizione del reato e della ragionevole durata del processo.
Sono certo incompatibili con la logica della durata ragionevole del processo infatti sia la previsione che la violazione dei termini massimi di durata non rileva, e dunque «la declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo» anche oltre il prescritto termine (art. 344 bis comma 7); sia la previsione che l’improcedibilità per durata irragionevole del processo non opera per i delitti puniti con l'ergastolo, indipendentemente dalla complessità dell’accertamento (art. 344 bis comma 9). Tuttavia l’equilibrio politico così faticosamente raggiunto ha una sua pur residuale coerenza, perché nella disciplina della proroga del termine di durata dei giudizi di impugnazione si recupera in qualche misura la logica della durata ragionevole del processo, ancorata alla complessità del caso piuttosto che alla gravità del reato.
6. E’ dunque possibile una lettura coordinata dei nuovi art. 3 bis disp. att., 408 comma 1 e 344 bis c.p.p. che concili il pragmatismo efficientista della riforma con un’etica della giurisdizione fondata sui principi costituzionali.
Il filo conduttore della riforma, nella prospettiva qui esaminata, è dunque nella responsabilizzazione del pubblico ministero, in piena coerenza con l’impostazione originaria del codice del 1988, che impose l'alternatività tra esercizio dell'azione penale e richiesta di archiviazione, troncando un'antica disputa dottrinale. L’azione penale è la domanda rivolta dal pubblico ministero al giudice di decidere conformemente all'ipotesi di colpevolezza sintetizzata nell'imputazione, non è la richiesta di aprire comunque il processo indipendentemente da qualsiasi assunzione di responsabilità per il suo prevedibile esito.
Questa possibile ricostruzione del nuovo status assegnato al pubblico ministero dalla riforma Cartabia lascia comunque da chiarire se permanga l’esigenza della cosiddetta separazione delle carriere anche oltre il limite dell’unico passaggio da una funzione all’altra oggi ammesso nella vita professionale dei magistrati.
Per tornare all’esempio di esordio, occorre in conclusione domandarsi se oggi la prospettiva di allontanare il pubblico ministero dal giudice finisca per essere equiparabile all’allontanamento delle ONG dal canale di Sicilia.
Tuttavia non autorizzano alla fiducia talune preannunciate iniziative legislative, intese a eliminare l’appello contro le sentenza del giudice monocratico, mantenendolo solo contro le sentenze collegiali, nello stesso momento in cui si propone di sostituire un giudice collegiale al giudice monocratico per le decisioni cautelari che già prevedono il riesame da parte di un giudice collegiale.
La propaganda continua!