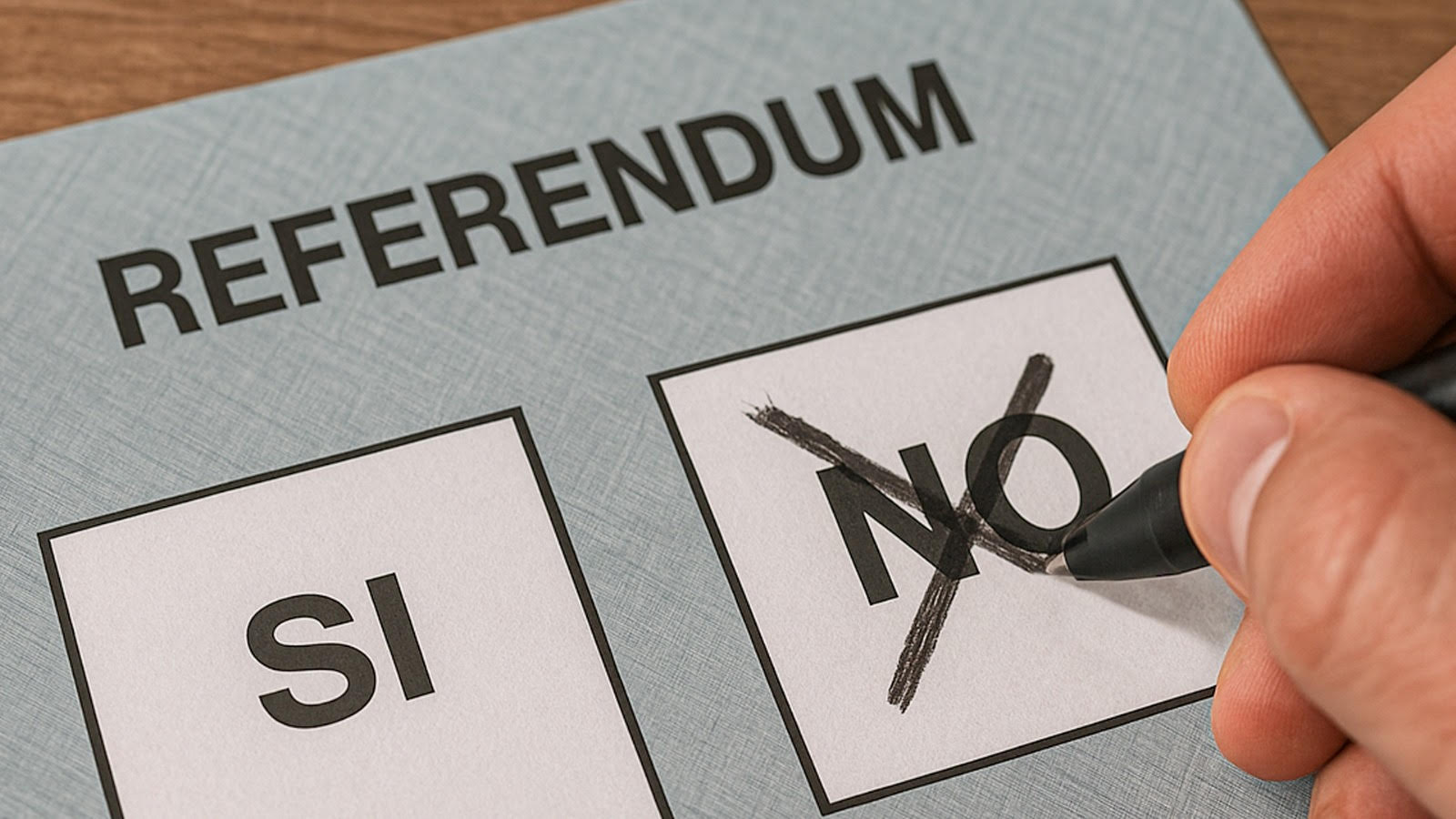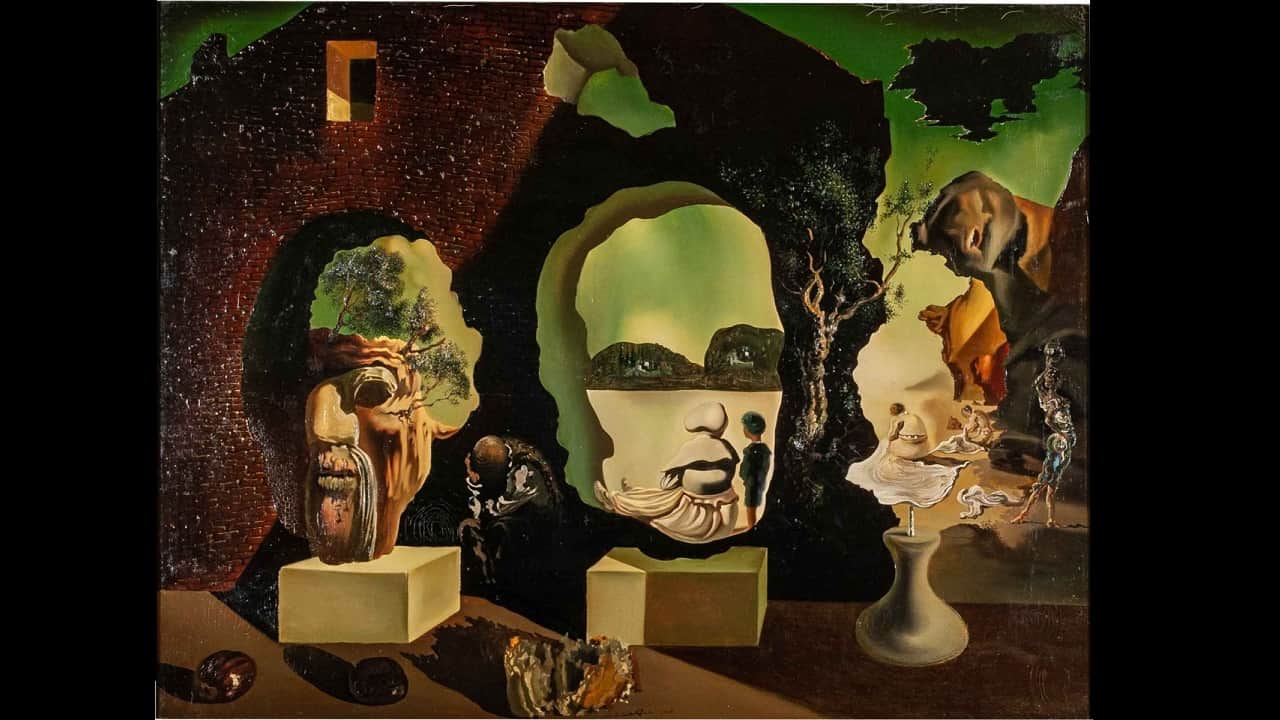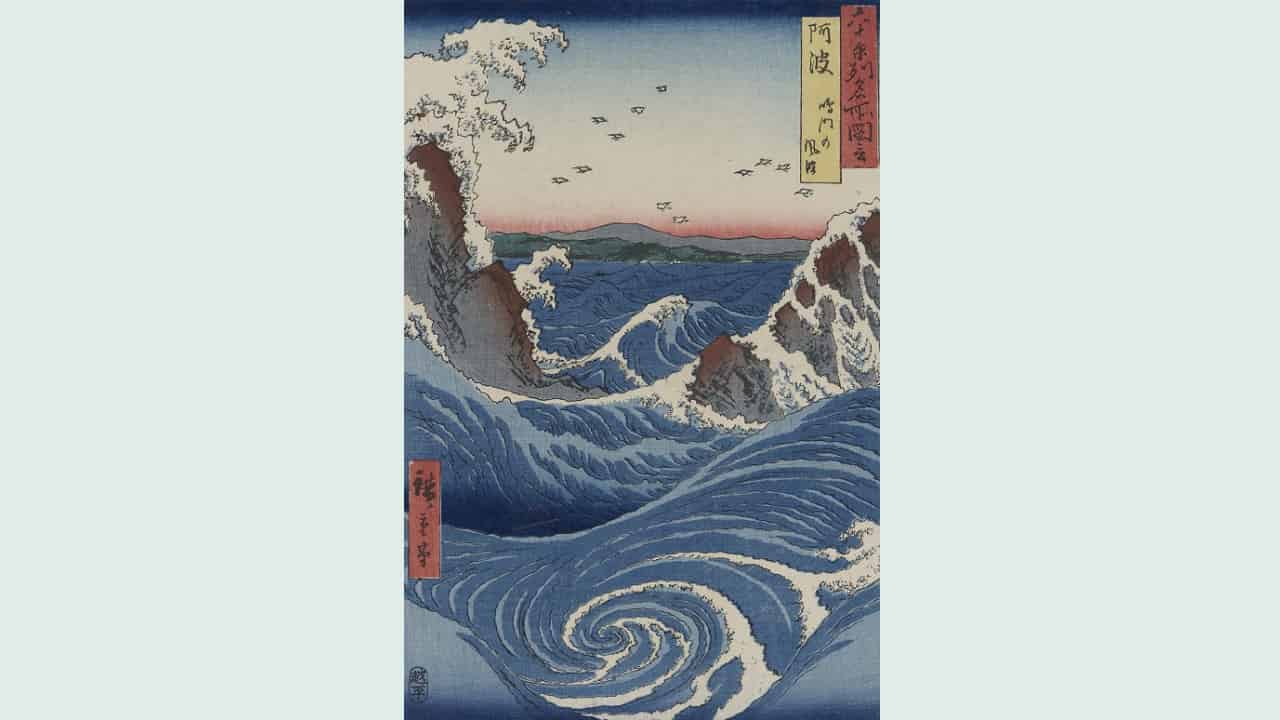Oltre la separazione delle carriere (28 ottobre 2025, Università Magna Graecia di Catanzaro)
“La riforma costituzionale della magistratura. Uno sguardo oltre la separazione delle carriere” è il titolo dell’incontro - che si terrà il 28 ottobre 2025 presso l’Edificio di Giurisprudenza - promosso dalla Rivista Giustizia Insieme e dalla associazione studentesca ELSA Catanzaro, con la collaborazione del Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia e della Cattedra di diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza. L’incontro è aperto al pubblico.
Sommario: 1. Giuriste e giuristi di fronte alla Costituzione; 2. “Oltre la separazione delle carriere”; 3. La divisione dell’assetto istituzionale della magistratura; 4. La differenziazione rispetto alle altre magistrature e altre “novità” costituzionali; 5. Un percorso giuridico per tre questioni. Programma dell’incontro.
1. Giuriste e giuristi di fronte alla Costituzione
L’incontro scientifico ha l’obiettivo di portare il discorso giuridico sulla riforma costituzionale della magistratura - la c.d. “riforma della separazione delle carriere” come è riduttivamente appellata - nell’università con la partecipazione attiva di studentesse, studenti, dottorande e dottorandi. La Costituzione è un patrimonio di tutte e tutti, giuridico e non solo, ma è soprattutto la visione e il progetto del futuro.
“La Costituzione va letta, va studiata e va praticata, prendendo le mosse dai principi fondamentali che costituiscono la sua ragione d’essere”.
Parte da questa esortazione del Presidente della Repubblica G. Napolitano l’idea di affrontare la riforma, da giuriste e giuristi e di fronte alle giuriste e ai giuristi di domani, per quel che primariamente è: una legge di strutturale modifica, immediata e diretta, dell’attuale quadro costituzionale.
Perché il ruolo del giurista è quello di studiare e interpretare in modo critico la legge, qualsiasi legge, per proteggere il senso stesso del diritto.
2. “Oltre la separazione delle carriere”
L’incontro non sarà incentrato sull’annoso e divisivo tema della “separazione delle carriere” e non tenterà quindi di rispondere direttamente alla domanda valoriale: “È giusto e opportuno che giudici e pubblici ministeri siano separati, siano due realtà distinte? È necessario avere carriere separate per realizzare il giusto processo penale ex art. 111 Cost.? ”.
Si tenterà invece di impostare il discorso, nel percorso argomentativo proposto, partendo dalla risposta affermativa che a questa domanda ha dato la maggioranza parlamentare formulando la riforma e dichiarando espressamente, nella relazione illustrativa, la necessità di essa per il giusto processo ex art. 111 Cost.
La “separazione delle carriere” - intesa come scelta valoriale di dividere alcuni soggetti della giurisdizione - sarà quindi assunta come un presupposto dato, giusto o ingiusto che sia, e non discusso nell’incontro.
Si discuterà invece, in modo critico, della struttura giuridico-costituzionale della riforma, la sua congruità rispetto al contesto costituzionale e alle finalità dichiarate.
“Oltre la separazione delle carriere” significa due cose sul piano argomentativo: “depenalizzare” il discorso sulla riforma per riportarlo sul piano costituzionale, ossia quello che gli è proprio; evidenziare che la riforma non riguarda solo una “separazione di carriere” ma l’assetto costituzionale dell’intera magistratura ordinaria e la rivisitazione di importanti principi costituzionali.
3. La divisione in più parti dell’assetto istituzionale della magistratura
L’incontro muove da un primo dato legislativo: il C.S.M., che è il vertice istituzionale della magistratura previsto dal Costituente del 1948, viene diviso in 3 distinti organi e perde il suo elemento rappresentativo.
È la divisione in più parti del c.d. “autogoverno” fino ad ora unitario, termine che si usa per sintetizzare, come ha ricordato il Prof. Sergio Bartole, l’autonomia e indipendenza della magistratura quale organizzazione.
La divisione del C.S.M. in tre organi
La Costituzione del 1948 prevede difatti un unico organo di governo - il C.S.M. in cui siedono sia giudici che p.m. - cui attribuisce tre principali poteri, funzionali – nell’idea costituente – a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura:
il potere normativo, protetto da una riserva di legge intesa come relativa, che si esprime in atti generali di disciplina del funzionamento della magistratura (nei limiti fissati dalla legge);
il potere amministrativo che si esprime nelle decisioni specifiche in merito alla carriera dei magistrati;
il potere giurisdizionale-disciplinare di primo grado per i magistrati.
La riforma prevede in luogo dell’unico C.S.M. tre distinti organi:
1) un C.S.M. per i giudici (da cui sono esclusi i p.m.);
2) un C.S.M. per i pubblici ministeri (da cui sono esclusi i giudici);
3) l’istituzione di un giudice speciale, l’Alta Corte disciplinare, destinata ad esercitare sia la funzione di giudice disciplinare di primo grado (sino ad ora attribuito all’unico C.S.M.), sia la funzione di giudice di secondo grado per contestare la decisione disciplinare presa dalla stessa Alta Corte (oggi la decisione disciplinare del C.S.M. è invece impugnabile davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel rispetto dell’art. 111 Cost., quale organo supremo della giurisdizione italiana).
La perdita dell’elemento rappresentativo
A questa divisione dell’unico organo di autogoverno in tre distinte istituzioni se ne affianca un’altra, non direttamente operante sul piano della composizione degli organi quanto piuttosto su quello della loro natura, ossia la perdita dell’elemento rappresentativo.
La Costituzione del 1948 (art. 104) prevede che l’unico C.S.M. - oltre che dai membri di diritto - sia composto per 2/3 da magistrati – eletti dagli stessi magistrati – e per 1/3 da professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio – eletti dal Parlamento in seduta comune (i c.d. laici). La realtà vede i magistrati (13 giudici, 5 p.m. e 2 magistrati di legittimità) tendenzialmente eletti tra gli appartenenti ai diversi gruppi associativi – le c.d. “correnti” espressione delle differenti idee su come debba atteggiarsi l’indipendenza e l’autonomia della magistratura - interni all’Associazione Nazionale Magistrati (che riunisce quasi tutti i p.m. e giudici). Gli avvocati e i professori (nel numero di 10) vengono eletti dal Parlamento cercando un equilibrio utile a soddisfare le forze di maggioranza e quelle di minoranza.
La riforma prevede l’abrogazione del sistema elettivo e la sua sostituzione con un sistema di “estrazione a sorte”. Il C.S.M. dei giudici sarà composto per 2/3 da giudici estratti a sorte (tra i 7000 giudici). Il C.S.M. dei p.m. sarà composto per 2/3 da p.m. estratti a sorte (tra i 2000 p.m.). In entrambi i Consigli siederanno dei “laici” - per 1/3 della composizione - estratti a sorte da una lista contenente nomi selezionati dal Parlamento in seduta comune mediante elezione.
4. La differenziazione rispetto alle altre magistrature e altre “novità” costituzionali
Il secondo dato legislativo è quello per cui la riforma prevede delle “novità” di importanza sistemica:
1) La riforma differenzia nettamente - con i 2 C.S.M., l’Alta Corte e l’abrogazione del sistema elettorale - il profilo istituzionale dei giudici ordinari rispetto a quello dei giudici delle altre magistrature (amministrativa, contabile, militare e tributaria) e quindi disegna in modo differenziato l’autonomia e l’indipendenza della magistratura ordinaria rispetto alle altre.
2) Per la prima volta nella storia costituzionale è prevista l’istituzione di un giudice speciale, l’Alta Corte, destinato a giudicare - sia come primo che come secondo grado - una categoria specifica di soggetti (p.m. e giudici ordinari).
3) Per la prima volta è prevista l’abrogazione del sistema elettorale per un organo di rilievo costituzionale avente funzioni di “governo” (poteri normativi e amministrativi seppur limitati alla “sola” magistratura ordinaria) e la sua sostituzione con un sistema di estrazione a sorte.
Appaiono fuorvianti, in questo senso, i confronti con altre forme di sorteggio previste dall’ordinamento (ad esempio corti giudicanti o le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale per i professori - sorteggio da lista di candidati scelti che soddisfano i requisiti di merito-) in quanto obliterano, ad esempio, la specifica attribuzione del potere normativo del C.S.M. (che gli altri enti non hanno) protetto da una riserva di legge relativa.
4) Non da ultimo, in discontinuità con passati tentativi di riforma costituzionale, in parte naufragati, volti alla riduzione degli organi costituzionali o di rilievo costituzionale, la riforma prevede una moltiplicazione degli organi di rilievo costituzionale.
5. Un percorso giuridico per tre questioni
L’incontro proporrà così un percorso giuridico all’interno della riforma, un “gioco” argomentativo e giuridico di risposta a tre delle grandi questioni che essa pone:
Gli istituti della riforma come si rapportano ai principi costituzionali, alle altre norme costituzionali sulla magistratura non oggetto della riforma e al complessivo disegno costituzionale del 1948?
La riforma impone un confronto con i principi della democrazia rappresentativa e pluralista (vista l’abrogazione del sistema elettivo e l’introduzione della estrazione a sorte); con il divieto di istituzione di giudici speciali ex art. 102 Cost. e con i principi del giusto processo ex art. 111 Cost (vista l’istituzione dell’Alta Corte); con l’art. 101, secondo comma e l’ art. 107, ultimo comma, Cost. che differenziano testualmente il giudice dal p.m.
Gli istituti della riforma come incidono giuridicamente sull’autonomia e indipendenza della magistratura, e in particolare del giudice, e sulla natura dell’autogoverno?
La riforma richiede di verificare l’incidenza dei suoi istituti portanti - la divisione dell’unico autogoverno, la perdita del potere giurisdizionale-disciplinare (considerata sia dal costituente che dalla stessa relazione alla riforma un elemento centrale per la garanzia dell’autonomia e indipendenza), la perdita dell’elemento rappresentativo e pluralista, la differenziazione rispetto alle altre magistrature – sull’autonomia e indipendenza della magistratura, in particolare quella giudicante.
Ha contenuto e valore giuridico l’affermazione testuale, contenuta nel nuovo articolo 104 Cost., secondo cui la magistratura rimane un unico ordine (“un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”), come previsto dal vecchio 104 Cost., seppur diviso in magistrati della “carriera giudicante” e magistrati della “carriera requirente”?
La struttura giuridico-istituzionale di quest’ordine affermato come unico, a seguito della riforma, appare infatti - ad una immediata lettura - limitata a tre istituti: la presidenza dei due C.S.M. affidata al Presidente della Repubblica (nuovo art. 104 Cost.); l’Alta Corte disciplinare (nuovo art. 105 Cost.); la possibilità, per i soli p.m., di passare alle funzioni giudicanti di legittimità (nuovo art. 106 Cost.).
Nel solco di questo percorso l’incontro, diviso in 2 sessioni e con le conclusioni del Prof. Falzea, affronterà diversi temi:
1) l’Alta Corte disciplinare per i soli p.m. e giudici ordinari e il suo rapporto con il divieto di istituzione di giudici speciali previsto dall’art. 102 Cost. e con le norme sul giusto processo ex art. 111 Cost. e 6 CEDU in considerazione del ristretto numero dei suoi componenti (15), della doppia funzione primo e secondo grado, del problema della titolarità dell’accusa ad un altro potere esterno alla magistratura giudicante (p.m. o Ministero?), della struttura soggettiva della sua composizione (i componenti giudici saranno poco più di 1/3, in carriera devono aver svolto funzioni di legittimità – il che recupera la possibilità che ivi confluiscano degli ex p.m. ex art. 106 Cost. -, ed aumenterà il peso proporzionale dei laici);
2) il rapporto tra i principi costituzionali della democrazia pluralista e rappresentativa con l’abrogazione del sistema elettivo e la sua sostituzione con un sistema di estrazione a sorte; la “tollerabilità” costituzionale – anche alla luce dell’art. 2 Cost. – di una riforma che vuole superare espressamente il momento elettivo, come dichiarato nella relazione illustrativa, privando sia le forze parlamentari, sia l’associazionismo giudiziario – i corpi intermedi – di un trasparente sbocco “istituzionale” nell’organo di autogoverno;
3) l’istituzionalizzazione, al massimo livello costituzionale, della pubblica accusa. La problematica di un potere che mantiene l’obbligatorietà dell’azione penale, il controllo della polizia giudiziaria e che guadagna altresì la possibilità di stabilire anche le regole del proprio funzionamento generale e concreto. Da un lato la possibilità istituzionale che 2mila pubblici ministeri possano così trasformarsi ne “Il potere dello Stato più forte che si sia mai avuto in alcun ordinamento costituzionale dell’epoca contemporanea” - come ha scritto il Prof. Alessandro Pizzorusso – dall’altro la possibilità di dover rileggere, in modo restrittivo, l’art. 101, secondo comma, Cost. (“I giudici sono soggetti soltanto alla legge”) e l’art. 107 ultimo comma Cost. (“Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario”);
4) il rapporto tra i nuovi organi oggetto della moltiplicazione costituzionale – in particolare tra i due C.S.M. - e la lettura della riforma sia alla luce della via “costituzionale” scelta dalle forze della maggioranza, sia del complesso movimento del quadro costituzionale che vede all’orizzonte, dopo la riforma della magistratura, la riforma del c.d. “premierato” e la riforma dell’autonomia regionale differenziata.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA MAGISTRATURA
UNO SGUARDO OLTRE LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
Università Magna Graecia di Catanzaro
Edificio di Giurisprudenza
28 ottobre 2025 ore 15.15-18.15
Programma
Saluti introduttivi 15.15-15.30
Prof.ssa Aquila Villella, Direttrice del Dipartimento DiGES
Avv. Vincenza Matacera, Presidente COA Catanzaro
Dott.ssa Concettina Epifanio, Presidente CDA Catanzaro
Sessione I 15.30-16.45
Dott.ssa Claudia Migliazza, Dottoranda in Filosofia del diritto e rappresentante dei dottorandi presso il CNSU
Dott. Stefano Mangiacasale, Dottorando in Diritto Costituzionale
Avv. Vincenzo Ranieri, Consigliere Ordine Avvocati Catanzaro
Dott. Riccardo Ionta (discussant), Giudice del lavoro, membro della redazione della Rivista Giustizia Insieme
Sessione II 16.45-17.45
Prof. Andrea Lollo, Ordinario di diritto costituzionale
Dott. Camillo Falvo, Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia
Saverio Morello (discussant), Studente e Presidente Elsa di Catanzaro
Conclusioni
Prof. Paolo Falzea, Ordinario di diritto costituzionale