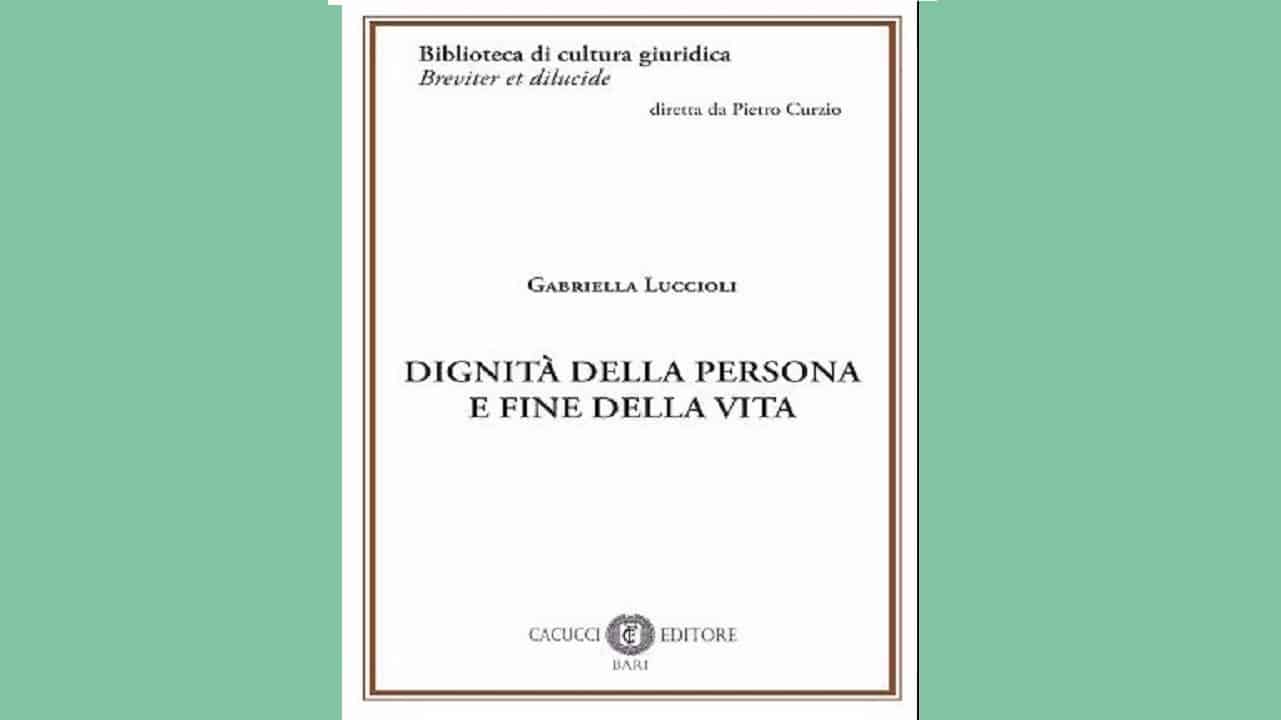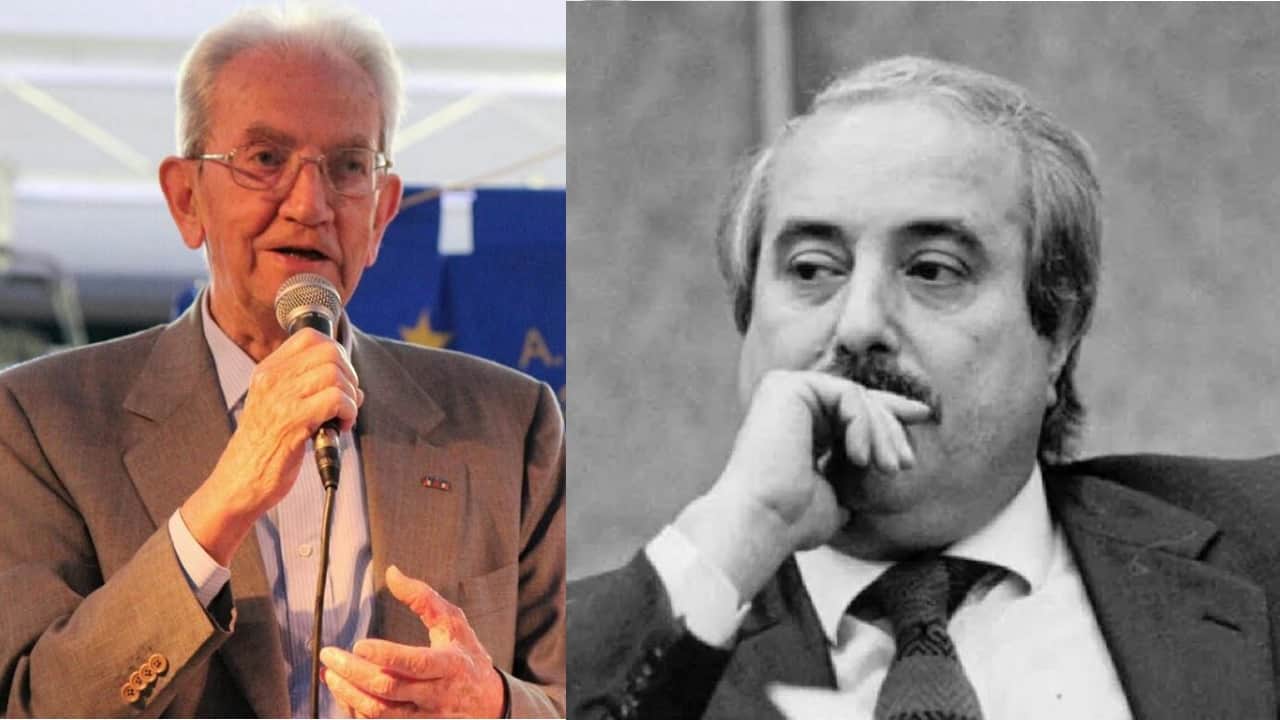Ergastolo ostativo: buttare la chiave o riflettere?
Intervista di Roberto Giovanni Conti a Giovanni Fiandaca
Sommario:1.La scelta del tema. 2. Le risposte. 3. Le conclusioni. 4. L’intervista in pdf.
1) Numerosi giuristi e personalità del mondo giudiziario hanno commentato la sentenza della Corte edu Viola c. Italia, ormai definitiva, sul c.d. ergastolo ostativo nei confronti di condannato per reati di criminalità mafiosa, esprimendo valutazioni divergenti. Professore Fiandaca, qual è la sua opinione in proposito?
2) A suo avviso la decisione della Corte edu, riconoscendo la violazione dell’art.3 CEDU nel caso sopra ricordato, è coerente con i principi costituzionali in tema di rieducazione della pena sanciti dall’art.27 Cost.?
3) Il passaggio
dal divieto ex lege di concessione all’ergastolano non collaborante di benefici
premiali alla possibilità che sia la magistratura di sorveglianza a verificare
la ricorrenza dei presupposti per il loro eventuale riconoscimento attenuerebbe
il livello di contrasto alla lotta contro la criminalità dello Stato ovvero
produrrebbe un sistema coerente con il quadro costituzionale e convenzionale
fondato sul bilanciato fra interesse collettivo e diritti del condannato?
4) La Corte costituzionale sarà chiamata ad esaminare diverse questioni di legittimità costituzionale sui c.d. automatismi impeditivi di benefici premiali in favore di condannati - fra le quali quella sollevata da Cass., Sez. 1, n. 57913 del 20/11/2018, Cannizzaro–. Quali saranno, a suo avviso, le ripercussioni di ordine giuridico o psicologico della pronunzia della Corte edu sulle decisioni che la Corte costituzionale sarà chiamata ad affrontare?
1.La scelta del tema
Roberto Giovanni Conti
Giustizia insieme, già prima dei clamori suscitati dalla recente definitività della sentenza Viola c.Italia della Corte edu, correlata al rigetto dell’istanza di rinvio alla Grande Camera della Corte di Strasburgo di pochi giorni fa, aveva acceso i riflettori sulla pronunzia di condanna dell’Italia in relazione alla figura del c.d. ergastolo ostativo della Corte europea con gli articoli di Davide Galliani - La forza della democrazia è non avere paura”. L’ergastolo ostativo e Viola v. Italia n. 2 della Corte di Strasburgo-, Paolo Canevelli -Ergastolo ostativo e permessi premio: superamento di una preclusione assoluta?-, Enrico Amati - Legge ‘spazzacorrotti’ e disciplina intertemporale. L’interpretazione formalistica (ma ‘garantista’) della Suprema Corte in attesa dell’auspicabile svolta sostanzialistica della Corte Costituzionale - e di Giorgio Spangher - Il ruolo della pena -.
A pochissimi giorni dalle attese decisioni della Corte costituzionale su questioni affini abbiamo posto alcune domande sull’argomento al Professore Giovanni Fiandaca. La statura accademica e culturale sono tali da rendere superflua la presentazione del nostro ospite. È invece utile, per i lettori della Rivista, ricordarne la partecipazione attiva, in qualità di componente laico, al Consiglio Superiore della magistratura e più recentemente al Comitato scientifico presso la Nona commissione del CSM prima che entrasse in funzione la Scuola della Magistratura. Dati, questi ultimi, assai sintomatici della voglia di Fiandaca di dialogare con la magistratura, senza che ciò gli abbia peraltro impedito di assumere posizioni divisive su alcuni grandi processi ancora in corso.
Un desiderio profondo di dialogo che Fiandaca mostra apertamente di nutrire nelle risposte che seguono, alle quali si è dedicato in un lasso di tempo strettissimo che ha invece impedito a Roberto Scarpinato, per ragioni professionali non rinviabili, di offrire la sua voce, assicurataci comunque all’esito delle pronunzie della Corte costituzionale.
2. Le risposte.
Giovanni Fiandaca
Numerosi giuristi e personalità del mondo giudiziario hanno commentato la sentenza della Corte edu Viola c. Italia, ormai definitiva, sul c.d. ergastolo ostativo nei confronti di condannato per reati di criminalità mafiosa, esprimendo valutazioni divergenti. Professore Fiandaca, qual è la sua opinione in proposito?
La sentenza della Corte di Strasburgo sull’ergastolo ostativo ha provocato, com’è noto, reazioni di segno opposto. Era prevedibile che, a differenza del versante dei giuristi di matrice accademica propensi a salutarla con prevalente favore, dal fronte pressoché compatto dei magistrati antimafia si levasse invece un allarmato coro di critiche e di preoccupazioni. Ciò era prevedibile perché questi due versanti sono portatori di culture giuridiche che bilanciano in maniera diversa i valori in giuoco. L’antimafia giudiziaria tende, infatti, a privilegiare la dimensione dell’efficacia dell’azione di contrasto alle mafie, manifestando minore sensibilità per le ragioni di principio e valoriali poste alla base della sentenza europea. Mentre nel mondo degli studiosi hanno un peso tendenzialmente preponderante i limiti e i vincoli che il costituzionalismo nazionale ed europeo frappongono alla politica criminale, e ciò anche riguardo al settore della criminalità organizzata, a garanzia dei fondamentali diritti individuali degli stessi delinquenti. Nella mia ottica, sarebbe in realtà auspicabile, non ultimo per evitare il disorientamento dei cittadini, che rispetto al modo di concepire i principi di fondo della giustizia penale vi fosse una buona volta una maggiore convergenza di vedute tra i diversi attori giuridici coinvolti. L’affermazione del diritto è infatti una impresa collettiva, nel cui ambito nessun protagonista può pretendere di vantare titoli di legittimazione tali da imporre unilateralmente la prevalenza delle proprie concezioni rispetto a quelle degli altri protagonisti.
Sempre dal mio punto di vista, non è senza significato che le obiezioni dei magistrati antimafia si siano i ogni caso basate poco su argomentazioni di natura strettamente giuridico-costituzionale. Oltre che preoccupazioni di politica criminale, sono state infatti messe in campo considerazioni di tipo socio-criminologico e/o antropologico relative alla ritenuta specificità del fenomeno mafioso e ai connessi (presunti) tratti identitari degli associati di mafia. Così, ad esempio, esponenti celebri dell’antimafia giudiziaria come Caselli e Scarpinato, intervenendo sulla stampa, si sono preoccupati di ribadire quelle che sarebbero verità empiriche consolidate. Cioè che i mafiosi giurano fedeltà perpetua all’associazione criminale di appartenenza, per cui non vi sarebbe modalità diversa dalla collaborazione giudiziaria per verificarne l’avvenuta dissociazione; inoltre, consentire ai boss non collaboranti di uscire dal carcere equivarrebbe, in termini di certezza, a permettere loro di tornare a rivestire gli originari ruoli criminali. E, ancora, eliminare o attenuare l’ergastolo ostativo significherebbe abolire la forma di detenzione che gli uomini di mafia temono maggiormente, e che perciò costituirebbe ancor oggi un insostituibile strumento di contrasto. Si tratta davvero di verità empiriche comprovabili mediante leggi dotate di qualche attendibilità scientifica? In realtà, non esiste una mafiologia assimilabile alle scienze in senso stretto. Le conoscenze finora accumulate sul fenomeno mafioso sono frutto della generalizzazione di massime di esperienza, che ben possono ammettere eccezioni e modificazioni dovute per un verso all’evoluzione della criminalità mafiosa e, per altro verso, ai mutamenti socio-culturali che si ripercuotono anche sulla cultura o subcultura criminale. Da questo punto di vista, non sarebbe molto plausibile ipotizzare che un giovane mafioso dei nostri giorni abbia ad esempio connotati antropologici identici a quelli di un Totò Riina o di un Bernardo Provenzano.
Se così è, continuare a ribadire una concezione di Cosa nostra desunta soprattutto dall’esperienza del passato reca con sé il rischio di riproporre schemi da vecchia sociologia positivistica di marca ottocentesca, illusoriamente convinta di avere scoperto le eterne leggi scientifiche che spiegano l’uomo-delinquente. Piuttosto, le scienze sociali contemporaneo tendono per lo più a escludere nel campo del comportamento umano forme di determinismo rigido, e perciò concedono non piccoli spazi di libertà di azione anche ai criminali, inclusi quelli di tipo mafioso. Insomma, è tutt’altro che dimostrabile (eccettuati, forse, i casi di individui affetti da alcune gravi patologie psichiatricamente rilevanti) che chi è stato omicida una volta, è destinato ad esserlo necessariamente in futuro. E ciò vale anche rispetto allo specifico universo mafioso: è tutt’altro che scontato che chi è stato mafioso una volta lo sarà per sempre. Ritenerlo contraddirebbe, oltretutto, quella visione antropologica a sfondo non pessimistico sottostante al principio rieducativo e al principio di umanità delle pene così come recepiti nella Costituzione italiana. In particolare dalla costituzionalizzazione della finalità rieducativa quale finalità generale delle sanzioni penali, riferita senza eccezione a tutti i tipi di reato e di autore, si ricava implicitamente che secondo la nostra Costituzione nessun uomo è perduto per sempre, e che dunque ogni delinquente è potenzialmente capace di miglioramento grazie a interventi di tipo risocializzante. In piena coerenza con queste premesse, e nel contempo a loro conferma, leggiamo nella ancora recente e importante sentenza costituzionale n. 149/2018: “la persona umana del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest’ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell’intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali della convivenza civile; ma che non può non chiamare in causa – assieme – la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso”.
È appena il caso, a questo punto, di esplicitare che l’approccio costituzionale alla rieducazione concepisce quest’ultima come processo, in ogni caso, mirato al reinserimento del condannato nella società esterna: mentre contraddirebbe il vero senso costituzionale della rieducazione il limitarsi a concepirla come mero ravvedimento interiore nel chiuso di un carcere.
A suo avviso la decisione della Corte edu, riconoscendo la violazione dell’art.3 CEDU nel caso sopra ricordato, è coerente con i principi costituzionali in tema di rieducazione della pena sanciti dall’art.27 Cost.?
In base alle considerazioni che precedono ritengo si intuisca che, a mio avviso, vi è piena coerenza tra i principi costituzionali relativi alla materia penale esplicitamente previsti nella nostra Costituzione all’art. 27 e quelli impiegati dalla Corte di Strasburgo nel diagnosticare il contrasto tra l‘ergastolo ostativo e l’art. 3 della Convenzione europea. Anzi, più ancora che di coerenza, parlerei di piena consonanza in termini di principio e valoriali.
In estrema sintesi, la Corte EDU ha sviluppato un impianto argomentativo che con parole mie esprimerei così: esigere la collaborazione giudiziaria – come fa l’ordinamento italiano, eccetto che nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante – quale condizione necessaria per concedere agli ergastolani mafiosi (o terroristi) la liberazione condizionale o i cosiddetti benefici penitenziari, equivale a trascurare che i progressi sulla via della rieducazione sono di fatto possibili, e accertabili dalla magistratura di sorveglianza, anche in assenza di collaborazione giudiziaria; sicché, il disconoscerlo finisce col rinnegare il diritto alla speranza e col ledere la dignità umana dell’ergastolano non collaborante. Confesso che, in linea di principio, concordo. Anche perché ad una conclusione analoga si potrebbe giungere ragionando alla stregua della sola Costituzione italiana, a condizione beninteso di interpretarla senza eccessive timidezze. Quali sono stati, infatti, i principi utilizzati dai giudici di Strasburgo per bocciare l’ergastolo ostativo? Sono stati, fondamentalmente, due principi tutt’altro che sconosciuti o irrilevanti dentro i nostri confini: cioè quello di rieducazione come scopo preponderante della pena, fatto oggetto di significativa e progressiva valorizzazione nella più recente giurisprudenza convenzionale, ancorché – a differenza che nella Costituzione italiana – non esplicitamente contemplato a livello normativo; e il principio di umanità, quale implicito fondamento del divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito espressamente dall’art. 3 CEDU. Due principi, dunque, che nel nostro ordinamento costituzionale ricevono un riconoscimento espresso comparativamente maggiore. Se così è, se ne può allora dedurre che l’eventuale contrasto ravvisabile tra la giurisprudenza costituzionale italiana, che ha finora operato il salvataggio dell’ergastolo ostativo (pur avendone progressivamente ridotto il campo di operatività), e la giurisprudenza convenzionale non riguarda i suddetti principi in sé considerati, ma il modo di interpretarli anche sotto il profilo del bilanciamento tra preoccupazioni politico-criminali in chiave di lotta alle mafie e garanzia dei diritti dei mafiosi condannati.
Ma, a parte il fatto che la nostra giurisprudenza costituzionale non può ormai rimanere sorda o indifferente (tanto più per effetto dei vincoli anche ermeneutici derivanti dall’art.117 Cost. in base all’assunzione dei principi convenzionali a parametri interposti di costituzionalità) alle tendenze interpretative di fonte europea, è fuori discussione che la stessa ermeneutica costituzionale domestica è soggetta ad una continua evoluzione influenzata, rispettivamente, dal progressivo affinamento della lettura dei principi, dai mutamenti registrabili nei fenomeni criminali da contrastare e dai cambiamenti socio-culturali connessi ai mutevoli contesti generali di riferimento. E se ne hanno non pochi esempi proprio dando uno sguardo all’evoluzione ricostruttiva di cui sono stati fatti oggetto principi come quelli della personalità della responsabilità penale e dello stesso finalismo rieducativo. Vero questo, nulla in linea teorica o di fatto può impedire, allora, alla Consulta di rivedere il suo precedente punto di vista sulla ritenuta compatibilità della vigente disciplina dell’ergastolo ostativo col principio di rieducazione e con altri principi basilari dell’ordinamento costituzionale.
A mio avviso, occorre da parte della Corte un supplemento di riflessione sia sul nodo dei rapporti tra rieducazione e mancata collaborazione giudiziaria, sia sul contenuto di una rieducazione riferita in particolare ai criminali appartenenti al crimine organizzato.
Sotto il primo aspetto, è già stato più volte rilevato – e, tra l’altro, anche dalla Cassazione nella motivazione dell’ordinanza n.57913/2018, relativa all’eccezione di costituzionalità nel caso dell’ergastolano non collaborante Sebastiano Cannizzaro, in decisione il prossimo 22 ottobre – che esistono fondati motivi per ritenere che non vi sia una correlazione necessaria tra collaborazione giudiziaria e ravvedimento (o, viceversa, tra mancata collaborazione e assenza di ravvedimento). Il mafioso può infatti decidere di collaborare al solo scopo utilitaristico di accedere ai benefici penitenziari, ma senza sottoporre a effettiva revisione critica il suo passato criminale, come può farlo per realizzare una vendetta indiretta contro i mafiosi di una fazione avversa (emblematico in questo senso il caso del celeberrimo collaboratore Tommaso Buscetta, che ha denunciato i misfatti dei nemici “corleonesi”, ma rimanendo intimamente convinto di appartenere a una mafia “buona” soppiantata da una cattiva e deteriorata nei principi e valori). Così come un mafioso può rifiutarsi di collaborare, pur essendosi effettivamente ravveduto, per il timore di esporre se stesso o propri familiari al pericolo di gravi ritorsioni, oppure per la indisponibilità morale a scambiare la propria libertà con quella di altri, od ancora per la preoccupazione che lo svelamento di fatti delittuosi coinvolgenti terze persone possa comportare un eventuale aggravamento del proprio carico di responsabilità. Dunque, vi sono possibili ragioni che nell’insieme convergono, per un verso, a porre fortemente in dubbio che la scelta collaborativa abbia una sicura valenza indiziante di una effettiva “metanoia” e, per altro verso, a sollevare un problema di compatibilità tra l’ergastolo ostativo e il diritto sia alla libertà morale dello stesso mafioso, sia al silenzio quale aspetto del diritto di difesa. Sollevare questi problemi di compatibilità equivale a privilegiare un garantismo da “anime belle”, trascurando che la prevenzione generale e la difesa sociale dalla criminalità corrispondono a interessi anch’essi di rilievo costituzionale quantomeno implicito? A mio giudizio, il salvataggio della legittimità di fondo dell’ergastolo ostativo è spiegabile col fatto che la Consulta, più che essere davvero convinta della sua coerenza col principio rieducativo (o con altri principi costituzionali), ha finora ritenuto opportuno fare a meno di contestare la fondatezza razionale ed empirica delle scelte di politica criminale effettuate dal legislatore del 1992, nel clima emergenziale conseguente alla strage di Capaci.
Comunque sia, verosimilmente, il legislatore di allora era poco interessato a prendere in approfondita considerazione il problema della rieducatività dei condannati mafiosi, e quello connesso della compatibilità col principio rieducativo (o con altri principi costituzionali) delle restrizioni apportate all’accesso ai benefici penitenziari da parte dei criminali organizzati: la sua principale (e peraltro comprensibile) preoccupazione era quella di introdurre un meccanismo sanzionatorio diretto a incentivare la collaborazione giudiziaria mediante una forma di pressione psicologica, quale strumento finalizzato a facilitare l’attività investigativa e repressiva antimafia. Pressione attuata, appunto, mettendo il condannato di fronte all’alternativa di rimanere in carcere serbando il silenzio, o di poterne uscire denunciando altri associati. Se è così, giungere a considerare la collaborazione, come si è anche ritenuto nella giurisprudenza ordinaria, una sorta di prova legale della rieducazione mi sembra il frutto di una ricostruzione forzata ed eccessivamente affrettata (oltre che troppo ottimistica!).
A mio avviso, la scelta collaborativa si presta di per sé meglio a indiziare – più che una compiuta rieducazione – la cessazione di una pericolosità sociale “attuale”, quale effetto della rottura della passata appartenenza criminale prodotta appunto dalla intrapresa collaborazione giudiziaria. Ma, per verificare un effettivo ravvedimento, è più che plausibile ritenere che siano necessari requisiti ulteriori rispetto alla cessata pericolosità. Quali? Il modo di individuarli dipende, a sua volta, dalla maniera di concepire il contenuto della rieducazione. Sul punto tornerò tra poco.
Va aggiunto che sarebbe però egualmente discutibile, in una prospettiva costituzionale, far derivare dalla mancanza di collaborazione una presunzione assoluta di persistenza della stessa pericolosità sociale. Anche rispetto a quest’ultima, l’esistenza o l’assenza di collaborazione non può fungere da unico criterio di verifica, ma il giudice dovrà valorizzare anche elementi sintomatici diversi che ne prescindono . E’ stata del resto la stessa Corte costituzionale ad affermare, in proposito, che “dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione (…) di mantenimento dei legami di solidarietà con l’organizzazione criminale” (sent. n. 306/1993). In ogni caso, le presunzioni assolute di pericolosità – com’è noto - sono anche più in generale considerate con molto sfavore dalla Consulta, in quanto si pongono in forte tensione non solo con i principi costituzionali relativi alla materia penale, ma anche con principi di portata ben più ampia come quello di uguaglianza-ragionevolezza: ciò è comprovato dalla ripetuta bocciatura delle presunzioni legislative rigide riscontrabile nella giurisprudenza costituzionale concernente prima le misure di sicurezza, e più di recente le misure cautelari (e, non a caso, questa giurisprudenza è ampiamente valorizzata dalla Cassazione a supporto della già menzionata eccezione di costituzionalità sollevata nel caso dell’ergastolano Sebastiano Cannizzaro).
Ciò detto, torniamo al problema di determinare il contenuto del concetto di rieducazione in sé considerato: concetto, questo, di non agevole concretizzazione definitoria, anche perché connotato da uno strettissimo e complicato intreccio di componenti empiriche e valutative che finisce col conferire una qualche misura di opinabilità ad ogni accertamento giudiziale del ravvedimento. Non potendo qui ripercorrere la lunga e non sempre lineare evoluzione interpretativa dell’art. 27, comma 3, Cost., mi limito in sintesi a ricordare che nella giurisprudenza costituzionale è andata consolidandosi una nozione – direi – abbastanza laica di rieducazione (o ravvedimento o recupero sociale), che tende a identificarla con l’acquisizione della capacità, da parte del soggetto sottoposto a punizione, di rispettare le regole della convivenza sociale. Senonché, che in proposito non tutto sia ancora chiaro e pacifico emerge, ad esempio, dalla vicenda - a mio avviso in questo senso emblematica – relativa al recente diniego della detenzione domiciliare al boss pluriomicida “pentito” Giovanni Brusca (condannato invero non all’ergastolo, ma a una lunga pena detentiva – in larga parte già scontata – grazie ai benefici della collaborazione). Orbene, dalla lettura di alcuni provvedimenti giudiziari, e altresì di alcun commenti anche in forma di intervista apparsi sulla stampa, affiorano modi di intendere il significato del ravvedimento tutt’altro che convergenti. Mentre nell’ottica in particolare dei magistrati d’accusa l’avere fornito una collaborazione giudiziaria duratura ed efficace viene (non a caso!) considerato il più affidabile criterio diagnostico di un maturato ravvedimento, nella diversa prospettiva del tribunale di sorveglianza di Roma (e – aggiungo – delle vittime di mafia) la rieducazione di un efferato boss mafioso richiederebbe molto di più: cioè un mutamento profondo e sensibile della personalità, una sorta di “pentimento civile” inclusivo di momenti di riparazione-riconciliazione anche simboliche nei confronti dei discendenti delle vittime. Un concetto così impegnativo di rieducazione, denso di venature eticheggianti in senso anche retributivo e di riflessi emozionali, si mantiene nel solco della suddetta concezione “laica” sostenuta e ribadita dalla Consulta o la trascende indebitamente?
Forse, sarebbe opportuno che la Corte costituzionale, nelle occasioni di intervento più o meno prossime, si sforzasse di fare ulteriore chiarezza sul modo di intendere la rieducazione, così da orientare in maniera più sicura e univoca i giudici ordinari. Anche se riuscirvi non è facile, dal momento che termini come rieducazione o ravvedimento evocano concetti indeterminati, ambigui e “porosi”, inevitabilmente al confine tra il diritto, la psicologia, le culture di sfondo e le differenti concezioni morali compresenti in una società pluralista e frammentata come l’attuale.
Il passaggio dal divieto ex lege di concessione all’ergastolano non collaborante di benefici premiali alla possibilità che sia la magistratura di sorveglianza a verificare la ricorrenza dei presupposti per il loro eventuale riconoscimento attenuerebbe il livello di contrasto alla lotta contro la criminalità dello Stato ovvero produrrebbe un sistema coerente con il quadro costituzionale e convenzionale fondato sul bilanciato fra interesse collettivo e diritti del condannato?
L’eliminazione delle preclusioni legali e la conseguente restituzione alla magistratura di sorveglianza del compito di verificare, anche nel caso degli ergastolani non collaboranti, l’esistenza dei presupposti per concedere i benefici, rappresentano senz’altro la soluzione più coerente con il quadro costituzionale e convenzionale. Tra le critiche giustificate rivolte dalla dottrina alla disciplina dei reati ostativi rientra, non a caso, anche quella di violare il principio della riserva di giurisdizione, spogliando i giudici del potere istituzionalmente loro spettante di verificare nei diversi casi concreti gli sviluppi del processo rieducativo, in modo tale da emettere giudizi che tengano conto delle peculiarità delle varie situazioni oggetto di vaglio. Da questo punto di vista, il superamento delle presunzioni legali rigide obbedisce nel contempo all’esigenza – più volte riconosciuta nella giurisprudenza costituzionale – che il giudice rispetti un principio di eguaglianza-ragionevolezza concepito anche in chiave di decisione adeguata o giusta dei casi concreti riguardati nelle loro specificità.
È stato obiettato – è vero – che il ripristino del potere valutativo della magistratura di sorveglianza può comportare come costo un indebolimento dell’azione di contrasto delle mafie, e ciò per un insieme di ragioni intuibili che inducono anche a paventare rischi di eccesso di responsabilizzazione e sovraesposizione funzionale, di pressioni e condizionamenti da parte dei poteri criminali e di decisioni errate o inopportune a causa delle difficoltà oggettive e delle inevitabili incertezze che la verifica giudiziale del percorso rieducativo non di rado comporta. Ma è altrettanto vero che rischi di sovraesposizione, di pressioni ecc. possono più in generale incombere in relazione a tutte le fasi processuali in cui i magistrati si trovano a vario titolo nella condizione di dover comunque emettere provvedimenti che incidono in senso fortemente restrittivo sulla libertà o su altri diritti dei criminali organizzati. Ciò detto, anche se la preoccupazione relativa a un effetto di possibile indebolimento della lotta antimafia fosse non infondata, riterrei comunque che si tratti di un accettabile prezzo da pagare nella prospettiva di un più equilibrato bilanciamento costituzionale tra l’interesse collettivo alla difesa sociale e la tutela dei diritti dei condannati.
La Corte costituzionale sarà chiamata ad esaminare diverse questioni di legittimità costituzionale sui c.d. automatismi impeditivi di benefici premiali in favore di condannati - fra le quali quella sollevata da Cass., Sez. 1, n. 57913 del 20/11/2018, Cannizzaro–. Quali saranno, a suo avviso, le ripercussioni di ordine giuridico o psicologico della pronunzia della Corte edu sulle decisioni che la Corte costituzionale sarà chiamata ad affrontare?
Anch’io ritengo che la decisione europea dello scorso giugno sia idonea a influenzare, sotto diversi aspetti, le future prese di posizione della Corte costituzionale su casi analogamente incentrati sulla problematica dell’ergastolo ostativo, a cominciare dal già accennato caso Cannizzaro che sarà in discussone il 22 ottobre prossimo. E il primo effetto - pressoché scontato - penso che sarà quello di sollecitare un ulteriore approfondimento del tema, in vista di un superamento - dal mio punto di vista auspicabile - degli argomenti meno persuasivi finora utilizzati per giustificare il salvataggio dell’istituto.
Come sappiamo, la Corte di Strasburgo ha bocciato la vigente disciplina dell’ergastolo ostativo in quanto a suo giudizio irrispettosa della dignità umana del condannato, e perciò contrastante col divieto convenzionale di trattamenti inumani e degradanti. In effetti, questa angolazione prospettica è stata ad esempio adottata anche da un costituzionalista italiano come Andrea Pugiotto, che ha analogamente sostenuto l’incompatibilità della forma di ergastolo in questione non solo col principio di rieducazione, ma anche col senso di umanità (anch’esso espressamente richiamato dall’ art. 27, comma 3, Cost.). A mio giudizio, obiezioni comparativamente più forti sono formulabili facendo leva su di un sempre più coerente (e coraggioso) sviluppo di una trama argomentativa pur sempre basata sulla virtuosa interazione tra i principi di rieducazione ed eguaglianza-ragionevolezza, vale a dire su di una coppia di principi che la nostra Corte costituzionale è ben abituata a maneggiare, come infatti dimostrano non poche significative pronunce emerse nel corso degli anni a proposito di altre importanti tematiche penalistiche.
Ciò premesso, mi attenderei – appunto - che grazie a un ulteriore sviluppo dei suddetti principi si giungesse finalmente a riconoscere l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo, nella parte in cui la sua attuale disciplina preclude alla magistratura di sorveglianza di verificare in concreto i progressi sulla via del ravvedimento comunque compiuti dal condannato nonostante l’assenza di collaborazione giudiziaria, e dunque di entrare anche nel merito delle ragioni della mancata collaborazione per valutarne la rilevanza come possibili indici ai fini del giudizio sull’avvenuta maturazione o meno del ravvedimento. D’altra parte, la stessa Corte potrebbe altresì additare – benché non sia facile - criteri destinati a orientare i giudici circa la valenza da attribuire alla scelta (o, viceversa, alla mancata scelta) collaborativa nell’ economia complessiva dei fattori rilevanti in sede di verifica del processo rieducativo, esigendo in proposito un particolare rigore sul piano motivazionale. Ma che in ogni caso sia soprattutto quello di rieducazione il principio-cardine su cui far leva, lo desumo anche dal fatto che la stessa Corte, nella importante e già menzionata sentenza di accoglimento n.149/2108 in tema di ergastolo ex art.630 c.p. e 58-quater, comma 4, ord.penit., è giunta ad affermare il “principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena”.
Qualche ulteriore considerazione, infine, indotta dalla specificità del caso Cannizzaro oggetto di vaglio costituzionale fra pochi giorni. In questa vicenda, il beneficio negato all’ergastolano non collaborante è consistito, precisamente, in un permesso-premio. Ora, come ha condivisibilmente rilevato la Cassazione nell’ordinanza di rimessione alla Consulta, le caratteristiche e la funzione del permesso-premio sono tali da rafforzare i motivi di incostituzionalità della vigente disciplina preclusiva. Infatti il permesso, piuttosto che presupporre un ravvedimento già maturato, è uno strumento finalizzato dall’ordinamento penitenziario a favorire progressi graduali nell’ambito di un procedimento rieducativo in corso di svolgimento. Da questo punto di vista, la previsione normativa che ne impedisce la concessione a causa della mancata collaborazione si frappone allora irragionevolmente - essa stessa - al potenziale maturare di un ravvedimento che potrebbe, a sua volta, avere come sbocco anche una scelta collaborativa.
Un’altra peculiarità rilevante di questo caso è costituita dalla circostanza che la condanna all’ergastolo ha fatto seguito alla commissione di delitti aggravati dal fine di agevolare l’attività illecite di associazioni mafiose, per cui manca una diretta appartenenza mafiosa dell’autore: questa assenza di appartenenza può, appunto, fare apparire a fortiori priva di razionale giustificazione la subordinazione della concezione del beneficio ad una collaborazione interruttiva di un vincolo associativo che di fatto in questo caso manca.
Se così è, mi sentirei – in conclusione - di pronosticare una pronuncia più di accoglimento che di rigetto.
3.Le conclusioni
Roberto Giovanni Conti
Giovanni Fiandaca si è rivolto in maniera schietta alla Corte costituzionale, alla collettività, ai giudici antimafia ed alla magistratura di sorveglianza scandagliando dal punto di vista tecnico-giuridico le questioni sul tappeto, né mancando di disegnare, con l’onestà intellettuale che gli appartiene, le ragioni opposte sostenute da chi si è dichiarato contrario alla modifica dell’attuale sistema normativo per sottolinearne, tuttavia, la non decisività rispetto alla reale posta in gioco.
I punti qualificanti della riflessione di Fiandaca mi pare possano così sintetizzarsi.
La vicenda Viola c. Italia può costituire lo spunto per dare nuovo impulso al dibattito culturale, sociologico e giuridico sulla figura dell’autore del reato e, specificamente, dell’appartenente all’associazione mafiosa, oggi ancorata a schemi ed esperienze forse da aggiornare anche alla luce della crescente consapevolezza del rilievo assunto dai principii di umanità e rieducazione.
Fiandaca sottolinea la piena "consonanza" fra la protezione offerta a livello convenzionale dal divieto di tortura al condannato e quella di stampo costituzionale agganciata all’art.27 Cost. per dimostrare quanto la prima assuma una funzione propulsiva rispetto ai contenuti valoriali ed all’applicazione concreta che della seconda occorre fare. Per tali ragioni la giurisprudenza convenzionale potrebbe rappresentare il volano per modificare le conclusioni fin qui espresse sul tema dell’ergastolo ostativo dalla giustizia costituzionale che, ci ricorda Fiandaca, ha già in via autonoma offerto plurime risposte rivolte ad arricchire la garanzia costituzionale offerta dall’art.27, anche facendo leva sulla virtuosa interazione fra i principi di rieducazione ed eguaglianza-ragionevolezza. Canoni che consentirebbero di fare nuova luce sugli aspetti di incostituzionalità sollevati dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di rimessione sul caso Cannizzaro
Di straordinario rilevo risulta la domanda di approfondimento sul nodo dei rapporti fra rieducazione e mancata collaborazione giudiziaria e su quello dei contenuti in sé del piano rieducativo, sollecitando al giudice costituzionale un supplemento di attenzione su tematiche che, secondo Fiandaca, anche di recente hanno mostrano diversità di approccio e, quindi, differenti soluzioni capaci di produrre risposte disomogenee.
La centralità della figura del magistrato di sorveglianza nella verifica del concreto ravvedimento del condannato che sollecita Fiandaca, in una prospettiva che guarda senza riserve evidenti alla sostanza dei valori in gioco più che ad una prospettiva gerarchica fra le Carte dei diritti e le Corti, costituisce l’elemento al contempo necessario per attuare la Costituzione e sufficiente per realizzare un corretto bilanciamento tra l’interesse collettivo alla difesa sociale e la tutela dei diritti dei condannati. Certo, non va sottovalutata la concorrente sovraesposizione di quella stessa figura professionale che tuttavia, nota Fiandaca, non assume tratti distintivi significativamente diversi da quella dei magistrati giudicanti impegnati nell’accertamento della verità.
Fin qui Fiandaca.
Qual è, dunque la posta in gioco: lo scardinamento del sistema repressivo faticosamente approntato dallo Stato – soprattutto grazie al sacrificio massimo di chi ha dato la vita in nome di un ideale di giustizia spesso scarsamente avvertito dal corpo sociale – per contenere il fenomeno mafioso – ma in realtà sempre più esteso, quanto al regime ostativo, a forme criminali spurie rispetto alla mafia – ovvero l’indeclinabile e insopprimibile dignità del condannato, anche di quello ritenuto responsabile per reati avvertiti come efferati e irredimibili ad essere giudizialmente valutato per la condotta successiva allo stato di detenzione in vista di un possibile beneficio premiale?
Appunto, il dilemma è proprio quello che si avverte tra l’esigenza, a volte incontrollabile se si guarda alle ferite insanabili prodotte da alcune condotte criminali ed al contesto nel quale esse prendono corpo, di “buttare la chiave” della cella del condannato all’ergastolo ostativo e quella, altrettanto insopprimibile, di considerare il condannato, anche il più abietto, pur sempre una persona.
Già qualche anno addietro Gaetano Silvestri, nella prefazione al testo di Andrea Pugiotto e dell’ergastolano Carmelo Musumeci, aveva riconosciuto che il condannato “non può essere privato della propria dignità, che, secondi i valori che stanno alla base dello Stato costituzionale, val persino più della vita”, giungendo alla conclusione che “…la deprivazione definitiva e irrimediabile della socialità derivante dal c.d. ergastolo ostativo, non è coerente con la tutela della dignità della persona, che non può essere ritenuta integra in assenza della dimensione della socialità”. E non può non far riflettere la circostanza che lo stesso Silvestri, idealmente ponendosi sul piano poi sviluppato dalla giurisprudenza convenzionale, avesse equiparato la condizione richiesta all’ergastolano ostativo per l’ammissione ai benefici a “quella di chi è sottoposto a tortura: ti tolgo qualcosa cui avresti diritto (secondo la legge generale ed i principi costituzionali) e ti sottopongo ad una sofferenza aggiuntiva, che durerà finché non ti deciderai a collaborare”.
Le riflessioni che Giovanni Fiandaca ha dedicato alla questione aprono necessariamente plurimi piani d’indagine non più declinabili nemmeno da parte della magistratura - associativa e correntizia - rispetto alla rilevanza di una dimensione sempre più sovranazionale del diritto e dei diritti fondamentali che a volte ci si accorge esistente solo occasionalmente, in ragione della rilevanza massmediatica di alcune vicende, senza spesso cogliere la reale posta in gioco, nella quale entrano in campo la natura “pilota” o “quasi pilota” delle sentenze della Corte edu, i rapporti fra le Carte dei diritti, i plessi giurisdizionali sovranazionali, il giudice comune, la Corte costituzionale ed il legislatore.
Ecco, ancora una volta, tornare sotto i riflettori i temi del bilanciamento fra valori fondamentali al quale sono chiamati in prima battuta e su un piano astratto il legislatore, ma anche il giudice comune in termini concreti e particolari ed i giudici costituzionali e sovranazionali, qui essi atteggiandosi come bilanciamenti concreti e generali che tendono ad “universalizzarsi”, per dirla con Antonio Ruggeri. Ecco riemergere l’alternativa fra gli automatismi normativamente imposti e la personalizzazione della risposta statale affidata al giudice in vista di un’esigenza di giustizia che guardi alle vittime, ai colpevoli ed alla sicurezza della collettività senza perdere mai di vista la bilancia sulla quale si pongono i beni bisognosi di bilanciamento, appunto la dignità della persona.
È dunque auspicabile che i “seguiti” della sentenza Viola c. Italia sul piano interno possano essere anche l’occasione per una riflessione complessiva della cultura giuridica alla quale sarebbe immorale e pericolosissimo che la magistratura non partecipasse attivamente con tutte le sue componenti e straordinarie energie, aprendosi a quel confronto con l’Accademia e con l’Avvocatura che Fiandaca, con la sua autorevolezza, reclama a gran voce.
Sarebbe un peccato mortale fare spegnere i riflettori sulla vicenda ergastolo ostativo senza cogliere, appunto, la vera posta in gioco.