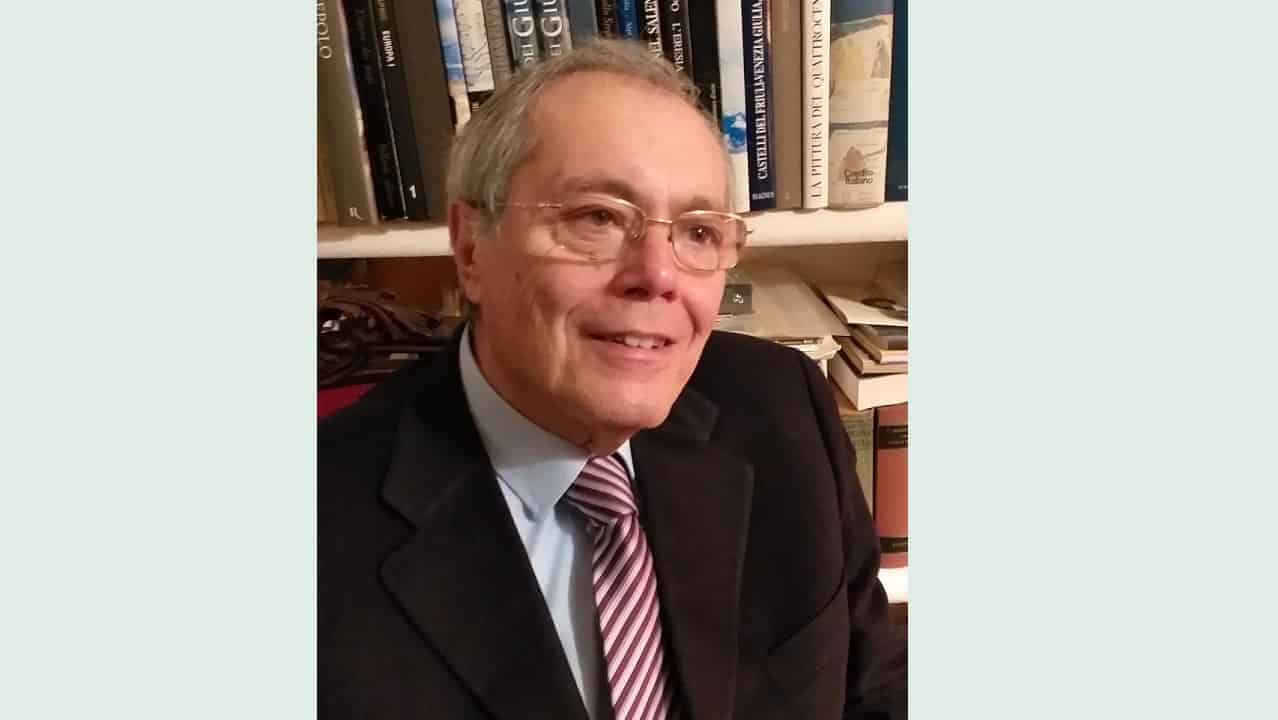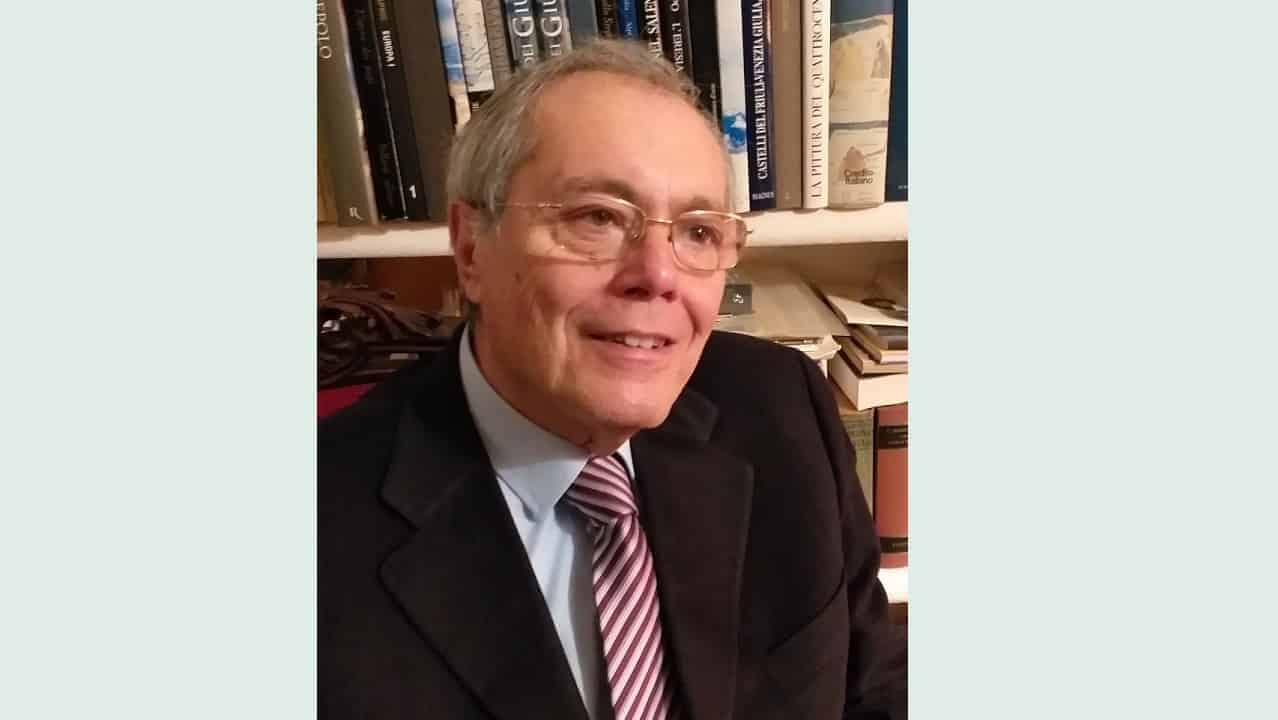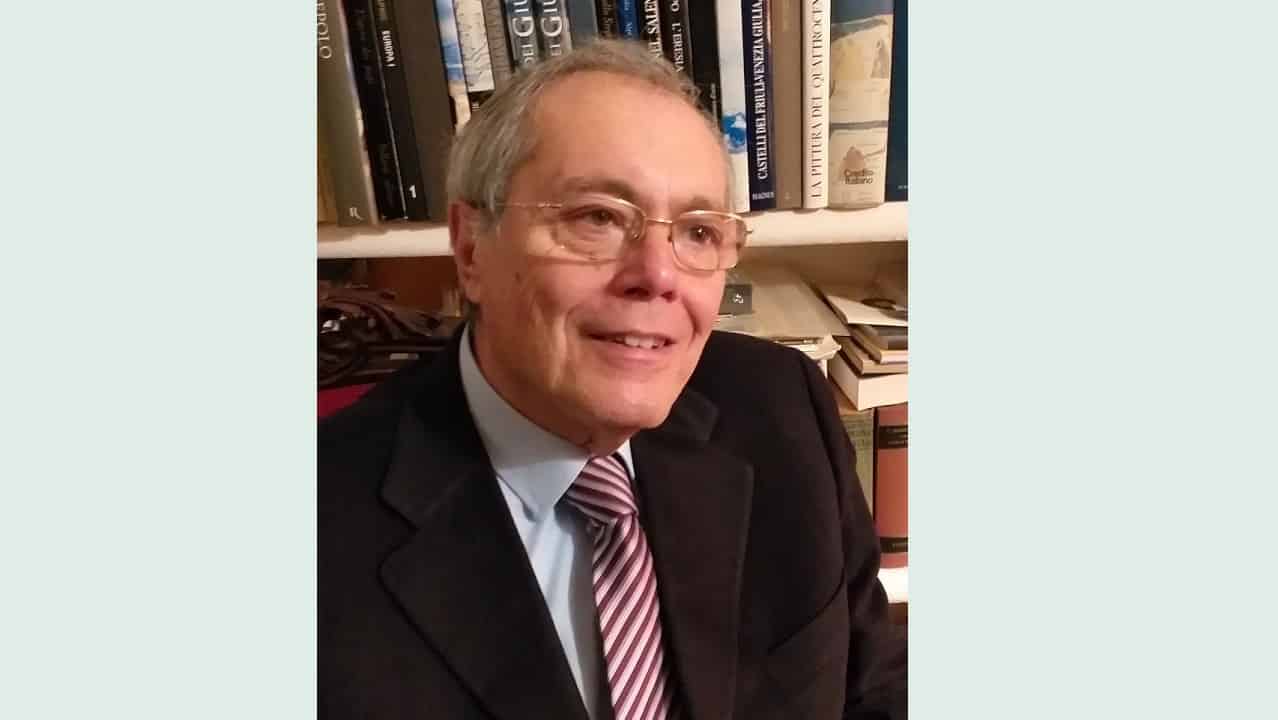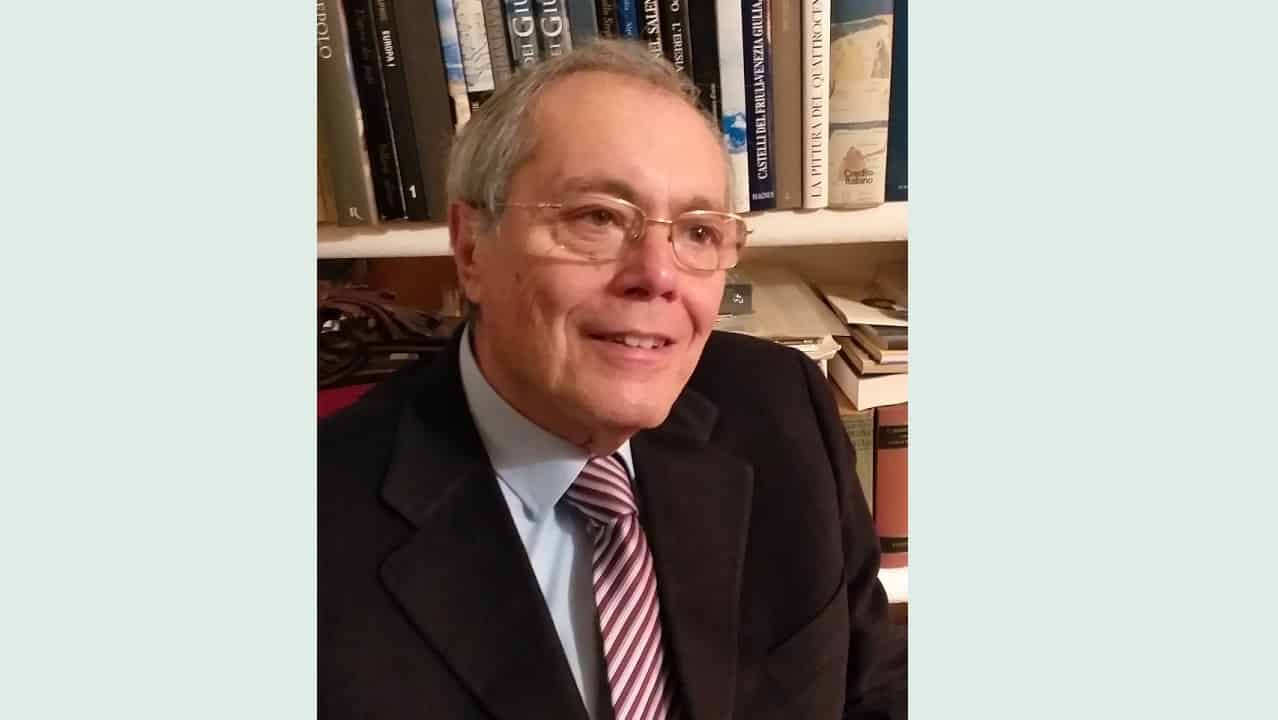Giudice o giudici nell'Italia postmoderna?
La prima domanda:
“La pluralità di Carte dei diritti fondamentali (Costituzione, Cedu, Carta UE dei diritti fondamentali, Convenzioni internazionali) ha favorito la proliferazione di poli decisionali e di sentenze pronunziate da giudici nazionali e sovranazionali destinate ad interagire, a sovrapporsi o, a volte, a porsi in dichiarato conflitto fra loro. Rispetto a tale fenomeno il giudice nazionale esce indebolito o rafforzato nel suo ruolo?”
Antonio Ruggeri: “Una preliminare avvertenza, prima di tentare di rispondere al primo quesito che mi pare si ponga a base dei restanti che da esso risultano variamente, significativamente condizionati; ed è che mi riservo di ripartire in modo non equo lo spazio che è stato messo a disposizione per le nostre risposte, preferendo svolgere subito un più articolato ragionamento al quale farò quindi rimando trattando delle questioni poste nei successivi quesiti.
A me pare che la risposta all’interrogativo sia, perlomeno in parte, implicita nel quesito che subito segue. Più che indebolito o rafforzato (ciò che – come dirò – a me sembra assai arduo da stabilire), il giudice risulta infatti oggi gravato di responsabilità di gran lunga accresciute rispetto anche ad un recente passato; la qual cosa, poi, si deve a plurime cause, reciprocamente intrecciate e solo in parte fatte oggetto di analisi adeguate alla loro complessità e gravità. Il vero è che il contesto in cui s’inscrive il quotidiano servizio prestato dal giudice porta naturalmente a quest’esito, che dunque si deve non soltanto al proliferare delle Carte dei diritti (quelle esplicitamente nominate ed altre ancora, alcune delle quali purtroppo non sfruttate nella pratica giuridica, come invece si dovrebbe, in tutto il loro formidabile potenziale espressivo).
Per limitare qui il riferimento ai soli profili istituzionali, si pensi all’aumento esponenziale delle domande sociali, tra le quali appunto quelle di giustizia, ed alla palesata inadeguatezza del legislatore a farvi fronte, che sollecita naturalmente i portatori di diritti e interessi in genere costituzionalmente protetti a rivolgersi al giudice per avere da quest’ultimo quelle risposte che, in primo luogo, dovrebbero venire proprio dal legislatore. In realtà, come ho tentato di argomentare in altri luoghi, un congruo appagamento delle istanze della persona richiederebbe – secondo modello – uno sforzo poderoso prodotto in spirito di reciproca collaborazione ed autentico servizio tanto dal legislatore quanto dai giudici (da tutti i giudici: nazionali e non, costituzionali e comuni). La qual cosa si rende particolarmente apprezzabile sul terreno sul quale maturano le esperienze riguardanti i diritti fondamentali, in ispecie i nuovi (o nuovissimi). Al legislatore tocca, ad ogni buon conto, giocare la prima mano: è suo, infatti, il compito di dar vita ad un pugno di enunciati connotati da strutturale duttilità ed apertura di linguaggio, sì da potersi agevolmente adattare alla incontenibile varietà del reale, enunciati dunque essenzialmente per principia, “delegandosi” quindi ai giudici la estrazione da essi delle regole fatte su misura, come un abito sartoriale, per le complessive (e non di rado complesse) esigenze di ciascun caso.
Questo – perlomeno ai miei occhi – appare essere il modello costituzionale; e, d’altro canto, se ne ha conferma dall’esperienza: tutte le volte, infatti, che il legislatore si è spinto a far luogo a discipline connotate da disposti eccessivamente rigidi e minuti, tanto più poi se infarciti di irragionevoli divieti (come, ad es., s’è fatto con la legge 40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita), i giudici si sono trovati costretti a far luogo ad autentiche acrobazie interpretative o a sollecitare l’adozione di meccanismi sanzionatori (da parte della Consulta) allo scopo di rendere almeno in parte duttile ed aperto ciò che invece in origine si connotava per una insopportabile rigidezza e asfittica chiusura.
Ora, la pluralità delle Carte, in ispecie di quelle menzionate nel quesito sottopostoci, per un verso agevola e per un altro però aggrava il compito sia del legislatore che del giudice, più ancora a conti fatti di quest’ultimo, se si considera che il modello sopra succintamente rappresentato molte volte nella pratica giuridica “è saltato”(e “salta”) non soltanto laddove il legislatore abbia dato vita – come si diceva – a prodotti normativi irragionevolmente dettagliati ma anche nel caso opposto che si sia reso responsabile di ingiustificati ritardi e complessive carenze, tali quindi da obbligare i giudici ad una impegnativa e non di rado sofferta “supplenza” – come è usualmente chiamata – che, come è stato fatto notare anni addietro dal Presidente pro tempore della Corte costituzionale, G. Zagrebelsky, appare essere “non richiesta e non gradita”.
La pluralità delle Carte, in realtà, può, per un verso, spianare la via agli operatori istituzionali nell’esercizio delle loro funzioni e, per un altro verso, però rendere l’esercizio stesso ancora più impegnativo ed oneroso.
La ragione è presto spiegata. Le Carte, infatti, sono per loro natura ed indeclinabile vocazione portate a darsi mutuo sostegno, alimentandosi a vicenda nei fatti interpretativi e per le esigenze dell’applicazione, secondo quanto riconosciuto già da tempo in giurisprudenza (ad es., da Corte cost. n. 388 del 1999); e, poiché le Carte “vivono” – come suol dirsi – per il modo con cui s’inverano nell’esperienza grazie, in primo luogo, proprio all’opera dei giudici, se ne ha che preziosi ed indefettibili si rivelano essere i riferimenti agli orientamenti pregressi maturati nelle aule in cui si amministra giustizia sulla base delle Carte suddette.
Si faccia caso al carattere generale di questa mia affermazione: ogni Carta, infatti, “vive” non soltanto così come la intende e mette in pratica una sola Corte (per la Carta dell’Unione, quella di giustizia; per la CEDU, la Corte di Strasburgo; per la Costituzione, la Corte costituzionale), secondo una visione schematica, riduttiva e, ad esser franchi, forzosa, seppur talora accreditata. Non si trascuri e, comunque, non si sottovaluti, infatti, in primo luogo, proprio l’opera che quotidianamente e – sovente – in modo discreto e non appariscente svolgono i giudici comuni quali interpreti e garanti di ciascuna di tali Carte e di tutte assieme, pur nella tipicità dei ruoli propri di ciascun operatore di giustizia. Nessun giudice, dunque, può rivendicare per sé il monopolio della interpretazione costituzionale (sintagma che qui intendo in senso materiale, riferendolo appunto ad ogni documento – per dirla con la Consulta: sent. n. 269 del 2017 – “tipicamente costituzionale”, qual è appunto una Carta dei diritti); e, se ciò pretendesse, sarebbe un ingenuo o un folle. I ruoli istituzionali sono, sì, distinti, e tali devono restare, ma nessuno può considerare essere affare suo proprio ed esclusivo l’interpretazione della Costituzione o di altra Carta, che poi altro non è che un servizio reso alla stessa, al quale tutti sono comunque chiamati a dare il loro fattivo concorso.
Si vede allora con chiarezza come tra la singola pronunzia del giudice e il contesto giurisprudenziale in cui essa s’inscrive ed invera venga a costituirsi un rapporto di circolare alimentazione: la prima entrando a comporre ed a rinnovare incessantemente il secondo, dal quale nondimeno trae suggestioni ed indicazioni preziose al fine della sua formazione e del suo radicamento in esso.
Dicevo all’inizio di questa mia risposta che il giudice è oggi maggiormente responsabilizzato rispetto al passato. Le Carte infatti si prestano ad essere variamente combinate secondo i casi; il che, poi, in buona sostanza equivale a dire che varie possono essere le combinazioni degli orientamenti della giurisprudenza pregressa, persino di quelli espressi da una stessa Corte, non poche volte – come si sa – internamente oscillanti e afflitti da non rimosse contraddizioni, orientamenti dunque suscettibili di selezioni grazie ad un uso raffinato della tecnica dell’auto- o eterocitazione.
A ciò si aggiungano le non comuni risorse offerte dalla tecnica della interpretazione conforme che, dovendosi simultaneamente indirizzare verso tutte le Carte e, in genere, le fonti di diritto internazionale e sovranazionale, si apre naturalmente a plurimi ed imprevedibili esiti, rendendo perciò per la sua parte testimonianza della gravosità del compito al cui adempimento il giudice è chiamato.
Infine, non si trascuri la circostanza per cui, pur laddove il giudice dovesse sollecitare l’entrata in campo della Corte costituzionale o di altra Corte (e, segnatamente, della Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale, o, un domani, della Corte EDU, in base a quanto previsto dal prot. 16, che nondimeno predispone uno strumento di cui solo alcuni operatori di giustizia possono avvalersi), di cruciale rilievo è la domanda, ancora prima della risposta, la quale risulta da quella in significativa misura condizionata. Com’è stato più volte rilevato dalla più avveduta dottrina, importa infatti non solo chi parla per ultimo ma anche chi parla (o non parla…) per primo. Non si perda, ad ogni buon conto, di vista che le Corti materialmente costituzionali (e tali ormai sono, sia pure tendenzialmente, anche le Corti europee) non parlano mai per ultime, non chiudono cioè il cerchio di una esperienza processuale data, il quale invece si perfeziona unicamente nelle aule in cui si amministra la giustizia comune, dal momento che è presso di queste che le pronunzie delle Corti suddette ricevono esecuzione (che, poi, in qualche caso – e così con riferimento alle additive di principio della Consulta o alle decisioni-pilota della Corte europea – meglio si farebbe a chiamare “attuazione”); una esecuzione o attuazione che non è affatto – come invece erroneamente da parte di molti si pensa – un’attività meramente meccanica e priva di qualsivoglia apprezzamento discrezionale ma, all’inverso, richiede, specie in alcuni frangenti, un’attiva compartecipazione alle operazioni di giustizia costituzionale in senso materiale, che – come si vede – è in nuce una sorta di work in progress ai cui capi, iniziale e terminale, resta pur sempre, solo con se stesso (la propria scienza e coscienza), il giudice comune.
Tutto ciò posto, è poi innegabile che si sia assistito, specie nel tempo a noi più vicino, ad un forte rigurgito di “riaccentramento” del sindacato presso la Consulta, con specifico riguardo alle antinomie tra norme interne e norme eurounitarie: un “riaccentramento”, a mia opinione, assai discutibile già con riferimento ai casi in cui il parametro evocato in campo sia dato da norme self executing della Carta di Nizza-Strasburgo, secondo quanto stabilito da Corte cost. n. 269 del 2017, ma più ancora meritevole di essere fatto oggetto di vaglio critico in relazione ai casi, di cui a Corte cost. n. 20 del 2019, in cui risultino disattese norme parimenti suscettibili d’immediata applicazione prodotte da fonti diverse dalla Carta suddetta ancorché a quest’ultima strumentalmente connesse. Come si è fatto in altri luoghi notare, in tal modo si rischia di mettere da canto in un numero imprevedibile di casi il collaudato meccanismo dell’applicazione diretta sul quale – non è inopportuno rammentare – si è inteso fare particolare affidamento al fine di dar modo al processo d’integrazione sovranazionale di portarsi avanti, coerentemente con il fine istituzionale che ne ha giustificato la messa in moto.
La situazione appare, nondimeno, fluida ed incerta circa i suoi prossimi sviluppi. Se n’è avuta, da ultimo, conferma da Corte cost. n. 63 del 2019 che, riprendendo ed ulteriormente precisando uno spunto già presente nella sent. 20, appena richiamata, dà modo al giudice comune di rivolgersi in ogni tempo in via pregiudiziale alla Corte dell’Unione, dunque sia prima che dopo il giudizio di costituzionalità. Non è chiaro, allora, quali scenari possano di conseguenza delinearsi. Perché, rivolgendosi in via prioritaria alla Corte di giustizia e ricevuta da quest’ultima una indicazione che solleciti l’applicazione diretta della norma sovranazionale, parrebbe che il successivo giudizio di costituzionalità non possa più aversi. D’altro canto, la Consulta ribadisce quanto già affermato nella sent. 20, secondo cui, se interpellata dal giudice comune, a quest’ultimo può (e deve) esser data una risposta nel merito. Sembra, insomma, lavarsi pilatescamente le mani e scaricare sul giudice stesso la responsabilità della scelta circa la via da intraprendere, se quella che può portare alla disapplicazione diretta della norma interna accompagnata dall’applicazione della norma sovranazionale dalla prima non rispettata ovvero l’altra che porta al sindacato accentrato di costituzionalità, idoneo a concludersi – se del caso – con l’annullamento con effetti erga omnes della norma nazionale o, in via di mera ipotesi, con l’opposizione dei controlimiti alla disciplina eurounitaria.
Ora, con riserva di approfondimento in altro luogo, non credo tuttavia che la Consulta – le piaccia o no – possa rendersi corresponsabile della eventuale trasgressione da parte del giudice comune del canone fondamentale dell’applicazione diretta che – come si sa – è l’autentico cuore pulsante dell’Unione, la ragion d’essere della sua esistenza. Insomma (e per chiudere sul punto), l’applicazione diretta non è un optional, rimesso all’apprezzamento discrezionale dell’operatore istituzionale di turno ma risponde ad un preciso ed indeclinabile obbligo discendente dal principio fondamentale di cui all’art. 11 della Carta, nel suo fare “sistema” con i principi fondamentali restanti.
Il quadro complessivo – come si vede già dai brevi cenni ora fatti – si presenta, ad ogni buon conto, per riprendere un’immagine che ho altrove rappresentato, in chiaroscuro, esibendo tanto tracce marcate di un ruolo attivo dei giudici comuni quanto tracce vistose di un ruolo parimenti attivo delle Corti materialmente costituzionali (nel senso sopra precisato). Credo che, al tirar delle somme, solo nei singoli casi sia possibile stabilire in concreto da che parte penda maggiormente la bilancia.”
Roberto Bin: “È aumentata senz’altro la sua “autonomia”, ma è di molto diminuita la sua autorità. L’art. 101 Cost. fissa i confini costituzionali del ruolo del giudice, che amministra la giustizia “in nome del popolo”, ma non in rappresentanza di esso, ed è soggetto soltanto alla legge, cioè alle regole poste da chi il popolo legittimamente rappresenta. La legge è frutto del compromesso politico e se il giudice ritiene che quello raggiunto dal legislatore non corrisponda ai principi costituzionali, deve ricorrere alla Corte costituzionale. Questo è il quadro costituzionale, corrispondente alla tradizione dello Stato di diritto. In esso si collocano anche le “aperture” internazionali alla UE e alla CEDU e alla giurisprudenza delle relative Corti. Sono ordinamenti non sovrani né “superiori”, ma “derivati” dall’autorità degli Stati e istituiti grazie ad atti di diritto internazionali, recepiti dalla legge italiana e “protetti” dall’art. 117.1 Cost. In nessun modo essi possono essere usati per “andare oltre” ai limiti dell’ordinamento italiano, a cui il giudice è soggetto. I tentativi di molti tribunali e di alcune sezioni della Cassazione di liberarsi dal “vincolo della legge” e attingere invece a questa o quella giurisprudenza sovranazionale costituiscono – a mio modo di vedere – veri e propri abusi che offuscano il ruolo costituzionale del giudice e ne minano l’autorità.
L’idea che spetti ai giudici «alimentare incessantemente i contenuti dei rispettivi documenti in un gioco al rialzo rivolto al perseguimento della miglior tutela possibile dei diritti fondamentali» (così R.G. CONTI, La giurisdizione del giudice ordinario e il diritto Ue, in Le trasformazioni istituzionali a sessant’anni dai trattati di Roma, a cura di A. Ciancio, Torino 2017, 99, in cui il debito culturale nei confronti di Ruggeri è apertamente riconosciuto) è profondamente sbagliata. I giudici non costituiscono l’“Agenzia per la promozione dei diritti fondamentali”: c’è una fondamentale differenza. L’immagine del giudice si accredita e si legittima per la sua funzione, che – come ripete la giurisprudenza costituzionale da sempre - è «l’applicazione obiettiva del diritto»; la sua indipendenza lo protegge da qualsiasi altra volontà che non sia quella obiettiva della legge (Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova 19759, 378). In ciò la giurisdizione si distingue dall’amministrazione, che invece è “finalizzata” al perseguimento dell’interesse pubblico, dello specifico interesse pubblico alla cui cura ogni ramo e ogni ufficio è preposto. L’attività amministrativa si pone quindi come “funzione” in senso proprio, ossia come deputatio ad finem (Cfr. M.S. GIANNINI, Attività amministrativa, in Enc.dir. III, 1958, 989); alla giurisdizione, invece, il conferimento dei poteri «non avviene mai secondo il criterio della definizione di un interesse specifico da perseguire, ma soltanto in funzione del raggiungimento dell’interesse generale obiettivo della giustizia» (G. . BERTI, Interpretazione costituzionale, Padova 1987, 265).
Capisco, può apparire come la vecchia e logora dommatica giuridica. Ma l’alternativa fuzzy del giudice che cerca il maximum standard della protezione dei diritti è, al tempo stesso, dissonante rispetto al ruolo assegnatogli dalla Costituzione e minata in radice perché si basa su un fondamento teorico sbagliato, sull’idea per cui davvero possa esistere un maximum standard dei diritti(tema che non posso sviluppare qua e per il quale rimando a Critica della teoria dei diritti, Milano, F. Angeli, 2018 e al più recente Cose e idee. Per un consolidamento della teoria delle fonti, in Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale, 1/2019). Come la Corte costituzionale ha intuito sin dalle primissime sentenze, nessun diritto nasce assoluto, ma ognuno deve essere bilanciato con diritti e interessi che si rivelano concorrenziali nel caso specifico. Il maximum standard può perciò essere creduto e predicato solo da chi vede soltanto uno dei diritti o interessi in gioco, e non gli altri: e questa non sembra poter essere un atteggiamento apprezzato in un giudice”.
3. La seconda domanda:
“L’avvento di strumenti sovranazionali con al centro i diritti fondamentali ha aggravato le responsabilità del giudice egli divenendo, per dirla con Paolo Grossi, “…il più autentico garante della crescita di un ordinamento giuridico”. Si sentirebbe di offrire al giudice dei suggerimenti minimi per affrontare nel modo migliore l’era del pos-moderno?”
Antonio Ruggeri: “Le notazioni appena svolte agevolano la risposta al quesito che ci è ora posto, con l’avvertenza che ricette pronte all’uso non credo che siano formulabili al piano teorico-astratto, come tali idonee a valere per ogni caso, pur nella estrema varietà dei connotati degli stessi, la complessità degli interessi che a ciascuno di essi fanno capo, la gravosità di impegno sollecitato al fine di darvi l’ottimale risoluzione.
Ferma restando, dunque, la necessità del concorso di tutti gli operatori, in spirito di feconda, reciproca collaborazione ed autentico servizio, per ciò che è richiesto al giudice comune a me pare che quest’ultimo si debba, in primo luogo, attrezzare culturalmente sì da poter esercitare al meglio il munus sullo stesso gravante. Di qui, l’apertura nei riguardi delle indicazioni che vengono da discipline non giuridiche, specie da quelle che nel modo più diretto ed immediato sono evocate in campo dal caso, come ad es. – per ciò che ha riguardo alla salvaguardia dei diritti eticamente e/o scientificamente sensibili – la bioetica e la medicina. Si richiede, inoltre, una conoscenza adeguata del diritto e della giurisprudenza non nazionali, a partire ovviamente da quelli che fanno capo all’Unione europea ed alla CEDU, ai quali d’altronde non per mero accidente è fatto esplicito richiamo nella domanda precedente.
Quanto detto fin qui, poi, rimanda a generali questioni, delle quali non siamo chiamati ad occuparci, concernenti le modalità del reclutamento e dell’aggiornamento costante nella formazione dei magistrati, nonché dei controlli – e qui il terreno si fa davvero minato – relativi alla permanente idoneità degli stessi all’esercizio delle funzioni. Ulteriormente risalendo, rimanda all’assetto degli studi universitari che precedono l’accesso ai ruoli dell’ordine giudiziario, nel corso dei quali ancora oggi si dedica uno spazio assai contenuto, palesemente insufficiente, all’approfondimento di temi e problemi riguardanti il diritto internazionale e sovranazionale, laddove non v’è praticamente ormai più disciplina giuridica (perlomeno di diritto positivo) che non richieda di essere declinata in chiave europea.
Mi limito, dunque, qui al solo cenno appena fatto ma mi permetto di suggerire uno specifico approfondimento delle questioni ora appena evocate, specie per ciò che concerne il raccordo – in atto totalmente inesistente – tra lo studio universitario, ad oggi svolto in regime di piena autonomia e nel chiuso della istituzione preposta ad impartirlo, e l’aggiornamento della formazione dei magistrati che ha luogo una volta che l’accesso nell’ordine giudiziario si sia ormai perfezionato.
Solo un suggerimento ancora, visto che ci viene sollecitato da chi ha pensato il quesito; ed è che occorre operare perché si radichi e diffonda in seno agli operatori di giustizia una mentalità ispirata, a un tempo, al senso del limite ed alla consapevolezza delle risorse di mente e di cuore di cui ciascun operatore può (e deve) essere dotato e che vanno fino in fondo portate a frutto.
L’uno porta naturalmente a tracciare la soglia ideale oltre la quale non è consentito spingersi. E così, solo per fare il primo esempio che viene in mente, occorre sempre attenersi al canone fondamentale per cui a mezzo della interpretazione non è possibile fare “tutto”, far dire cioè ai testi normativi (a partire, appunto, da quelli delle Carte) anche ciò che frontalmente si oppone alla loro lettera ed alla ratio in ciascuno di essi racchiusa. La “supplenza” nei riguardi del legislatore è, non poche volte, necessitata ma lo smarrimento della tipicità dei ruoli non è, in alcun caso o modo, tollerabile, per la elementare ragione che, venendo meno il principio della separazione dei poteri (pur se nella forma temperata conosciuta nel nostro come in altri ordinamenti), verrebbe fatalmente meno anche quella salvaguardia dei diritti fondamentali in funzione della quale la separazione stessa è stata storicamente pensata, facendo essa tutt’uno – secondo la mirabile espressione dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789 – con l’idea stessa di Costituzione.
Come mi sono sforzato di mettere in chiaro altrove, non di rado prende corpo nella pratica giuridica un autentico ossimoro: alcuni giudici – non importa se costituzionali (nell’accezione materiale dietro data) o comuni – al fine di dare garanzia ai diritti si fanno, innaturalmente, legislatori, non avvedendosi però del fatto che, in tal modo, si pongono le basi per lo smarrimento dello Stato costituzionale, nel figurino ideale consegnatoci dai rivoluzionari francesi al tramonto del diciottesimo secolo.
La tipicità dei ruoli va, poi, tenuta ferma non soltanto al piano dei rapporti tra i decisori politici e gli operatori di giustizia ma anche a quello di questi ultimi inter se. La manovra di “riaccentramento” risolutamente posta in essere dalla Consulta, alla quale facevo cenno nella risposta al quesito precedente, offre una testimonianza lampante, per tabulas, della erosione del campo riservato tanto alle Corti europee quanto – per ciò che qui più direttamente ci tocca – ai giudici comuni, con specifico riguardo all’obbligo di applicazione diretta sugli stessi gravante nei riguardi del diritto eurounitario, in ciascuna delle sue espressioni (anche, dunque, in quelle di cui si ha traccia nella Carta dell’Unione o in fonti a questa connesse). È anche vero, però, l’inverso; ed occorre con onestà d’intelletto chiedersi quante volte questo o quel giudice abbia ammantato delle candide vesti dell’interpretazione conforme una sostanziale manipolazione dei dati normativi, invece di investire – come si sarebbe dovuto – la Consulta di una questione di legittimità costituzionale.
Ancora una volta, però, occorre prestare attenzione a tutte le facce del fenomeno, non trascurando dunque quanto (ed è davvero molto) può e deve farsi attingendo alle formidabili risorse prestate dall’interpretazione in vista della ottimale risoluzione del caso, per complesso, impegnativo ed anche non poco sofferto che sia non di rado il suo raggiungimento. Un giudice che non abbia il coraggio di mettersi in gioco, anche – laddove necessario – esponendosi in prima persona, farebbe bene a cambiare mestiere.”
Roberto Bin: “Un unico suggerimento: non prestare fede a visioni distorte e ipersemplificate del panorama “multilivello” dei diritti. La nostra Costituzione è tale perché prodotto storico di una lotta politica che è approdata ad un compromesso, che nella pluralità e nella (pretesa) contraddittorietà dei diritti trova la sua sintesi: ed è attuata da un legislatore politico che esercita il suo potere in base alle regole democratiche poste dalla Costituzione stessa, e che quindi riscrive di continuo il punto di bilanciamento dei diritti. Altrettanto non si può dire né della CEDU né della Carta di Nizza. La prima nasce nel dopoguerra come patto tra le democrazie occidentali di non ricadere nel fascismo e non scivolare nel comunismo: ancora oggi la sua giurisprudenza dovrebbe servire a bloccare i vari Orban, Morawieck, Putin e Erdogan nella deriva autoritaria e antiliberale di cui sono protagonisti (compito che sta clamorosamente mancando); e invece si occupano di delicati bilanciamenti dei diritti dicendo se un albergo abusivo possa o meno essere legalmente abbattuto o quale trattamento pensionistico debba essere riconosciuto ad un lavoratore italiano che ha lavorato in Svizzera. Questo è un abuso, a me pare chiaro; e bene fa la Corte costituzionale a reagire ponendo limiti alla pretesa dei giudici italiani di preferire quella giurisprudenza alle leggi (e ai rimedi) offerte dal nostro ordinamento. Dietro alla Corte EDU non c’è un (vero) ordinamento politico e solo la distopia di alcuni “padri” del diritto internazionale (Verdross) ha potuto confondere la CEDU con una Costituzione. Quanto alla Carta di Nizza, essa fa parte dell’ordinamento della UE ed è interpretata dalla Corte di giustizia. Un’altra Costituzione? Neppure alla lontana. Che la Corte di giustizia sia – come spesso inconsapevolmente si dice – una “corte dei diritti” è falso: è una Corte che tutela (e espande di continuo) l’ordinamento UE e in particolare la disciplina del mercato e le sue “quattro libertà”. Oggi, in particolare, è una Corte che tutela l’ordine liberistico– quindi, ideologico - del mercato: metterla sullo stesso piano della nostra Corte costituzionale offende la nostra Costituzione e la sua storia.
Ecco allora il mio suggerimento. Non confondere le cose, liberarsi da schemi banali e sbagliati che impilano le “carte dei diritti” come se fossero la stessa cosa e capire che l’ordinamento italiano, la CEDU, la UE sono ordinamenti diversi, di cui quello italiano ha fini (e valori) davvero generali, mentre gli altri due hanno fini (e valori) particolari e specializzati”.
4. La terza domanda:
“Una delle accuse che si rivolge al giudice “garante della legalità” è quella di avere contribuito ad erodere i canoni di prevedibilità e certezza incarnati dal legislatore, divenendo egli stesso artefice primo del diritto e favorendo, non solo nuova litigiosità ma anche scelte contromaggioritarie, in nome dei diritti fondamentali. Esistono dei rimedi di agevole portata che, a suo giudizio, possono evitare o attenuare tali rischi? Ed ancora, i momenti di raccordo fra giudici nazionali e giudici sovranazionali(rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiesta di parere preventivo alla Corte Edu, quando sarà entrato in vigore per l’Italia il Protocollo n.16 annesso alla CEDU) possono offrire un antidoto all’incertezza e se sì in che misura?”
Antonio Ruggeri: “Sulla certezza del diritto occorre, una buona volta, intendersi, dissipando alcuni equivoci ricorrenti. Il terreno sul quale va ricercata, coltivata, preservata è, invero, oggettivamente scivoloso, e sempre incombente è dunque il rischio ora di sottostimarla ora di seguitare stancamente a riprodurre, a mo’ di slogan, una sua antica e tuttavia ricorrente idea esasperata, mitica o sacrale. Nessuno, ovviamente, dubita che la certezza sia una risorsa preziosa di cui l’ordinamento e la pratica giuridica non possono fare comunque a meno ma va, appunto, vista ed apprezzata nella giusta dimensione.
Desidero qui, prima di affrontare il cuore del problema evocato nel duplice quesito postoci, tornare a fare alcune avvertenze, già altrove rappresentate, che a mia opinione meritano di essere tenute adeguatamente in conto.
La prima è che non è affatto scontato che la certezza del diritto si accompagni sempre e comunque al disporre in via generale ed astratta che è attributo – secondo certa tradizione teorica – considerato proprio delle leggi.
In disparte, infatti, la circostanza per cui siffatti connotati non sono sempre presenti e che, peraltro, si dimostrano essere alle volte di assai incerto riscontro, non si trascuri il fatto che non di rado la opacità del linguaggio delle leggi e le loro complessive carenze risultano foriere di gravi incertezze, le quali poi non risparmiano neppure la Carta costituzionale, tanto più laddove sia fatta oggetto di revisioni segnate da vistose oscillazioni semantiche e persino da veri e propri sbandamenti concettuali. Se ne ha che sono proprio i giudici – quelli comuni come pure il giudice costituzionale – a trovarsi obbligati ad una faticosa opera di ricucitura interna in funzione di quella certezza del diritto dapprima insufficiente o, addirittura, del tutto assente. È pur vero, però, che il raggiungimento di questo risultato passa non poche volte attraverso quella sostanziale riscrittura dei testi per il cui tramite si concreta quella confusione dei ruoli istituzionali cui si faceva poc’anzi cenno.
Suona quasi paradossale dover ammettere che la scrittura costituzionale, storicamente pensata come strumentale alla salvaguardia della certezza del diritto costituzionale e, a un tempo, della certezza dei diritti costituzionali, per conquistare le quali l’Europa è stata infiammata a cavallo tra fine settecento e primo ottocento dalla lotta per la Costituzione, può a conti fatti convertirsi talora, per una singolare eterogenesi del fine, nel suo opposto, in fonte cioè di gravi e perniciose incertezze, sì da far rimpiangere un sano diritto costituzionale non scritto, quale peraltro affermatosi – come si sa – per via consuetudinaria nella patria del parlamentarismo liberale, la Gran Bretagna (le cui vicende istituzionali, nondimeno, sono state – come si sa – scandite dal varo di importanti documenti scritti, a partire dalla Magna Charta Libertatum).
Sta di fatto che è proprio grazie alla certosina ed encomiabile opera dei pratici (e, segnatamente, dei giudici) che si riesce – fin dove possibile – a restituire certezze ad una Carta costituzionale che, specie nella forma acquisita attraverso le novelle cui è andata soggetta, appare afflitta da strutturali, non rimosse carenze di linguaggio.
La seconda avvertenza si richiama proprio a quella idea di Costituzione che ho poc’anzi rammentato, rifacendomi alla lapidaria, efficacissima formula dell’art. 16 della Dichiarazione del 1789; ed è che nessuna certezza del diritto (sub specie del diritto costituzionale) ha, a mio modo di vedere, alcun senso laddove non sia in grado di convertirsi ed interamente risolversi nella certezza dei diritti costituzionali, vale a dire nella effettività della loro tutela, la massima consentita dalle condizioni oggettive di contesto. Se ne ha, d’altronde, conferma da alcune recenti esperienze venute a maturazione sul terreno in cui si svolge il “dialogo” intergiurisprudenziale, com’è usualmente e sia pure con una non rimossa ipoteca teorica chiamato; ciò che, nondimeno, non giustifica – a me pare – il severo giudizio di un’accreditata dottrina (R. Bin) che lo ha da ultimo qualificato come una “chimera” o una “pietosa finzione”, sol che si pensi ai benefici che sono venuti ai diritti proprio grazie allo sforzo poderoso prodotto dai giudici, anche quando questi ultimi si sono fatti (e si fanno) portatori di indirizzi divergenti, secondo quanto peraltro preciserò meglio sul finire di questa mia esposizione.
Ebbene, si pensi, ad es., al possibile superamento del giudicato (un altro dei miti giuridici bisognosi di un complessivo ripensamento nel presente contesto segnato da una integrazione sovranazionale avanzata): una delle più efficaci “invenzioni” del pensiero giuridico al servizio della certezza del diritto (in senso oggettivo) può trovarsi, dunque, costretta a ripiegare a fronte del bisogno di assicurare adeguata tutela alla certezza dei diritti costituzionali non salvaguardati nel processo.
La terza avvertenza rimanda al principio (o, per dir meglio, al “metaprincipio”) della massimizzazione della tutela dei diritti fondamentali, alla cui luce vanno condotte le operazioni di ponderazione, assiologicamente connotate, dei beni costituzionalmente protetti. La giurisprudenza costituzionale vi ha fatto – come si sa – ripetutamente riferimento, specie con riguardo al rilievo da assegnare alla CEDU in ambito interno (un cenno c’è già nella prima delle famose sentenze “gemelle” del 2007 e, quindi, in modo ancora più esplicito ed incisivo nella sent. n. 317 del 2009 e in altre ancora, nelle quali nondimeno perdurano talune gravi aporie di costruzione teorica ad oggi non rimosse: ad es., in Corte cost. n. 25 del 2019 troviamo riconosciuta l’attitudine della CEDU ad offrire una tutela più ampia di quella discendente dalla stessa Carta costituzionale, della quale ultima tuttavia si riconferma il “predominio assiologico” sulla prima; ed è da chiedersi come le due affermazioni possano stare assieme).
Ora, questo principio, in realtà, possiede, a mia opinione, generale valenza, ponendosi quale la più emblematica e probante testimonianza di un generale modo di essere e di rinnovarsi dell’ordinamento e di una sua parimenti generale rappresentazione teorica, assiologicamente ispirata e valevole anche nelle sue proiezioni al piano delle relazioni interordinamentali.
E infatti. Non v’è solo la CEDU a doversi (ed a volersi: art. 53) fare da canto all’incontro o allo scontro con norma interna idonea ad innalzare il livello della tutela dei diritti in campo ma ogni norma da qualunque fonte (interna o esterna) prodotta, sempre che appunto a giudizio (ed a responsabilità) dell’operatore di turno ciò sia imposto dal bisogno di far sì che la Costituzione possa affermarsi magis ut valeat, anche nel suo fare “sistema” integrandosi con le altre Carte nei fatti interpretativi.
La partita, in realtà, si apre a tutto campo, ad ogni possibile esito.
Giusta, infatti, la premessa per cui le Carte possono dare una tutela “graduata” ai diritti in gioco, non può escludersi, se non per un assiomatico convincimento, che la CEDU o altro documento normativo “tipicamente costituzionale” possa dare una tutela ancora più adeguata di quella offerta dalle leggi nazionali e persino – perché no? – della stessa Costituzione. È solo in forza di un autentico crampo mentale – se posso esprimermi con linguaggio franco –, ovverosia per un malinteso nazionalismo costituzionale (non meno pernicioso del nazionalismo tout court…), che può assumersi essere in ogni caso maggiormente attrezzata culturalmente e positivamente la Costituzione rispetto alle altre Carte al fine di poter rendere un servizio adeguato ai beni della vita dei quali si reclama di volta in volta tutela.
Dobbiamo scoprire le carte sul tavolo: perché escludere assiomaticamente che possa darsi un orientamento giurisprudenziale, maturato extra moenia e che dà voce ad una Carta dei diritti diversa dalla Costituzione, idoneo a dare ai beni stessi una protezione ancora più efficace di quella che è ad essi assicurata da orientamenti venuti a formazione entro i confini nazionali e per mano di qualunque giudice (costituzionale e non)?
Questo discorso, portato fino ai suoi ultimi e conseguenti svolgimenti, conduce ad un esito che riconosco essere difficilmente accettabile o, diciamo pure, digeribile, quanto meno a tener ferme alcune antiche e consolidate credenze, vale a dire che nessuna fonte del diritto – Costituzione inclusa – è incondizionatamente prescrittiva, piuttosto valendo, sullo specifico terreno sul quale maturano le esperienze relative ai diritti, sub condicione, sempre che cioè appaia agli occhi dell’operatore di turno in grado di far conseguire la sintesi ottimale dei valori fondamentali evocati in campo dal caso, nel loro fare appunto “sistema”. Eppure, come si diceva, a quest’esito non è possibile comunque sottrarsi se si ha a cuore il bisogno di assicurare l’ottimale realizzazione dei valori stessi, in ispecie della coppia assiologica fondamentale – come a me piace chiamarla – costituita dai valori transepocali di libertà ed eguaglianza e, in ultima istanza, dignità della persona umana. E non è inopportuno qui nuovamente precisare che, alle volte, proprio umiliandosi e rendendosi disponibile ad accogliere nel proprio seno le indicazioni che vengono ab extra (da altre Carte e Corti), la Costituzione si esalta ed afferma al meglio di sé, della coppia suddetta e della radice da cui essa si tiene ed alimenta, la dignità.
Tutto ciò posto e nella consapevolezza che ogni criterio di natura assiologico-sostanziale si espone, per sua natura, a rischi non lievi al momento e per le finalità dell’applicazione, occorre – come si diceva poc’anzi – sfruttare fino in fondo le risorse disponibili al fine di parare il rischio della deriva soggettivistica.
Vengo così al cuore del quesito prospettatoci, specie nella sua parte terminale. I rimedi al riguardo apprestati non fanno invero difetto; si tratta solo di metterli in atto a modo nella pratica giuridica di ogni giorno.
Da tempo sono convinto (e vado anzi sempre di più radicandomi nel convincimento) che, per effetto del “dialogo” intergiurisprudenziale (specie, ma non solo, laddove veicolato dal rinvio pregiudiziale o, un domani, dallo strumento di collaborazione previsto dal prot. 16), possano alla lunga realizzarsi convergenze, più ancora che divergenze, di vedute e, con esse, consolidarsi orientamenti espressivi di consuetudini culturali – come a me piace chiamarle –, della cui formazione si rendano artefici tutti gli operatori di giustizia, in fatto di riconoscimento e tutela dei diritti fondamentali.
Sia chiaro. “Dialogare” non equivale – è persino superfluo dover qui rammentare – a pensarla allo stesso modo, meno che mai a pensarla secondo stereotipi astrattamente prefissati e resi insensibili al pulsare dei bisogni maggiormente avvertiti in seno al corpo sociale, nei quali si rispecchino i valori fondamentali dell’ordinamento, specie quei valori di libertà eguaglianza dignità che – volutamente – rappresento qui non separati da virgola, proprio perché in realtà inseparabili e bisognosi di darsi costante e mutuo sostegno. E, però, il comunicare a vicenda senza preconcetto alcuno, ideologico o di dottrina, agevola – come dicevo – la ricerca dei punti d’incontro, di mediazione, di reciproca e soddisfacente affermazione, di cui soprattutto nel presente contesto segnato da plurime e soffocanti emergenze si ha davvero vitale necessità.
La certezza del diritto e dei diritti assieme si fa proprio così: si costruisce passo dopo passo e giorno dopo giorno, attraverso uno sforzo collettivo e non di rado sofferto ma, allo stesso tempo, esaltante perché prodotto nella consapevolezza di rendere un servizio all’uomo, ai suoi più avvertiti bisogni, alla sua sete di giustizia.”
Roberto Bin: “Ho evidentemente un concetto diverso di legalità, che per me coincide con “i canoni di prevedibilità e certezza incarnati dal legislatore” (e, aggiungerei, legislatore democratico, anche se di questi tempi ne abbiamo perso la percezione): se il giudice vuole essere artefice di promozione di avanzamento dei diritti lo deve fare nell’ambito della Costituzione, che infatti si presta ad essere impiegata in senso contro-maggioritario. Ma le vie sono quelle offerte – appunto – dalla Costituzione e sono costituite essenzialmente dal ricorso alla Corte costituzionale. Non escludo ovviamente che il giudice debba usare il ricorso pregiudiziale alla Corte di giustizia, né che possa estendere l’interpretazione di un diritto ispirandosi alla giurisprudenza EDU: non dimenticando però le diverse coordinate politiche e culturali in cui quelle giurisdizioni operano e di come la loro applicazione in Italia lasci scoperto il fianco “sociale” della Costituzione.
Ho sempre avvertito una certa distanza dall’“uso alternativo del diritto” che era di moda anni fa. Al contrario di allora, l’analoga ideologia della funzione giurisdizionale oggi sembra operare in senso opposto, premiare una visione liberale e liberista dei diritti, dimenticandone la componente sociale e la tutela del lavoratore. D’altra parte, come dicevo, quello è l’orizzonte delle due corti internazionali, rispetto alle quali non mi sembra che la giurisprudenza che pretende di muoversi “in nome dei diritti fondamentali” pratichi sentieri anticonformisti. Non ho visto – ma può essere che mi sbagli – tentativi di superare la giurisprudenza iperlibertista dalla Corte di giustizia cercando di migliorare la tutela del lavoro e dei lavoratori (che non sia quelli trasfrontalieri, naturalmente). Infatti, non mi pare che la giurisprudenza abbia escogitato strategie per provocare la Corte di giustizia ad applicare i suoi stessi precedenti in chiave anti-liberista: possibile, per esempio, che il principio “chi inquina paga”, così brillantemente elaborato e difeso dalla Corte di Lussemburgo, non sia mai stato invocato contro gli imprenditori che, usando la loro libertà di stabilimento consacrata dai Trattati e dalla Corte, delocalizzano la loro impresa e lasciano dietro di sé non solo macerie sociali, ma anche siti da loro pesantemente inquinati, che saranno gli enti pubblici a dover risanare ponendo gli oneri a carico della società? Perché le leggi, a partire da quella fallimentare, non inseriscono al primo posto i debiti “ambientali” nei confronti della collettività? Bella domanda da porre alla Corte di giustizia.Questo – a mio modo di vedere – non sarebbe altro che riaffermare la legalità, cioè applicare principi e regole positivamente poste dal legislatore (europeo, in questo caso) a casi concreti che palesemente ricadono nel loro ambito di applicazione. Sarebbe quindi un modo per rafforzare la legalità, almeno per come la vedo io.