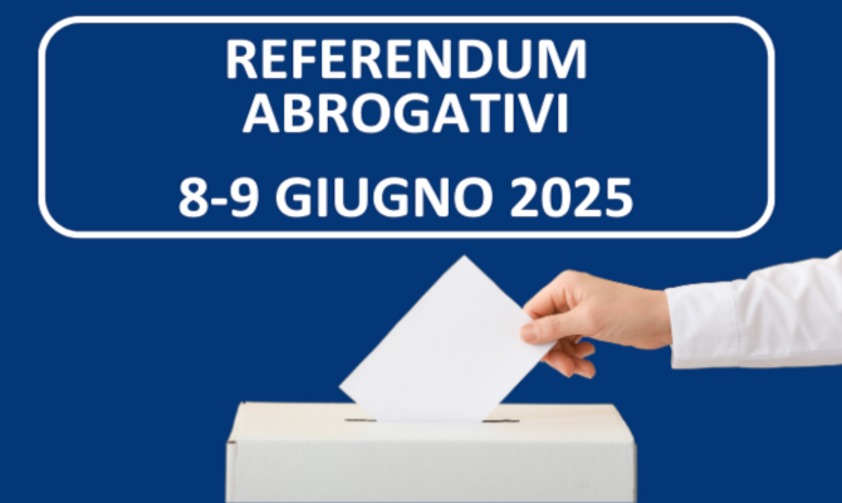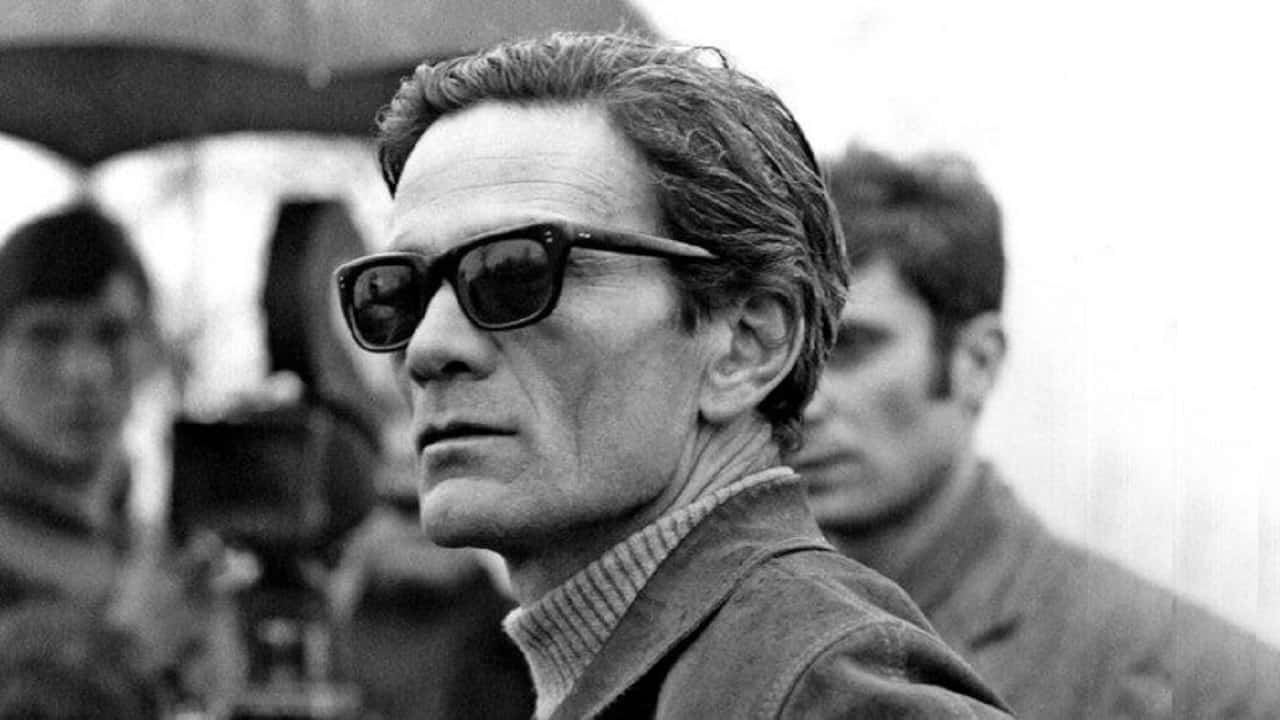
La nonviolenza: mi sembra una nozione stupenda. Essa è estremamente aristocratica (Gandhi, Russel …, Dostojevski …): d’origine preevangelica (orientale), come gran parte delle nozioni evangeliche, si è cristianizzata sopratutto col romanticismo nell’Ottocento, e ora si è scristianizzata, facendosi fieramente laica. Ma, si è visto nelle “Marce della Pace” di questa estate, tale sua fondamentale aristocraticità è facilmente accepibile dalle masse coscienti: non c’è contraddizione tra la sua elezione e la sua popolarità. Per questo, quelle “Marce della Pace” sono state il fenomeno politico italiano più interessante dell’anno. Una specie di riproposta, modernissima, del CLN. In esse era inclusa la svolta del XXII Congresso e la possibilità “reale” di un centro-sinistra.
La nonviolenza è l’acme ideale di una concezione razionale della realtà. Se ogni forma del pensiero ha bisogno, nell’atto pratico, di una manifestazione concreta e basata quindi sul sentimento e la persuasione, la nonviolenza è l’atteggiamento sentimentale e persuasivo di chi è totalmente fuori da ogni conformismo, di chi si è totalmente “liberato” attraverso gli strumenti della ragione e della cultura.
Pier Paolo Pasolini (Vie Nuove, 4 gennaio 1962)
Pier Paolo Pasolini e il Diritto
Il 5 marzo 2022 ricorrono 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (Casarsa, 5 marzo 1922 – Roma, 2 novembre 1975), intellettuale fra i più eclettici e discussi del ‘900. Poeta, scrittore, editorialista, traduttore, critico letterario, regista e drammaturgo, Pasolini ha sfidato i canoni tanto della tradizione che dell’avanguardia artistica, superando i confini fra generi letterari e fra vita privata e opera d’arte.
In un’Italia alle prese col boom economico e il passaggio alla postmodernità, Pasolini è stato uno dei più attenti osservatori e interpreti dei mutamenti sociali, politici, culturali ed economici del suo tempo. Sicché l’iter politico e culturale pasoliniano diviene paradigmatico di questa trasformazione non solo socio-economica, ma altresì antropologica, come Pasolini stesso ha intuito evocando «la scomparsa delle lucciole» in riferimento all’Italia della metà degli anni Sessanta dello scorso secolo (Il vuoto di potere in Italia, in “Corriere della Sera”, 1° febbraio 1975), distratta da una «violenta omologazione dell’industrializzazione».
A fronte dello svuotamento di potere della politica tradizionale dell’Italia del secondo dopoguerra, Pasolini ha sottolineato l’emergere di quel che definisce con sempre più convinzione il «nuovo fascismo» del consumo di massa, cifra delle società tardo-capitaliste. Una spinta centripeta si sostanzia così, secondo l’intellettuale, nella creazione di modelli omologanti elaborati dalla società del consumo, volti a ricondurre tutto ciò che è marginale e periferico verso un “nucleo” totalizzante che fornisce la base politica e culturale attraverso la quale avviene la neutralizzazione dell’originalità e delle differenze che hanno caratterizzato da sempre le culture provinciali e i dialetti (tanto cari al poeta), le borgate, le periferie. Il consumismo ha così finito per uniformare culturalmente l’Italia: si tratta perciò di una omologazione oppressiva, una completa borghesizzazione che conduce ad un vero e proprio genocidio culturale delle classi sociali subalterne e delle culture “altre”.
Contro questo nuovo ed egemonico sistema di valori l’impegno militante e politico di Pasolini è costante e irriverente, e lo scontro con il senso comune dell’uomo medio appare inevitabile, lasciando un segno tangibile nelle vicende giudiziarie dell’intellettuale.
Almeno due, pertanto, le prospettive che animano i diversi contributi che Giustizia Insieme si appresta a pubblicare in questo speciale “Pasolini e il Diritto”, per celebrare il centenario dalla nascita dello scrittore friulano.
Da una parte ci si interrogherà sul rapporto, non certo facile, dell’Autore con la macchina della giustizia italiana. Come ha avuto modo di sottolineare Stefano Rodotà (Il processo. In memoria di Pier Paolo Pasolini, oggi in La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 267 ss.), infatti, non si esagera se si afferma che Pasolini è stato l’intellettuale più processato di tutta l’Italia repubblicana: gran parte della sua produzione artistica è finita sotto la lente giudiziaria in processi in cui il ruolo della magistratura è stato spesso ideologico e personalistico. Ripensando alla vicenda giudiziaria di Pier Paolo Pasolini, invero, gli interrogativi si moltiplicano: quell’unico grande e continuo processo all’opera di Pasolini rappresenta la rottura delle convenzioni giudiziarie tradizionali. L’accertamento della verità pare cedere il passo alla violenza giudiziaria di una magistratura che si ostina a valutare con la prospettiva, omologante e conformista, dell’uomo medio. Pasolini, autore e regista, rimane per anni sotto la lente della giustizia: obiettivo è quello di “ridimensionare” un artista scomodo e scandaloso. Ma chi esce realmente vincitore da questa lotta? Chi, davvero, perde?
In un’altra prospettiva, infatti, il rapporto con la giustizia italiana ha accelerato fattivamente un’evoluzione del diritto e del costume sociale italiano, contribuendo a dare attuazione al pluralismo valoriale, al principio di laicità ed alle libertà inscritti nella Costituzione, che per troppo tempo erano rimasti lettera morta. In questo senso, invero, Pasolini ha costretto i giudici a ripensare e dare nuova linfa al “decoro”, al “buon costume”, all’“ordine pubblico” e, in definitiva, alla “dignità”, andando ben oltre il modello antropologico di uomo medio che ha conformato il diritto e la società borghese nella modernità.
Le due prospettive, quindi, ricalcano un po’ la dicotomia debito/credito che ha nel tempo hanno caratterizzato il rapporto fra il Diritto e l’intellettuale Pasolini: da un lato, infatti, il Diritto è oggi in credito con Pasolini in termini di valorizzazione delle differenze, delle identità, della laicità e delle libertà fondamentali; dall’altro il Diritto rimane in debito per la strumentalizzazione processuale fatta dell’opera di Pasolini, prima, e dell’incapacità di far chiarezza sulla sua morte, dopo.
I saggi, le interviste, le considerazioni che in queste prospettive intendono omaggiare Pier Paolo Pasolini, l’uomo e l’intellettuale, sono allora un’occasione di riflessione sul ruolo del diritto e dei suoi meccanismi performativi e “normalizzanti”.
Per tracciare un quadro completo e complesso di Pasolini verranno proposte alcune interviste, utili a meglio focalizzare il rapporto fra l’intellettuale e il suo tempo.
Con questo obiettivo Andrea Apollonio intervisterà Roberto Chiesi, critico cinematografico e responsabile del Centro Studi Pier Paolo Pasolini e Dacia Maraini, scrittrice, intellettuale ed amica di Pasolini, autrice del recente libro “Caro Pier Paolo” (Neri Pozza, Milano, 2022).
Un primo ritratto di Pasolini ci è fornito da Umberto Apice, di cui pubblichiamo in anteprima un paragrafo del capitolo del libro "Una Musa per Temi. Diritto e processi in letteratura" dedicato al poeta friulano, Una vita piena di letteratura e processi: Pier Paolo Pasolini.
In occasione della celebrazione del 25 aprile Pierpaolo Gori, nel contributo Pasolini, l’invasore e la resistenza, illustra la riflessione sulla resistenza del poeta di Casarsa, contenuta nella sua unica tragedia, I turcs tal Friùl.
Il saggio di Luca Peloso, Lo sguardo sospeso. Aporìe pasoliniane tra normatività sociale e pratiche singolari, intende poi mettere in luce come quello fra Pasolini e l’universo del diritto sia stato un rapporto contraddittorio e non risolto.
L’iter che tracceremo del rapporto fra Pasolini e il Diritto prende le mosse dall'inchiesta sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, sulla quale rifletterà Michela Petrini. Al processo a Pino Pelosi, invece, è dedicato il contributo di Giovanni Landi, Processo alla vittima: l’omicidio Pasolini.
Sui processi alla produzione artistica di Pasolini, a seguire, sono dedicati i contributi di Andrea Apollonio, Il processo a Pasolini difeso dal “fascista” Alfredo De Marsico, che evidenzia l’importanza storico-giuridica del processo a “I racconti di Canterbury”, ove l’intellettuale comunista è difeso da uno dei giuristi di spicco del regime fascista, che aveva in parte collaborato ai lavori preparatori di quello stesso codice penale su cui si chiedeva la condanna di Pasolini per oscenità delle sue opere; e di Maurizio Di Masi, Pasolini e il diritto di scandalizzare l’uomo medio, che traccia un parallelismo fra l’accanimento giudiziario contro l’autore e l’opera dello stesso Pasolini, da una parte, e l’attuale rapporto fra diritto, libertà e violenza, dall’altra.
Luigi Cavallaro, poi, nelle riflessioni su Pasolini e Sciascia, metterà a confronto i due intellettuali e la loro visione critica della società, della giustizia e della verità.
Maria Federica Moscati, a seguire, contribuirà con alcune riflessioni su “Infanzia e adolescenza nell'opera di Pasolini e comparazione con il diritto”.
Il rapporto fra potere ed omologazione, peraltro, passa nelle opere letterarie e cinematografiche di Pasolini per la fisicità dei corpi e la sessualità: a ciò sarà dedicato il saggio di Mauro Balestrieri, Corpo Pasolini. Legge e desiderio nella vita del libertino.
Nella prospettiva giusfilosofica, successivamente, Mariavittoria Catanzariti si soffermerà sulla mercificazione delle identità apportata dalle nuove tecnologie informatiche, con nessi sul potere pseudo-emancipativo del progresso, tema caro a Pier Paolo Pasolini, mentre Francesco Messina rifletterà sulla “Conoscenza della realtà, domanda di sacro e memoria in Pier Paolo Pasolini”.
Barbara Castaldo, infine, nel saggio Alcune riflessioni intorno al concetto di legge nell’opera di Pier Paolo Pasolini, fornirà una lettura conclusiva, che permetterà di sciogliere i nodi del rapporto fra legge e pensiero critico di Pasolini.
Sino a novembre, peraltro, questo itinerario sarà aggiornato ed arricchito con i contributi di altri studiosi e studiose, che completeranno il percorso che Giustizia Insieme intende qui intraprendere per riscoprire i molteplici volti di Pasolini.
Un ringraziamento convinto, per concludere, va al gruppo di ricerca “Visioni del giuridico”, che ha messo al servizio della Rivista e dei lettori l’esperienza acquisita in occasione del convegno organizzato dall’Università di Perugia nell’anno 2015 dedicato a Pasolini e il diritto, così come a tutti le Autrici e gli Autori che hanno voluto e potuto condividere con noi questo insolito, ma speriamo stimolante, itinerario giuridico.
Buona lettura!
La redazione






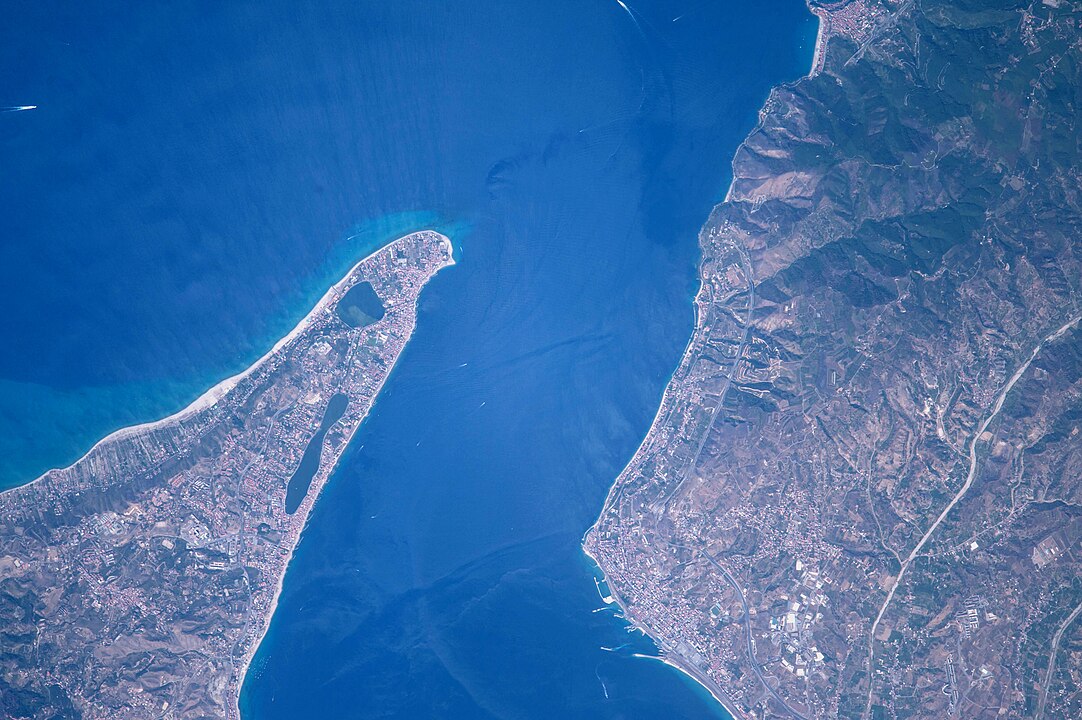
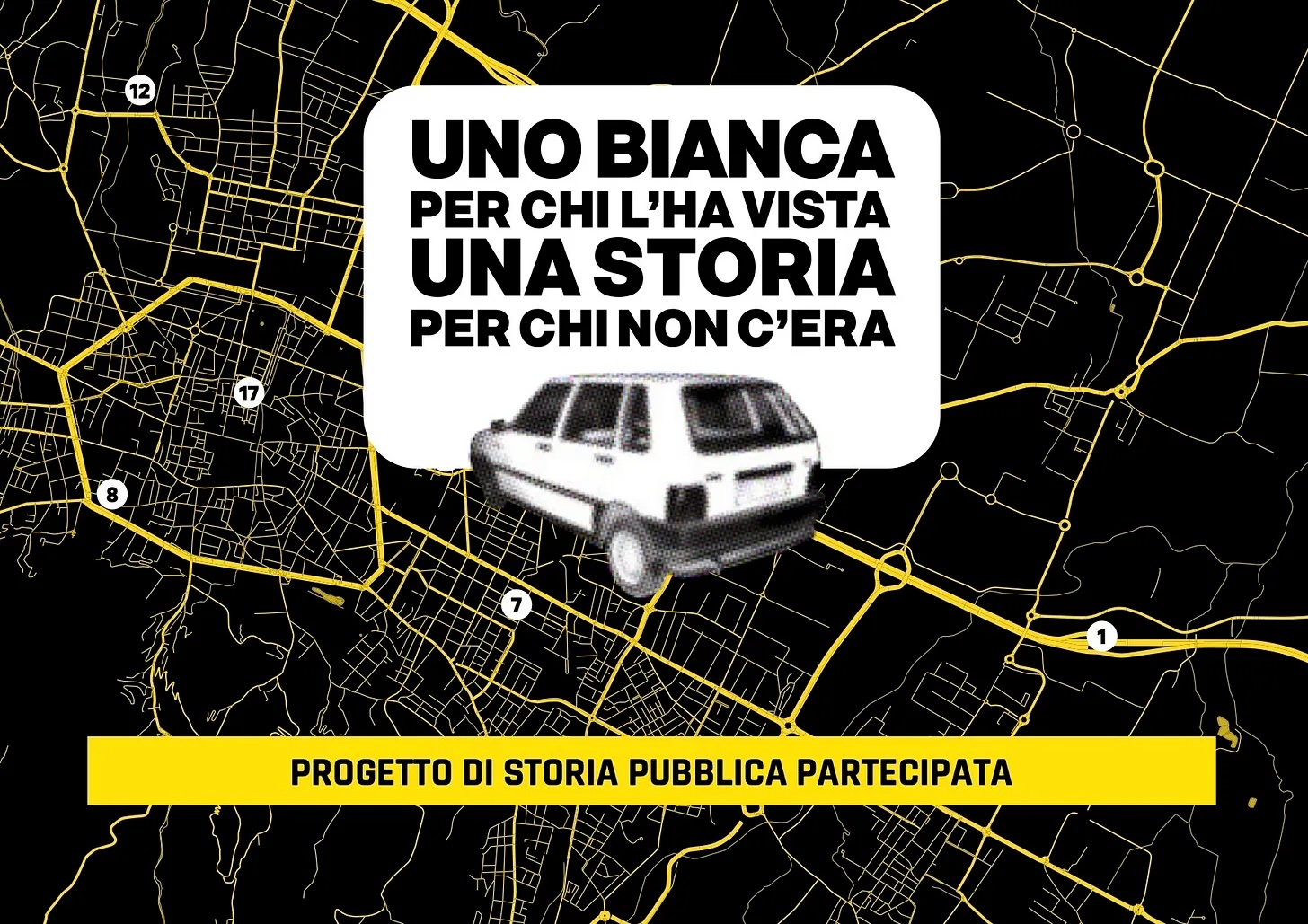


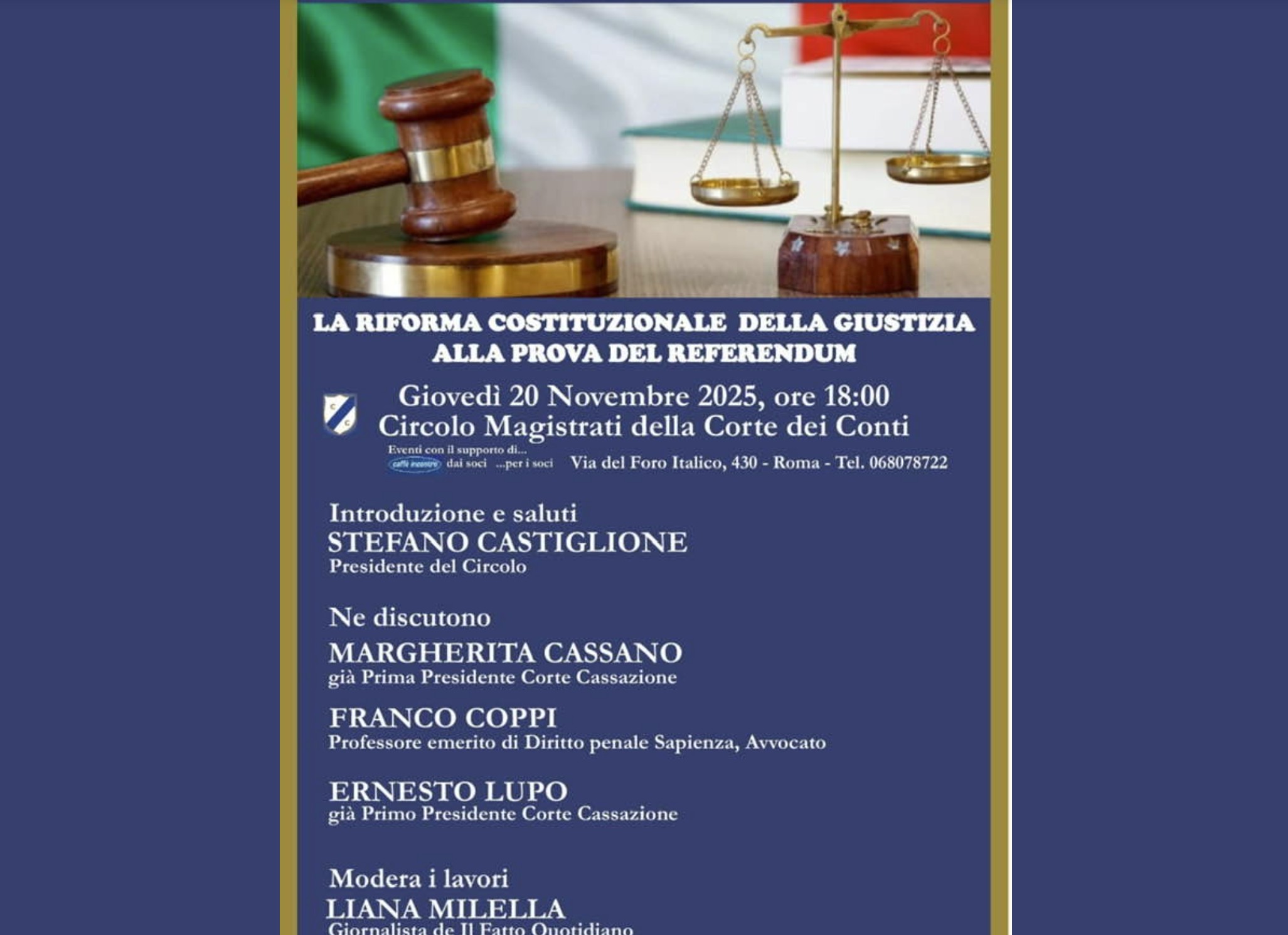





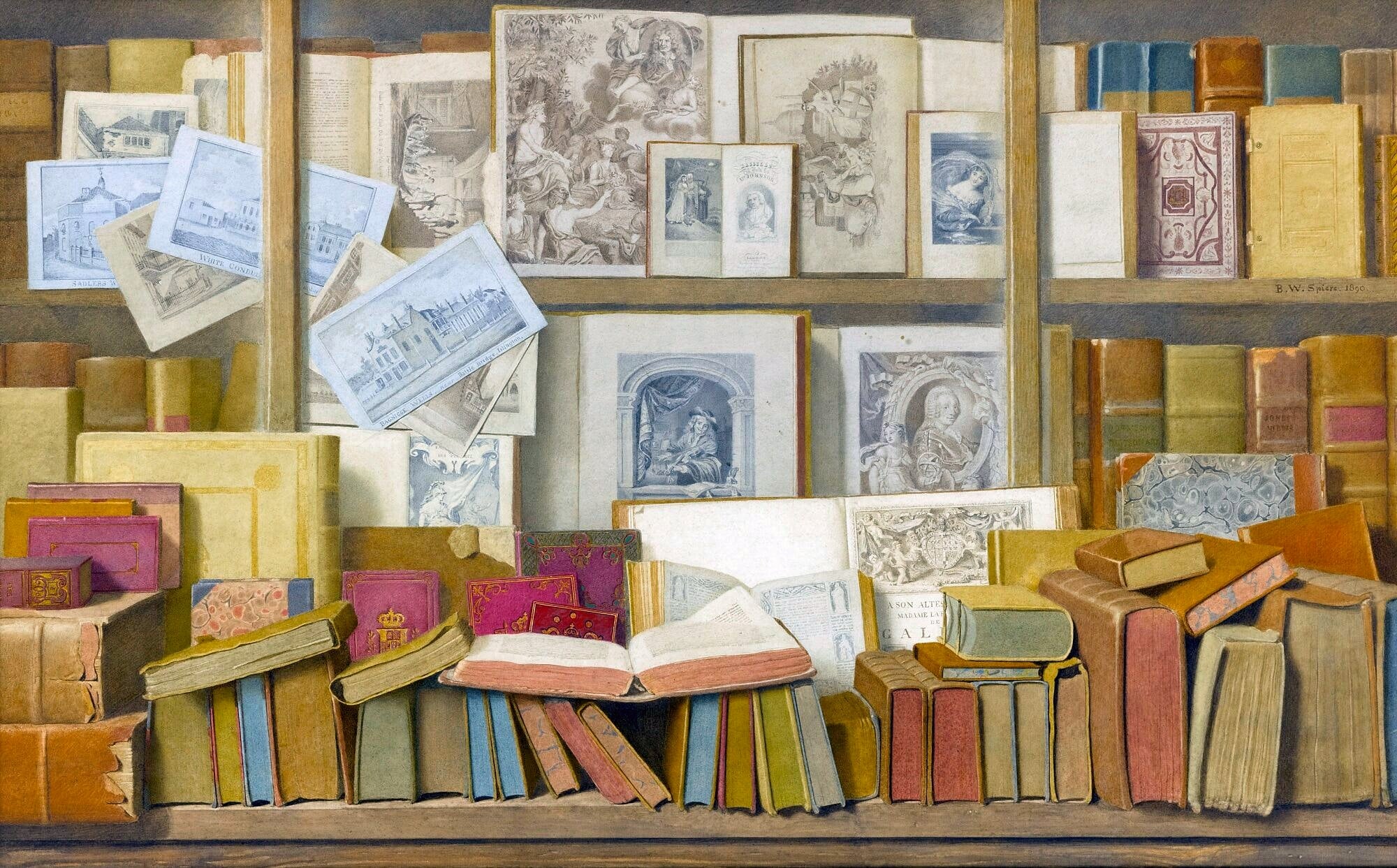



![La Corte di giustizia sulla nozione di “paese sicuro” e l’esclusione di particolari categorie soggettive- Corte giust, 1 agosto 2025, Cause riunite C‑758/24 [Alace] e C‑759/24 [Canpelli]](/foto/3586.jpeg)