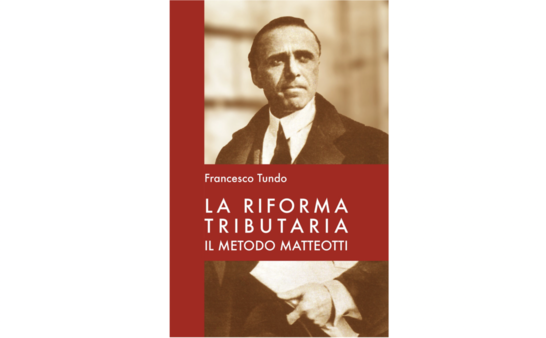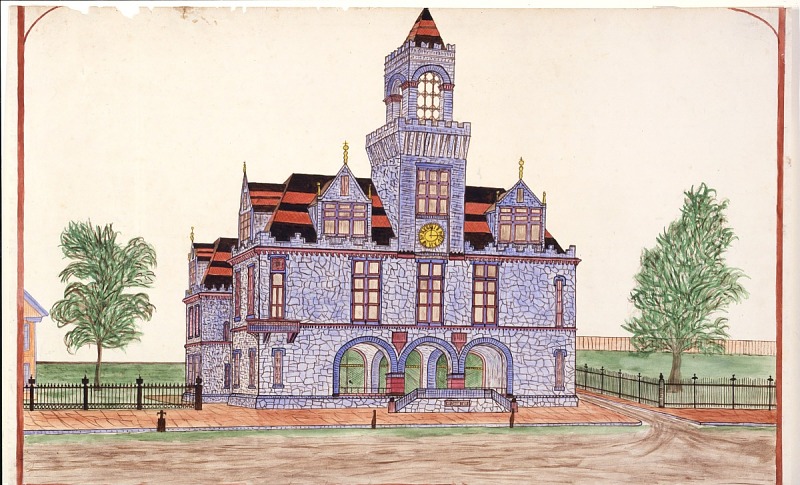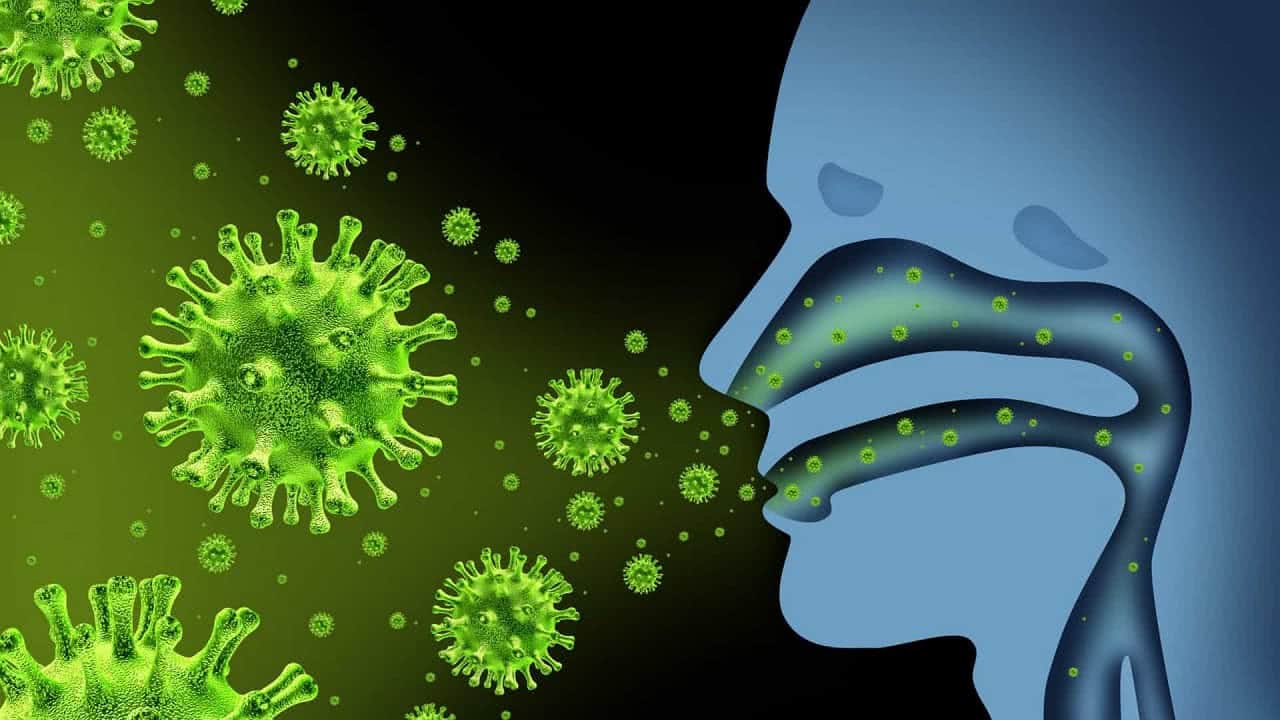Io non perdono e non dimentico, ma non odio (L.Segre)
Riflessioni di Giuseppe Savagnone - Odio, perdono, memoria e verità - e Tommaso Manzon - Quale diritto? Quale giustizia? -
Liliana Segre, nel corso di una conversazione con gli studienti - l'ultima, per sua scelta, il 9 ottobre 2020 nella Cittadella della Pace di Arezzo, sede dell’organizzazione internazionale impegnata nella trasformazione creativa dei conflitti - è tornata su argomenti già in passato affrontati, ribadendo che rispetto allo sterminio nazista ha ritenuto di non dovere e potere perdonare il male altrui, in nome di un dovere di ricordare che andava unito al dovere, non meno cogente, di non odiare.
Il tema del perdono rispetto al crimine contro l'umanità più doloroso che il pensiero umano ricordi è risalente e già Primo Levi e Simon Wiesenthal, più volte, non mancarono di offrire una chiave di lettura sostanzialmente simile a quella espressa da Liliana Segre.
Giustizia insieme ha voluto riportare la riflessione su questo punto, riconoscendo che il contenuto di quella presa di posizione stimola in chi vi si accosta nuovi interrogativi. Alcuni immediatamente legati alla prospettiva religiosa che, in un Paese a larga maggioranza cattolica, istintivamente sembra rendere quella posizione distonica rispetto ad uno dei valori portanti del cristianesimo; altri ancora più difficili da sciogliere se si cerca di andare al fondo del significato di quella scelta.
Questi temi, che chiamano in causa questioni di grande complessità - odio, memoria, verità (e post-verità), perdono, ma anche dignità nella sua poliedrica accezione - sono stati proposti a due studiosi, l'uno di formazione evangelica- Tommaso Manzon-, l'altro di estrazione cattolica -Giuseppe Savagnone- che hanno offerto prospettive ed approfondimenti assai stimolanti.
Odio, perdono, memoria e verità
di Giuseppe Savagnone
Sommario: 1. Perdono e non perdono nella prospettiva ebraica - 2. Odio e perdono - 3. Perdono e memoria - 4. Memoria e verità.
1. Perdono e non perdono nella prospettiva ebraica
Le parole di Liliana Segre - «Io non perdono e non dimentico, ma non odio» - nel suo intervento alla conferenza «Science for peace», organizzata all’Università Bocconi di Milano nel novembre del 2019, poi riproposte nell'incontro del 9 ottobre 2020 nella Cittadella della Pace– possono essere lette da diversi punti di vista.
Sicuramente significativo può essere considerare questa affermazione alla luce della concezione ebraica del perdono, per certi versi affine, per altri diversa rispetto a quella del cristianesimo. Scrive a questo proposito Ariel Di Porto, rabbino capo della comunità ebraica di Torino: «All’interno della concezione del perdono ebraica è possibile individuare tre elementi distintivi, che la differenziano da quella cristiana – secondo la quale non è indispensabile che chi ha offeso si penta e prescinde dalla gravità della colpa – : l’obbligo di perdonare è sottoposto al pentimento e alla richiesta di persona da parte di chi ha compiuto l’offesa; non tutte le colpe possono essere perdonate; non è possibile perdonare a nome di qualcun altro» [1].
La prima condizione è imprescindibile. Il rabbino Riccardo Di Segni, in una intervista su questo tema, sottolinea che, nella prospettiva ebraica, il perdono «si ottiene con la richiesta di perdono da parte della persona che ha arrecato offesa a chi ne è stato vittima: deve esserci un sincero desiderio di riconciliazione, consapevolezza dell’azione fatta e intenzione a non ripeterla più»[2].
Chi ha recato l’offesa, insomma, deve prendere coscienza di ciò che ha fatto e cambiare radicalmente atteggiamento. È la ‘Teshuvà’. Spiega Di Segni: «‘Teshuvà’ rappresenta il ‘ritorno’: è l’impegno che uno fa a non commettere più una certa colpa rendendosi conto della gravità della stessa. Dopo questi atti chi ha recato offesa deve riconciliarsi con l’offeso, chiedendogli il perdono. A sua volta l’offeso deve concedergli il perdono; può rifiutarlo per due volte, alla terza deve cedere; se non lo fa, chi ha offeso non è più tenuto a chiedere scusa»[3].
E’ innegabile che siamo davanti a una condizione del tutto ragionevole. Ma quando Gesù, sulla croce, chiede a Dio di perdonare i suoi aguzzini - «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34) - , non sembra subordinare la sua richiesta alla loro conversione. Né vi accenna nell’invito rivolto ai suoi discepoli: «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe» (Mc 11,25).
C’è poi la seconda condizione, la gravità della colpa commessa. Alla domanda: «Ci sono colpe che non possono essere perdonate?», Di Segni risponde: « La questione è molto complicata: al limite possono esistere tali colpe, ma molto dipende dall’atteggiamento di chi si è comportato male»[4].
Il riferimento spontaneo è alla tragedia dell’Olocausto: «Nel suo Girasole, Simon Wiesenthal pone una domanda estremamente lacerante: come ci si deve comportare di fronte alla richiesta di perdono di una SS morente? L’autore scrive: “Io avrei dovuto perdonargli? O potuto perdonargli? E gli altri avrebbero dovuto o potuto farlo? (…) So che molti mi comprenderanno e approveranno il mio comportamento verso la SS morente. Ma so pure che altrettanti mi condanneranno per non aver aiutato un assassino pentito a chiudere gli occhi in pace”»[5].
È chiaro che, anche in presenza di un pentimento sincero, come può essere quello di un uomo in punto di morte, per l’ebraismo «ci sono colpe che non possono essere perdonate». E l’Olocausto è evidentemente una di esse: come scrive Di Porto, «la Shoah è un crimine troppo grande per essere perdonato, i cui esecutori hanno superato abbondantemente il limite della “perdonabilità”»[6].
Ancora una volta, la visione cristiana del perdono appare più radicale e, se vogliamo, meno accettabile dal comune buon senso. La colpa per cui, nella sua passione, Gesù invoca la remissione - l’assassinio del Figlio di Dio - è stata, agli occhi dei cristiani la peggiore che mai sia stata commessa,
Si potrà dire che nella storia successiva essi, per molti secoli, non hanno affatto perdonato agli ebrei e li hanno spietatamente perseguitati, accusandoli di “deicidio”. Ma questa è stata una loro vergognosa infedeltà allo spirito allo spirito del vangelo, di cui Giovanni Paolo II, nel 2000, a sua volta ha chiesto pubblicamente perdono e che non rispecchia la dottrina cattolica, secondo la quale «non c’è nessuna colpa, per grave che sia, che non possa essere perdonata dalla santa Chiesa»[7].
Quanto all’ultima condizione, secondo la tradizione ebraica nel perdono «non esistono deleghe (...); ciascuno può perdonare il male arrecatogli a chi glielo ha fatto»[8]. Ora, nel caso della Shoah, «la maggior parte delle vittime sono morte. Il perdono operato da terzi non può sostituire quello delle vittime»[9].
In realtà questa condizione non vale, evidentemente, per Liliana Segre, ma certamente bastano le altre due per rendere perfettamente comprensibile la sua posizione di ebrea di fronte alla persecuzione di cui è stata vittima.
2. Odio e perdono
L’affermazione su cui stiamo riflettendo - «Io non perdono e non dimentico, ma non odio» - si presta però ad un altro tipo di lettura che, a prescindere dalle diverse tradizioni religiose, ne metta a fuoco il significato semplicemente umano.
Qui è in primo piano il rapporto tra odio, perdono e memoria. Liliana Segre pone una netta divaricazione tra il primo termine e gli altri due, che invece collega strettamente. Lasciamo per un momento da parte il rapporto tra perdono e memoria, per focalizzare la nostra attenzione piuttosto su quello tra odio e perdono. E’ possibile non odiare, quando ci si rifiuta di perdonare o comunque non si riesce a farlo?
L’odio, di per sé, è un sentimento di rifiuto radicale dell’altro, che porta a desiderare la sua distruzione. Può anche radicarsi e diventare un permanente atteggiamento interiore, anzi perfino un approccio culturale, se ai fattori emotivi si uniscono delle ragioni che giustificano questo atteggiamento, agli occhi di chi lo assume. In quest’ultimo caso, l’odio è spesso un fenomeno che va al di là della sfera puramente individuale e coinvolge dei gruppi più o meno numerosi.
Specialmente come clima culturale collettivo esso non è necessariamente connesso al problema del perdono. C’è un odio che non nasce dall’aver subìto dei torti, ma da una segreta paura dell’implicita minaccia che deriva dalla stessa esistenza dell’altro, per il solo fatto della sua diversità.
Ne è un tipico esempio l’odio che spessissimo, in passato e fino ai giorni nostri, ha contrapposto fra loro persone di nazionalità divise da ataviche inimicizie: ebrei e palestinesi, greci e turchi - per citare solo alcuni casi di cui parlano le cronache - sono divisi da un odio collettivo che prescinde dai rapporti personali tra i membri dei due gruppi e che non esclude che a volte essi, a livello individuale, riescano a superare, anche se con difficoltà, le diffidenze e i pregiudizi reciproci.
Appartiene a questa categoria dell’odio “collettivo” quello razziale, che fa sentire i membri di un’intera categoria di persone – i neri, gli ebrei, i rom – , anche se appartenenti alla propria stessa nazionalità, come un potenziale pericolo, non a causa di atti concreti compiuti dai singoli, ma in base al solo fatto di esistere. Anche in questo caso, i singoli dei rispettivi gruppi possono superare questo atteggiamento culturale e stringere fra loro dei legami di amicizia o sentimentali.
Più arduo è questo superamento quando entrano in gioco gravi torti subìti a livello personale, che richiedono il perdono. Significativo, per quanto riguarda l’odio nazionalista, il racconto di Fred Zinnemann, nel suo film Storia di una monaca (1959), della vicenda di una suora che, proprio perché incapace di perdonare, abbandona la sua vocazione religiosa per entrare nella resistenza francese contro l’occupazione nazista, spinta dall’odio per i tedeschi che le hanno ucciso il padre.
Qui la mancanza di perdono produce l’odio, che si manifesta nel desiderio di vendetta. Si può però negare il perdono a chi ci ha fatto del male, senza per questo nutrire quel sentimento, che spingerebbe a vendicarsi e a distruggere il responsabile.
Sembra questo il caso di Liliana Segre, impegnata a combattere il clima di odio che domina la nostra società a vari livelli e promotrice di uno stile di rispetto reciproco e di dialogo, ma non per questo disposta a considerare superato il male che lei stessa e il suo popolo hanno subìto nell’Olocausto.
3. Perdono e memoria
Questa impossibilità di perdonare sembra, dalle sua parole, strettamente associata al suo rifiuto di dimenticare. Chi perdona accetta che l’altro, il colpevole, venga reintegrato nella sua dignità, lo riconosce nella sua umanità anche dopo ciò che ha compiuto. Liliana Segre - pur rinunziando ad odiare i responsabili della Shoah e i loro tristi epigoni contemporanei - , non ritiene di poter fare questo gesto, perché rifiuta di dimenticare. Non è solo una incapacità: è una scelta, percepita come doverosa verso se stessi, verso le vittime, verso l’intera società.
Non si può non ammirare questa fedeltà alla memoria, specialmente in un tempo come il nostro, dove essa è ormai molto rara. Abbiamo assistito e assistiamo ogni giorno al triste spettacolo di personaggi politici che, all’indomani di una loro presa di posizione chiara e netta, sostengono di “non aver mai detto” quello che hanno detto. Dove ciò che è più grave non è la loro sfacciata menzogna, ma il fatto che questa, invece di essere subito rilevata e contestata con indignazione, venga avallata da un silenzio che è un implicito consenso.
Lo stesso, peraltro, vale per i fatti. E’ come se le cose accadute negli anni – a volte addirittura nei mesi - precedenti non fossero mai accadute. Comportamenti stigmatizzati, allora, dalla coscienza comune, non immunizzano l’opinione pubblica dal fidarsi ciecamente di chi ne è stato responsabile. Al passato nessuno guarda e, se lo fa, è per inventarselo secondo il proprio interesse. Nessuno ricorda nulla.
Questa crisi della memoria è in realtà una crisi dell’essere umano. Noi siamo i nostri ricordi. Spogliate un individuo delle cose che ha esperito, che ha appreso, che conserva come sua storia, e non resterà che una creatura smarrita e incapace di affrontare le sfide della vita.
La memoria, aveva già spiegato Agostino, è il nostro modo di trattenere nell’essere ciò che accade. “L’attimo fuggente” del presente dura un istante e inesorabilmente sprofonda nel nulla. Solo il ricordo di ciò che è stato ne perpetua l’esistenza, almeno dentro di noi. Dimenticare è già un morire. Per questo le malattie che colpiscono la memoria sono forse le più tremende.
Ma se una intera società – la nostra – è colpita da questa incapacità di ricordare e di custodire il suo passato, allora il dramma diventa collettivo. Ne è una manifestazione il negazionismo in quelle sue forme che implicano l’annullamento della storia. Quella che riguarda l’Olocausto è una delle più sconcertanti.
È già triste vedere tanti dimenticare che i vaccini hanno praticamente eliminato – nei Paesi dove sono stati fatti – malattie spaventose, come il vaiolo o la poliomelite. Ma il rifiuto, a dispetto di ogni evidenza, di riconoscere un crimine che ha causato sei milioni di morti, mette in discussione la comune appartenenza a un storia, lacera la comunità umana. E fa temere che, dietro la smemoratezza, si nasconda una segreta connivenza con quel crimine, o, peggio, l’intenzione di giustificarne la ripetizione nel futuro.
Per questo Liliana Segre ha non solo il diritto, ma il dovere – come tutti noi – di non dimenticare. Resta la domanda se davvero da questo debba seguire come conseguenza inevitabile anche la negazione del perdono.
A metterlo in dubbio è la semplice constatazione che per perdonare bisogna avere memoria del male sofferto e della colpa dell’altro. Solo una concezione superficiale del perdono può ridurlo a un impossibile “fare come se nulla fosse accaduto”. Chi perdona ricorda fin troppo bene che cosa è accaduto e le responsabilità dei colpevoli.
Per questo il perdono è una manifestazione di illimitata misericordia che ha inevitabilmente a che fare con una prospettiva religiosa. In fondo, solo Dio può perdonare. Questo vale per ogni perdono, anche se diventa ancora più evidente nel perdono cristiano, con la sua sfida ad ogni elementare criterio di reciprocità e di buon senso umano. Chi perdona lo fa solo a nome di Dio e può farlo perché, grazie a Lui, ha perdonato prima di tutto se stesso.
Da ciò deriva anche il carattere creativo del perdono, che non si limita a esonerare dall’odio verso l’altro, ma vuole restituirgli la sua umanità perduta. Quando il padre della parabola evangelica (cfr Lc, 15,11ss), che non ha certo mai dimenticato la colpa del figlio, lo accoglie nel suo perdono, lo ricostituisce nella sua dignità, facendolo rivestire con il vestito più bello e facendogli mettere al dito l’anello.
Questa gratuità, però, paradossalmente è più esigente di qualunque patto preliminare. Il perdono chiede al colpevole – non come condizione, ma come rinnovamento suscitato dal perdono stesso - un impegno a cambiare. Ancora nel vangelo questo aspetto è messo in luce nell’episodio della donna adultera. Sono significative le parole di Gesù, quando, dopo la sua sfida a scagliare la prima pietra, gli accusatori se ne sono andati ed egli rimane da solo con l’accusata: «“Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?”. Ed ella rispose: “Nessuno, Signore”. E Gesù disse: “Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare più”» (Gv 8,10-11).
Rispettiamo dal profondo la posizione di Liliana Segre. Resta comunque ammirevole la sua capacità di andare al di là dell’odio e dello spirito di vendetta. Ma forse proprio la sua speranza di contribuire a un mondo diverso, in cui non ci siano più carnefici né vittime, può trovare la sua piena giustificazione solo nell’esperienza, misteriosamente creativa, di una memoria che perdona.
4. Memoria e verità
Si può ricordare solo ciò che è realmente accaduto. Sullo sfondo della presa di posizione di Liliana Segre nei confronti dei negazionisti c’è non solo il diritto – anzi il dovere – della memoria, ma la rivendicazione della verità dei terribili eventi della Shoah.
Certo, oggi risuona più attuale che mai la domanda di Pilato: «Che cos’è la verità?» (Gv 18,38). La definizione classica di Aristotele, secondo cui verità è «dire che è quello che è e che non è quello che non è»[10], implicava due elementi, il “dire” (o pensare) da parte del soggetto, e la realtà che questo dire esprime.
Un elegante relativismo tende oggi a mettere tra parentesi il secondo elemento. Da quando gli Oxford Dictionaries hanno indicato come “parola dell’anno”, per il 2016, il termine inglese post-truth (in italiano “post-verità”), sempre più questo concetto si è imposto nella nostra cultura corrente, sui social e sui mezzi di informazione. Per “post-verità” si intende un’«argomentazione, caratterizzata da un forte appello all'emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su fatti verificati tende a essere accettata come veritiera, influenzando l'opinione pubblica» [11].
Qui si pretende sia superata la tradizionale contrapposizione tra “vero” e “falso”. La post-verità, infatti, non è “falsa”, anche se non è neppure propriamente “vera”. Viene presentata come un nuovo modello di verità, che fa riferimento a una realtà mutevole e riducibile alle infinite interpretazioni che se ne possono dare, a seconda dei diversi punti di vista individuali e culturali.
Un ruolo importante, per l’affermazione di questo modo di intendere la verità, l’ha avuto l’avvento della “realtà virtuale”, il solo mezzo di rappresentazione della realtà finora inventato dagli uomini che nasconde il suo ruolo di intermediario e pretende di sostituirsi all’oggetto rappresentato. Al punto da farci credere nella sua presenza, anche quando fisicamente non c’è.
È significativa l’affermazione del nuovo genere costituito dal “giornalismo-spettacolo”, in cui si trovano uniti due termini in passato agli antipodi, poiché il primo indica la fedeltà ai fatti, il secondo la libera creazione di apparenze. Ma a questo punto, si ripresenta l’amaro interrogativo di Pilato: «Che cos’è la verità?»
Ma in quest’ottica, che significherebbe ricordare se non “ri-creare”, secondo le proprie esigenze e inclinazioni, un passato che in sé non avrebbe alcuna realtà?
A metterci in guardia nei confronti di questa prospettiva - che elimina l’elemento fondante della definizione di verità, la realtà - è il famoso romanzo di Georges Orwell 1984 (1949), dove si rappresenta una società dominata da un regime totalitario, in cui la memoria del passato è continuamente revisionata e manipolata da un apposito ufficio, che la riadatta di momento in momento alle scelte del “Grande Fratello”, il dittatore in carica.
Quanto questa negazione della memoria sia collegata a quella della verità emerge chiaramente nella vicenda del protagonista, un dissidente che viene crudelmente torturato non perché riveli in nomi dei compagni o dichiari la sua adesione al regime, ma perché ammetta che 2+2 non fa quattro, ma quello che il “Grande Fratello” decide. Dove si evidenzia che proprio la verità è l’ultimo baluardo della dignità e della libertà dell’essere umano, di fronte alla prevaricazione del potere e alla sua pretesa di decidere cosa è reale e cosa no.
La posta in gioco è dunque alta. Se non ci fosse verità, si sarebbe in balìa del più forte. Questo è particolarmente realistico nella vita pubblica del nostro Paese (e non solo di esso), dove – come una triste esperienza ci dimostra – il serio dibattito sulle questioni di comune interesse viene sostituito da uno scontro di macchine propagandistiche contrapposte e si impone chi riesce a sovrastare la voce degli altri. «Se è fin dall’inizio ovvio che di discutere non vale la pena, perché non c’è niente di oggettivo su cui discutere, allora (…) non cercherò di convincerti (…) farò meglio a vincerti» (R. De Monticelli). La realtà non conta più. E questa è la fine di una democrazia degna di questo nome.
Questo non vuol dire che i diversi punti di vista da cui essa viene osservata non debbano essere valorizzati. Anche il primo termine della definizione aristotelica è importante per capire che cosa è la verità. La filosofia ermeneutica ha giustamente sottolineato che il dualismo tra “oggettività” e “soggettività” è illusorio. La conoscenza oggettiva è sempre anche soggettiva, perché a conoscere il mondo è un soggetto, situato in un punto preciso dello spazio e del tempo, con la sua personalità, la sua storia, le sue esperienze. Non esiste “uno sguardo da nessun luogo”.
Perciò nessuno ha il diritto di pretendere che la sua opinione si identifichi con la verità nella sua totalità. Si tratta di una ricerca incessante, che procede per successive approssimazioni, nella consapevolezza della relatività della propria ottica e della necessità di confrontarla con quella degli altri, talora per integrarla, talora per correggerla.
Non bisogna però confondere questa relatività dei punti di vista col relativismo. Una montagna assume contorni molto diversi a seconda che la si guardi da lontano o da vicino, di fronte o di lato, ma è sempre di essa che parlano gli osservatori. Anzi, il fatto che ci si possa trovare talora in disaccordo, garantisce che questi punti di vista convergono su una comune verità. Come ha scritto Hannah Arendt, «solo dove le cose possono esser viste da molti in una varietà di aspetti senza che sia cambiata la loro identità, così che quelli che sono radunati intorno ad esse sanno di vedere la stessa cosa pur in una totale diversità, la realtà del mondo può apparire certa e sicura».
Per recuperare la memoria perduta – condizione del vero perdono – bisogna dunque tornare a prendere sul serio il concetto di verità, superando la diffidenza che ormai lo circonda nella nostra cultura.
Ad aiutarci in questo recupero può essere la consapevolezza che, se non ci fosse la verità, non ci sarebbero neppure le falsità. Ma da queste siamo ogni giorno, senza alcun dubbio, assediati! Il negazionismo è una di esse. E chi, come Liliana Segre, rifiuta di piegarsi a questa falsificazione della realtà, testimonia, oltre che la propria fedeltà alla memoria, che la verità esiste.
[1] A. Di Porto, La concezione ebraica del perdono, (13 settembre 2018), in «Confronti» 9/2018 (www.confronti.net).
[2] M. C. Strappaveccia, Il perdono per gli ebrei. Intervista a Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma, (14 aprile 2014), in «L’Indro» (www.lindro.it).
[3] Ivi.
[4] Ivi.
[5] A. Di Porto, La concezione ebraica del perdono, cit.
[6] Ivi.
[7] Catechismo della Chiesa cattolica, n. 982.
[8] Riccardo Di Segni, in M. C Strappaveccia, Il perdono per gli ebrei, cit.
[9] A. Di Porto, La concezione ebraica del perdono, cit.
[10] Aristotele, Metafisica, IV, c. 7, n. 1
[11] Enciclopedia Treccani, voce «Post-verità».
Quale diritto? Quale giustizia?
di Tommaso Manzon
“Voi dunque siate completi, come è completo il Padre vostro celeste” (Matteo 5:48)
“L’unico rapporto fruttuoso con gli uomini […] è l’amore, cioè la volontà di mantenere la comunione con loro. Dio non ha disprezzato gli uomini, ma si è fatto uomo per amor loro” (Dietrich Bonhoeffer[1])
Sommario: 1. Introduzione: quale diritto? Quale giustizia? - 2. La Croce - 3. Il diritto alla verità.
1. Introduzione: quale diritto? Quale giustizia?
Prima di tuffarmi nel tema di questo breve intervento, vorrei fare alcune premesse di metodo che mi sembrano doverose e necessarie. In primo luogo vorrei offrire la considerazione che in un dibattito o in uno studio di qualsiasi tipo non si dovrebbe mai discutere delle parole, bensì delle cose. Le parole sono veicoli di pensieri, concetti, stati d’animo che spesso possono generare offesa, divisione, e che talvolta possono trasformarsi in vere proprie armi. Allo stesso tempo però non bisogna perdere di vista che le parole sono “soltanto” questo, ossia dei veicoli: esse non sono completamente scollegate dalla realtà che significano, ma nemmeno s’identificano con essa. Pertanto se si vuole veramente capire qualcosa non bisogna fermarsi al livello dell’espressione verbale ma addentrarsi nell’ambito della “cosa in sé”. Questo è specialmente vero quando si esprimono punti di vista divergenti in merito allo stesso tema, e pertanto diventa necessario assicurarsi che il linguaggio di tutti sia effettivamente orientato nella stessa direzione. Per dirla in maniera il più semplice possibile, bisogna essere sicuri che stiamo parlando della stessa cosa; su quest’ultima possono benissimo esserci punti di vista differenti – possiamo in altri termini “non vederla tutti allo stesso modo” – ma dobbiamo essere sicuri che, ancora una volta, stiamo tutti parlando della medesima realtà. In secondo luogo e ben più brevemente vorrei specificare che questo contributo vuole proporre una meditazione che si muove all’interno della tradizione cristiana evangelica (o protestante, o riformata, che dir si voglia). Non si chiede al lettore di essere per forza d’accordo con quello che gli passa davanti agli occhi, ma solo di offrire un orecchio generoso.
Il soggetto che ci viene proposto è duplice: da un lato il diritto a non perdonare e a non dimenticare – accompagnati al contempo dal dovere di non odiare – e dall’altro la proposta di tematizzare tali questioni insieme a quella del diritto alla verità. Il punto di partenza per meditare su questi argomenti è “offerto” dalle parole della senatrice a vita Liliana Segre, pronunciate nel novembre del 2019 alla conferenza “Science for peace” presso l’Università Bocconi di Milano: “io non perdono e non dimentico, ma non odio”[2]. Io però vorrei spostarmi in un altro contesto, ovverosia quello dell’ultima apparizione pubblica della senatrice, tenutasi il 9 ottobre scorso a Rondine. In quest’occasione la Segre pronuncia quasi le medesime parole già utilizzate alla Bocconi, calandole però in un contesto che a mio parere ci spiegano meglio qual è per l’appunto “la cosa in sé” a cui vuole fare riferimento. In un primo momento nel discorso di Rondine la senatrice afferma: “non ho perdonato [i nazisti]. Non ho questa forza, io non ho perdonato come non ho dimenticato perché certe cose, io non riesco, non sono riuscita mai a perdonarle”[3]. In seguito, verso la conclusione del suo intervento, ricordando la tentazione avuta di raccogliere una pistola per uccidere uno dei suoi aguzzini, afferma: “io non ero quella che sono oggi, io mi ero nutrita di odio e di vendetta. Lasciando la mano sacra di mio padre, giorno dopo giorno ero diventata un’altra, quella che loro volevano che io diventassi. Un essere insensibile che sognava odio e sognava la vendetta. Pensai: adesso raccolgo questa pistola che tanto avevo visto usare e gli sparo […] fu un attimo. Fu un attimo importantissimo e decisivo nella mia vita, perché io capii che mai, per nessun motivo al mondo, io avrei potuto uccidere qualcuno, che io non ero come il mio assassino […] da quel momento sono diventata quella donna libera e quella donna di pace con cui ho convissuto fino ad adesso”[4]. Questo secondo estratto dell’intervento, mi pare, parafrasa e contestualizza l’affermazione sull’odio fatta dalla Segre alla Bocconi.
Come bene individuato dal Professor Savagnone nel suo intervento, la Segre lega a stretto giro la memoria al perdono: non si perdona perché non si dimentica; allo stesso tempo il carico di odio e di rancore – che nelle parole di Rondine assume i tratti di una vera e propria “possessione demoniaca” che trasforma le vittime in “esseri insensibili” e che non sono capaci di sognare altro che di restituire quanto subito – è passato, anzi, è il passato, memoria morta e non viva, che non diventa più presente ma che è relegata invece ad una fase precedente della propria esistenza e perciò viene messa da parte, impedendole così di avvelenare tutto quanto è avvenuto in seguito. Savagnone coglie a mio parere nel segno anche quando sottolinea come in questa prospettiva perdonare sarebbe – scusate il gioco di parole – imperdonabile, nella misura in cui parrebbe l’equivalente di dare un colpo di spugna a quanto è successo. In altri termini non si può fare con l’Olocausto quello che si fa con il proprio odio: quest’ultimo può e deve diventare morto ma il dolore subito deve rimanere memoria viva, presente, attiva e questo impedisce il perdono, nella misura in cui in quest’ottica perdonare sembrerebbe passare sopra questo dolore, facendo torto alla gravità dell’accaduto e dunque anche alla dignità dell’esperienza di chi ci è stato – e di chi ci è rimasto.
È giusto tutto ciò?
Posto che stia ben rappresentando i pensieri della senatrice – perché in fondo sto solo cercando di darne un’interpretazione plausibile – credo che nessuno di noi vorrebbe e potrebbe dire di no. A un livello della giustizia e del diritto umano, la senatrice ha fatto e la vede in un modo totalmente giustificabile. Anzi, la verità è che molti di noi avrebbero preso quella pistola e avrebbero sparato a quell’ufficiale tedesco senza pensarci troppo sopra. Direi quindi che Liliana Segre ha fatto meglio di tanti, dando dimostrazione di una solidità morale di cui si ha rara traccia. Se non credessi che ci fosse anche un’altra giustizia e un altro diritto di cui dover tenere conto, allora quest’intervento potrebbe benissimo finire qui. Voglio invece spostare momentaneamente il discorso dall’Europa del ’45 e del 2020 ad un altro luogo, per andare ad ascoltare quale sia la giustizia che proviene dal Calvario.
2. La Croce
Abraham Kuyper – noto pastore, filosofo, teologo e uomo di stato olandese vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo – scrive quanto segue all’inizio di uno dei suoi testi più noti: “non è dalla Grecia né da Roma che venne la rigenerazione della vita umana, bensì da Betlemme e dal Golgota”[5]. Da questo punto di vista l’affermazione di Kuyper ben rappresenta non solo una convinzione fondamentale della fede cristiana, ma anche nello specifico una particolare enfasi che caratterizza la famiglia delle chiese nate dalla Riforma. Fu Lutero che per primo pose con estrema chiarezza i termini della questione. Questo avvenne nel contesto della cosiddetta disputa di Heidelberg del 1518, allorquando gli agostiniani si riunirono per ascoltare le posizioni del professore di Wittenberg, diventando questa l’occasione e il luogo per dibattere parte dei temi contenuti in quelle 95 tesi che, travolte dal furore che seguì la loro pubblicazione, non erano poi di fatto mai state discusse[6]. Anche all’epoca venne chiesto a Lutero di formulare delle tesi – 28 tesi teologiche e 12 tesi filosofiche – ciascuna seguita da una breve spiegazione.
Le celeberrime tesi 19-20-21 recitano “colui che guarda alle cose invisibili di Dio come se fosse possibile percepirle nello scorrere degli eventi non merita di essere chiamato teologo [19]. Merita invece di essere chiamato teologo colui che comprende le cose visibili e manifeste di Dio per come esse appaiono attraverso la sofferenza e la croce [20]. Un teologo della gloria chiama ‘bene’ il male e ‘male’ il bene. Un teologo della croce dice le cose come stanno [21]”[7]. Tenendo presente che per Lutero il falso teologo e il teologo della gloria coincidono – mentre quella di “teologia della croce” è proprio la “cifra” con cui viene indicato il pensiero del sassone – nell’argomentazione in favore della 20° tesi egli afferma che è inutile conoscere Dio nella sua gloria e nella sua maestà se non lo si riconosce prima nella sua umiltà e vergogna, questo perché Dio stesso ha desiderato che lo si cercasse e gli si rendesse onore nel mentre il suo splendore era nascosto nel dolore del supplizio. Invertire i termini finirebbe per determinare una falsa idea di Dio, rendendo incomprensibile il contatto tra la sovranità e l’autorità di Dio e il modo del suo esercizio per come esso è incarnato visibilmente nella vita di Gesù di Nazaret. Sicché, conclude Lutero, si può riconoscere la vera identità di Dio e di conseguenza fare della vera teologia – cioè produrre un corretto discorso intorno a Dio – solamente in riferimento, a partire e attraverso la figura di Cristo crocifisso[8].
Le implicazioni della presa di posizione di Lutero sono molteplici e le tesi di Heidelberg, prese nel loro complesso, furono di una tale esplosività che finirono per aggiungere carburante al fuoco che accese la Riforma. Per quanto riguarda gli scopi limitati di questo scritto possiamo limitarci a constatare questo: se la giustizia manifesta la propria natura nel suo esercitarsi o manifestarsi e se Dio in quanto giudice supremo è colui che può esercitare la più alta giustizia e se infine accettiamo – anche solo momentaneamente per ipotesi – che la scena della crocifissione debba essere l’inizio di ogni corretta riflessione su Dio, allora dobbiamo concludere che la giustizia più alta si manifesta a partire dalla deposizione del suo stesso diritto. Dio come magistrato il quale al di sopra non ve ne è nessuno, mostra il proprio carattere a partire dalla rinuncia ad esercitare la funzione che gli è propria per essenza. Non solo: egli accetta di essere maledetto e ucciso dai colpevoli che potrebbe e che dovrebbe punire. Storicamente questo punto è stato manipolato da buona parte della tradizione cristiana e si è voluto incolpare esclusivamente il popolo ebraico di deicidio; ma la verità che emerge dal racconto evangelico è ben più profonda. Gesù di Nazaret viene tradito prima dalla Chiesa – nella persona di Giuda che lo vende e di Pietro che lo rinnega – poi viene tradito dal popolo eletto nella figura dei suoi massimi rappresentanti che lo accusano falsamente e lo consegnano alle autorità romane, infine viene tradito dal potere secolare – e quindi anche dai cosiddetti “gentili” ossia da tutta l’umanità non-ebrea che qui è rappresentata da Roma – allorché Ponzio Pilato, pur sapendolo e riconoscendolo pubblicamente innocente, prima lo fa frustare e poi lo condanna a morte.
Sebbene in ciascuno di questi gruppi vi sia chi si distingue dalla massa – il racconto dei vangeli ne fa menzione, per esempio, nelle donne che accompagnano Gesù alla croce, in Giuseppe di Arimatea e nella moglie di Ponzio Pilato – il messaggio è evidente per chi lo vuole comprendere: il “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno” che Gesù leva al cielo in Luca 23:34 è diretto a un’intera umanità che si fa giudice del giudice, ribellandosi e maledicendo il proprio Creatore. E qui avviene il rovesciamento che Dio compie sulla croce: di fronte alla maledizione universale che l’umanità riversa su Dio, Egli non se ne fa travolgere ma la assorbe e la spegne, sicché Gesù dall’alto della croce intercede per i propri assassini nell’ora della sua morte, gli arti stesi non come se fosse inchiodato, ma come se stesse avvolgendo tutto il creato in un abbraccio.
3. Il diritto alla verità
Ma quella che ho chiamato la “giustizia” che viene dal Calvario non si conclude qui. Perché sarà anche vero che ogni discorso su Dio deve cominciare dalla croce, ma questo non significa che essa debba anche essere il suo termine. Se così fosse allora dovremmo arruolarci nella schiera di coloro che, con il barbuto di Treviri, affermano che la religione è l’“oppio dei popoli”. Perché se la morte in croce di Gesù fosse la fine della sua giustizia, quello che ci rimarrebbe sarebbe soltanto il grido di morte di un innocente massacrato – fosse pure di natura divina, questo farebbe ben poca differenza in termini pratici. Certo permarrebbe nella mente il pensiero di un’ingiustizia che chiede di essere controbilanciata dalla giusta punizione di coloro che sono colpevoli di averla commessa, ma ecco che così ci saremmo subito allontanati dal Calvario per marciare risolutamente verso Norimberga e i suoi tribunali. La giustizia che viene dal Calvario trova però il suo proseguimento, e quindi il resto della sua teologia, nella tomba che fu trovata vuota all’alba del terzo giorno.
Qui ci colleghiamo infine alla seconda parte del tema che ci è stato proposto, quello del diritto alla verità. Incamminandoci dal Calvario verso la tomba che era vuota, è stata occupata ed è tornata ad essere vuota, il diritto alla verità significa essere partecipi dell’esistenza della Verità: significa testimoniare di una vita risorta che non è il semplice prolungamento della vita precedente ma che è un nuovo inizio ed è in senso eminente la manifestazione infine visibile, anche al di là del dolore, della Verità che si è fatta uomo. Il dolore qui non è svanito, cancellato dalla storia, perché l’apostolo Tommaso testimonia delle ferite della crocifissione e quindi esse permangono anche nel corpo risorto. Ciò non di meno esse fanno parte delle cose del passato che non sono più, oramai tratti distintivi di un amore che “non tiene conto del male subito” (1Cor 13:5): Cristo infatti non risorge per radunare un esercito e vendicarsi, ma per dire a tutti che una nuova vita è iniziata e che chiunque lo desideri può ricevere anch’egli, gratuitamente, la sua porzione di Verità.
In tempi molto più recenti un altro pastore protestante di nome Martin Lutero – questo però faceva di cognome King e veniva dall’Alabama – scrisse:
“il male è talmente capace di dare forma agli eventi che Cesare vive in un palazzo mentre Cristo viene messo in croce, ma è quello stesso Cristo che ha spaccato la storia in due dividendola in ciò che viene prima e dopo di lui, sicché persino la vita di Cesare viene datata secondo il nome di Gesù. L’arco dell’universo morale è lungo, ma tende inevitabilmente verso la giustizia[.] La verità schiacciata al suolo riuscirà sempre a rialzarsi”[9].
Che le affermazioni del Dr. King possano risuonare ingenue e false sono sicuro che lo avesse messo in conto lui stesso. Esse infatti appaiono evidenti e ben fondate soltanto nella misura in cui questo stesso arco appare agli occhi di chi lo veda, ed il medesimo osservatore divenga inoltre testimone del rialzarsi della Verità. Allora soltanto appare chiaro come Cristo stia sopra Cesare e che una più alta giustizia, di cui è possibile diventare partecipi, avanza inesorabilmente nella storia verso la sua destinazione. Ma questo è possibile solamente a chi guarda all’universo avendo la croce e la tomba vuota come punto prospettico.
Torniamo da dove eravamo partiti, ossia dalla Segre e dalle sue parole. Che cosa dobbiamo dire della giustizia che traspare da quest’ultime e di quell’altra di cui abbiamo voluto rendere conto? Anche dopo tutto quello che abbiamo aggiunto, possiamo ancora dire che sia giusto affermare che la senatrice a vita Liliana Segre goda di un diritto a non perdonare? Sicuramente sì. Perché del resto chi potrebbe permettersi di dire a questa gran donna, che spicca in mezzo alla mediocrità a cui siamo ormai assuefatti, che dovrebbe andare al di là di sé stessa e delle atrocità che ha subito e di cui è stata testimone, per poi infine perdonare i propri aguzzini? Sicuramente chi scrive non può osare tanto, ma aggiungerei nemmeno chiunque altro. Nessuno può chiedere una cosa simile a un proprio pari. Del resto abbiamo già detto più sopra come la Segre abbia mostrato più integrità di quanto ci si sarebbe potuto aspettare e di quanta ne avremmo richiesta da lei se fossimo stati lì presenti, in quel lontano giorno del ’45 in Germania in cui decise di risparmiare il suo aguzzino. Liliana Segre ha così in un certo senso raggiunto il limite della giustizia umana, rifiutando di farsi modellare dal suo nemico e scegliendo invece di trovare forza in sé stessa e nella propria dirittura morale. Speriamo poi che quel tedesco a Norimberga ci sia andato per davvero e non solo figurativamente, e che abbia reso conto delle sue azioni di fronte a un tribunale umano; e grazie a Dio che ci sono state le varie Norimberghe della storia, dove uomini hanno cercato, per quanto i loro limiti consentissero, di fare giustizia dei vari Herman Gӧring e delle loro azioni. E da ciò ne deriva che da un certo punto di vista vi è un innegabile diritto a non dimenticare e alla verità: perché la storia della giustizia e dell’ingiustizia umana va ricordata, preservata, utilizzata onde evitare gli errori del passato – anche se, ahimè, ritengo che se l’arco dell’alta giustizia avanza sempre, lento, tortuoso, ma inarrestabile, quello della giustizia umana si ripete in modo spiralico, allargandosi sempre di più ma al contempo avvolgendosi su sé stesso.
In una prospettiva biblica bisogna dire che anche questa giustizia umana è stabilita da Dio e anch’essa procede dal suo carattere. “Non vi è autorità se non da Dio” scrive Paolo nella sua missiva ai Romani, per poi aggiungere che “il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada invano; infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male” (Romani: 13:1b, 4). Questo non implica porre un cappello “teocratico” sul potere politico e nello specifico su quello giudiziario – del resto Paolo scrive ai romani del primo secolo DC, che vivono in un impero che è ben lungi dal riconoscere il cristianesimo e che anzi ne è ancora quasi del tutto ignaro – bensì affermare che anche la giustizia degli uomini se esiste è perché, quando è ben esercitata, svolge un ruolo essenziale e ordinato da Dio. A questo fine, cioè quello di ben utilizzare la “spada” ed evitare il verificarsi del male, il magistrato e chi in generale si muove nell’ottica della giustizia umana ha diritto a non perdonare, a non dimenticare e a raccontare una verità che mantenga viva il ricordo, l’attenzione e il discernimento degli uomini. Questo però, prendendo esempio dalla Segre, dev’essere fatto senza uno spirito di vendetta e di odio – altrimenti anche chi porta la spada sarebbe meritevole di punizione – bensì per l’appunto con uno spirito di giustizia.
È chiaro che questa giustizia umana può intrecciarsi e anzi nutrirsi con l’altra giustizia di cui abbiamo parlato, la quale non annulla la prima ma la avvolge in una realtà più ampia, di cui del resto quella, essendo stabilita da Dio fa già parte sin dalla sua origine. La differenza è però che questa giustizia non può essere amministrata con la Spada. Ben dice Lutero sempre nelle tesi di Heidelberg, quando nella 28° e ultima tesi afferma che “l’amore di Dio non trova bensì crea ciò che è a esso gradito”[10]. Questo significa che la giustizia divina che inizia con la croce e finisce laddove conduce l’arco morale dell’universo non è una nostra creazione o qualcosa che possiamo reclamare; semmai possiamo semplicemente riceverla da Dio nel momento in cui egli la crea in noi. Per questo essa è una giustizia che non si può né comandare, né chiedere, né ce la si può aspettare – da Liliana Segre o da chiunque altro. Si può solamente testimoniare ed accogliere la testimonianza della croce e della tomba vuota che ne sono la radice e l’origine.
Bibliografia[11]
[1] Dietrich Bonhoeffer, Resistenza e Resa: Lettere e scritti dal carcere, a cura di Eberhard Bethge, edizione italiana a cura di Alberto Gallas (Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 2015), p. 76.
[2] Liliana Segre, “Milano, Segre cita Levi: “non perdono e non dimentico, ma non odio”, Youtube.
[3] Liliana Segre, “L’ultima testimonianza di Liliana Segre ‘Non ho mai perdonato, ma ho imparato a non odiare”, Youtube, minuto 55:00.
[4] Segre, “L’ultima testimonianza”, 1:11:00.
[5] Abraham Kuyper, Lezioni sul calvinismo (Caltanissetta: Alfa & Omega, 2020). Sulla notevole figura di Kuyper si può anche consultare l’eccellente biografia di James D. Brat, Abraham Kuyper. Calvinista moderno, cristiano democratico (Firenze: BE, 2018).
[6] Cfr. Alister E. McGrath, Luther’s Theology of the Cross: Martin Luther’s Theological Breakthrough, seconda edizione (Oxford: Wiley-Blackwell, 2011).
[7] Le tesi e il loro commento sono prese, tradotte e collazionate da Martin Lutero, Luther’s Works, a cura di Jaroslav Pelikan e Helmut T. Lehmann (Minneapolis: Fortress Press, 1957), pp. 39-58.
[8] Nelle parole di Jürgen Moltmann, un teologo riformato che disse di essere stato “trovato da Cristo” mentre era in un campo di prigionia alleato nonché un grande erede di Lutero, si può quindi affermare che “la teologia cristiana deve essere una teologia della croce, se essa vuole identificarsi attraverso Cristo come una teologia cristiana”. Jürgen Moltmann, The Crucified God (Minneapolis: Fortress Press, 2015), pp. 7, 44.
[9] Martin Luther King Jr., “Out of the Long Night”, in The Gospel Messenger, 08/02/1958, p. 14. Per dovere di precisione, bisogna specificare che l’espressione indicante l’arco dell’universo morale venne utilizzata per la prima volta da Theodore Parker, mentre le parole sulla verità sono indicate esplicitamente da King come una citazione di William Cullen Bryant. Cfr. Theodore Parker, Ten Sermons of Religion (Boston: Nichols and Company, 1853), p. 66.
[10] Si veda nota 6 supra.
[11] Bibliografia: Bonhoeffer, Dietrich, Resistenza e Resa: Lettere e scritti dal carcere, a cura di Eberhard Bethge, edizione italiana a cura di Alberto Gallas (Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo, 2015).
Brat, James D., Abraham Kuyper. Calvinista moderno, cristiano democratico (Firenze: BE, 2018).
King, Martin Luther Jr., “Out of the Long Night”, in The Gospel Messenger, 08/02/1958.
Kuyper, Abraham, Lezioni sul calvinismo (Caltanissetta: Alfa & Omega, 2020).
Lutero, Martin, Luther’s Works: Career of the Reformer, a cura di Harold J. Grimm e Helmut T. Lehmann (Minneapolis: Fortress Press, 1957).
McGrath, Alister E., Luther’s Theology of the Cross: Martin Luther’s Theological Breakthrough, seconda edizione (Oxford: Wiley-Blackwell, 2011).
Moltmann, Jürgen, The Crucified God (Minneapolis: Fortress Press, 2015).
Parker, Theodore, Ten Sermons of Religion by Theodore Parker (Boston: Nichols and Company, 1853).
Segre, Liliana, “L’ultima testimonianza di Liliana Segre ‘Non ho mai perdonato, ma ho imparato a non odiare”, www.Youtube.com
Segre, Liliana, “Milano, Segre cita Levi: “non perdono e non dimentico, ma non odio”, www.Youtube.com