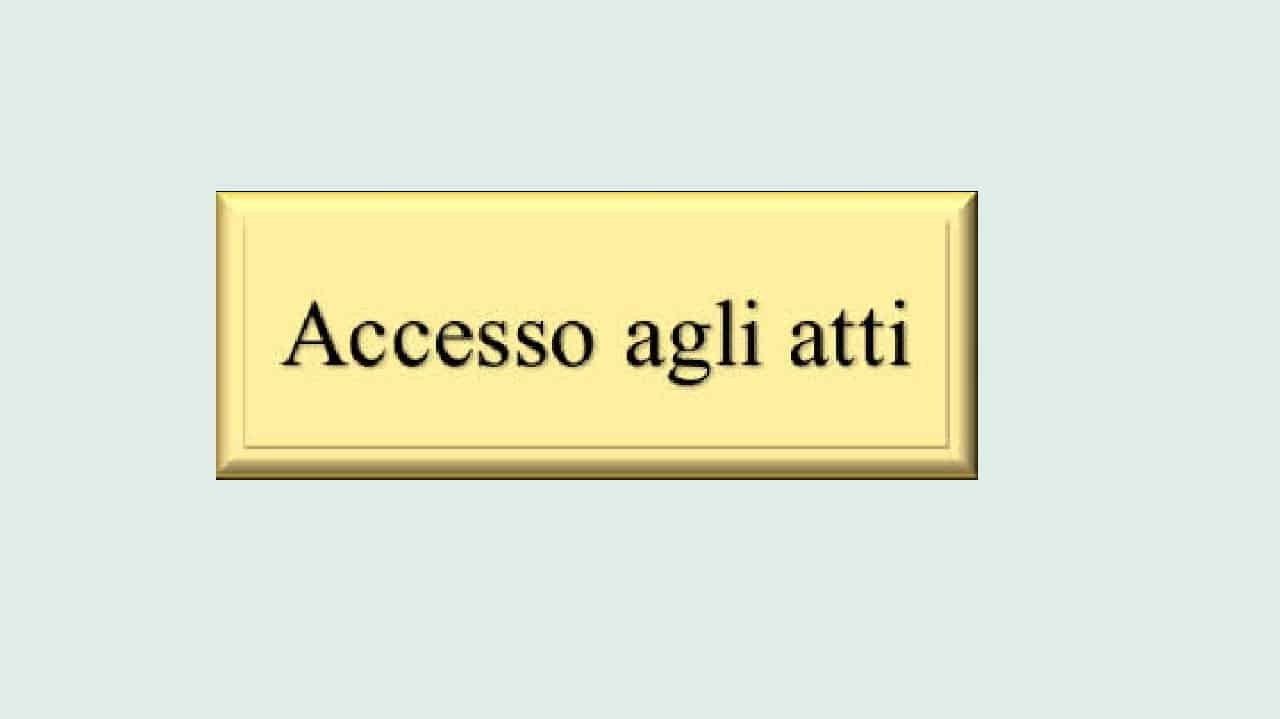Dissenso dei condòmini, legittimità urbanistica e controlli dell’amministrazione: un ritorno alla tutela civilistica dei terzi (nota a CGARS, sez. giurisdizionale, 5 giugno 2023, n. 392).
di Ippolito Piazza
Sommario: 1. Il tema e i fatti all’origine della controversia. – 2. Dissenso dei condòmini e legittimità urbanistica. – 3. La distinzione di piani nella sentenza del CGARS. – 4. Le ragioni per la tesi civilistica.
1. Il tema e i fatti all’origine della controversia.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa adotta, nella sentenza in commento, una posizione netta circa la natura delle controversie edilizie tra vicini e il ruolo che (non) deve avere l’amministrazione. Ad avviso dei giudici siciliani, l’illegittimità urbanistica di un’opera non può mai dipendere dalla presunta lesione di un diritto civilistico del terzo-vicino di casa: non è infatti compito dell’amministrazione effettuare un simile accertamento, come non lo è quello di dare esecuzione a eventuali pronunce del giudice ordinario intervenute sul punto. Come si proverà ad argomentare, si tratta di una tesi condivisibile, perché consente di tenere distinti il piano delle relazioni civilistiche tra vicini da quello delle relazioni pubblicistiche tra costruttore e pubblica amministrazione, evitando così di attribuire a quest’ultima un compito che l’ordinamento non le attribuisce.
La pronuncia è importante perché sembra discostarsi da alcuni diffusi indirizzi giurisprudenziali: il primo è quello in base al quale l’amministrazione, se edotta dell’esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, debba effettuare un controllo sull’attendibilità di quanto affermato dal richiedente, pur non potendosi sostituire al giudice ordinario nell’effettuare valutazioni civilistiche[i]; il secondo è quello che afferma l’esistenza della cosiddetta ‘doppia tutela’, in base alla quale il terzo-vicino di casa sarebbe titolare sia di un diritto derivante dal rispetto delle norme civilistiche sugli immobili, sia di un interesse legittimo al rispetto della normativa edilizia, da far valere rispettivamente di fronte al giudice ordinario e al giudice amministrativo[ii]. La sentenza del CGARS consente quindi di svolgere alcune considerazioni riguardo all’incidenza dei rapporti privati sull’attività di controllo dell’amministrazione e alla tutela dei terzi in materia edilizia.
Prima di tutto è, però, necessario descrivere la vicenda. La controversia nasce dall’ordinanza di demolizione di una canna fumaria a servizio esclusivo di un’attività di ristorazione, posta su un muro esterno condominiale comune. La presenza della canna fumaria aveva già dato luogo a un giudizio civile tra il proprietario dell’immobile al piano terra, adibito a ristorante, e la proprietaria degli immobili soprastanti, conclusosi con una sentenza che imponeva la rimozione dell’opera per alterazione del decoro architettonico dell’edificio. Il proprietario dell’immobile al piano terreno aveva, pertanto, dapprima rimosso la canna fumaria e poi ne aveva installata una diversa, che riteneva conforme alla legge e al giudicato. La nuova collocazione della canna fumaria era autorizzata dal Comune, previo parere dell’ARPA. Anche la nuova canna fumaria veniva però rimossa, stavolta a opera dell’ufficiale giudiziario, in esecuzione della sentenza civile sopra richiamata. A questo punto, gli interessati, dopo aver presentato una Scia nel 2020 ritenuta inammissibile dal Comune, trasmettevano al Comune una CIL e reinstallavano la canna fumaria. Il caso tuttavia rimaneva aperto: in esito a un sopralluogo, i tecnici comunali e i vigili urbani evidenziavano nella loro relazione come la installazione della canna fumaria, già autorizzata dal Comune, avesse bisogno del consenso di tutti i condòmini, consenso che invece mancava nel caso di specie. In base a tale relazione, il Comune ingiungeva la demolizione della canna fumaria, pur confermando che quest’ultima rispettasse i parametri fissati dal regolamento edilizio.
Gli odierni proprietari e il conduttore dell’immobile al piano terra ricorrevano quindi al Tar per l’annullamento dell’ordine di demolizione e dei provvedimenti conseguenti[iii]. Il Tar respingeva il ricorso[iv], tra l’altro, perché condivideva la tesi dell’amministrazione secondo cui occorresse il previo assenso degli altri condòmini per la realizzazione dell’opera. La necessità di tale consenso, assente nel caso di specie, risponde secondo il Tar, «(anche) all’esigenza di prevenire controversie in ordine alla gestione della cosa comune ed alla potenziale lesione delle prerogative proprietarie»: in quest’ottica, il provvedimento dell’amministrazione svolge una funzione arbitrale rispetto a una questione civilistica.
2. Dissenso dei condòmini e legittimità urbanistica.
La asserita mancanza del consenso dei condòmini viene quindi a condizionare, nella ricostruzione del giudice di primo grado, la legittimità dell’intervento edilizio, a causa della violazione dell’art. 1102, c. 1, del codice civile. Quest’ultima disposizione prevede che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto»; le modifiche apportate dal singolo condomino sono soggette inoltre al rispetto del decoro architettonico dell’edificio, limite posto in generale dall’art. 1120, c. 4, c.c., per le innovazioni nel condominio di edifici[v].
Nella prospettiva adottata dal Tar, il rispetto di questi limiti civilistici costituisce un presupposto necessario per la sussistenza della legittimazione a richiedere il titolo edilizio e deve pertanto essere soggetto a un controllo da parte dell’amministrazione. Sulla natura di questo controllo si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa: se, infatti, può sembrare ragionevole che l’amministrazione effettui un simile controllo (così da evitare che sia concesso un titolo edilizio a chi non è legittimato), è pur vero che su una questione civilistica la parola non può che essere affidata al giudice ordinario. In ragione di ciò, la giurisprudenza maggioritaria (sia in materia di interventi su parti condominiali comuni che, in generale, in materia di rilascio di titoli edilizi) si attesta, come noto, su una linea interpretativa mediana, in base alla quale l’amministrazione, «quando venga a conoscenza dell’esistenza di contestazioni sul diritto del richiedente il titolo abilitativo, debba compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni, senza però sostituirsi a valutazioni squisitamente civilistiche (che appartengono alla competenza del giudice ordinario), arrestandosi dal procedere solo se il richiedente non sia in grado di fornire elementi prima facie attendibili»[vi]. La specificazione della attendibilità prima facie consente di evitare che l’amministrazione sia tenuta a effettuare dispendiosi accertamenti sulla titolarità di un diritto civilistico.
Una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi precisato che il controllo dell’amministrazione debba «sempre collegarsi al riscontro di profili d’illegittimità dell’attività per contrasto con leggi, regolamenti, piani, programmi e regolamenti edilizi, mentre non può essere esercitato a tutela di diritti di terzi non riconducibili a quelli connessi con interessi di natura pubblicistica, quali ad esempio il rispetto delle distanze dai confini di proprietà o del distacco dagli edifici». In altre parole, il controllo dell’amministrazione riguarderebbe solo la legittimità urbanistica delle opere; tuttavia, la stessa sentenza – in linea con l’orientamento maggioritario – fa salvo il caso in cui «de plano risulti l’inesistenza di un titolo giuridico che fondi la legittimazione attiva del richiedente il titolo edilizio»[vii]. Se da quest’ultima giurisprudenza emerge l’idea che l’amministrazione non debba, almeno in linea di principio, occuparsi di questioni civilistiche, vi sono altre pronunce, proprio in tema di opere su parti comuni, che, pur scindendo il profilo della conformità urbanistica da quello del consenso dei condòmini, ammettono invece che il controllo dell’amministrazione risponda specificamente «alla esigenza di prevenire controversie in ordine alla gestione della cosa comune ed alla potenziale lesione delle prerogative proprietarie»[viii].
Queste oscillazioni giurisprudenziali sulla finalità del controllo e sulla effettiva distinzione tra legittimità urbanistica e titolo civilistico mostrano come, una volta accettata l’idea che all’amministrazione competa un controllo sui titoli, non sia facile individuarne il limite. Del resto, il criterio della facile rilevabilità della contestazione – pur fondato sulle ragioni richiamate: evitare il rilascio di titoli edilizi a chi non ne abbia la legittimazione e al contempo non gravare l’amministrazione di un onere di controllo eccessivo – non appare pienamente convincente dal punto di vista teorico. Infatti, o si ritiene che la legge imponga all’amministrazione un controllo sui titoli del richiedente[ix] – e, allora, se così fosse, il controllo dovrebbe essere sempre fatto e in modo completo – oppure si ritiene che tale controllo non competa all’amministrazione.
Proprio quest’ultima è la via intrapresa dal CGARS nella sentenza che si annota: basandosi sulla distinzione tra rapporti fra condòmini e rapporto con l’amministrazione, il giudice ‘libera’ quest’ultima dall’onere del controllo sul rispetto delle regole civilistiche da parte del richiedente e si fa carico in maniera convincente delle conseguenze di tale distinzione.
3. La distinzione di piani nella sentenza del CGARS
La pronuncia ruota attorno alla questione dell’assenza del consenso dei condòmini alla costruzione della canna fumaria: il punto è, del resto, «dirimente» per i giudici dal momento che l’ordinanza di demolizione è motivata con rinvio alla relazione di sopralluogo nella quale «dopo il riferimento all’art. 1102 del c.c., testualmente è riportato che “in conseguenza del mancato assenso preventivo reso dagli altri soggetti comproprietari, viene meno la piena legittimità da parte del sig. …, alla collocazione dell’opera in argomento su parti comuni…”».
Ebbene, ad avviso del CGARS, l’errore dell’amministrazione è consistito proprio nell’aver sovrapposto il piano dei rapporti civilistici tra condòmini con quello relativo alla conformità urbanistica dell’opera. Si legge, infatti, nella pronuncia che l’amministrazione «dalla supposta violazione dell’art. 1102 c.c., il cui accertamento invece appartiene al Giudice ordinario, ha fatto derivare l’illegittimità urbanistica, con conseguente emissione dell’ordinanza di demolizione e, a seguire, quella di acquisizione»: secondo i giudici siciliani, invece, l’abusività di un’opera «che sia urbanisticamente realizzabile» non può essere «in alcun senso condizionata dall’assenso o dal dissenso degli altri comproprietari», essendo pacifico che i loro diritti «non sono giammai pregiudicati dal rilascio del titolo edilizio». E tra questi diritti rientrano anche quelli connessi all’eventuale violazione dei limiti posti dall’art. 1102 c.c. e alla lesione del decoro architettonico dell’edificio. La distinzione dei piani non porta naturalmente ad affermare l’irrilevanza delle norme civilistiche ma a prendere atto che la loro violazione rileva unicamente nei rapporti fra condòmini: ricorrendo ancora alle parole della sentenza, alla violazione di tali norme «corrispondono diritti soggettivi individuali di ogni altro condomino, e non già interessi legittimi tutelabili in via amministrativa».
Ne consegue che «i diritti dei terzi sono tutelabili (esclusivamente) mediante azioni civili innanzi al Giudice ordinario». Il CGARS nega dunque la possibilità per il terzo, in un caso di questo tipo, di ottenere la ‘doppia tutela’, cioè la tutela dei diritti di fronte al giudice ordinario e degli interessi legittimi lesi dal titolo edilizio di fronte al giudice amministrativo: il condomino è, infatti, estraneo al rapporto tra l’amministrazione e il costruttore e, per definizione, non può venirne leso.
La tesi del CGARS è molto lineare e porta con sé alcune conseguenze, esplicitate nella sentenza.
In primo luogo, secondo i giudici siciliani, la legittimità di un intervento edilizio che uno dei condòmini richieda di fare sulla parte comune ai sensi dell’art. 1102 c.c. deve essere valutata dall’amministrazione «senza riguardo ai profili civilistici e ai connessi limiti posti dal cit. art. 1102», incluso quindi il rispetto del decoro architettonico. L’amministrazione è infatti competente ad autorizzare un simile intervento «solo per i profili amministrativi», mentre sui profili civilistici ha titolo di pronunciarsi unicamente il giudice civile.
La stessa distinzione di profili si realizza anche sul piano esecutivo. Secondo la tesi del CGRAS, non è compito dell’amministrazione quello di dare esecuzione alle sentenze del giudice civile[x]. Del resto, come sottolinea la sentenza, l’amministrazione ha la possibilità di intervenire in autotutela per revocare o annullare un’autorizzazione illegittima, senza che ciò dipenda da una precedente o sopravvenuta sentenza del giudice civile. Il CGARS ammette naturalmente che dalla sentenza del giudice civile possa sorgere un obbligo di rimozione di un’opera: tuttavia, un simile intervento repressivo è azionabile da chi ne abbia titolo nei modi previsti dal codice di procedura civile.
Infine, mentre la tesi del giudice di primo grado si fondava sulla difesa dei diritti dei condòmini, il CGARS svolge in proposito un ragionamento opposto: l’amministrazione non solo difetta del potere di intervenire in tal senso, ma difetta anche «degli strumenti tecnici per valutare» simili questioni civilistiche. Vi è di più: i diritti dei condòmini – prosegue la sentenza – potrebbero addirittura essere lesi dall’intervento dell’autorità pubblica («anche solo in via di stretta esecuzione delle sentenze rese dal giudice civile»). Infatti, anche dopo la demolizione imposta dal giudicato civile, le parti «restano perfettamente libere di transigere o novare ogni loro diritto od obbligo scaturente da esso»: pertanto, l’esecuzione della pronuncia da parte dell’amministrazione potrebbe ledere «il diritto di tutte le parti a ulteriormente esercitare la propria autonomia negoziale pur dopo il giudicato civile». Se, invece, la condomina controinteressata avesse inteso opporsi ancora all’attività edilizia, avrebbe dovuto coerentemente «rivolgersi nuovamente al Giudice ordinario per accertare se la nuova canna fumaria violasse ancora il decoro architettonico».
4. Le ragioni per la tesi civilistica.
La soluzione individuata dal CGARS si distingue per chiarezza dei presupposti e coerenza degli sviluppi. A fronte di una vicenda che, pur nella sua ordinarietà di lite condominiale, si era intricata per il susseguirsi di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, i giudici siciliani individuano la soluzione nella separazione dei rapporti che intercorrono, rispettivamente, tra i condòmini e tra il costruttore e la pubblica amministrazione.
Non si tratta di una novità: la stessa Corte di Cassazione[xi] afferma che è irrilevante, sul piano civilistico, che l’attività edilizia sia stata acconsentita dalla pubblica amministrazione. Meno limpida è invece, come s’è detto, la giurisprudenza amministrativa[xii], che anche quando riconosce che l’amministrazione non debba occuparsi di questioni civilistiche, tuttavia ritiene sussistente un dovere di controllo prima faciedell’amministrazione sul titolo del richiedente. Non sembra però potersi tenere tutto insieme: se si ammette che l’amministrazione debba – più o meno approfonditamente – occuparsi delle vicende civilistiche, allora i due piani finiscono per sovrapporsi[xiii], con le conseguenze stigmatizzate dallo stesso CGARS, cioè l’assenza dei mezzi per dirimere la controversia in capo all’amministrazione e la potenziale lesione dell’autonomia privata[xiv].
Che la soluzione di un contrasto tra privati circa la titolarità di un diritto sia un compito complesso, che sfugge alla competenza dell’amministrazione pubblica, è dimostrato anche dal caso che ci interessa, nel quale la questione civilistica pareva invece chiara, sia perché evidente risultava il dissenso di un condomino, sia perché si era addirittura formato sul punto un giudicato civile: eppure, come ammesso dallo stesso Tar nella pronuncia di primo grado, i limiti di quel giudicato non erano facilmente identificabili (si poneva infatti, in concreto, la questione di individuare a quale delle diverse canne fumarie installate nel tempo si riferisse l’ordine di demolizione del giudice civile)[xv].
Di là dalla difficoltà pratica, occorre però ancor prima domandarsi se sul piano giuridico l’amministrazione sia tenuta a svolgere una simile funzione arbitrale e se la sua attività debba essere condizionata da una contestazione sul titolo civilistico. La risposta alla domanda dovrebbe dipendere dalla disciplina della singola fattispecie: l’amministrazione è, infatti, titolata a intervenire e a effettuare un controllo quando una norma lo richieda[xvi]. Ebbene, in questo caso, sia che si ritenga (come fa il Tar) che l’installazione della canna fumaria necessitasse del permesso di costruire, sia che si ritenga invece (come il CGARS) che l’intervento richiedesse una semplice s.c.i.a., le norme che disciplinano l’attività dell’amministrazione non richiedono un controllo sul titolo del richiedente[xvii]. A quest’ordine di idee aderisce anche il CGARS, che addirittura offre un esempio in motivazione: dopo aver ribadito che non spetta all’amministrazione, «neanche incidentalmente», di valutare se l’opera integri un’alterazione della destinazione della cosa comune o se il suo utilizzo sia incompatibile con l’uso paritario altrui o se l’opera sia lesiva del decoro architettonico, i giudici sottolineano che quest’ultimo compito potrebbe spettare semmai «solo nei congrui casi» all’amministrazione dei beni culturali.
Vero è che il permesso di costruire deve essere rilasciato dall’amministrazione al «proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo», tuttavia lo stesso articolo del testo unico sull’edilizia si chiude con la clausola di salvezza dei diritti dei terzi (art. 11, c. 3, d.P.R. n. 380/2001), sulla quale si fonda il sistema. I terzi non sono pregiudicati dal rilascio del titolo edilizio e non sono privati di tutela, ma possono richiederla nelle forme previste dalle leggi e dal processo civile[xviii].
Questa non è l’unica possibile interpretazione della clausola di salvezza dei diritti dei terzi. Si è, infatti, anche sostenuto in dottrina che i diritti dei terzi non solo non possano, ma neppure debbano essere lesi dall’attività dell’amministrazione. Ne conseguirebbe che l’amministrazione sarebbe tenuta a negare il rilascio del titolo edilizio ogni volta che vi sia una contestazione sul diritto del richiedente, «pur in presenza di un progetto astrattamente conforme alla normativa urbanistica della zona di riferimento»: ciò non solo nel caso in cui emerga «con chiarezza» l’assenza del titolo di godimento ma anche quando la sua sussistenza sia «incerta o contestata»[xix]. Simile ricostruzione supera, quindi, anche l’impostazione della giurisprudenza prevalente (che richiede solo un controllo prima facie sui titoli) ed è certamente coerente con le proprie premesse.
Si può, tuttavia, obiettare che il significato della clausola di salvezza sembra proprio quello di separare il rapporto che corre tra amministrazione e richiedente da quello privatistico che lega quest’ultimo a eventuali terzi. Si arriverebbe inoltre, sul piano pratico, alla conseguenza, difficilmente accettabile, che il rilascio di un titolo edilizio dovrebbe essere negato, pur se vi sia la conformità urbanistica, almeno[xx] fino alla pronuncia del giudice civile[xxi], e in presenza di una semplice opposizione[xxii] da parte di un controinteressato.
[i] Per questo orientamento, in dottrina, v. F. Gaffuri, Il permesso di costruire e i diritti dei terzi, in Urb. App., 2/2012, 150 ss., secondo cui «(…) il potere amministrativo di conformazione delle iniziative edilizie si pone in stretta correlazione con tutte le altre discipline che hanno come “terminale”, immediato e diretto, il territorio, nel suo complesso o nelle singole parti di cui si compone, quali, ad esempio, la materia ambientale, la materia paesaggistica e, per l’appunto, la disciplina dei rapporti negoziali e dei diritti reali contenuta nel codice civile» (ivi, 157).
[ii] Per una rassegna degli orientamenti giurisprudenziali in materia, si vedano, tra altri, A. Berra, R. Damonte, Art. 11, in M.A. Sandulli (a cura di), Testo unico dell’edilizia, III ed., Giuffrè, Milano, 2015, spec. 336 ss. e A. Chierichetti, Testo unico in materia edilizia, Art. 11, in R. Ferrara, G.F. Ferrari (a cura di), Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia, III ed., Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2019, spec. 293 ss.
[iii] Cioè il conseguente accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, nonché il provvedimento con cui veniva comunicata la immissione in possesso e l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31, c. 3, d.P.R. n. 380/2001.
[iv] Tar Sicilia, Catania, I, 13 dicembre 2021, n. 3730.
[v] In particolare, l’art. 1120, c. 4, c.c. prevede che «Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino».
[vi] La citazione è tratta da Cons. Stato, VI, 13 marzo 2023, n. 2618, pronuncia conforme alla più recente giurisprudenza del massimo giudice amministrativo. Nella stessa sentenza si legge che, in un caso simile a quello di cui ci si sta occupando, «era preciso compito dell’Amministrazione verificare l’effettiva legittimazione dell’appellante a richiedere il titolo richiesto» e che il Comune «non poteva ignorare la posizione esplicitamente espressa dal condominio» in senso contrario all’intervento edilizio. Si vedano anche, sempre in tema di costruzioni su parti comuni, Cons. Stato, VI, 30 agosto 2022, n. 7540 e Cons. Stato, IV, 4 maggio 2010, n. 2546 (dove i giudici ritengono che, pur mancando il consenso dei condòmini, lo stesso non era necessario poiché, nel caso di specie, appariva «manifesta» la «osservanza dei limiti posti dagli artt. 1102 e 1120 c.c. all’uso del tetto comune da parte dei singoli comproprietari»).
[vii] Cons. Stato, IV, 24 febbraio 2022, n. 1302, citata da M.A. Sandulli, Edilizia, in Riv. Giur. Ed., 3/2022, 171 ss., cui si rinvia in generale sul tema. Netta circa la distinzione tra rapporto pubblico e rapporti privati è anche Cons. Stato, 24 marzo 2011, n. 1770, ove si legge che «la concessione edilizia è un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l’attività edilizia nell’ordinamento pubblicistico, e regola solo il rapporto che, in relazione a quell'attività, si pone in essere tra l'autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all’attività stessa, la cui titolarità deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune» (in proposito v. anche A. Chierichetti, Testo unico in materia edilizia, Art. 11, cit., 293). La distinzione tra attività pubblicistiche e questioni civilistiche trova conferma anche nella giurisprudenza della Cassazione: si veda, per esempio, Cass. civ., II, 20 gennaio 2022, n. 1764, secondo cui «[…] in tema di distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, deve essere inteso nel senso che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell’opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l’aspetto formale dell’attività costruttiva, con la conseguenza che, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino, così l’aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni».
[viii] Tar Campania, VI, 18 aprile 2017, n. 2114, ove si legge che l’assenso dei condòmini «non rileva ai fini della conformità urbanistica […] trattandosi di aspetti rimessi alla esclusiva valutazione della autorità amministrativa», ma tuttavia «la necessità di acquisire il previo assenso dei condomini ai fini del rilascio di titoli abilitativi al posizionamento sulle facciate dei fabbricati di canne fumarie, risponde alla esigenza di prevenire controversie in ordine alla gestione della cosa comune ed alla potenziale lesione delle prerogative proprietarie».
[ix] L’obbligo del controllo si potrebbe ricavare dall’art. 11, c. 1, d.P.R. n. 380/2001, che stabilisce che il permesso di costruire sia rilasciato «al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo» oppure, in generale, dall’art. 6, c, 1, lett. a) della l. n. 241/1990, laddove richiede che il responsabile del procedimento valuti «le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento» (in tal senso, v. A. Berra, R. Damonte, Art. 11, cit., 338); si veda anche F. Gaffuri, Il permesso di costruire e i diritti dei terzi, cit., 157.
[x] In senso conforme, v. anche la successiva sentenza del CGARS, sez. giurisdizionale, 21 agosto 2023, n. 535.
[xi] Cass. civ., SS.UU., 22 settembre 2016, n. 18571; Cass. civ., II, 20 ottobre 2021, n. 29166.
[xii] Non tutta, però: si vedano per esempio Tar Abruzzo, L’Aquila, I, 23 marzo 2016, n. 177 e Cons. Stato, V, 7 settembre 2009, n. 5223.
[xiii] Per usare le parole di A. Berra, R. Damonte, Art. 11, cit., 325, «la disciplina civilistica si proietta su quella amministrativa per quanto riguarda l’esatta individuazione del soggetto titolare dello jus aedificandi ed in quanto tale abilitato a conseguire il titolo edificatorio».
[xiv] Sul punto sia consentito rinviare a L. Ferrara, G. Mannucci, I. Piazza, Sui rapporti di vicinato in una giurisprudenza recente. Diritti soggettivi e interessi legittimi, diritti soggettivi trasformati in interessi legittimi o soltanto diritti soggettivi?, in Dir. Pubbl., 2023, spec. 315.
[xv] Si trova in ciò conferma, incidentalmente, che in sede di esecuzione civile vengono compiuti accertamenti preordinati alla stessa esecuzione della sentenza: in generale sul tema si rinvia, per tutti, a P. Biavati, Argomenti di diritto processuale civile, BUP, Bologna, 2023, 783 ss.; in particolare sulla analogia, da questo punto di vista, tra processo di esecuzione e giudizio di ottemperanza si rinvia invece a L. Ferrara, Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione. La dissoluzione del concetto di interesse legittimo nel nuovo assetto della giurisdizione amministrativa, Giuffrè, Milano, 2003, spec. 57 ss. e 250 ss.
[xvi] Per questa impostazione, v. G. Mannucci, La tutela dei terzi nel diritto amministrativo. Dalla legalità ai diritti, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2016, 246 ss.
[xvii] Diverso è il caso delle norme sulle distanze tra le costruzioni, che, come noto, costituiscono limiti legali e integrano il parametro di conformità edilizia: oltretutto, in questo caso, «trattandosi (…) di vincoli direttamente imposti dalla legge, per essi non si pongono certo problemi in tema di “conoscibilità” dei medesimi da parte dell’Amministrazione» (A. Berra, R. Damonte, Art. 11, cit., 322). Anche su questo punto, v. G. Mannucci, La tutela dei terzi nel diritto amministrativo, cit., 249 ss. Nega che la verifica dell’amministrazione sul titolo del richiedente possa «mai tradursi in una funzione arbitrale o paragiudiziale» G. Pagliari, Il permesso di costruire, in F.G. Scoca, P. Stella Richter, P. Urbani (a cura di), Trattato di diritto del territorio, vol. I, Giappichelli, Torino, 2018, 771 s., secondo cui l’attività dell’amministrazione debba limitarsi a una «verifica dell’idoneità giuridico-formale del documento prodotto ad attestare la titolarità del diritto di proprietà o della diversa qualità vantata per legittimare la richiesta del permesso di costruire».
[xviii] Come ricorda anche il CGARS nella sentenza, il rilascio del titolo edilizio deve avere «esclusivo riguardo alla compatibilità urbanistica» dell’opera; il che «non implica affatto che essa non sia lesiva di diritti soggettivi altrui», ma ogni questione che li riguarda ha una «unica sede competente, che è il giudizio civile». Una ricostruzione simile è seguita anche in L. Ferrara, G. Mannucci, I. Piazza, Sui rapporti di vicinato in una giurisprudenza recente, cit., spec. 314 ss.
[xix] F. Gaffuri, Il permesso di costruire e i diritti dei terzi, cit., 158.
[xx] Ché, come abbiamo visto, neppure il giudicato civile è a volte in grado di chiudere la questione.
[xxi] F. Gaffuri, Il permesso di costruire e i diritti dei terzi, cit., 159.
[xxii] Lo stesso Autore specifica che la contestazione dovrebbe essere «puntuale e dettagliat[a]» (F. Gaffuri, Il permesso di costruire e i diritti dei terzi, cit., 158), introducendo tuttavia così un elemento di valutazione che si scontra con la linearità della stessa tesi; anche D. Chinello, Legittimazione edilizia dei singoli condòmini per intervenire sulle parti comuni e poteri comunali di verifica, in Urb. App., 4/2012, 461, che aderisce alla tesi del controllo sui titoli da parte dell’amministrazione, suggerisce di porre a carico del richiedente una «accurata verifica tecnica» circa la applicazione dell’art. 1102 c.c. e, quindi, circa possibilità di effettuare un intervento sulle parti comuni senza aver prima ottenuto il consenso dei condòmini. Sulla necessaria ‘serietà’ delle contestazioni sul titolo civilistico, si veda la recente sentenza del CGARS, sez. giurisdizionale, 15 settembre 2023, n. 569.